Tutte le attività
Questo elenco si aggiorna automaticamente
- Ultima ora
-

500 lire
petronius arbiter ha risposto a un topic di Den 1890765 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Le foto non sono il massimo, ma solo a me il ritratto di Donna Letizia sembra inguardabile, con quell'occhio spalancato? E poi monete così non si "trovano" petronius -
Il problema si è presentato dopo aver inviato il messaggio precedente (sistema bloccato in loop). Per inviare questo messaggio ho dovuto chiudere e ricollegarmi al sito. Può darsi che si verfichi anche dopo l'invio del presente messaggio. apollonia
-

500 lire
Oppiano ha risposto a un topic di Den 1890765 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
“Apparentemente” la “moneta” dovrebbe rappresentare: 500 Lire Caravelle "Bandiere Rovesciate" 1957. Hai trovato dove? -
Ho notato che il problema si ripresenta (schermo in bianco, sistema in loop) se l'attività è stata sospesa per qualche tempo, mentre non c'è se si chiude e poi si riapre il collegamento al forum. Faccio notare che mi collego al forum da PC. apollonia
-

moneta da 1 euro croata 2023
petronius arbiter ha risposto a un topic di Getro inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
@Getro, c'è qualche motivo per cui pensavi che questa moneta potesse presentare un errore? petronius -

500 lire
Oppiano ha risposto a un topic di Den 1890765 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Per stavolta, le posto io le foto (un po’ sfocate). Dovresti postare però anche una foto del contorno che dovrebbe recare in rilievo il millesimo e la scritta REPVBBLICA ITALIANA tra stellette. -
Storia di Roma e delle sue monete
L. Licinio Lucullo ha risposto a un topic di L. Licinio Lucullo inviato in Monete Romane Repubblicane
LA RIFORMA MONETARIA DI AUGUSTO Nel rinnovare lo Stato, Augusto operò anche una radicale riforma del sistema monetario; convenzionalmente, la comparsa delle sue “nuove” emissioni segna la fine della monetazione repubblicana. Gli ultimi (in ordine cronologico) aurei, denarî e quinarî censiti da Crawford come “repubblicani” sono datati al 31 a.C. La riforma augustea perseguiva chiaramente due scopi: dimostrare la maggior efficienza del nuovo regime (rispetto al sistema oligarchico) e privare gli antagonisti politici di uno strumento di propaganda. Al fine di mostrare l’efficienza del suo sistema politico, Augusto agì in due direzioni, volendo al contempo rimediare alla carenza di “spiccioli” che affliggeva l’impero e migliorare l’estetica delle monete. Fu avviata quindi una produzione stabile di monete di tutti i valori, aurei e mezzi aurei (in oro), denarî e quinarî (in argento), sesterzî e dupondî (in oricalco[1]), assi, semissi e quadranti (in bronzo); furono rafforzate le zecche provinciali e alcune di esse (prima fra tutte Lugudunum) furono elevate al rango di zecche imperiali (distaccate rispetto a quella di Roma, ma incaricate di produrre le stesse monete). Sul piano estetico, le monete cominciarono a presentare tondelli ben circolari, disegni centrati meglio e immagini curate, chiare e semplici (senza la sovrabbondanza di scritte che aveva reso illegibili alcune produzioni tardo repubblicane); sugli esemplari in altissima conservazione, inoltre, si può constatare che il fondo venne attentamente levigato, per far risaltare e rendere più suggestive le immagini stesse. Erano le monete più belle mai coniate a Roma. Uno strumento così forte di propaganda fu quindi sottratto all’iniziativa dei singoli: furono vietate le emissioni imperatoriali e la scelta dell’iconografia venne riservata al Senato e all’imperatore; il primo, in particolare, si interessò dei pezzi in bronzo e oricalco (che pertanto, a partire da questa data, riportano sempre la sigla SC), il secondo di quelli in argento e oro. L'estetica fu così posta al servizio della politica, per rafforzare nella pubblica opinione la sensazione di un clima di pace, sicurezza, ordine e prosperità. Paul Zanker, storico e archeologo, ha osservato in proposito che mediante “il potere delle immagini” l’imperatore alimentò “un mito capace … di produrre per intere generazioni la certezza di vivere nel migliore degli Stati possibili e nella pienezza dei tempi”. _________________________ L’osservazione della prima monetazione imperiale consente di capire meglio - per contrasto - quella tardo repubblicana: ciò che Augusto “aggiunse” (la produzione di spiccioli, la cura dell’estetica, etc.) è qualcosa di cui egli aveva percepito la carenza; parallelamente, ciò che egli “tolse”, ossia in primo luogo la facoltà, per i singoli, di scegliere le iconografie, è qualcosa di cui aveva apprezzato il potere destabilizzante. Nel mondo moderno, la scelta della grafica del denaro è divenuta un accessorio, al massimo una curiosità da collezionisti; nell’antica Roma, invece, era uno strumento potentissimo, l’unico capace di far arrivare una determinata immagine nelle mani della moltitudine dei cittadini. L’iniziativa di Augusto si capisce meglio se si considera che egli avocò a sé stesso anche un altro importante privilegio, il trionfo (da allora in poi, solo i membri della famiglia imperiale poterono celebrarlo); la finalità è la medesima: privare gli esponenti dell’aristocrazia di uno strumento attraverso cui mettersi in mostra davanti al popolo, evitando così che maturi in loro la tentazione di sovvertire il potere costituito. Questo tipo di strumento erano diventate le monete, alla fine della Repubblica. _________________________ Fra le tante monete di Augusto, alcune sono interessanti anche perché sono collegate a eventi avvenuti o comunque iniziati alla fine della Repubblica. Il denario RIC I 253 ad esempio, datato al 32-29 a.C., reca al dritto il busto di Venere, dea protettrice del padre adottivo di Augusto, al rovescio l’immagine dell’imperatore stesso, in abiti militari, con il braccio alzato: si tratta dell’adlocutio, il discorso che ogni comandante militare faceva alle sue truppe per infervorarle prima della battaglia, e specificamente di una adlocutio che egli fece durante la campagna contro Antonio, probabilmente quella stessa che precedette la battaglia di Azio. Il denario RIC I 266, datato al 29 a.C., reca al dritto il ritratto di Augusto, al rovescio l’immagine della Curia Iulia, la nuova sede del Senato voluta da Giulio Cesare ma inaugurata appunto nel 29. La ricchezza dei dettagli è incredibile: l’edificio risulta preceduto da un portico in stile ionico e sormontato da tre statue, Vittoria (riconoscibile per le ali), con in mano il globo, e altre due figure, con in mano una lancia e un parazonium (una piccola spada), voltate verso di essa. Il timpano era decorato con i bassorilievi di una figura seduta in mezzo ad animali e sull’architrave compariva la dedica IMP. CAESAR. È raffigurata persino la porta di bronzo. Si noti l’uso di imperator come praenomen, riferito a Cesare (la dedica è a lui, che aveva avviato la costruzione, non ad Augusto), che sembra confermare come egli avesse effettivamente avviato questa prassi. L’edificio è tuttora integro e, grazie a questo denario, sappiamo che la sua struttura è rimasta inalterata (salvo il comprensibile fatto che sulla moneta ne era stato ingigantito il timpano); anche il portone in bronzo si è conservato, sebbene sia stato trasferito all’ingresso della chiesa di San Giovanni in Laterano. Il quinario RIC I 276, riporta, oltre al consueto ritratto, l’immagine di una Vittoria in piedi su una cista mistica, circondata da serpenti. La didascalia del dritto, CAESAR e IMP VII, consente di datare l’emissione al 26 a.C., quando Augusto fu acclamato imperator per la settima volta. Più interessante è la legenda sul rovescio: ASIA RECEPTA (“Asia riconquistata”); sappiamo infatti che Augusto volle chiudere lo stato di belligeranza con i Parti mediante accordi diplomatici (nel 20 a.C. essi restituiranno anche le aquile legionarie sottratto all’esercito di Crasso) e se ne vantò come se fosse stato un successo militare. In questo senso, la dea in piedi sulla cista (simbolo dell’Oriente) è una metafora della vittoria romana in Asia. NOTE [1] Il peso dei sesterzî fu fissato in un’oncia, ossia circa 27 g. È per questa ragione che molti autori sospettano che anche le monete di peso superiori ai 20 g che li precedettero (come quelle dei due figli di Pompeo), soprattutto se in oricalco (come quelle di Cesare e di Ottaviano), potessero già essere sesterzî. ILLUSTRAZIONI 29 a.C., denario RIC I 266 29 a.C., denario RIC I 266. La Curia Iulia, oggi 26 a.C., quinario RIC I 276. -

Vaticano 2024
donato11 ha risposto a un topic di naga inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.
Ogni commento è superfluo ... -

500 lire
caravelle82 ha risposto a un topic di Den 1890765 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Buonasera É regolamento ed anche un modo per fruire del forum per sempre. I link prima o poi si perdono. Non bisogna pensare a soddisfare una richiesta nell'immediato e il resto nulla, in un forum ci si proietta anche per future richieste e chi vorrá sapere su questo quesito, ne potrá giovare vedendo delle foto, non link corrotti. -
50 centesimi 2021
Beppes86 ha risposto a un topic di Beppes86 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Potrebbe non essere detenuto?proverò a cercare informazioni online ma non ne trovo molte, qualcosa su eBay ma niente di particolare -

Sterlina regina Vittoria 1892- richiesta parere-
Pontetto ha risposto a un topic di Bolio inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Perfetto. È proprio lui. Il problema è che è vero che la moneta è più gradevole con questo "unto", ma é solo sporco, un residuo credo generato proprio dalla plastica. Quindi non è reale, è finto, una manipolazione. Non a caso le case d'asta fanno finta di niente (e non a caso io scarto queste monete). Per me è è da rimuovere e poi le monete vanno poste in un altro contenitore. -

Monete sparite in dogana 8 reales spagnoli chi le vede segnali
ceolo ha risposto a un topic di Andrea79 inviato in Zecche Straniere
Non credo che le monete siano "sparite" in dogana. Sono andate smarrite al centro di smistamento postale. Saluti Federico -
Storia di Roma e delle sue monete
L. Licinio Lucullo ha risposto a un topic di L. Licinio Lucullo inviato in Monete Romane Repubblicane
Ad ogni buon conto, per chi preferisca la lettura on-line, il testo degli ultimi due capitoli è il seguente: LA FINE DELLA REPUBBLICA Dopo la battaglia di Philippi, i triumviri si spartirono le sfere d’influenza: a Lepido l’Africa, a Ottaviano l’Italia, l’Hiberia e la Sicilia (dove, però, continuava a spadroneggiare Sesto Pompeo), ad Antonio le Gallie e tutto l’Oriente; l’equilibrio tra loro era, tuttavia, instabile. _________________________ Ottaviano si dedicò a consolidare ulteriormente il ricordo di Cesare e, per tramite di esso, la propria autorità. Nel luglio del 44 a.C., dopo la morte di Cesare, era apparsa per sette giorni una cometa, che fu ritenuta un chiaro segno della sua divinizzazione e, quindi, venne chiamata sidus Iulium. Infatti per la mentalità romana, sebbene nessun vivente potesse affermare di essere un dio, ciò non escludeva che dopo morte gli dei decidessero di accogliere un defunto fra loro: si trattava della cosiddetta “apoteosi” (non molto dissimile dalla “santificazione” della dottrina cattolica) ed era successa, sino allora, solo con Romolo (identificato, per questo motivo, con il dio Quirino ). Preso atto di questa prova evidente di apoteosi, nel dicembre del 42 a.C. il Senato, su iniziativa di Ottaviano, dichiarò formalmente Cesare “divus” (ossia un mortale divinizzato, qualcosa di meno di un vero deus); Ottaviano, pertanto, poté vantarsi di essere Gaius Iulius Caesar divi filus e lo pubblicizzò su due emissioni di bronzo. La prima, RRC 535/1, reca da un lato il ritratto di Ottaviano e la legenda CAESAR DIVI F., dall’altro il ritratto di Cesare e la legenda DIVOS IVLIVS[1]; la seconda, RRC 535/2, reca da un lato il ritratto di Ottaviano con una stella, il sidus Iulium, sotto il mento e la legenda DIVI F., dall’altro la legenda DIVOS IVLIVS in una corona d’alloro. Si tratta sicuramente di emissioni itineranti, ma si discute molto sulla loro interpretazione, resa difficile anche dall’estrema variabilità di peso[2]. Grueber ipotizza che fossero sesterzî, emessi in Gallia; Martini[3] crede che le prime monete siano state prodotte in Gallia nel 43 a.C., le successive invece in Italia nel 37-36 e ne deduce che, nel tempo intercorso, ne sia stato abbassato progressivamente il peso; Amisano, concordando con Martini, suggerisce che le monete fossero in origine sesterzî (come le emissioni di Gneo Pompeo ) ma poi, a causa della diminuzione di peso, possano essere state accettate come dupondî o assi; McCabe ritiene che fossero dupondî. _________________________ Anche se la fazione dei cesaricidi era stata definitivamente debellata, la numismatica ci tramanda un interessante indizio di come l’aristocrazia oligarchica, invece, non si fosse ancora rassegnata alla progressiva trasformazione del sistema di governo romano in senso monarchico. Si tratta del denario RRC 515/2, datato al 41 a.C. e firmato da tale Lucio Servio Rufo, non altrimenti noto. Esso reca, al rovescio, l’immagine dei Dioscuri in piedi, ma la particolarità è al dritto: un ritratto privo di didascalia; probabilmente il monetiere avrà affermato che voleva celebrare un suo antenato, tuttavia a chiunque è evidente la piena somiglianza fra questo ritratto e quello di Bruto, presente sul denario RRC 508/3. A pochi mesi dalla morte di Bruto, il più acerrimo nemico di Ottaviano, un oscuro aristocratico si permetteva di inneggiare a lui, sulle monete della Repubblica. _________________________ Nel 41 a.C. Antonio si diresse a Tarso, ove convocò Cleopatra per accusarla di aver appoggiato i cesaricidi; quando la regina arrivò, tuttavia, se ne invaghì perdutamente e, alla fine dell’anno, la seguì ad Alessandria. _________________________ Antonio era sposato con Fulvia, persona ricca, astuta e volitiva. Era stata in passato la moglie di Clodio, grazie al quale era riuscita a entrare nella cerchia dell’aristocrazia; morto lui, nel 50 a.C. aveva sposato un altro giovane aristocratico, Curione, tramite il quale aveva conosciuto Antonio, suo debitore. Sebbene i contemporanei la descrivessero come una donna brutta, Antonio si ne era perdutamente innamorato, divenendone l’amante nel 49 (quando Curione era morto in guerra) e sposandola nel 44. Antonio volle immortalare l’immagine della moglie sulle monete della Repubblica; usò allora lo stratagemma di Gneo Pompeo iunior (che aveva emesso assi con Giano avente le fattezze del padre) e fece produrre alcuni quinarî, RRC 489/5 e RRC 489/6, su cui la dea Vittoria (riconoscibile per le piccole ali sulle spalle) ha le fattezze di Fulvia. Sappiamo che si tratta di lei in quanto nel 41 a.C. anche una città anatolica (ora non più esistente), ribattezzata Φουλούια (Fulvia) in onore del triumviro, emise un bronzo che reca il medesimo ritratto nonché la legenda ΦΟΥΛΟΥΙΑΝΩΝ (“dei Fulviani”), la moneta RPC I 3139. Intrigante e manipolatrice, Fulvia si ingeriva continuamente in politica, manovrando il marito e i suoi alleati: fu lei che spinse Antonio a mettere a morte Cicerone, offesa perché l’aveva pubblicamente motteggiata invitandola a usare le sue doti di iettatrice per far morire Antonio, così come era riuscita con Clodio e con Curione. Pertanto nel 41 a.C., vedendo crescere in Italia il malcontento contro Ottaviano (che stava espropriando molti terreni in Etruria, per assegnarli ai veterani prossimi al congedo), convinse il cognato Lucio Antonio, uno dei consoli di quell’anno, ad aggregare un esercito per combatterlo. Il progetto tuttavia fallì e i due cospiratori si rifugiarono a Perusia (odierna Perugia), che Ottaviano pose sotto assedio; si arresero agli inizî del 40. Per non esacerbare le tensioni con Antonio, Ottaviano risparmiò la vita del fratello e della moglie, ma Fulvia fu inviata in esilio in Grecia. La accompagnò un fidato amico di Antonio, Lucio Munazio Planco (l’ufficiale con cui Cesare aveva attraversato il Rubicone ), diretto ad assumere il governatorato della Bitinia. Ad Atene Fulvia fu raggiunta dal marito, proveniente da Alessandria e diretto in Italia e ne nacque un duro litigio: lui accusava lei di aver scatenato una guerra fallimentare, lei contestava a lui di non essere accorso in loro aiuto solo per stare con Cleopatra. Fu il loro ultimo incontro: Antonio partì per l’Italia e Fulvia, poco tempo dopo, morì di malattia. Nell’occasione, Planco coniò il denario RRC 522/2, che celebra al dritto il triumviro con la raffigurazione di lituus e praefericulum (strumenti dell’augurato, sacerdozio all’epoca ricoperto da Antonio), al rovescio lo stesso Planco con la raffigurazione di simboli della Bitinia (fulmine, anfora e caduceo, rispettivamente allusioni allo esercito là stanziato, al vino che la Bitinia esportava e al commercio praticato nei suoi porti); la legenda recita M. ANTON. IMP. AVG. III.VIR RPC al dritto, L. PLANCVS PRO. COS. al rovescio. Antonio sbarcò presso Brundisium nell’estate del 40 a.C. e fu accolto da una brutta notizia: il suo luogotenente nelle Gallie, Quinto Fufio Caleno, era morto e le sue legioni si erano messe al servizio di Ottaviano, che aveva così ottenuto il controllo su quel vasto e ricco territorio. Furioso, Antonio meditò di scatenare un’ennesima guerra civile, ma non gli riuscì perché le truppe rifiutarono di combattere; a settembre, allora, stipulò con Ottaviano un nuovo patto di alleanza, noto come “pace di Brindisi”, con cui gli riconobbe il potere sulle Gallie. _________________________ Nel frattempo, a febbraio del 40 a.C., i Parti - approfittando delle divisioni fra i triumviri e dei consigli del traditore Quinto Labieno (figlio del Tito Labieno che si era ribellato a Cesare) - attaccarono i territorî romani della penisola anatolica, arrivando sino sulle coste del Mar Egeo. Labieno, che comandava la cavalleria, emise un denario, RRC 524/2 (ormai rarissimo), che raffigura al dritto il suo ritratto, al rovescio un cavallo partico con arco e faretra appesi alla sella. _________________________ Antonio, rimasto vedovo, per sugellare la pace di Brindisi sposò Ottavia Minore, sorella di Ottaviano. Inizialmente ella riuscì a tenerlo lontano da Cleopatra (cosa che, sicuramente, Ottaviano aveva sperato, combinando il matrimonio), ma in seguito Antonio tornò nelle braccia della regina. Anche a Ottavia egli concesse l’onore di essere effigiata su una moneta della Repubblica, l’aureo RRC 533/3 del 38 a.C. (che, al dritto, reca il ritratto di Antonio stesso). Pur essendo stata prima tradita, poi rifiutata e infine ripudiata dal marito, Ottavia gli resterà sempre fedele e cercherà più volte di riconquistarne l’affetto; infine, quando Antonio morirà, si assumerà l’onere di accudirne i figli, non solo i proprî anche quelli che lui aveva avuto da Fluvia e da Cleopatra. Morirà nell’11 a.C.; per renderne immortale il nome il fratello le dedicherà un grandioso monumento, il Portico di Ottavia a Roma. _________________________ Poco tempo dopo Antonio, anche Ottaviano si risposò. Nel 39 a.C., infatti, fece decretare un’amnistia per gli avversarî politici che erano stati proscritti; allora poté tornare a Roma, fra gli altri, anche tale Tiberio Claudio Nerone, con il figlioletto omonimo e la moglie Livia Drusilla, di nuovo incinta. Narrano le fonti che, appena si incontrarono, Livia e Ottaviano si innamorarono perdutamente: lui decise quindi di ripudiare la propria moglie (una parente di Sesto Pompeo, che aveva sposato per calcolo politico e non per amore), convinse Tiberio a ripudiare Livia e la sposò nel gennaio del 38 a.C., il giorno dopo che aveva partorito. Livia resterà con Ottaviano sino alla morte di lui, nel 14 d.C.; intelligente, modesta e schiva, costituirà la più fidata consigliera del primo imperatore di Roma, senza cercare la notorietà pubblica. Nel tentativo, anzi, di costituire un modello per le matrone romane, eviterà ogni sfoggio di lusso, continuando anche a vivere nella (relativamente modesta) casa sul Palatino, e sopporterà i tradimenti del marito senza denigrarlo. La coppia non ebbe figli proprî, ma il primo figlio di Livia sarà in futuro adottato da Ottaviano e passerà alla storia con il solo cognomen di Tiberio, secondo imperatore di Roma. Ottaviano, a differenza di Antonio, non cedette alla tentazione di raffigurare la propria moglie sulle monete. _________________________ Nel 38 a.C. Ottaviano prese alcune iniziative per rinforzare la presa del suo potere sulle Gallie. Sul piano militare, assegnò il governatorato a un suo coetaneo, di cui era amico stretto sin dai tempi dell’infanzia, Marco Vipsanio Agrippa, e lo incaricò di ricacciare al di là del Reno alcune tribù germaniche che avevano sconfinato, cosa in cui Agrippa ebbe pieno successo. Sul piano propagandistico, avviò presso la zecca di due coloniae, Felix Munatia Lugdunum (fondata da Lucio Munazio Planco, chiamata anche Copia o Lugudunum, attuale Lione) e Iulia Viennensis (dedotta da Cesare al posto della capitale degli Allobrogi, attuale Vienne) la produzione dupondî (RPC I 514-515 e RPC I 517) che raffiguravano al dritto il ritratto suo e di Cesare, al rovescio la prora navis (con uno stile grafico peculiare). La particolarità di queste monete è che, oggi, molte risultano tagliate a metà lungo l’asse che separava le due teste al dritto, chiaro segno della grave carenza di spiccioli che afflisse la Repubblica nei suoi ultimi anni, cui i privati cercarono di rimediare dimezzando le monete più grandi . _________________________ Il 31 dicembre del 38 a.C. il triumvirato arrivò a scadenza; Ottaviano continuò a comportarsi da capo della Repubblica, ma la sua posizione era divenuta del tutto illegittima e, quindi, debole. Grazie all’intermediazione e di un fido consigliere, Gaio Cilnio Mecenate, e a quella di Ottavia, ottenne quindi che Antonio tornasse in Italia per un incontro con lui e Lepido. L’incontro si tenne a Taranto nel 37 a.C.; nell’occasione fu pattuito non solo di far prorogare il triumvirato, con altra apposita legge, per ulteriori 5 anni, ma anche che Antonio e Ottaviano si sarebbero forniti appoggio reciproco nelle campagne militari che intendevano intraprendere: il primo contro i Parti, il secondo contro Sesto Pompeo. _________________________ Sesto Pompeo, infatti, continuava a spadroneggiare in Sicilia, da dove poteva ricattare Roma interrompendo il flusso di grano che ne sosteneva la popolazione; un primo tentativo di cacciarlo, compiuto da Ottaviano nel 38 a.C., era fallito. Sull’isola egli continuò la prassi del fratello di emettere monete di bronzo con l’iconografia degli assi tradizionali, ma il ritratto del padre; le sue, RRC 479/1, recano la legenda MGN (Magnus, cognomen del padre) al dritto e PIVS (Pius, cognomen assunto da Sesto proprio per la sua devozione al genitore) e IMP al rovescio. La datazione è incerta: l’emissione iniziò forse nel 45 a.C. in Hispania o dopo il 44 in Sicilia, ma si protrasse per diversi anni. Anche per queste monete, come per gli altri bronzi emessi dal 46 in poi, è stato proposto da Amisano e altri autori che fossero sesterzî o dupondî, anziché assi. Per sconfiggerlo, Ottaviano decise di affidarsi alle doti militari di Agrippa: alla fine del 38 a.C. lo richiamò dalla Gallia e lo designò console per l’anno successivo. La designazione (che era formalmente solo una “indicazione”, ma sarebbe stata sicuramente ratificata dai comizî) fu celebrata sul denario RRC 534/3. Questa moneta è particolarmente interessante per la legenda al dritto: IMP. CAESAR a sinistra del ritratto di Ottaviano, DIVI IVLI F. a destra; risulta quindi evidente che “IMP” non è aggiunto alla fine del nome (come normalmente si usava) ma usato come praenomen. Sembra che Cesare avesse fatto altrettanto in alcune sue monete (non è tuttavia sicuro, perché su di esse la legenda ha andamento circolare); Mommsen, al riguardo, ipotizza che egli volesse istituire una nuova magistratura con questo nome (che gli permettesse di esercitare poteri monarchici senza farsi rex). Probabilmente Ottaviano, vedendo andare a scadenza il triumvirato, meditava di percorrere la stessa strada; in futuro abbandonerà la prassi di usare imperator come praenomen, probabilmente perché riterrà inutile l’istituzione di una nuova magistratura. Tale prassi tuttavia sarà ripresa a partire da Nerone ed è per tale motivo che noi, oggi, definiamo “imperatori” i monarchi di Roma. Nel 36 a.C. l’esercito di Ottaviano, grazie alle navi fornite da Antonio e alle grandi capacità tattiche dimostrate da Agrippa, riuscì finalmente a sbarcare sull’isola e a conquistarla. Sesto Pompeo fuggì in Asia, dove nel 35, fu catturato, processato e giustiziato su ordine di Antonio. Lepido, che aveva contribuito alla guerra contro Sesto Pompeo, pretese per sé il governo della Sicilia; fu una mossa falsa: Ottaviano lo sconfisse agevolmente, gli tolse ogni potere politico e lo confinò al Circeo, ove continuò a esercitare unicamente le funzioni religiose di pontifex maximus. _________________________ Nel 40 a.C., durante la permanenza ad Atene, Antonio aveva inviato i proprî più fidati ufficiali a riprendere il controllo delle province anatoliche (compreso, come detto, Lucio Munazio Planco). Il più abile di loro, Publio Ventidio Basso, nel 38 si scontrò contro la cavalleria dei Parti (la stessa che aveva decimato le legioni di Crasso, a Carre, pochi anni prima) alla battaglia del Monte Gindaro, la sconfisse duramente, uccise Labieno e costrinse i nemici a ritirarsi fin oltre l’Eufrate. Antonio, rincuorato dalla vittoria di Ventidio Basso, dalla rinnovata alleanza con Ottaviano e dal sostegno finanziario dell’Egitto, ritenne che fosse finalmente arrivato il momento giusto per attaccare il regno dei Parti. Trascorse l’inverno del 37 a.C. e la primavera del 36 in Siria, preparando la campagna militare e allietandosi della compagnia di Cleopatra (che lo raggiunse su sua richiesta); giunta l’estate, passò l’Eufrate con 16 legioni e numerosi contingenti alleati, per un totale di oltre 100.000 soldati. Fu una disfatta: i Romani, duramente sconfitti, dovettero affrontare una penosa marcia nel deserto per tornare in Siria. Durante la ritirata, tuttavia, Antonio dette prova delle sue grandi abilità militari, riuscendo a evitare che l’esercito - malgrado le ingenti perdite subite, i continui attacchi nemici e le durissime condizioni di vita - fosse distrutto. Quando Antonio tornò in Siria, Cleopatra si fece trovare ad accoglierlo: la sconfitta lo aveva reso ancora più dipendente da lei, sul piano non solo materiale (aveva bisogno delle ricchezze egiziane per riparare le perdite), ma soprattutto morale: la devozione che la regina gli dimostrava blandiva il suo smisurato orgoglio, consolandolo della grave umiliazione militare subita. Quando Ottaviano gli inviò i rinforzi (in verità, solo 2.000 legionarî), Ottavia partì con loro, per rivedere il marito e, se possibile, sottrarlo alle grinfie di Cleopatra; Antonio tuttavia non volle neppure incontrala e le mandò un messaggero ad Atene, per ordinarle di tornare in Italia. Antonio attribuì la responsabilità della sconfitta agli alleati armeni (che si sarebbero ritirati dalla battaglia in un momento critico) e per questo, nel 34 a.C., dopo aver rinforzato nuovamente l’esercito, invase l’Armenia, riducendola a provincia. Fra le legioni che parteciparono alle operazioni c’era la X Equestris. _________________________ A questo punto, accadde un fatto inaudito: Antonio celebrò il trionfo, la sacra e antichissima cerimonia che mirava a esaltare la grandezza militare di Roma, ringraziare gli dei per la loro benevolenza e rinsaldare la coesione tra i cittadini e le legioni dell’Urbe … e lo celebrò ad Alessandria d’Egitto. Antonio ringraziò il popolo e gli dei dell’Egitto, uno Stato straniero, per i successi ottenuti dai soldati di Roma: si può facilmente immaginare lo sgomento di quanti, a differenza sua, credevano ancora nella grandezza di Roma. In aggiunta, Antonio donò all’Egitto vasti territorî del dominio romano e proclamò Cleopatra “regina dei re”, Cesarione suo coreggente e gli altri suoi figli “re” dei territorî donati all’Egitto. Infine, inviò una lettera a Roma per ripudiare Ottavia e sposò la regina[4]. Anche Cleopatra ricevette da Antonio l’onore di comparire su una moneta della Repubblica, il denario RRC 543/1, di cui è particolarmente interessante la legenda del rovescio: CLEOPATRAE REGINAE REGVM FILIORVM REGVM. Non è chiaramente Latino classico, a dimostrazione che fu scritto da uno straniero poco pratico della lingua dell’Urbe; probabilmente voleva significare “a Cleopatra [che è] regina dei re [e quindi anche dei proprî] figli, [in quanto anche essi sono soltanto] re”. Fu un’altra grave offesa all’onore dei Romani: sino a 12 anni prima avevano aborrito la raffigurazione dei viventi sulle monete, ritenendo che fosse un privilegio tipico di un rex; ora invece non solo un governante straniero faceva mostra di sé su un denario, ma si trattava - appunto - di una regina e si proclamava come tale. Altri Romani, da Cinna a Cesare, avevano cercato di conseguire un potere monarchico, ma solo Antonio trattava la Repubblica come se fosse una sua proprietà, di cui stava regalando i pezzi a una regina straniera. Era troppo: un suo carissimo amico, che gli era affezionato ma sapeva di dover dare la sua fedeltà a Roma, decise di tradirlo. Si trattava di Lucio Munazio Planco; convintosi che Cleopatra avesse ormai irretito il triumviro, tornò a Roma, raggiunse Ottaviano e gli confidò che le Vestali, lì nell’Urbe, custodivano in segreto il testamento di Antonio, un testamento dal contenuto sconvolgente. Ottaviano capì al volo l’importanza dell’informazione, sottrasse il documento alle sacerdotesse e lo lesse in Senato. O, comunque, lesse qualcosa: alcuni storici credono infatti che abbia lui stesso ingigantito il contenuto del vero testamento, per suscitare sdegno. Sia come sia, i senatori appresero dalla voce di Ottaviano che Antonio voleva lasciare all’Egitto, alla sua morte, il dominio su tutto l’Oriente. Era inammissibile: fu subito dichiarata guerra a Cleopatra (uno stratagemma per nascondere il fatto che si trattava, in realtà, di un’ennesima guerra civile, contro Antonio). _________________________ I due eserciti si fronteggiarono sulla costa ionica della Grecia. Lo schieramento era titanico: 21 legioni e 400 navi per Ottaviano e Agrippa, 30 legioni (fra cui la X Equestris[5] e la VI Ferrata) e 500 navi per Antonio e Cleopatra. Le truppe di Antonio, in particolare, si acquartierarono a Patrae (odierna Patrasso) e là, tra il 32 a.C. e il 31, egli diede un ordine che ci ha consentito di avere una delle più particolari serie monetali repubblicane: dispose infatti che ogni legione coniasse le proprie monete. Nacque così la serie cosiddetta “legionaria”, RRC 544: aurei e denarî identici fra loro, salvo che per il numero della legione. L’iconografia esprime la potenza militare di Antonio: una galera al dritto, simbolo della flotta, e le insegne delle legioni (secondo la simbologia iniziata con RRC 365/1[6]) al rovescio. La legenda al dritto, ANT AVG III VIR RPC, declama le fonti del potere religioso (àugure) e politico (triumviro) di Antonio, nel chiaro tentativo di contrastare la propaganda di Ottaviano, che lo dipingeva come servo di un regno nemico; al rovescio, invece, è riportata la dicitura LEG seguita dal numero della legione[7]. La battaglia finale fu risolta nel 31 a.C. da uno scontro navale al largo del promontorio di Azio: Agrippa vinse, Antonio e Cleopatra fuggirono e le loro legioni si arresero. L’anno dopo, Ottaviano giunse ad Alessandria, ove Antonio e Cleopatra si suicidarono, mentre Cesarione fu giustiziato; l’Egitto venne ridotto a provincia (la prima amministrata dall’imperatore, anziché dal Senato) e la legio VI Ferrata fu lasciata a presidiarla. Tornato a Roma, Ottaviano rinunciò alla carica di triumviro ma fu nominato princeps senatus (“il primo a parlare in Senato”: un privilegio che sembrava solo onorifico ma, in realtà, consentiva di orientare la politica del consesso) e ricevette una serie di poteri speciali, fra cui la tribunicia potestas e l’imperium proconsolare. Infine nel 27 a.C., su proposta di Lucio Munazio Planco, gli fu conferito il cognomen di Augusto (che può essere liberamente tradotto come “colui che conferisce sacralità ed effettività alle azioni altrui”): la Repubblica era finita. Lucio Munazio Placo, afflitto da gravi malattie, si suicidò nel 1° d.C.; la sua tomba svetta ancora a Gaeta. NOTE [1] La desinenza del nominativo in -os è inusuale ma non sconosciuta. In particolare, una glanda plumbea (“ghianda di piombo”, proiettile per i frombolieri) rinvenuta a Perugia e risalente all’assedio del 41-40 a.C. riporta la legenda “L XI DIVOM IVLIVM”. [2] Peso che, in generale, oscilla tra 13 e 27 g, ma esistono alcuni falsi d’epoca di soli 10 g (e talvolta è difficile distinguere tra falsi e monete autentiche) nonché, all’estremo opposto, un esemplare, conservato al Castello Sforzesco di Milano, di ben 40 g. [3] Monetazione bronzea romana tardo-repubblicana, 1988. [4] Il matrimonio tra Antonio non è attestato con sicurezza dalle fonti, anche perché dal punto di vista romano era privo di efficacia giuridica; nondimeno, i due cominciarono a comportarsi da coreggenti e questo fa ritenere probabile che si fossero sposati. [5] La legio X Equestris di Cesare fu sciolta dopo la battaglia di Tapso (nel 46 a.C.) e ai suoi veterani furono assegnati terreni presso Narbo Martius; quando però, alla fine di quello stesso anno, Cesare transitò da Narbo diretto in Hispania, insoddisfatti della vita civile e bramosi di nuove ricchezze essi chiesero di essere reintegrati nell’esercito. Cesare ordinò allora ad Antonio di ricostituirla e la legio X combatté a Munda (nel 45). Nuovamente sciolta, fu ricostituita un’altra volta da Lepido dopo la morte del dittatore; combatté a Philippi (nel 42) agli ordini di Antonio (perché Lepido era rimasto a presidiare l’Italia). Probabilmente fu di nuovo sciolta, perché sappiamo di suoi veterani stanziati vicino a Cremona. Dopo di ciò, una legio X ricompare nel novero delle truppe che Antonio condusse in Armenia (nel 34) e ad Azio (nel 31): che sia la stessa di Cesare lo dimostra il fatto che, dopo la battaglia di Azio, sarà fusa con quella di Ottaviano, denominata legio X Gemina. Infatti, gemina significa “gemella” e quindi, in questo caso, “doppione”: ciò rende evidente che - per i contemporanei - la legione “originale” era quella di Antonio. Tra il momento in cui la legio X affrontò da sola gli Elvezi e sfidò per prima Ariovisto e quello in cui combatté ad Azio trascorsero 27 anni: alcuni veterani delle prime battaglie erano, probabilmente, ancora in servizio (l’età dei legionarî andava dai 17 ai 46 anni). [6] Scompaiono, però, le lettere H e P di hastati e principes, evidentemente ormai anacronistiche. [7] La prima legione è indicata come LEG PRI; si susseguono poi i numeri da II a XXIII. Esistono inoltre rarissime monete con i numeri da XXIV a XXX e unico esemplare con XXXII, ma sono di dubbia autenticità (soprattutto l’ultimo). Per tre legioni è riportata anche la denominazione (LEG XII ANTIQUAE, LEG XVII CLASSICAE e LEG XVIII LYBICAE). Infine, un aureo e un denario sono dedicati sia alle coorti pretorie (con legenda CHORTIVM PRAETORIARVM) sia alla coorte degli speculatores (“esploratori navali”, con legenda CHORTIS SPECVLATORVM); quelli degli speculatores presentano tre insegne navali (senza aquila). ILLUSTRAZIONI 43-36 a.C., bronzi RRC 535/1 e RRC 535/2 41 a.C., denario RRC 515/2 42-40 a.C., quinario RRC 489/6 e bronzo provinciale RPC I 3139, entrambi con le fattezze di Fulvia. 40 a.C., denario RRC 522/2. 40 a.C., denario RRC 524/2. 38 a.C., aureo RRC 533/3 36 a.C., dupondio RPC I 517 39-37 a.C., asse RRC 479/1 38 a.C., denario RRC 534/3. 34-32 a.C., denario RRC 543/1. 32-31 a.C., denari RRC 544/8 e 544/30 Gaeta, mausoleo di Lucio Munazio Planco. -
Storia di Roma e delle sue monete
L. Licinio Lucullo ha risposto a un topic di L. Licinio Lucullo inviato in Monete Romane Repubblicane
Come promesso, pubblico il file pdf in "formato libro", che credo renda più agevole il confronto fra testo e illustrazioni. Ho aggiunto un primo brevissimo capitolo, LA FONDAZIONE, e soprattutto, di maggior interesse, gli ultimi due , LA FINE DELLA REPUBBLICA e LA RIFORMA MONETARIA DI AUGUSTO. Storia di Roma e delle sue monete.pdf Vi prego di farmi conoscere impressioni, correzioni, suggerimenti. Mi piacerebbe sapere le opinioni differenti, su alcune interpretazioni forse un po' azzardate che ho proposto ... Spero almeno che la lettura non vi annoi - Oggi
-

500 lire
Den 1890765 ha risposto a un topic di Den 1890765 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Scusate ma cosa cambia se le posto (non riesco in nessun modo) o le metto così. Le vedete comunque Lo so che le foto sono leggermente sfuocate ma perché ho la fotocamera rovinata -
L'ho pensato anche io🫠
-
caravelle82 ha iniziato a seguire 500 lire
-

500 lire
caravelle82 ha risposto a un topic di Den 1890765 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
-

50 centesimi 2021
NoNmi4PPLICO ha risposto a un topic di Beppes86 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Le monete di Andorra sono coniate ad anni alterni o dalla zecca spagnola o da quella francese, bisogna andare a controllare all'interno di quelle zecche come annullano le monete e con che tipo di macchinario e stabilire se è un annullo ufficiale o è stato fatto un mese fa in qualche garage. Poi bisogna anche capire se può essere detenuto e venduto, nel caso fosse originale. -
50 centesimi 2021
Beppes86 ha risposto a un topic di Beppes86 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Grazie ragazzi siete stati gentilissimi -

Vaticano 2024
atg ha risposto a un topic di naga inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.
un saluto a tutti oggi ho ricevuto il primo ordine, francobolli, fatto a fine luglio spediti il 30 agosto ed arrivati tutto sommato senza problemi adesso aspetto un altro ordine di francobolli fatto ai primi di settembre ma soprattutto un giro di monete ordinato ai primi di agosto che ancora non risultano in lavorazione -

1 lira 1860 re eletto autenticita
Carlo. ha risposto a un topic di Paio70 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
buonasera @Paio70, dovrebbe essere 1 lira del 1° tipo (legenda "ELETTO" al D/ che termina circa allineata alla barba) per il 1860 zecca di Firenze. il segno di zecca "mano con scettro" tra Firenze e l'anno è associato alla variante R2 per il 1° tipo come conservazione, a mio avviso, siamo sotto al MB. su autenticità lascio agli esperti -
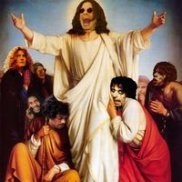
200 lire (prova) con impronta in incuso.
Massimiliano Tiburzi ha risposto a un topic di Pierluigi 1965 inviato in Tecniche, varianti ed errori di coniazione
Si era già parlato di questo caso tempo addietro, mi sembra di ricordare che alcune PROVA vennero coniate successivamente alla prima mandata per necessità di regali o cose del genere ed il conio di dritto era usurato con il famoso mezza luna sotto il collo. -

1 lira 1860 re eletto autenticita
gennydbmoney ha risposto a un topic di Paio70 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Sembra autentica ma la conservazione è veramente bassa.. -
1 lira 1860 re eletto autenticita
Paio70 ha aggiunto un nuovo link in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Volevo un vostro parere riguardo a questa moneta e in particolare su autenticita e grado di conservazione.grazie (peso 4.78,23.06 diam.) Altre foto -

20 settembre 2025, Catania, Mostra del collezionismo numismatico
dabbene ha risposto a un topic di dabbene inviato in Segnalazione mostre, convegni, incontri e altro
Negli ultimi convegni fu fatta anche una diretta Facebook per la parte culturale che poi rimase disponibile alla visione. Di certo questo Convegno dimostra ulteriormente la grande dinamicità e organizzazione della convegnistica numismatica del sud Italia in questi ultimi anni !
Lamoneta.it
Il network
Hai bisogno di aiuto?



