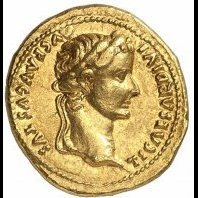Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 05/04/13 in Risposte
-
Lo staff sta cercando un modo non effimero per onorare la memoria di Sergio. Per il momento abbiamo pensato che fosse un atto sentito e doveroso nominare Agrippa Utente Oro: In effetti, ripensandoci a posteriori, credo che nessuno meritasse questo riconoscimento quanto lui, vista anche la traccia importante di affetto e considerazione che ha lasciato qui sul forum. Forse l'unico vero motivo per cui non è stato fatto prima è che questo riconoscimento è stato creato quando purtroppo la sua presenza su Lamoneta si era già molto rarefatta. Abbiamo in mente anche della altre iniziative più a lungo termine, di cui vi daremo ovviamente notizia non appena avremo in mano qualcosa di più concreto.4 punti
-
Piccolo excursus extranumismatico su una notizia che ho appena letto (decisamente non recente ma non mi sembra sia mai passata nel forum). In alcune monete della serie Judaea Capta appare una palma: Fonte Acsearch Che sia una palma da datteri penso sia abbastanza pacifico dai frutti. E in effetti la palma da datteri era una risorsa alimentare abbastanza importante del deserto della giudea dove formava un striscia larga una decina di chilometri attorno alle rive del giordano con piante alte anche oltre i 20 metri. Non è quindi inconsueto la scelta di raffigurarla su una moneta. Sebbene le palme da dattero siano tuttora diffusissime (anche in Italia meridionale per altro), questa specifica varietà (la palma della Giudea) era del tutto estinta. Infatti con i vari sconvolgimenti socio politici della zona della palma della giudea si perdono le tracce nei primi secoli dopo Cristo. Ho usato l'imperfetto in quanto è temporaneamente risorta grazie all'..... archeologia! Infatti in uno scavo presso Masada hanno recuperato un recipiente pieno di semi di palma essiccati di circa 2000 anni di età. Nel 2005 (dopo circa 40 anni dal ritrovamento) hanno provato a farne germogliare tre dopo un trattamento a basi di ormoni e fertilizzanti. Con uno di questi l'impresa è riuscita e il risultato è questo: Test genetici hanno in effetti dimostrato che è una variante sconosciuta e geneticamente differente dalle cultivar moderne.3 punti
-
Da ignorante: ho sempre visto la monetazione magno greca come una sorta di mini-quadri iper realistici. Ve lo dico sinceramente, né una stella marina, né un polipo né una pianta. La sola resa stilistica del muso del delfino non mi vuole far credere che al centro vi sia un essere vivente. Per me è una stella di quelle che son sempre esistite sulle monete...avvicinata ad un essere marino a causa dei delfini. Per assurdo la vedrei più papabile come "stella polare". Ripeto, non sono né zoologo né cultore delle magno greche...2 punti
-
Che bella moneta! Anche se tosata trasmette tutto il fascino dell'epoca. Purtroppo la ribattitura rende difficoltosa la lettura dello stemma, ma credo anch'io che si tratta dello stemma Orsini-Annibaldi come indicato da fra crasellame. Tra l'altro mi pare di vedere anche una rosetta al R/, sopra la palma, che la porterebbe ad essere classificata come Muntoni 43. Visto che dal catalogo non si vede bene, provo ad inserire l'immagine proveniente dal listino n°2 di Numismatica Picena proprio riferito al Muntoni n°43.2 punti
-
2 punti
-
io, come i miei compagni e amici Piemontesi veniamo a Verona per gli amici, per incontrarvi, scambiare pareri e passare una giornata in allegria. non possiamo rinunciare anche a questo.2 punti
-
vorrei dedicare questa discussione all amico Sergio (agrippa/rugser) che ci ha purtroppo lasciati prendo spunto da una discussione che avevamo fatto qualche tempo fa sul FAC sulla presenza di prigionieri della dacia o della persia (quelli con il cappello a punta per intenderci) nelle monete costantiniane i prigionieri con il cappello a punta erano spesso raffigurati nell oriens sotto aureliano ma nei soli invicto comiti del periodo costantiniano son presenti solo in un paio di emissioni , tra l altro se non erro solo nella zecca di Roma oggi ho pescato questo da una ciotola , che purtroppo ha un evidente schiacciatura di conio proprio sul prigioniero la mia e` la ric 6 roma 344 classificata R dal ric 6 e databile al 313 l altra serie di soli invicto comiti di costantino del 316 e` la ric 7 roma 52 c e` anche una serie di licinio per antiochia del 317-319 che raffigura iovi conservatori con un prigioniero al posto della solita aquila e un altra serie del mezzo follis , sempre di zecche orientali di licinio del 317-319 , quelli con il XII Mu in esergo. allego anche un altra moneta curiosa e` una virtus romanorum di costanzo II emessa dalla zecca di siscia nel 350 e anche questa raffigura un prigioniero con il cappello questa e` classificata come ric 8 siscia 295 segnalo anche che esistono fel temp reparatio con il guerriero a terra con il cappello a punta da quel che so io dopo le FTR la raffigurazione dei prigioneri cessano completamente1 punto
-
Nel frattempo, dal 63 al 64 deve essere andata di moda una nuova pettinatura...e lui, in qualità di imperatore, non si trattenne dal proporla al popolo...la porterà fino alla morte...aveva ora 26-27 anni. ...ed eccolo qua...alla soglia dei 30...è lui, il Nerone che tutti conosciamo, quello che rimarrà nell'immaginario collettivo...colui che consacrò la sua immagine in eterno...(65-66 d.C.) ed infine, in un momento che non doveva essere per niente tranquillo, mentre probabilmente sapeva che di li a poco sarebbe morto, il suo viso si incupì, divenne cattivo, la rabbia di aver fatto finire la dinastia Giulio Claudia...la rabbia di non poter essere morto di vecchiaia come ogni uomo vorrebbe per se (67-68 d.C.). Finisce così la vita di un Imperatore e proprio come negli epiloghi dei film, come nel Titanic, quando si vede la vita di Rose trascorrere fino alla vecchiaia, o come in Armageddon, quando Henri vede la vita di sua figlia prima di far esplodere l'asteroide, anche a noi è stato concesso di veder il passare del tempo dei brevi 14 anni dell'impero di Nerone. Per questo amo le fotografie...i ritratti nello specifico...e dedico questo piccolo excursus a chi si è visto togliere la vita prima del dovuto e a chi come il nostro caro Agrippa ha riempito la sua lunga, ma mai troppo, di bontà e generosità verso il prossimo. Spero vi sia piaciuto questo excursus, vi lascio con una visione completa del tutto. Mirko :) p.s. no, non mi sono dimenticato di Marco Aurelio e dei suoi due o tre ritratti e nemmeno di Caracalla...ma emozionanti come quelli di Nerone, credo che non ce ne siano altri...1 punto
-
ho fatto una piccola ricerca anche io, ma non ne ho trovati dell'anno 1736 per Rennes confermi che dovrebbe trattarsi di questo tipo ?? LOUIS XV "THE WELL-BELOVED" (01/09/1715-10/05/1774) Dixième d'écu dit "aux branches d'olivier" Titolatura diritto : LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX.. Descrittivo diritto : Buste de Louis XV à gauche, la tête nue, portant un veste brodée avec la croix de l'ordre du Saint-Esprit ; au-dessous (Mm). Traduzione diritto : (Louis XV, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre). Titolatura rovescio : SIT NOMEN DOMINI - 9 - [bEN]EDICTUM . Descrittivo rovescio : Écu de France ovale couronné, entre deux branches d'olivier ; au-dessous lettre d'atelier. Traduzione rovescio : (Béni soit le nom du Seigneur).1 punto
-
Si diceva di Livorno. Uno dei porti più importanti per il commercio per il Levante, così come tutta quell'area compresa tra Marsiglia e Livorno stessa. Non a caso fu proprio in quell'area geografica che numerosi mercanti-zecchieri sollecitarono l'apertura di numerose zecche presso vari "signori" che avevano diritto di zecca. Molti di questi mercanti di origine francese operavano proprio sulla piazza di Livorno (per deformazione dovuta a interessi personali ricordo Giovanni Margariti o Antonio Laget zecchieri a Massa di Lunigiana, entrambi mercanti francesi in Livorno). Probabilmente è lecito pensare che proprio su Livorno si concentrassero i traffici di Luigini (vi sono fonti, e non sono certo le uniche, che documentano come i "luigini" massesi fossero abitualmente trasportati (e saggiati) a Livorno e Viareggio, (il ruolo di Viareggio sarebbe da approfondire con esperti di localistica, si tratta forse del porto di Motrone?)), in particolare negli ultimi anni di spaccio dei luigini dopo che la Francia aveva dapprima regolamentato la produzione di luigini e poi l'aveva vietata, cosi' come fatto anche da Genova che nel 1666 con varie grida proibì anche lo smercio e il traffico via mare dei luigini (salve coniarne pochi esemplari "leali" nel 1668 e 1669). Analoghi provvedimenti furono presi anche dall'arciduca di Toscana, ma evidentemente ebbero un pò meno effetto se non sulla produzione granducale.1 punto
-
ma il ritratto sembra di Vero, ma la legenda non torna troppo lunga, quella di Severo, non mi pare anch'essa troppo corta; il finale CEBCE, è un indizio dell'egitto, anche se non l'ho trovata nel dattari e come legenda non esiste, a me intriga il AVR, che mi farebbe propendere per Marco aurelio se a sx ci fosse antoninoc ce. Se sei daccordo posso postarla sul FAC e vediamo che ne viene fuori, ormai è una questione d'onore, l'unico sarebbe Luigi ( Tacrolimus ), grandissimo esperto, ma purtroppo è molto che non lo vedo nel sito. Roberto1 punto
-
Ogni mattina un furbo e un fesso si svegliano.. Se s'incontrano l'affare è fatto :rofl: :rofl: Senza offesa per nessuno, è un detto che ho letto e mi è sembrato pertinente..1 punto
-
Credo non sia necessario chiarire che le leggi economiche impongono che in mercato libero vi sia una determinazione del prezzo dettata da chi acquista e chi vende. L'asta è l'unione ideale di questa legge. Ricordo che la stessa placchetta, credo in asta Nomisma, di qualche anno prima, abbia segnato un prezzo superiore a quello di INASTA.1 punto
-
ciao Giov, permettimi alcune considerazioni. Non credo che questa discussione sia stata un "dire e non dire". Al primo posto deve esserci l'informazione e il forum è strumento fantastico per questo. Premetto che non ho nessuno interesse nel segnalare le monete "sospette", ma vista la quantità di pezzi che circolano, mi sembra corretto porsi degli interrogativi e cercare di dare delle risposte, soprattutto per chi la materia non la mastica al 100% (e allo stesso tempo sono anche io qua per imparare e approfondire argomenti). Non deve esserci una paranoica paura, ma sai, quando in certe vendite spuntano esemplari chiaramente falsi/sospetti, credo sia obbligo per chi sta in una comunità come la nostra segnalarli. Poi chi vuole tiri le dovute conclusioni. Che Nac, possa avere ritirato la moneta, credo sia la dimostrazione e la serietà della casa d'aste, che tiene a tutelare i propri clienti. Spero vivamente che anche Romanumismatics e Lanz facciano lo stesso per gli altri esemplari posti in vendita e segnalati nelle altre discussioni. L'ho sempre sostenuto e lo sosterrò sempre, che chi ama collezionare la monetazione antica, deve essere preparato. un caro saluto skuby1 punto
-
quelli che possedeno un bolone sotto....di certo,son piu recenti.....per via che la pressionne aumentava con canalizazione moderne..... ....ma quelli altri,senza quel attrezzo di bulonatura....eranno piu anziani,e antici.......il bronzo fuzionato li an datto lettera di nobilezza......... :lol:1 punto
-
1 punto
-
Maroco 5 mazunas 1321 Algeria 5 centimes http://monetemondo.altervista.org/Global%20Coin/africa/algeria-/standard-5-centimes-/algeria-5-centimes-1974.jpg.html Maroco 20 santimat 1987 moneta chinese 1 pound Egitto 1479 1 Shilling 1948 Est Africa ù moneta Chinese le ultime due Egitto con queste foto fai topa confusione meti 2-3 alla volta1 punto
-
Moneta gradevole e sicuramente in conservazione superiore alla media. Purtroppo però devo concordare con @@profausto, non che non voglia concordare con lui :p, ma semplicemente perchè anche me pare che ci sia stato un maldestro uso del bulino (o altro strumento) con l'intento di evidenziare i rilievi stessi della moneta, magari associato anche ad un probabile tentativo di eliminare qualche incrostazione sulla superficie del tondello. Se non si è maniaci delle alte conservazioni (e per questa monetazione sarebbe impossibile) la moneta è collezionabile senza problemi, ma sinceramente, se l'occhio non mi ha ingannato, avrei preferito una moneta senza interventi.1 punto
-
Guarda che sono belle e interessanti anche così :) è un bell'oggetto. A Trieste "pila" è sinonimo di soldi, "gaver pila" = essere ricchi1 punto
-
@@vwgolf pure io stò invecchiando, ma il Metal lo sò ancora usare, ti vengo a trovare molto volentieri. :ph34r: :rofl:1 punto
-
Sono attratto da questa tipologia di monetazione. anche se non la colleziono, ma..mi permetto di dare una mia valutazione Mi sembra di notare che la moneta è stata "aiutata" da una bulinatura che in alcuni punti non ha perfettamente seguito i profili dell'immagine originale. (specialmente nel busto inferiore) tutto sommato pero' è piacevole oltre che essere rara e a mio parere è da considerarsi MB+1 punto
-
Ecco un altro magnifico esemplare, venduto per 368 euro (19 offerte) il 17 febbraio 2013 dal famoso pataccaro ebay "aitnacoins". Qui la definizione della foto è talmente buona da poter apprezzare il piercing sul naso della ninfa. Forse sarà stato questo dettaglio a spingere il venditore a definire la moneta come una variante di quelle catalogate dal Calciati? Osservando l'esemplare Lanz, manca un globetto sul rovescio. Forse è stato ritoccato per rendere la moneta meglio vendibile? Infatti i bronzetti catalogati come hexas dal Calciati I, 295, 12, pesano in media 8-9 grammi, mentre l'esemplare Lanz pesa solo 4,76g. In effetti Calciati descrive una onkia del peso di 4,3g (I, 296, 14) con al rovescio un solo globetto sotto la pancia del cane, ma la testa di ninfa al dritto dovrebbe essere differente, con i capelli in korymbos, e non raccolti dal nastro (taenia). In definitiva questa patacca, più che una replica moderna, è una moneta di fantasia. Una ultima notazione. Sono molto colpito dallo spirito di inventiva di alcune case d'asta. Guardando il dritto, nel campo a destra, dietro il collo della ninfa, il falsario che ha creato i conii, deve aver frainteso il tipo originale, scambiando la ciocca di capelli che sfugge dalla taenia sulla nuca della ninfa (descritta da Calciati), con quello strano ghirigori un po' barocco. I venditori, molto prontamente, hanno interpretato la cosa come "simbolo" (aitnacoins), o addirittura come "ornamentierter Zweig", ramoscello ornamentale (Lanz). O.T. Non riesco più ad accedere al forum col mio solito account TARAS (tutto maiuscole). Il sistema non riconosce più la mia password, e non riesco a cambiarla. Ho provato a collegarmi direttamente col mio account gmail ed è spuntato automaticamente questo nuovo profilo Taras (solo iniziale maiuscola), che risulta creato lo stesso giorno dell'altro account, ma ha zero messaggi postati e niente avatar... ??? Se qualche admin del forum fosse così gentile da mandare sulla email collegata a questo account (gmail) le credenziali per accedere al mio vecchio account TARAS, gli sarei molto grato. Altrimenti continuerò a usare questo nuovo account.1 punto
-
18/02/10, INASTA 33, lotto 4738 prezzo base 80 euro realizzo 104 euro (compresi diritti d'asta) Ciao M.1 punto
-
Carissimi, vi allego - im due steps - una parte della scheda descrittiva della medaglia, dalla quale potete ricavare notizie sull'autore Giancarlo Defendi. Questa è la 49a delle 111 medaglie da noi emesse a oggi. Cordialità. Gianpietro Basetti- Presidente C.N.B.1 punto
-
1 punto
-
Ciao Frisax : un interesse storico la tua placca ce l'ha sicuramente e, pertanto, anche un controvalore economico. Quale non saprei, né mi va di azzardare valutazioni a caso : se ti capita di visitare una Mostra/Mercato te ne potrai fare una idea più precisa mostrandola agli espositori. Non è una medaglia, ma ad un collezionista di cimeli dell'epoca potrebbe senz'altro interessare : oggetti analoghi li ho visti varie volte in vendita.1 punto
-
1 punto
-
@@gennydbmoney Troppa grazia !! :D A parte gli scherzi, ti ringraziamo per il materiale che hai postato. Io sarò assente per qualche giorno e potrò fare qualche considerazione solamente in seguito. Tengo a precisare, comunque, che personalmente non conosco così a fondo l'argomento e che "in giro" ci sono esperti ben più preparati di quanto lo sia io. Questo per la precisione. Ti anticipo che nelle immagini sono presenti due esemplari molto interessanti e che in base alle loro caratteristiche secondarie sono riconducibili ad un lasso di tempo molto breve, senza ombra di dubbio alcuno. Come ti ha anticipato l'ottimo @@fedafa ci sono anche esemplari francesi. Spero nell'intervento di qualche amico utente e nel frattempo vi saluto A presto1 punto
-
Complimenti @@gennydbmoney per la serie dei provisini. In attesa del co-curatore (dovrai pazientare un paio di giorni), posso anticiparti che non sono tutti romani, ma tra essi c'è qualcuno di conio francese, ma attendiamo @@adolfos per conferme o smentite in merito. Sicuramente monete interessanti ed affascinanti, troppo spesso poco considerate.1 punto
-
rileggendo la discussione sui grossi ad integrazione rubo a magdi la segnalazione della letteratura su Chiusi ques Grosso Agontano (Repubblica) 1337 g 1.14/1.34 R, Junior Day William L'agontano di Chiusi L'AGONTANO, una moneta d'argento per l'Italia Medievale (atti del convegno del11-12 Ottobre 2001) Centro Stampa regione Umbria Perugia 2003 Betti - Montagano - Sozzi - Villoresi Grossi da 6 e da 20 Denari di Arezzo, Firenze, Massa Marittima, Siena e Volterra in un documento orvietano del 1318 RIN CV SNI Como 20041 punto
-
ciao a tutti,questo 3 cavalli di Ferdinando IV° presenta al dritto la ribattitura della parola REX...1 punto
-
Ciao a tutti,come avevo promesso posto le immagini dei miei denarini sperando di fare cosa gradita,in più posso imparare qualcosa su queste affascinanti monetine,ecco la prima,peso 0,5 grammi e diametro 16,23 millimetri:1 punto
-
@ Rex Siciliae: a me non sembra uno Spahr 62 (Travaini 193), ma proprio un Travaini 248, per intenderci, il tipo con la "Vergine orante" e scritta cufica a forma di croce, come indicato nella didascalia della foto. La Travaini attribuisce questo follaro a Messina, mentre Ruotolo lo assegna a Bari, insieme al tipo con San Nicola ed ai tre tipi con San Demetrio. Basandomi sul numero di apparizioni nelle aste degli ultimi anni direi che il follaro "Vergine orante" è più comune del tipo con busto di Cristo e data in cifre, sebbene sembra che la letteratura dia il primo come Molto Raro e il secondo al massimo come Non Comune. Sono comunque monete difficili da trovare in alta conservazione, e secondo me hanno il loro fascino anche se consunte. Un saluto! Paolo1 punto
-
Ciao...non sono un'appassionato di questa monetazione, però cercando informazioni per darti un'aiuto ho trovato uno studio su questa moneta..........spero possa interessarti. http://www.ilportaledelsud.org/bcnn1932d.pdf Un saluto Pietro1 punto
-
comunque, leggendo le varie risposte, devo dire che, gli utenti del forum, hanno davvero una pazienza biblica con chi gli fa domande cretine.........1 punto
-
Tutti i miei preziosi comprese le monete romane, li ho ingoiati avvolti in ovuli di cellophane.........devo ammettere che ho trovato difficolta` con il rolex......................1 punto
-
BB+ - qSPL :rofl: :bash: :bash: :bash: Ma dai...... forse siete troppo giovani, ma monete così uscivano dai rotolini, certo è che dalla zecca non uscivano FDC, ma dire BB+ il D/ di questa moneta........ riporto solo per dovere di cronaca la definizione di BB riportata dal Gigante: La circolazione ha attenuato i rilievi maggiori ma la moneta, salvo per qualche particolare minore, è perfettamente leggibile, ed intera. Può avere colpi sul bordo non deturpanti" saluti TIBERIVS1 punto
-
@@fra crasellame Grande, fra. Sembra proprio quello !!!!! Quella N al centro potrebbe essere identificata con Cola (Nicola) di Rienzo. Sono in corso studi a riguardo. SALUTONI1 punto
-
Sarò ubriaco di Ypocras... ma mi sembra di vedere nell'armetta in basso a sinistra una rosetta ed il tutto mi sembra assomigliare al grosso dei senatori Orsini-N-Annibaldi. A giudicare dalla foto del catalogo la tosatura mi sembra "affare corrente". Queste monete mi piacciono da matti... prima o poi... Fonte Cataloghi Online http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-SENRMH/11 punto
-
Lo Spahr inizia cosi':::: BARI e CAPUA emisero una moneta di rame sotto Ruggero Re. Non ti sarai confuso nel titolo d'intestazione di zecca!!!????? :mellow: :mellow: Resetta tutto......! :) Dalle foto in basso a sinistra e'citata Messina.....! ;) ............ecc.ecc.......Travaini 248........RR.....(e cosi'descritto) :) :) Da fonte Spahr"le monete Siciliane dai Bizantini a CArlo d'Angio' " :(invece!!!!) :D Ruggero II gia' (sottolineato)Re di Sicilia nel 1130 fino al 1154....... 3.Emissioni col titolo reale,anteriori al 1140...al numero 62 a pagina 152 tav.XIX cosi descritta': FRAZIONE DI FOLLARO(battuta a Messina nel 1138) D:/ Quattro righe di leggenda cufica entro un cerchio perlinato: Per ordine/di Re Ruggero il magnifico / forte dell'aiuto di Dio / 533 (in cifre arabe) R:/Busto del Redentore entro le sigle IC - XC (ambi due con stanghette sopra " -" ) Spinelli V/28;lagumina 31;Sambon"Normanni",20;Rep.887. Moneta comune Ae d.13/15 mm -----gr.0,80-1,42 Ed infine: "Di tutta la monetazione araba e' l'unica moneta che porta la data in cifre arabe"(sottolineato tre volte) :D ;) Spero di aver fatto cosa gradita e di non aver dimenticato nulla :D !!!!! :D Qualunque commento e'gradito!! ;) .......ci sono persone che conoscono queste monete.......... Dopo qualche altra conferma...un curatore si occupera'del titolo di emissione sbagliato! :D Ringrazio! Saluti1 punto
-
Ciao è una Pubblica da 3 Tornesi di Carlo di Borbone per il Regno di Napoli.. L'anno della tua dovrebbe essere o 1756 o 1757, riesci a capirlo tu con la moneta in mano? Se dovesse essere del '56 è rara mentre se si trattasse di un '57 sarebbe un R3 purtroppo però la conservazione è molto bassa.. Ti posto il link del catalogo on-line a questa moneta http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-CB/5 Spero di esserti stato utile :) Gaetano1 punto
-
Il segno di valore XVI compare qui per la prima volta. Plinio (XXXIII, 45) mette in relazione la ritariffazione a 16 assi alla riduzione onciale, specificando che non si applicò ai soldati (nel senso, probabilmente, che lo stipendium rimase invariato) e la data alla dittatura di Q. Fabio Massimo. La datazione è ritenuta erronea e viene attribuita (grazie a un frammento mutilo di Festo) al fatto che fu disposta con una Lex Flaminia minus solvendi, che Plinio potrebbe aver ricondotto al console caduto sul Trasimeno. I numismatici concordano sul ritenere che la ritariffazione sia avvenuta nel II secolo: Grueber tra il 150 e il 140, Campana nel 147 (quando Roma combatteva contemporaneamente su tre fronti, in Africa contro Cartagine, in Hispania contro i Celtiberi e i Lusitani e in Macedonia contro Andrisco), Thomsen nel 145, Crawford nel 141, Buttrey nel intorno al 130. La ritariffazione non portò immediatamente alla scomparsa del segno di valore X; la sigla XVI apparve in sole cinque emissioni (RRC 224, 225, 226, 227 e 228) e, quindi, ebbe probabilmente scarso successo. In seguito fu riproposto il segno X, in alternanza con * e solo alla fine del II secolo il segno di valore tese a sparire, fino alla sua totale scomparsa nei primi anni del I secolo.1 punto
-
Gentile mfalier, ti posto anche un immagine dimensioni: 8,17 mm. peso: 0,17. Preferirei che la moneta fosse visionata dal vivo. :) Grazie.1 punto
-
SIcuramente è stata una scelta difficile, perche da collezionista e appassionato posso dire di essere legato a tutte le monete che possiedo, anche quelle che non hanno valore commerciale o doppioni e quindi posso capire che cedere certe monete sia davvero difficile. Non parliamo poi del fatto che tali monete anno anche un valore storico legato alla mia terra e quindi sicuramente io avrei avuto molta difficoltà a separarmi da tali monete, ma comunque la moneta che hai ricevuto in cambio è davvero uno splendido esemplare che rappresenta di per se la splendida storia della Sardegna, non conoscita da molti ma sicuramente affascinante.1 punto
-
succede... anche con gli umani... vabbe, se ti viene la malinconia puoi sempre consolarti quardando le foto. hai fatto le foto vero, prima di cederle?1 punto
-
Tradizionalmente quando si è parlato di mezzi denari, come nel caso di Ancona, Ravenna ma anche Mantova e Pisa ci si è sempre riferiti a monete con coni predisposti per tondelli di diametro inferiore (quindi con punzoni più piccoli, oppure in numero minore, oppure semplicemente più ravvicinati). Cioè a pezzi chiaramente e volutamente distinguibili da quelli di modulo maggiore. Non è che Papadopoli, Castellani, Murari, tanto per citare alcuni che hanno ipotizzato l’esistenza di mezzi denari, erano dei fessacchiotti che si innamoravano di idee strampalate :silly: . Non credo quindi che l'esempio di monete realizzate con tondelli più piccoli rispetto al conio abbia molto a che fare con questi esemplari, che infatti rappresentavano un diverso valore nominale (fosse esso un mezzo denaro oppure, come io ritengo nel caso di Ancona-Ravenna, un denaro ufficialmente svalutato). Nel caso di tondelli più piccoli rispetto al conio può invece trattarsi semplicemente di un fatto tecnico (produzione molto affrettata con tondelli tratti da lamine di diverso spessore, quindi necessariamente di diverso diametro), oppure anche un fatto economico, ma non tale da portare ad una svalutazione formale della valuta interessata. Mi spiego meglio: è assai probabile, anzi per me è certo, che per periodi più o meno lunghi molte zecche abbiano progressivamente diminuito il peso e/o la lega della loro moneta di mistura secondo l’andamento del mercato dei metalli, senza però svalutare ufficialmente l'unità di conto (in questo caso è proprio sbagliato parlare di svalutazione (devaluation in Inglese), perché la svalutazione è sempre una diminuzione del valore nominale di una moneta, da cui dipende il suo potere d’acquisto, non del suo intrinseco; in questo caso la parola corretta è svilimento = debasement) . In pratica tutti quei denari, ancorché di peso e lega calanti, avevano lo stesso valore nominale (probabilmente perché la fiduciarietà della moneta di mistura era abbastanza elevata da consentire un certo lasco). Questo può facilmente spiegare l’uso degli stessi coni anche con tondelli di modulo e peso diversi. Quando però il mercato non era più in grado di tollerare tale svilimento, ovviamente si doveva procedere ad una ‘svalutazione (cioè a fissare un certo cambio fra le monete nuove e quelle vecchie), e naturalmente in questo caso i pezzi dovevano esser chiaramente distinguibili a vista, altrimenti tutti avrebbero cercato di spendere le nuove monete al valore delle vecchie, grazie anche alle notevoli variazioni di peso individuali di questi esemplari. Ergo se non sono mezzi denari questo pezzi di modulo ridotto sono denari ‘nuovi’ o comunque li abbiano chiamati, di sicuro non sono pezzi semplicemente sotto peso. Per concludere trovo poco credibile, se ho capito bene alcune osservazioni non ricordo di chi, che monete di diverso valore nominale potessero essere battute con tondelli dello stesso diametro, essendo comunque distinguibili dal peso: pensare che soltanto il peso, e non fattori molto più evidenti come il modulo o, che so, la scodellatura, potesse essere il metodo con cui nelle normali transazioni si distinguevano nominali di mistura tipologicamente identici ma di valore diverso (magari con variazioni da 0,25 a 0,5 g) significa evidentemente non aver mai dovuto usare vecchie bilance da farmacista per pesare qualche decina di monete di quel genere. Più o meno per completare un pagamento di cinque lire, non particolarmente elevato, ci sarebbero voluti un paio di giorni interi. A meno che per andare a comprare anche un cesto di mele ci si dovesse fornire di un 'trabucco' tarato proprio sui nominali che si intendevano usare. Trovereste normale, ad esempio, che oggi il pezzo da 2 euro e quello da 1 euro avessero lo stesso diametro e le stesse raffigurazioni, senza che sopra vi fosse neanche scritto il valore, solo perché facilmente distinguibli dal peso ? Buona notte, Andreas1 punto
-
1 punto
-
Be'..., un ottimo sondaggio per capire quali sono i posti più probabili dove la gente tiene la roba... Nel caso si decidesse di cambiare mestiere! :rofl:1 punto
-
10) Spink 28-03-12, Magnus collection n.78 D3 - R3 (in questo esemplare oltre ad avere un diverso conio di D/, sembrerebbe che siano intervenuti nuovamente sul conio di R/, mantenendo lo stile generale, con i soliti musi dei delfini decisamente poco naturali, ma andando ad allungare le pinne dorsali e le pinne codali). Concludendo, appare chiaro che il problema relativo alle falsificazioni riguarda anche monete da poche centinaia di euro, serve molta attenzione!!! ciao skuby1 punto
-
Ipotesi di destinazione Secondo Plinio (N. H., 33, 46) il vittoriato sarebbe stato introdotto come mercis loco, ossia argento a peso, nell'Illirico. La teoria estrapolata dagli scritti di Plinio attualmente tende ad essere screditata; si ritiene infatti che l'associazione con i territori dell'Illirico sia scaturita da un'analogia ponderale con i nominali circolanti in quelle aree, come accade colla comparazione alle dracme padane. Plinio però scrisse la sua opera due secoli dopo l'entrata in circolazione del vittoriato e la sua associazione non appare molto credibile o comunque non verificabile. Patrick Marchetti, studioso belga, ritiene che il vittoriato sia un nominale destinato ad un differente canale di emissione. I Romani lo avrebbero utilizzato, almeno nel corso della guerra annibalica, per pagare gli auxilia. Le truppe straniere infatti ricevevano una paga inferiore rispetto a quella dei legionari e sempre secondo lo studioso belga ad un ausiliario spettava la paga di un vittoriato per 4 giorni di servizio, mentre ad un legionario un denario per il medesimo periodo. Il vittoriato rappresenterebbe dunque "una frode" perpetrata dallo Stato nei confronti degli ausiliari, ma si trattava di una truffa poco evidente in quanto apparentemente questi soldati percepivano lo stesso numero di monete di un legionario. Questa particolare ipotesi risulta incerta principalmente perché si ritiene che gli auxilia, in quel periodo, percepissero la paga direttamente dai governi di origine ma, al tempo stesso, fornisce una verosimile spiegazione sul perché questo nominale fu coniato. Sempre a sostegno di questa ipotesi vi è la corrispondenza tra le aree di circolazione del vittoriato e quelle costituenti il teatro bellico frequentato da queste truppe ed i territori di reclutamento. Un peso e una riduzione ponderale analoghi a quelli del vittoriato si rinvenirebbero nelle dracme dell'Illiria: inizialmente pari a 3 scrupoli sia ad Apollonia che a Dyrrachio, si sarebbero inoltre svalutate, nella prima città, a 2,92 grammi. Su questa base, Thomsen ha ipotizzato che il vittoriato fosse stato dapprima coniato nelle zecche del centro-sud Italia approssimativamente in contemporanea all'introduzione del denario, al fine di disporre di una moneta che, in vista della campagna illirica contro il regno macedone (alleato di Cartagine), rispondesse a una metrica ponderale compatibile con quella dei Paesi in cui si sarebbero svolte le operazioni belliche. Sulla base dei dati di circolazione, F. Barello (Archeologia della moneta. Produzione e utilizzo nell'antichità, Roma 2006, pp. 197-198) propende per l'ipotesi che il vittoriato fosse destinato a fare da aggancio con il sistema monetale dei Celti stanziati nella pianura padana, che utilizzavano, nella seconda metà del III secolo, una dracma al di sotto dei 3 grammi di peso. In questo senso è estremamente significativo il contenuto dell'arbitrato romano (117) tra gli abitanti di Genova (Genuates) e i Viturii Ligurenses (tribù ligure dell'interno), che impose a questi ultimi un tributo annuo di 400 nummi vittoriati, conservato sulla tavola bronzea detta "di Polcevera" (CIL I, 199)[1]. Considerato il basso contenuto d'argento del vittoriato, l'imposizione riportata sulla tavoletta di Polcevera potrebbe essere vista come un tentativo di risparmio di risorse: imponendo il pagamento in nummi vittoriati veniva utilizzata una moneta probabilmente più familiare ai diretti interessati ed al tempo stesso le risorse di argento dell'area di influsso romano venivano in certa misura preservate; quel nominale "povero" avrebbe poi circolato in quelle zone a tutto vantaggio del politicamente sempre più pesante denario di Roma. Per Coarelli (Argentum signatum, 2013) il vittoriato deve essere leggermente precedente al denario (come Thomsen ha dimostrato) e deve quindi incastrarsi fra la fine dell’emissione del quadrigato e la riforma denariale, quindi nell’anno dal 261 al 215. Riduzioni ponderali Mommsen, per primo, evidenziò l'esistenza di due differenti standard di peso per il vittoriato: 3 scrupoli (circa 3,41 g), il primo; 2 e 4/7 di scrupolo (circa 2,92 g), il secondo, con ogni evidenza più recente. Dalle fonti tradizionali sappiamo che nel 217, dopo l'inizio della Seconda Guerra Punica, la lex Flaminia ridusse il peso del denario da 4 a 3 e 3/7 scrupoli (portandolo a g 3,9); si ritiene che la prima riduzione del vittoriato, pari appunto a 1/7 di peso, sia contemporanea, per mantenere invariato il rapporto di 3/4 tra le due monete. Una successiva riduzione subì verso il 104 in seguito alla lex Clodia che ne fissava il peso a g 1,95 rendendolo quindi pari a mezzo denario e portandolo, di fatto, a ricostituire il quinario romano che aveva cessato di esistere colla riforma monetaria del 217. Vittoriati e dracme padane Mommsen (Histoire de la monnaie romaine, Tomo II, Parigi 1870, pag. 99) per primo ha supposto un'influenza ponderale del vittoriato sulla dracma padana. Osserva Pautasso (La monetazione preromana dell'Italia settentrionale, 1966) che la dracma padana, nata sotto l'influenza commerciale di Massalia, perde ben presto ogni relazione con la di originaria ispirazione; può quindi porsi il quesito se il diverso andamento ponderale della monetazione cisalpina possa essere stato determinato dall'influenza del vittoriato, coniato sul piede della dracma focese e destinato al commercio con le regioni adriatiche e ioniche, l'Italia meridionale, la Spagna, la Liguria e la stessa Massalia. I ripostigli forniscono indicazioni contrastanti. Sono pochi i casi di ritrovamenti congiunti di dracme padane e vittoriati e questo farebbe dubitare di un rapporto di coesistenza fra le due monetazioni e di una equivalenza ponderale, finalizzata a semplificare gli scambi. Tuttavia sono ancor più rari, forse inesistenti, i ritrovamenti delle dracme padane con quelle di Massalia, onde si può escludere che fosse Massilia il riferimento ponderale per i popoli padani. Su queste basi, alcuni studiosi escludono una connessione ponderale fra le due monetazioni: i ripostigli attesterebbero un afflusso graduale dele monete romane nelle regioni cisalpine, parallalelo alla crescente influenza commerciale di Roma, per cui la scarsità dei vittoriati (e, soprattutto, dei ritrovamenti congiunti con le dracme padane) dimostrerebbero una loro scarsa penetrazione, imputabile ala fatto che sarebbero arrivati solamente con la fondazione delle colonie, quando ormai erano una moneta in declino. Inoltre, le dracme padane non presenterebbero alcuna riduzione ponderale parallela a quella subita dal vittoriato con la lex Clodia (g 1,95), in un’epoca in cui ormai erano più intensi gli scambi col mondo romano, e ciò attesterbbe una totale mancanza di collegamento ponderale. G. Gorini, invece, ritiene che le monete celtiche del Nord Italia si siano sempre progressivamente adattate al peso del vittoriato e alle sue riduzioni (da 3,41 a 2,92 g e infine a 1,95 g). Infatti, dacendo riferimento alla classificazione del Pautasso, si osserva che i tipi da 1 a 3 (localizzati in area ligure-pedemontana) hanno peso medio di poco superiore a 3 g e possono quindi essere associati ai primi vittoriati (fine III secolo a.C.); presentano inoltre un’escursione ponderale da 3,5 a 2,7 g che potrebbe essere letta in chiave diacronica e giustificarsi con un progressivo adattamento alla prima riduzione ponderale dei vittoriati. I tipi successivi attestano una progressiva diminuzione di peso, anche in questo caso interpretabile come adattamento alla seconda riduzione ponderale del vittoriato: 2,8-2,7 g per il n. 4 (nord-est della Liguria); 2,6 g per il n. 5 (associato ai Salluvi, localizzati nel Ticinese oppure nel sud della Francia); 2,3 g per il n. 6 (Cenomani, tra Brescia e Verona) e il n. 7 (Insubri); 2,25-2,2 g per i n. 9 e 10 (con alfabeto leponzio o nord etrusco). Per il tipo n. 12 (con alfabeto leponzio) è stato ipotizzato uno standard ponderale di 2 g ma, in realtà, queste monete hanno quasi sempre peso inferiore e potrebbero quindi essere allineate ai vittoriati di 1,95 g, di cui peraltro condividono la datazione alla fine del II secolo a.C. Infine, i tipi da 13 a 30 sono quelli presenti nel tesoretto di Serra Riccò, spesso intepretati come mezze dracme od oboli; presentano tuttavia peso da 1,75 a 0,6 g e potrebbero quindi attestare un adattamento agli ultimi vittoriati e ai quinari del I secolo a.C. Zecche militari I vittoriati con simboli e lettere sembrerebbero emessi nell’Italia meridionale: alcuni simboli sembrano infatti adeguarsi a simboli già utilizzati su monete greche (ad esempio, il pentagrammacompare su bronzi di Teanum e su monete puniche del Bruttium) e se ne registra una maggior presenza nei ripostigli[2], rispetto ai vittoriati senza simboli. Il fenomeno potrebbe spiegarsi con la presenza di zecche ausiliarie, forse anche itineranti con l’esercito, operanti in loco per evitare il pericolo di spostamenti di denaro in un territorio altamente insicuro: infatti i vittoriati con simboli, mediamente più leggeri dei vittoriati senza simboli e quindi attribuibili ad anni successivi al 217, sarebbero stati emessi in concomitanza con l’occupazione cartaginese. Anche l’iconografia ne confermerebbe la natura di monetazione militare di guerra, assolvendo a una funzione di messaggio ideologico grazie all’associazione tra la protezione del dio supremo e la vittoria militare. Per altro verso, si registrano rinvenimenti di vittoriati con simboli in Hispania, lungo la direttrice della campagna di conquista finalizzata a tagliare i rifornimenti ad Annibale (in questa regione sarebbe stato emesso il vittoriato con legenda Roma in incuso, considerato tuittavia il più antico e quindi anteriore alla campagna degli Scipioni, e l’unico doppio vittoriato conosciuto). Campana propone di attribuire a zecca ispanica le coniazioni con pentagramma e con bastone (Cr. 105/1 e 106/1). [1] Lastra bronzea su cui è incisa un'iscrizione in lingua latina, che riporta una sentenza emessa dal Senato romano nel 117 in merito ad una vertenza di confini tra i Genuates e i Veiturii-Langenses, due tribù liguri. Fu rinvenuta nel 1506 nel greto del torrente Pernecco a Pedemonte di Serra Riccò da un contadino del luogo, Agostino Pedemonte, mentre era intento a dissodare un pezzo di terreno. La tavola arrivò quindi nelle mani del governo della Repubblica di Genova che ne permise lo studio e la traduzione. Attualmente è custodita nel Museo di archeologia ligure presso la villa Pallavicini di Genova Pegli. La vertenza tra i Genuates e i Veiturii-Langenses riguardava i confini tra alcuni terreni pubblici e terreni privati ed aveva raggiunto momenti di elevata tensione. Essendo il territorio oggetto del dissidio particolarmente delicato perché attraversato dalla via Postumia, i consoli e il Senato, decisero di intervenire direttamente inviando in loco i due magistrati citati nel testo, Quinto e Marco Minucio Rufo, i quali, dopo un'adeguata ispezione del territorio tornarono a Roma ed emisero la sentenza che fu resa esecutiva dal Senato il 13 dicembre dell'anno 637 di Roma (117). Detta sentenza venne incisa su alcune lastre di bronzo, di cui una sola venne ritrovata. [2] Sono però assenti dai ripostigli dell’Italia meridionale (compreso quello di Caltrano, ove sono presenti quasi tutti i tipi di vittoriati con simboli) il vittoriato con crescente (Cr. 57/1) e quello con pentagramma (Cr. 105/1, presente invece nei ripostigli di Pisa e di Fano).1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?




copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)





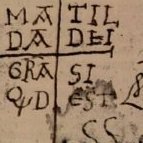














AdolfoViperetta.thumb.jpg.567df83d4aa18c98f435a6b9921cca31.jpg)