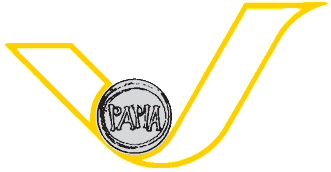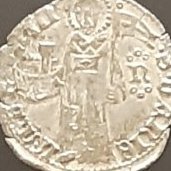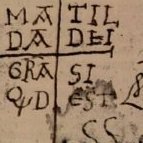Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 05/12/14 in Risposte
-
http://www.illuogodellalinguafestival.com/?q=content/la-citt%C3%A0-di-capua La città di Capua Capua è una città che accoglie il cittadino e il visitatore con le cupole delle sue chiese, con la cerchia dei suoi bastioni, con il suo grande fossato verde e l’ampia ansa del fiume Volturno, con i suoi giardini, i suoi monumenti, le sue fontane. È la città fortezza ideale di Federico II e di Carlo V, difesa e “Porta del Sud” fino all’Unità d’Italia, luogo strategico per la salvaguardia del Regno di Napoli. Storicamente Capua, antica capitale della Campania, secondo Cicerone nel I secolo a.C. fu, tra le città italiche, seconda solo a Roma. Egli la definì, infatti, “altera Roma” (“seconda Roma”), e come Roma aveva un proprio Senato da cui l’acronimo S.P.Q.C. (Senatus Populusque Capuanum) ancora impresso sulla facciata del palazzo municipale, antica sede della Corte di Giustizia. Tito Livio descrive la Capua del IV secolo a.C. come la più grande e ricca città d’Italia, estesa su 200 ettari di terreno. La città di Capua, da sempre caratterizzata da un carattere ribelle e combattivo, è famosa nel mondo per i suoi Ozi, storicamente noti per essere stati la causa principale della sconfitta del condottiero cartaginese Annibale, che nell’antica Capua, ambiziosa ed emula della capitale, trovò rifugio nel 211 a.C. Dopo due stagioni vissute nella lussureggiante città campana, Annibale e il suo esercito persero le loro energie belliche, travolti ed immersi nei piaceri e nel benessere. Ma l’animo combattivo del popolo capuano non fu sopito, tanto che circa 150 anni dopo, Spartaco, schiavo forte e carismatico, seppe riunire intorno a sé un numeroso esercito di gladiatori disertori e schiavi, quasi 120.000 combattenti, che diedero vita alla rivolta più pericolosa che Roma dovette affrontare. Il suo intento era quello di risalire la penisola con il suo esercito e di oltrepassare le Alpi, in modo da rendere la libertà a tutti gli schiavi dell’impero. Nell’841 i Saraceni distrussero la città di Capua e i sopravvissuti si rifugiarono in quello che era il suo porto fluviale, Casilinum, l’attuale Capua, dove ricostruirono la città; nell’856, infatti, in seguito alla distruzione di Sicopoli, grazie al conte longobardo Landone I fondarono “Capua Nova” a ricordo della vecchia. Nel X secolo Capua divenne contea e principato longobardo, ed è in quegli anni, precisamente nel 960, che si ha proprio a Capua la prima testimonianza scritta in volgare, il famoso “Placito Capuano”, considerato come il documento che ha sancito la nascita della lingua italiana. Nel 1062, poi, Capua divenne principato normanno e ancora città fortezza sveva, angioina, aragonese e dei viceré spagnoli. Ma soprattutto fu la città turrita di Federico II, che in essa volle rivivere le glorie dell’antica Capua, e che al suo fianco chiamò come cancelliere il capuano Pier della Vigna, di cui apprezzava l’eloquio dotto e la capacità di scrivere coniugando le situazioni più complicate con le conoscenze giuridiche. In breve tempo Pier delle Vigne si affermò in tutti gli ambienti diventando insigne poeta, diplomatico, ministro di Corte; utilizzato nelle missioni diplomatiche più delicate, raggiunse la carica di Logoteta del Regno di Sicilia. La città di Capua nel tempo continuò la sua ascesa divenendo fortezza dell’imperatore Carlo V e vicecapitale del Viceregno spagnolo. Fu, inoltre, città prediletta dai pontefici che, da Giovanni VIII a Onorio II, vi tennero ben nove Concili. È tristemente famoso il Sacco di Capua, perpetrato dai francesi dell’Aubigny e del duca Valentino, Cesare Borgia, ai danni della città il 24 luglio del 1501. Egli tramò il tradimento contro Capua: i francesi prima si fecerointrodurre in città promettendo la pace e poi iniziarono l’uccisione di cinquemila capuani. Il 13 febbraio 1503 in un campo neutrale tra Andria e Corato, si svolse lo scontro cavalleresco noto come Disfida di Barletta. In quell’anno il dominio del Regno di Napoli era retto dai francesi, ma gli spagnoli già avanzavano in terra di Puglia per occuparne il posto e, a tal fine, si erano asserragliati a Barletta. I francesi che, a seguito di uno scontro con gli spagnoli, furono fatti prigionieri, durante un banchetto offesero il valore dei cavalieri italiani. Si gettò così il guanto della sfida che avrebbe tolto la macchia che gravava sull’onore italiano; questo fu raccolto da un gruppo di 13 cavalieri venuti da diversi paesi d’Italia e guidati da Ettore Fieramosca, valente cavaliere capuano al servizio di Prospero e Fabrizio Colonna. Dopo aver solennemente giurato di combattere fino allo stremo, i 13 italiani affrontarono altrettanti cavalieri francesi guidati da La Motte. La tensione durò dall’alba alla notte quando tornarono vittoriosi a Barletta gli italiani. Questa straordinaria impresa eroica, consegnata alla storia dalle pagine del romanzo Ettore Fieramosca ossia la Disfida di Barletta di Massimo d’Azeglio nel’800, sottolinea ancora una volta il coraggio, la caparbietà del popolo capuano. Dal punto di vista architettonico e artistico, si possono ancora oggi ammirare tra le mura della città elementi di spoglio dell’epoca romana e monumenti straordinari che vanno dal Medioevo all’Ottocento: torri, castelli, caserme e fortificazioni, cattedrali, chiese e conventi, palazzi patrizi, porte monumentali, ponti, pozzi, 15 fontane e musei ricchi di opere d’arte (sarcofagi, ceramiche, dipinti, affreschi, monete, pergamene, sculture, statue lignee e bassorilievi); tra queste, le celebri Matres Matutae, oltre 150 statue in tufo grigio rinvenute in una favissa del VI secolo a.C., che rappresentano la più preziosa testimonianza dell’arte e della religione popolare campana. Capua ha inoltre dato i natali a illustri personaggi, oltre al poeta Pier della Vigna, notaio e consigliere di Federico II, e ad Ettore Fieramosca, l’eroe della Disfida di Barletta, anche Silvio Fiorillo da Capua commediografo, che fu il primo a portare ufficialmente in scena la figura di Pulcinella, nella sua commedia intitolata: La Lucilla costante, con le ridicole disfide e prodezze di Pulcinella, al pontefice Onorio I, ai musicisti Giuseppe Martucci e Andrea De Simone, e al medico Ferdinando Palasciano, precursore della Croce Rossa. È ancora il luogo ove fu stipulato il Trattato di Casalanza il 20 Maggio 1815, tra Austriaci e Napoletani, che pose fine al decennio napoleonico nel Regno che era stato di Ferdinando. Per mezzo di esso gli alleati Austriaci furono in grado di riconsegnare lo Stato ai Borbone, spodestando definitivamente Gioacchino Murat. @@Liutprand @ @@eliodoro5 punti
-
In vita mia ho visto dal vivo un solo esemplare da 4 tornesi 1799 in FDC rosso ed uno del 1800 in q.FDC, entrambi venduti davanti ai miei occhi a 5 milioni di LIT nel 1998, da allora ho visto solo MB e q.BB, non oltre.3 punti
-
Mi permetto di segnalare tre piccoli elementi, che forse possono aiutare ad inquadrare meglio il tema: Il primo è che grossus (raro nel latino classico, più comune nel medioevo) a giudicare dalla mia esperienza in genere non ha affatto il significato di 'grande' (o 'largo' in questo caso), ma proprio quello originale di grosso (cioè pesante, grosso, grasso, spesso, grossolano) ancor oggi assai diffuso anche se usato con meno precisione, come ormai tutto il lessico italiano (ma, ad esempio, di un tizio in carne non sì dirà mai che è grande, ma che è grosso, mentre di una persona alta, anche se magrissima, si può dire che è grande). Ergo, come è stato appena detto, non mi preoccuperei più di tanto di cercare prototipi 'più grandi' rispetto ad altri, perché grosso può riferirsi tranquillamente ad una moneta più pesante in termini monetari (cioè più ricca di metallo prezioso, anche se dello stesso modulo); - il secondo è che nell'intrepretare documenti d'archivio, soprattutto negli ultimi anni, a mio avviso si fa spesso un errore abbastanza importante: cioè si tende a pensare che le parole usate per registrare le monete siano state scelte dal notaio, quasi osservando una moneta reale e contemporanea di fronte a lui, in modo tale da renderla visivamente riconoscibile ai lettori del documento e, di conseguenza, anche ai posteri. Secondo me niente di più falso, si tratta proprio di un errore grossus, scusate il gioco di parole, anche se molto frequente. In realtà gli aggettivi che servono a qualificare una moneta hanno origini popolari che soltanto in un secondo momento entrano nelle registrazioni contabili (lo dimostra il fatto, ad esempio, che quasi sempre si tratta di nomi in volgare o in lingue straniere ri-tradotti in latino, così mancusus, tarenus, follarus, pegionus, blancus, sterlinus, quatrinus, ongarus etc). Il che vuol dire che non c'è motivo, in mancanza di una documentazione statistica significativa, che la registrazione debba indicare monete contemporanee al documento. Può essere benissimo che il termine grossus, ad esempio, sia stata usato in precedenza per indicare un tipo particolare di monete pavesi con un certo valore, ovviamente precedenti al 1095, e che in seguito sia stato ribadito, anche parecchi decenni dopo, ogni volta che occorreva richiamare quel valore. Il confronto più moderno che mi può venire in mente è quello con formule tipo 'dollari del 1956', 'lire del 1990' etc. che ovviamente saranno assai difficili da comprendere per quanti, in futuro, non potranno consultare gli annali ufficiali delle banche centrali sulla svalutazione. - il terzo punto è generale, ed ovviamente non riguarda i post nel nostro sito e questa particolare discussione, ma è un problema abbastanza serio che mi permetto di richiamare qui perché si sta trattando di un work in progress: occupandomi nei mesi scorsi assieme a Lorenzo Passera del Survey of Numismatic Research per l'Italia medievale (anni 2008-2013) ho notato che proprio negli ultimi tre / quatttro anni si va perdendo, da parte di molti autori, l'abitudine tradizionale di far partire la propria analisi dalle conclusioni dell'intervento dell'autore che l'ha immediatamente preceduta, pur avendolo letto e pur essendo tale intervento niente affatto negligeable. Credo che questo dipenda dalla facilità di con cui oggi la bibliografia è raggiungibile, grazie ad Internet ed a volumi come Le zecche di Lucia Travaini o la Bibliografia del MIrra, il che può indurre gli autori a pensare che essa sia ormai unviersalmente nota. Purtroppo non è così e queste dimenticanze vanno poi a scapito del possibile apprezzamento del saggio più recente. Per colpa di questa nuova abitudine, ad esempio, alcuni autori con numerosi libri e decine di articoli per nostra scelta sono quasi scomparsi dal Survey, perché i loro contributi sono apparsi di fatto impossibili da inserire nello sviluppo della bibliografia precedente. Scusate il pistolotto, Andreas3 punti
-
Segnalo lo studio di Alessandro Giaccardi intitolato: Il sistema monetario di Ferdinando IV di Borbone Liberamente disponibile su: https://independent.academia.edu/AlessandroGiaccardi2 punti
-
Condivido le indicazioni di @@claudioc47 Neanch'io conosco "Il sigillo nella storia e nella cultura", che vedo edito nel 1985. Dieci anni dopo venne pubblicato un altro volume, che invece conosco: aa.vv. (a cura di E. Capellini), Il sigillo. Impronta dell'uomo, Milano, Editoriale Giorgio Mondadori 1995 Più datate, ma comunque utili, possono essere le seguenti pubblicazioni (tutte reperibili in Rete): - le riviste della Schweizerische Heraldische Gesellschaft/Societé suisse d'héraldique, che nel periodo 1887-1894 erano intitolate esplicitamente alla sigillografia; - A. Chassant/P. J. Delbarre, Dictionnaire de sigillographie pratique, Parigi, J. B. Dumoulin 1860; - J. Roman, Manuel de sigillographie française, Parigi, A. Picard et fils 1912. Sempre in Rete, si trovano facilmente più testi di sigillografia pertinenti a singole zone.2 punti
-
Ci manca però la differenza tra la Capua Antica e la Capua moderna :D Riporto quanto scritto su wikipedia: Nell'anno 841, nel corso di una lotta per la successione al ducato di Benevento, il principe Radelchi I assoldò una banda diSaraceni, comandata dal berbero Halfun, contro Landolfo, Conte di Caserta: i mercenari al soldo di Radelchi saccheggiarono e distrussero la città di Capua Antica (oggi Santa Maria Capua Vetere), così da costringere la popolazione alla fuga. Dopo la distruzione, la popolazione fuoriusciva dalla città in rovina e si rifugiava dapprima a Sicopoli (villaggio ai piedi del Monte Triflisco) per poi collocarsi, dopo pochi anni (nell'856), su un'ansa del fiume Volturno, sul luogo dove aveva sede il porto fluviale romano di Casilinum. Veniva così costituita la "Nuova Capua" corrispondente oggi al comune della provincia di Caserta denominato appunto Capua. Purtroppo a questo fatto ci tengo troppo Francè :D @@francesco772 punti
-
@@francesco77 Grande Francesco, anche io come gli altri attendo le tue preziose notizie in merito alla piastra 1825 come quella mia... Sai la cosa dei soli 4 pezzi presenti stuzzica alquanto la mia curiosità! :) poi mi piacerebbe anche sapere la questione riguardo il contorno e del perchè è prensente solo al dritto... :D spero di leggerti quanto prima ;) buona serata a tutti ragazzi :clapping:2 punti
-
Proviamoci... con un po' di buona volontà da parte di tutti. Per fare un veloce riassunto, innanzittutto diciamo che la discussione verte soprattutto sulla tecnica di coniazione dei longobardi e sulle sue conseguenze sulle monete. Il primo punto riguarda la scodellatura e il cerchione. Come si otteneva la prima e a cosa serviva il secondo. Il secondo punto riguarda soprattutto le bolle sulla superficie dei tremissi e sulle sue cause. Vediamo se riusciamo ad arrivare a una soluzione condivisa. Arka2 punti
-
:good: .... @@francesco77 solo un piccolo "aggiustamento" dello scritto riguardo al Trattato di Casalanza ....eh...eh...eh.... si ebbe a due passi da dove ho vissuto la mia giovinezza - Pastorano (CE) ..... non per niente ma quando ero ragazzo in quei posti ci andavo spesso. http://www.ilportaledelsud.org/casa_lanza.htm2 punti
-
Anche io stamattina ho avuto la fortuna di ricevere un bellissimo libro di Numismatica. Posso solo ringraziare di cuore tutti gli Amici che hanno permesso la realizzazione di questo, promuovendo e divulgando tale Passione. Buona serata a tutti, Jack Sully2 punti
-
Se si riuscisse a mettere sui giusti binari la discussione, senza "conflitti", tornerei volentieri a leggere gli interventi di numa, andreas, antvwala, arka, teofrasto, 417 sonia, mombalda e di quanti hanno contribuito, o contribuirebbero, a renderla molto interessante.2 punti
-
Buongiorno il giusto termine tecnico della così detta "sigillografia" è SFRAGISTICA dal greco SPHRAGIS = sigillo e quindi SPHRAGISTIKE come aggettivo. Ti consiglio questo testo Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell'arte di G.C. Bascapè 2 voll. ediz. Giuffrè 1969-78 che comunque puoi trovare in pdf (altrimenti ti costa sui 450€!) su http://www.icar.beniculturali.it/biblio/_view_volume.asp?ID_VOLUME=63 Inoltre ho trovato il pdf di un opera in 30 Tomi (1739-86) relativa ai sigilli antichi che trovi qui http://www.icar.beniculturali.it/biblio/_view_volume.asp?ID_VOLUME=46 Poi c'è un altro testo, che però non conosco, "Il sigillo nella storia e nella cultura" che trovi a pag. 9 del catalogo della Libreria Classica Editrice Diana sul sito http://www.classicadiana.it Saluti Claudio2 punti
-
@@Val271 l' ahi individuata bene è una moneta di Mineo circa 200/150 a.C. è un Pentonkion (indicato dalla presenza della "P" greca al diritto) non è Demetra ma Apollo la moneta è riportata dal Calciati nel III vol. a pag. 184/185 ed è la n. 3 con varianti 3/1, al 3/7 e una moneta con n. 4 D/ Testa laureata di Apollo a destra ; dietro lettera "P" in greco R/ Asklepios di fronte con coppa nella destra e con la sinistra appoggiata ad un bastone con serpe attorcigliata ai lati , leggenda MENAINON in lettere greche , contorno perlinato. non ho fatto nient'altro che trascrivere ti allego anche due immagini, una è disegnata, sono ricavate dalla Monografia del Corpus del Dott. Campana a pag. 360 la n. 3 il peso va dai 5,81 gr. ai 2,76 per una più felice comparazione e visione. ciao Pietro2 punti
-
Che ci sia una moneta solo "dedicata" non mi preoccuperei più di tanto, se c'è invece una capsula incorporata contenente qualche "sedimento" (come tante altre monete già proposte in questa discussione) la cosa mi comincia a... puzzare parecchio! :rofl:2 punti
-
http://ilportaledelsud.org/bcnn1963_1.pdf Pagina 19, i 30 ducati con la nuove impronta del re Francesco I iniziarono ad essere coniati dal 9 aprile 1825, il re Ferdinando I, predecessore e augusto genitore di Francesco, morì il giorno prima delle none di gennaio del 1825 (4 gennaio) ............ e i primi 30 ducati hanno già il bordo decorato come tutte le piastre e 30 ducati già a noi noti ............... quindi la piastra con bordo particolare datata 1825 venne ............. (poi lo scoprirete).2 punti
-
Vi siete mai chiesti perchè tale particolarità è riscontrabile solo negli esemplari del 1825 e non al rovescio?2 punti
-
Vi state confondendo, i due glantuomini (cittadini Georgiani presenti in italia senza permesso di soggiorno, senza fissa dimora e senza mezzi di sostentamento), non avevano precedenti penali, ma erano stati arrestati 3 volte (dico TRE VOLTE) nel giro di pochi mesi sempre per lo stesso reato: furto in appartamento. Al momento dell'arresto erano im possesso di: la mia moneta, diversi gioelli, attrezzi da scasso, mazzette di banconote. Sicuramente chiunque di noi che si reca da un compro oro (noto per essere un ricettatore) ci va anche con i propri attezzi da scasso, no? E ci portiamo anche mazzette di banconote dietro, giusto? (chissà perchè non le hanno depositate in banca... ah già! Dei ladri extracomunitari, senza permesso di soggiorno, pluriarrestati, non possono avere un conto in banca). Ma veramente secondo alcuni di voi una persona nota alle forze dell'ordine come ladro abituale, che viene beccato ( a seguito di appostamento, perché, in quanto ladro abituale, la polizia conosceva il suo modus operandi) davanti ad un ricettatore, carico di refurtiva ed attrezzi da scasso, può essere paragonato ad uno di noi che vende una catenina al compro oro, oppure ad un collezionista incappato in assurde vicende con la giustizia? Ma credete realmente a quello che dite o vi va di parlare tanto per far polemica? Io solo uan cosa vi auguro, che a casa vostra non entri mai e poi mai uno di questo galantuomini, a cui volete che le leggi italiane vengano applicate nella maniera più garantista possibile. Ma se dovesse succedere, per favore non venite poi a lamentarvi sul forum, e anzi, andate in prigione a portargli la vostra solidarietà. Ma dovete fare in fretta, perchè quello più di due giorni, non ci rimane dietro alle sbarre. Mi sa che stiamo uscendo dal semiato del post e fra un po' ci sbattono in Agorà o ci chiudono, il che mi dispiacerebbe.2 punti
-
Salve, io sono un collezionista un po' particolare, nel senso che più che comprare monete (non ne acquisto da una decina d'anni) preferisco comprare, collezionare e leggere libri riguardanti monete e cartamoneta; in effetti la mia passione per la numismatica è eclettica e molto connessa ai contesti storici di riferimento, di conseguenza per me l'appagamento più che nella contemplazione delle monete in sé stesse è nella ricerca e lettura dei libri che le concernono :D..detto ciò si può capire che per me il massimo dell'espressione "libridinosa" sarebbe il poter sguazzare in una biblioteca numismatica, cioè specializzata nella raccolta, catalogazione e consultazione di ogni volume e periodico concernente le nostre passioni, è vero che sono di parte in quanto di professione sono specializzato in archivistica e biblioteconomia e quindi la passione per i libri l'ho nel sangue, ma credo che in ogni buon numismatico si nasconda sempre un piccolo o grande bibliofilo desideroso anche lui come me di poter sguazzare a piacere in un santuario ricco di libri sulle monete, medaglie e cartamoneta di ogni epoca e luogo...ora mi domandavo se in Italia esistano già tali santuari (per ora mi risulta solo a Milano), nel caso affermativo vorrei saperne di più e farei anche la proposta di provare a crearne qualcuno, io sono di Napoli e non esiterei a donare la mia piccola biblioteca numismatica e a occuparmi materialmente delle raccolte se ci fosse una possibilità concreta di fondazione nella mia bella quanto complessa città... che i numismatici libridinosi e bibliofili di tutta Italia lascino battere il loro Cuore affamato di monete, libri e cultura e si uniscano in questa discussione...chissà che non si possa sviluppare qualche bella idea :blum:1 punto
-
Buona domenica a tutti. Non l'ho ancora acquistata ma e' da un po' che ci penso. In che conservazione e', secondo voi, a me sembra bella. Grazie1 punto
-
Ciao, questa ricerca costituisce un piccolo omaggio alla recente nascita di Matilde, la secondogenita di un amico del Forum. Lei non potrà leggerlo, certo … ma i genitori sì e spero di far loro cosa gradita … ed anche agli altri utenti che leggeranno la presente discussione! :D Per motivi di "privacy" non metto il nickmane del padre della piccola Matilde... gli lascio la scelta di palesarsi o meno. ;) PROLOGO Il fenomeno della nascita è sempre stato considerato da sempre qualcosa di magico. Lo possiamo percepire ora, figuriamoci nell'antichità o nella Preistoria, quando davanti alle cose inspiegabili si ricorreva alla "scusa" dell'intervento divino (ma anche ora che sappiamo cosa succede fisicamente la nascita è pur sempre qualcosa di "magico"). Più genericamente l’immagine femminile ha rappresentato la stessa Terra, la sua fertilità e il sincretismo Donna-Terra fu spesso oggetto di culti spesso identificati in quello della “Dea Madre”, dove la figura femminile rappresenta lo spirito della Natura che dà vita, studiato da numerosi studiosi tra i quali M. Gimbutas. Per alcune immagini relative alle Veneri preistoriche (in questo caso neolitiche) di area balcanica: http://digilander.libero.it/Righel40/VEP/NEO/BLC/blc.htm Alcune figure femminili poi sono rappresentate durante il parto o nella fase dell’allattamento. Dea assisa sul trono, fiancheggiata da due felini. La piccola figura rotondeggiante tra le gambe è stata interpretata come un bambino nascente. Fu rinvenuta in un contenitore per il grano quindi correlata alla nascita e crescita del cereale. Catal Huyuk, Anatolia, circa 6000 a.C. Madonna di Gradac, Vinca. Gradac, Valle Morava, 5000 a.C. ca. v. Gimbutas, Il linguaggio della Dea, pag.37 fig. 58 .Il tema del nutrimento fin dal Paleolitico è espresso con l’evidenza delle mammelle. Qui è più caratterizzato simbolicamente con linee sul corpo, che rappresentano il fluire del liquido sacro, non solo il latte, ma l’acqua, il sangue, la pioggia, considerate fonte divina di nutrimento. Notate il perpetruarsi della simbologia nell’area anatolica-medioorientale in epoca romana: Culto di Cybele, originario dell’Anatolia. Un chiaro parallelismo con la Dea seduta tra i felini di cui sopra Rovescio di Giulia Domna, denario, Mater Deum assisa sul trono affiancata da due leoni.1 punto
-
Arrivata oggi, fresca fresca dallo Studio del Signor Emilio Tevere. Devo ringraziare Gallo/Marco che mi ha segnalato dell'ottimo rame della Somalia sul sito del Maestro! Purtroppo quando le conservazioni salgono ...i prezzi sono alle stelle, vedi andamento dell'asta Nomisma in scadenza. Mi sono accontentato di questo esemplare!1 punto
-
@@UmbertoI probabilmente ...anzi sicuramente ,a causa del clima della somalia.1 punto
-
@@rintintin vieni a Verona e falla vedere a Riccardo Rossi... lui è un'esperto della repubblica (oltre che un gran signore!!!) e non ti tratterà mai con sufficienza, nemmeno su monete di 50 centesimi... dico giusto @@cembruno5500 ?1 punto
-
52 piccoli sono 4 soldi e 1/3 (ma il loro valore dipende molto dall'anno preciso in cui questo dato è rilevato). Alcuni esempi provenienti dalla vicina Padova, così per farsi un'idea: Inizi XV secolo: una libbra (circa 3,5 etti) di pesce o di formaggio 4 o 5 soldi Prima metà XV secolo: un paio di calze rosse e azzurre usate 16 soldi; un berretto 20 soldi; un mantello 50 soldi Metà del XV secolo: un paio di scarpe usate 16 soldi.1 punto
-
con tutto il rispetto e la " condivisione " per quanto hai scritto ti ricordo il 3° punto I parenti ti portano torte ed arance al gabbio :hi: :help: Sergio1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
poco più di BB vuol dire più di 150 euro!! il catalogo gig. 2012 la riporta così, MB 80 BB 150 SPL 3201 punto
-
dubito che il peso sia solo 3 grammi ...... mi sembra un 2 reales come questo Tipo: B-309 a B-314 Valore : 2 REALES Materiale: 903 Diritto d'argento dal 1786 e Legge 896 Peso: . 6.76 gr Misura: 25 mm. Anteriore: III DEI GRATIA CAROLUS DATA (Carlos III per grazia di Dio) attorno ad un busto del re a destra. Reverse: Hispan REX ET IND menta e il valore saggiatore 2 R (re di Spagna e delle Indie) attorno uno scudo coronato con castelli e leoni Borbone scudo fra due colonne con il motto PLUS ULTRA. Zecche: B-309 GUATEMALA B-310 LIMA B-311 MESSICO B-312 NUOVO UNITO B-313 POTOSÍ B-314 SANTIAGO1 punto
-
Usa l'osservatorio prezzi di mercato per postare domande sulle quotazioni delle monete. Comunque, Vaticano 2012 103.000 ex, 28/30 euro; 2 euro monaco 2009 250.000 ex, 5/6 euro.1 punto
-
Superare il record dell'inter post mondiale era molto importante per riprenderci almeno una fetta di ciò che ci hanno tolto grande juve adesso puntiamo dritti al record europeo di 102 giusto per mettere un ulteriore tassello importante nella storia Poi un pensiero sulla telenovela conte, premettendo che spero resti ancora a guidarci per lungo tempo personalmente però mi ha un po rotto il suo tentennareè un grandissimo allenatore che ci ha riportato dove meritiamo e sarà sempre nei cuori juventini in ogni caso, ma se inizia a non credere piu nel progetto juve, appagamento della rosa o meno, allora è meglio cambiaree un jurgen klupp come si vocifera non sarebbe certo un ripiego...1 punto
-
Anche se piccole monete, hanno un gran fascino, un'altra trillina con l'abbondanza, purtroppo si tovano solo in cattivo stato di conservazione1 punto
-
Per comunicare che questa discussione, come quella sui testoni di Ferdinando II dè Medici e tante altre che si stanno sviluppando, le potete trovare per una migliore consultazione nella discusione tra le importanti, " Archivio : una moneta, una storia ", poco alla volta si sta sviluppando un bel nucleo di storie numismatiche interessanti. http://www.lamoneta.it/topic/104416-archivio-una-moneta-una-storia/1 punto
-
Vorrei sottolineare anche un'altra variante riguardante le 500 lire del 1982 con la firma Cretara piccola e grande, questa moneta non è recensita in alcun catalogo ma visto che possiedo tutte e due le tipologie posso dire che esiste.............1 punto
-
Considerando la bellezza di una moneta da 20L in oro del 1861, sia per il suo significato storico che per le sue impronte. Fermo restando che il giudizio sul grado di conservazione di una moneta è molto soggettivo e quindi soggetto a variazioni da persona a persona, per questo esemplare il mio piccolo parere è che si possa considerare SPL, propio come detto dagli altri.1 punto
-
Bel marengo! Molte volte i rilievi sono schiacciati per il procedimento di conio, a me sembra avere una buona freschezza, ed il R/ è particolarmente brillante, sembrerebbe essere quasi un prooflike con i rilievi satinati. A mio parere sono indeciso tra: Spl/Spl+ o Spl+/Spl=qFdC Il R/ di quella di Nomisma è decisamente un'altro pianeta, bordi della croce al R/ molto più deboli, scena dell'annunciazione altrettanto, minimi strappi di tondello periferici al R/ e appena accennati sul D/, e fondi non lucenti. Questa vince sembra ombra di dubbio per me :)1 punto
-
:hi: Ciao MAESTRO tutto il tempo che vuoi per gli approfondimenti . un affettuoso abbraccio, michele1 punto
-
io non la disprezzerei poi così tanto!! trovarle centrate e con i rilievi "freschi" è quasi impossibile! ti assicuro che se mi capitasse di trovare un 88 come il tuo cercherei di prenderlo! a me piace molto!!! complimenti!!1 punto
-
1 punto
-
Visto che tutti gli utenti sono timidini, comincio io con la biblioteca personale Aggiudicata per 270 euri ..giudicata BB+1 punto
-
Philadelphia :) Ormai giro solo in east coast Le tue sono tutte Denver, vivi nei middle states? :D1 punto
-
I conii delle monete antiche erano di bronzo indurito o di ferro. Quelli di bronzo erano più facili da incidere e non arrugginivano, ma si consumavano più rapidamente. I conii di ferro erano usati per coniare le monete greche di maggiori dimensioni, in particolare tetradrammi e decadrammi molti dei quali presentano tracce di arrugginimento. In effetti vari tetradrammi di Alessandro Magno presentano il segno del cosiddetto ‘die rust’, cioè conio arrugginito. Un tetradramma sul cui diritto i segni di ‘die rust’ sono piuttosto marcati è questo esemplare della zecca di Corinto, dove il volto di Eracle e anche il copricapo sono coperti da bollicine simili a quelle della varicella. KINGS of MACEDON. Alexander III 'the Great'. 336-323 BC. AR Tetradrachm (17.13 g, 6h). Corinth mint. Struck circa 310-290 BC. Head of Herakles right, wearing lion skin headdress / BASILEWS ALEXANDROU, Zeus Aëtophoros seated left; two Nikai decorating throne back; cornucopiae in left field, NO below throne. Price 691; SNG München 383. Near EF, die rust on obverse. Nonostante ciò la moneta presentata alla Triton IX nel 2006 è stata aggiudicata a un hammer di 425 $ partendo da un prezzo base di 500 $. Il meccanismo di formazione della ruggine sul ferro e dell’effetto di un conio arrugginito sulle caratteristiche fisiche del pezzo coniato saranno illustrati in prossimi interventi. apollonia1 punto
-
Dimenticavo Simone00..... Chiaramente, dopo le tipologie che ti ho consigliato per fare veramente centro, anche se richiederà un piccolo sforzo economico (ma non esoso e con un po' di accortezza) un bello statere di argento di Olimpia, in modo da poter rivivere, tenendo la moneta in mano, i tempi e lo spirito olimpico antico...... Come sai infatti le monete di Elis-Olimpia sono monete universali in quanto maneggiate da tutti i popoli greci e delle colonie nel sito del Santuario durante il periodo dei giochi..... Alcune di esse (per stile e tecnica realizzative) sono annoverate tra le più belle monete di tutti i tempi al pari e rivaleggiando con le più belle produzione siciliane del V sec a.C........ Buona collezione!!!!!!!!!!!!!!!! Odisseo1 punto
-
ma se, in alternativa a perquisizione eccetera, si convocasse, anche presso i CC , il malcapitato acquirente per chiedergli spiegazioni non sarebbe meglio e non farebbe risparmiare tempo e denaro? Sogna, sogna che sognare non si fa peccato :lazy:1 punto
-
1 punto
-
....e il secondo ribattuto dai Genovesi, al centro del diritto si vede bene DIO di MEDIOLANUM1 punto
-
Perché maneggiare una moneta è come fare all'amore, a me piace solo senza guanto. :blum:1 punto
-
nessuna scusa, ci mancherebbe. ricordatevi ragazzi, ogni moneta, anche se malconcia, rovinata, non più leggibile....... .........deve essere rispettata e collezionata. Questo è quello che mi diceva il mio maestro e ciò che ribadisco a voi amici Lamonetiani1 punto
-
1 punto
-
Permettetemi un piccolo intervento, non proprio numismatico ma attinente alla medaglia dedicata appunto a Publio Ovidio Nasone. Innanzitutto si tratta di una medaglia, senza dubbio alcuno, bellissima! caratterizzata soprattutto oltre che dagli alti rilievi, da una forte tridimensionalità prospettica nel rovescio. Ma cosa rappresenta realmente il rovescio? non è un semplice cavallo alato su una roccia, ma bensì un riferimento mitologico di primo ordine, in quanto raffinatissimo richiamo all'arte della poesia. Se avete qualche attimo ve ne racconto la storia.... Pegaso era figlio della Medusa, la Gorgone famosa per la sua bellezza che andò in sposa a Poseidone, il Dio del mare e dei cavalli. L'unione delle due divinità avvenne però nel tempio di Atena, dea della saggezza e della guerra, che furibonda per il sacrilegio compiuto nel suo tempio, trasformò Medusa in un mostro dalla testa ricoperta di serpenti il cui sguardo trasformava gli uomini in pietre. Pegaso "nacque" allorquando Perseo decapitò Medusa. Il nostro cavallo alato infatti, insieme al guerriero Crisaore, venne fuori dal suo collo mozzo. Una volta "nato" Pegaso si abbeverò nella fonte Pirene e dopo volò sul Monte Elicona nel quale era in corso una gara di canto tra le Muse e le Pieridi. Il cavallo, commosso dalla dolcezza del canto, colpì il suolo del Monte che nel frattempo si era alzato fino al cielo. Dal colpo con lo zoccolo scaturì Ippocrene , la “sorgente del cavallo”, alla quale le Muse si sarebbero dissetate, nutrendo la loro ispirazione , prima di volare verso l’Olimpo cantando con la loro voce suadente. Per tale motivo Pegaso, che aveva fatto sgorgare la sorgente delle Muse, è considerato l’emblema dell’immaginazione creatrice, del furore poetico e dell’ispirazione.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?







.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)