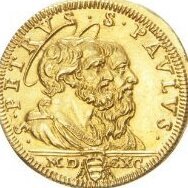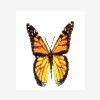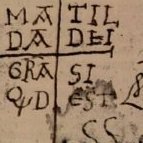Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 09/13/15 in Risposte
-
Il discorso dei limatori meriterebbe spazio idoneo. Nel mio discorso a Napoli rappresentava solo uno degli argomenti affrontati. Per quanto riguarda il tema in sè vorrei ricordare che anche Giuseppe Ruotolo (Presidente dell'Accademia di Studi Numismatici) ha ricordato che tra gli studiosi il fatto che i graffi di conio siano determinati dalla limatura dei tondelli (prima che vengano coniati e per portarli a peso) è dato solido ed acquisito. Ricordo che in tedesco i graffi di conio vengono definiti "Justiert" e in inglese "Adjusting marks", termini che definiscono l'aggiustamento di peso (chissà perchè da noi si usa il termine graffi di conio: oltretutto i tondelli erano coniati a freddo e di certo non si "attaccavano" ai conii...). Nelle zecche americane di fine XVIII ed inizio XIX secolo questi lavori erano svolti preferenzialmente dalle donne. Documenti bolognesi riportano che a Venezia nell'epoca napoleonica venivano usati preferenzialmentete dei tornietti, capaci di asportare una lamina circolare di metallo dalla superficie della moneta. Rimane traccia di ciò in molti esemplari (anche del periodo Lombardo Veneto) che presentano sottili tracce e graffietti circolari. Nell'archivio bolognese si legge anche che l'uso dei tornietti era stato importato a Milano (periodo Napoleonico) ma con poca fortuna e la maggioranza degli operai continuava ad utilizzare le lime. Personalmente ritengo che questa stessa modalità, più affinata, servisse a portare a peso anche i tondelli del Regno d'Italia Sabaudo (Umberto I e VE III), e di ciò rimanga segno evidente nelle "patine a bersaglio" che appunto evidenziano nella loro formazione l'asportazione concentrica. ... ;)4 punti
-
Credo sia difficile sostenere una discussione seria "in cieco", e cioè senza avere di fronte delle persone reali e in mano dei documenti giustificativi. Questo tipo di dibattiti si sono arenati anche in passato nel Forum, perchè ogni parere espresso sembra poter essere accettabile, chiunque sia a proporlo. Per questo stesso motivo non avrei voluto aprire una ulteriore discussione. Tra i partecipanti c'è chi è convinto che i "graffi di conio" siano dovuti alla espulsione delle monete dal conio (come indicherebbe il nome in questione), forse tramite l'improbabile utilizzo di strumenti atti a facilitare tale operazione, e anche chi ipotizza possano rappresentare segni di "sfregio" per il sovrano. http://www.lamoneta.it/topic/34742-sfregiare-le-monete/?hl=justiert#entry377985 http://www.lamoneta.it/topic/94591-strappigraffi-di-conio/ Quanto ho riportato brevemente nella discussione sul Convegno di Napoli (http://www.lamoneta.it/topic/129282-secondo-convegno-numismatico-partenopeo/page-11 #258) mantiene invece una sua validità documentale. Le carte che ho potuto consultare, e che costituiranno oggetto di pubblicazione, indicano i seguenti elementi: - A Bologna i tondelli (sia d'oro/argento che di rame) venivano limati per essere portati a peso (prima della coniazione): in epoca pre-napoleonica sul contorno, in epoca napoleonica sulle facce - Vi erano lime di varia gradazione, in rapporto ai tondelli. Erano fornite da Milano. - I tondelli venivano disposti sopra alcune tavolette di legno che presentavano serie di incavi regolari per alloggiare le monete e venivano limati in piano (in genere da una sola faccia) - Si consigliava di utilizzare la faccia limata del tondello per il conio di rovescio, per non deturpare eccessivamente le monete - A Milano si usava sia questo metodo che dei tornietti ad acqua (cioè mossi da forza idraulica) che "raspavano concentricamente una faccia della moneta (metodo meno utilizzato) - Quest'ultimo metodo era invece prevalentemente in uso nella zecca di Venezia Riporto, perchè già pubblicato da Michele Chimienti (La zecca di Bologna e le sue macchine, Eurocopy, Bologna 2008, p. 333) la seguente osservazione (è tratta da documento dell'Archiginnasio di Bologna - B1060- di Pellegrino Salvigni, direttore della zecca di Bologna in visita alla Zecca di Milano nel 1808) "Aggiustamento de’ tondini. Introdotti in Milano de’ tornetti ad acqua per raschiarli e non limarli. Dicesi da Morosi che questo metodo tolto da’ Veneziani dia risparmio di tempo. Non è vero. È però vantaggioso per la minor dispersione del metallo, e perché non vi restano i segni della lima. Presentemente però in Milano i limatori vecchi seguitano a mettere a peso colla lima, giacché non hanno potuto adattarsi al tornetto, ma i giovani usano di questo. Per riparare all’inconveniente de’ segni della lima si era ordinato che i tagli di essa fossero meno grandi, ma il Mastro ostava per la compassione de’ limatori, ed essi pagavano da bere al tagliatore perché tagliasse grosso." Vorrei completamente smentire @@demonetis dicendo che esistono documenti che riguardano tecniche e modalità di coniazione per Bologna, e che essi assumono una valenza piuttosto generale (Bologna è stata parte del Regno d'Italia Napoleonico, dello Stato Pontificio e del Regno d'Italia Sabaudo nel volgere di 50 anni) e che confidiamo di pubblicarli quanto prima. Consiglio inoltre chi sia interessato ad acquistare il nuovo libro di Chimienti (Incisori e conii della Zecca di Bologna, Bologna agosto 2015) che appare unico nel suo genere per le notizie relative alle tecniche di coniazione, oltrechè beninteso per tutte le altre notizie e immagini fornite. ;)3 punti
-
@@rickkk @@nando12 @@Il*Numismatico @@quadriga @@contemax67 @@david7 @@cembruno5500 Grazie a tutti per i pareri espressi! Non l'ho acquistata direttamente da chi ha chiuso la perizia ma in un negozio di articoli vintage che ne aveva alcune in vendita. La perizia è stata chiusa qBB. L'ho presa apposta perché il prezzo era 7 euro e credevo potesse meritare più di quello che dice la perizia..credevo fosse intorno a SPL.. Qualche parere è in linea col mio, altri sono più bassi, altri ancora più alti..capisco che la foto possa deviare un po' in meglio o peggio, in ogni caso nessuno è sceso a qBB.. Pensavo allo SPL pdr la veste e il fogliame ancora abbastanza presente, anche il baffo mi sembra messo bene, contando poi che è rame.. Peccato per quelle macchie al D/! In ogni caso grazie a tutti per i pareri! :)3 punti
-
Secondo me questa ed altre discussioni simili sono provocazioni degli amici delle sette di mattina, di quelli che pensano che noi appassionati di numismatica si sia tutti banditi, trafugatori di beni di esclusiva proprietà dello stato, evasori eccetera... Non vale la pena mettersi a rispondere, oppure incazzarsi!3 punti
-
Forse occorre precisare che la differenza fra 'imitazioni' e 'contraffazioni', riguardo alle coniazioni che copiano monete altrui, non è affatto basata sul rispetto del peso o della lega della moneta originale, ma sull'esplicitazione o meno di un' autorità emittente diversa da quella originale, che naturalmente deve essere un'autorità in grado di esercitare il diritto di conio, cioè in grado di esercitare il controllo su un determinato territorio. In questo senso le monete di Latisana e Lienz non possono essere altro che 'imitazioni', indipendentemente dalla loro bontà (che comunque mi risulta fosse identica), perché il nome di quel territorio è espresso in modo del tutto esplicito. La differenza è giuridica e non è di poco conto, perché in caso di contraffazioni il rischio per chi le spacciava era il rogo, mentre in caso di imitazioni quello di perdere le monete, se non addirittura solo di vedersele ridotte a bolzone, cioè demonetizzate ma lasciate al proprietario. Il fatto che l'autorità il cui nome o il cui territorio erano posti sulle monete non avesse il diritto di conio, ma lo avesse usurpato, non aveva grandi conseguenze su chi usava queste monete, perché ovviamente tale questione poteva essere risolta soltanto dall'autorità superiore da cui dipendeva tale concessione (re, imperatore o papa) l'unica che potesse dichiarare se una concessione era valida o meno (talvolta anche la semplice consuetudine rendeva legale una monetazione) e di conseguenza bandire come false le monete prodotte in base ad essa (come in effetti avvenne in Friuli per le imitazioni del Frisacense). Proprio questa differenza spiega perché tra '500 e '600 molti imprenditori del Centro-nord Europa si rivolsero ai piccolissimi principati padani con diritto di conio (anche l'imperatore Carlo V aveva largheggiato con le concessioni in Italia, in vista o in conseguenza della sua elezione a imperatore nel 1530) per battere monete che imitassero quelle transalpine: grazie a questo diritto non rischiavano di finire arrosto, importando tali esemplari in patria. L'importante è che sulla moneta fosse chiaramente indicato il titolare di tale produzione. Va da sé che sia per le contraffazioni che per le imitazioni il peggioramento della lega garantiva maggiori guadagni ai produttori, e quindi era largamente praticato. Tuttavia per monete di buon argento come gli 'aglaier', che circolavano in un ambito non analfabeta e assai avvertito dal punto di vista commerciale, produrre esemplari chiaramente distinguibili dagli originali (a causa della diversa legenda), ma con un intrinseco peggiore poteva anche risolversi in una rapida svalutazione di questi esemplari, azzerando così i possibili guadagni. Comunque recenti analisi hanno dimostrato che i soli frisacensi primitivi attribuibili con una certa probabilità ad Aquileia, quelli con la legenda P A (Patriarcha Aquilegensis?) avevano una lega peggiore degli altri. Come dire, per provare ci provavano! Saluti, Andrea3 punti
-
Illustriamo anche il tutto con le relative stampe (visto che le scansioni sono pesanti, ne mettiamo una al giorno :P). Partiamo in ordine, ecco la A2 punti
-
Buongiorno a voi, ringrazio @@fabry61 per la fiducia, ma ahimè non credo di essere la persona adatta per risolvere il busillis. Non ho molta esperienza riguardo alla monetazione di Rodi, tuttavia non credo che la moneta in asta da CNG sia falsa. O meglio, non credo che la moneta in oggetto sia un falso moderno. Negli ultimi anni sono stati venduti in aste pubbliche un certo numero di ducati a nome di Peter of Aubusson. Solo alcuni di questi erano di “bello stile”, con immagini ben definite nei particolari e lettere miste, capitali e pseudo onciali. Apparentemente (anche se in verità non ho fatto una comparazione approfondita), nessuno di questi ducati, “normali” - chiamiamoli così - e “anormali”, sembra provenire dalla stessa copia di conii. Basta dare un occhiata a CoinArchives o anche solo a acSearch per sincerarsene. In alcuni pezzi il volto di san Giovanni è visto di prospetto, in altri di tre quarti e in altri ancora, come nell’esemplare in esame, è visto di profilo; in alcuni il panneggio delle vesti del Cristo è ben definito, con volumi chiari e ampi, mentre in altri si è di fronte ad un panneggio minimale, quasi geometrico e appena tratteggiato. Per non parlare della differenza nelle lettere: generalmente le uniche che compaiono sempre con le stesse caratteristiche formali sono al “f” e la “E”, pseudo onciali, mentre le altre possono variare, da capitali “romane” a capitali “con grazie” più o meno pronunciate, a pseudo onciali. I fondi stessi dei vari esemplari, che evidentemente rispecchiano la preparazione dei conii con cui sono stati battuti, possono essere più o meno lisci. Quale il motivo di questa proliferazione? Si potrebbe pensare che solo le monete di buono stile siano quelle autentiche e tutte le altre siano false, ma secondo me non può essere così. E per il semplice motivo che le “false” sarebbero in numero maggiore di quelle autentiche e tutte - ripeto - con caratteristiche proprie. Una spiegazione che mi sembra più plausibile è quella secondo la quale in diversi casi - da identificare volta per volta - si tratterebbe di emissioni ufficiali, uscite dalla zecca rodia, mentre non pochi pezzi potrebbero/dovrebbero essere imitazioni levantine del ducato originale. Se ci pensate bene, esistono imitazioni del ducato di Venezia con caratteristiche analoghe a questo esemplare... Buona giornata, Teofrasto PS se cercate con Coin Archives potete utilizzare nella stringa di ricerca sia Peter of Aubusson sia Pierre d’Aubusson, mentre con acsearc, ricordate di digitare esclusivamente Pierre d’Aubusson perché se cercate sotto il nome Peter of Aubusson non trovate nulla... ;) PPS Se vi sembra falso il ducato, allora cosa mi dite di quest’altra moneta, sempre di Pierre d’Aubusson ma in questo caso un unicum comparso sul mercato nel 2004?2 punti
-
Cioè, se condo te avrebbe acquistato un 2 € Gk, lo avrebbe maneggiato un po', facendogli perdere di valore e lo avrebbe postato qui per bullarsi?2 punti
-
Aggiungo qualcosa in merito allo Zanetti. Questi afferma <Tali sono le Monete, delle quali m'è riuscito aver notizia, col nome de' Principi di Piombino. Questi le fecero coniare nella propria Zecca, che avevano fatto erigere sì in Piombino, in luogo vicino alla Cittadella, ove ancora si conserva la Fabbrica , sebben negletta, che in Follonica; come pure nell'Isola dell'Elba oltre Rio, ed anche in Marciana, restando oggidì denominata una stanza di ragione della Casa Bernotti la Officina della Zecca>. Occorre premettere che lo Zanetti scrive nel 1779, circa cento anni dopo la chiusura della Zecca piombinese, e tuttavia già denuncia nelle sue lettere la mancanza di documenti, non riuscendo a reperire neanche tutte le tipologie monetali emesse. Ancora una volta occorre procedere per indizi e deduzioni, anche se immagino già qualcuno alzare sprezzante un sopracciglio, pensando che voglia paragonarmi ad uno Sherlok Holmes de noantri (comunque la pipa la fumavo anch'io!). Partendo dalla semplice considerazione che un piccolo Stato come Piombino non poteva avere quattro officine monetarie (se non altro a ragione dei costi eccessivi ed inutili) occorre scartare Rio e Follonica, restando valide le ipotesi Piombino e Marciana. Infatti lì la Zecca è in Cittadella, residenza piombinese degli Appiani e del Ludovisi mentre a Marciana è presso la "casa Bernotti" famiglia legata strettamente ai Signori piombinesi e residente nello stesso complesso dove questi soggiornavano. Insomma, visto che lo Stato piombinese emetteva moneta - su questo non ci piove - e che da qualche parte doveva pur coniarla, finchè non emergono documenti comprovanti il contrario, credo che il ragionamento "deduttivo" abbia una sua logica. Nella ricerca storica, come in tanti altri campi della scienza, si procede assai di frequente per ipotesi di lavoro da verificare e/o ribaltare; l'importante è tenere sempre un atteggiamento laico e pronto alla discussione ed al confronto. Ben altra cosa è l'atteggiamento di chi si ritiene depositario della verità "a prescindere" di chi ha fatto dell' ego dixit l'unico metodo di ricerca.2 punti
-
La zecca aveva sede nel palazzo che oggi è occupato dalla Biblioteca nazionale Marciana: La struttura Oltrepassata la porta di entrata, l’organizzazione dello spazio al piano terra era così compartita: sulla destra si aprivano le officine per la fabbricazione delle monete, mentre a sinistra, nei locali prospicienti la laguna, erano disposti i magazzini e le fornaci a sinistra. Attorno al cortile si svolgevano tutte le attività di conio. In particolare, nell’attuale sala manoscritti del pianterreno era situata la fonderia, dove venivano affinati e poi raffreddati i metalli. Si affacciavano sul cortile le varie “botteghe” che trasformavano i lingotti in tondelli per le monete mediante l’utilizzo di varie macchine (laminatoi, presse, fornaci), tra queste: la bottega per la creazione dei tondelli con fornace e un’enorme ruota azionata a mano, che dava moto alle trafile per produrre le lamine dai lingotti (corrispondente all’attuale saletta dei terminali per la consultazione dei cataloghi on line); la bottega per l’imbiancamento dei tondelli (corrispondente alla prima parte della attuale sala cataloghi); la bottega per la cordonatura delle monete (corrispondente alla seconda parte della sala cataloghi, dietro la statua del Petrarca); la bottega del fabbro, con annessa fornace, (attuale ufficio dietro al zona cataloghi); la bottega per il conio delle monete. Qui il lavoro era effettuato meccanicamente con i torchi a bilancere, che col passare del tempo avevano sostituito le operazioni di coniatura manuale (attuale ufficio del prestito interbibliotecario); Un esemplare di torchio, datato 1756, è esposto all’Ufficio orientamento. Ovviamente, per motivi legati alla funzionalità del lavoro, le botteghe subirono vari riposizionamenti nel tempo, i dati qui riferiti si riferiscono al periodo attorno al 1750 Al primo piano, verso la laguna, c’erano gli uffici del Maestro della Zecca, del cassiere, del controllore, etc. Su questo piano, distribuiti in varie stanze, c’erano dodici forzieri per la custodia delle barre di metallo prezioso, ognuno col nome di un apostolo. Quattro di questi forzieri sono ancora oggi conservati all’interno della vecchia “cella” della Zecca, detta anche “prigione dell’oro” o “deposito delle paste”, oggi chiamata “stanza degli scrigni”. Una stanza chiusa da muri e volte poderose in blocchi di pietra d’Istria, un vero forziere di pietra a cui si accede da una stretta porta di metallo e al cui interno i quattro grandi scrigni in legno, rinforzati da barre di ferro, ancora custodiscono antichi cimeli della Biblioteca. Tre di questi scrigni imponenti conservano ancora le complicate serrature dell’epoca (sec. XVII-XVIII). http://marciana.venezia.sbn.it/la-biblioteca/la-storia-e-il-patrimonio/il-patrimonio/patrimonio-storicoartistico/il-palazzo-della-42 punti
-
Chiudo la discussione, ricordando ancora una volta che LE LEGGI VANNO SEMPRE RISPETTATE. petronius2 punti
-
Soggetto difficile. http://www.acsearch.info/search.html?term=Manbij&category=1-2&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1&images=1¤cy=usd&thesaurus=1&order=0&company=2 punti
-
Vi ringrazio per la partecipazione. Mi sono permesso di sollevare una questione che forse non viene sempre tenuta in debito conto, cioè quello che il Commerciante si aspetta dal Convegno. Ovvio che io esprimo il mio personale parere, che però è abbastanza condiviso anche a livello di Associazione. Creare il connubio che si è realizzato a Napoli è il messaggio ideale che dovremmo trasmettere, a livello teorico, della numismatica; la NIP lo ha stabilito anche a livello statutario; quindi la strada è questa. Forse non è quello che si vede nella maggioranza dei convegni italiani, ma questa è la strada per coinvolgere positivamente anche le istituzioni, che forse così la smetteranno di vederci come i tombaroli o i ricettatori di turno (perdonatemi il linguaggio un po' forte ma sono fermamente che in alcuni soggetti delle istituzioni sia effettivamente così). Se vogliamo sintetizzare tutti gli interventi, mi pare che siamo d'accordo che l'aspetto su cui dobbiamo lavorare, ognuno per le proprie possibilità, competenze e specificità, è l'aspetto dell'aumento della presenza di visitatori, che si porta dietro, ci auspichiamo, anche i risultati; oltre che consolidare comunque gli altri aspetti già positivi (logistica, sicurezza, ambientazione, ecc.). Io comunque, a proposito dei risultati di questa opera di divulgazione, ribadisco che il lavoro sul campo è quello più efficace, ben conscio che sia anche quello più lungo e difficile. Dobbiamo far conoscere la numismatica e trasmettere, con la massima efficacia e trasporto, la bellezza di questa forma di collezionismo. Bisogna cercare di immedesimarsi in un interlocutore e farsi la domanda: " cosa mi aspetto di sentire che mi colpisca al punto tale che mi faccia avvicinare alla numismatica?" Ogni persona ha le proprie personali leve; ed è su questo punto che sta l'efficacia del messaggio e del risultato. Chi cerca un'identificazione di appartenenza (le monete della propria regione o città, o quelle di un luogo a lui caro), chi cerca un'analisi storica/geografica (le monete di una certa area o periodo storico), chi cerca anche solo l'investimento (classico esempio di chi investe in oro monetato), ecc.. Ad ogni interlocutore bisogna toccare le corde giuste. E nei convegni questi "normotipi" ci sono già, ognuno di noi lo è. Adesso bisogna sforzarsi di stimolare l'interesse in persone terze. Perché una cosa è appurata; senza pensare alle monete correnti, ma quasi tutti, anche quelli non numismatici, abbiamo, o direttamente in famiglia o in situazioni limitrofe, avuto a che fare con accumuli di vecchie monete e banconote. Del nonno, dello zio, del parente; in ogni famiglia ce n'è uno. Poi c'è chi lo ha sviluppato come hobby e chi no. Se pensiamo solo a questo, il bacino dei potenziali interlocutori è immenso. Certo, non tutti saranno stimolati, ma il fatto stesso di far riflettere di come la moneta abbia sempre fatto parte, da quando è stata inventata, della nostra vita quotidiana, di tutti, deve far pensare che ognuno può esserne più o meno coinvolto. Ripeto, basta toccare i tasti giusti di ognuno. Per quanto mi riguarda sono disponibile a parlarne di persona con chi è interessato ad approfondire la cosa. Meglio verbalmente, è più efficace. Il mio numero lo trovate sul Sito NIP Buona serata a tutti2 punti
-
NEWS!!!!!!!!!!!! la prima italiana 2015 :yahoo: :yahoo: Taglio: 5 cent Nazione: Italia Anno: 2015 Tiratura: ??? Condizioni: qSPL Città: Milano Note: NEWS :yahoo:2 punti
-
Buona sera a tutti, Segnalo la pubblicazione sul sito della Società Numismatica Italiana de "La Moneta. Vocabolario Generale" di Edoardo Martinori. LINK2 punti
-
Aggiungo qui per ricordarlo l'immagine che Topgun ha inviato al forum per la vittoria nell'Oscar Euro 20122 punti
-
I luigini Il luigino nel Seicento Seborga emise per la prima volta una propria moneta nell’anno 1666. I monaci di Lerino, infatti, alla ricerca di fonti di reddito alternative alle rendite agricole, da alcuni anni piuttosto scarse, decisero di esercitare uno dei diritti che competevano al Principe sovrano e nel giorno della vigilia di Natale il Principe-Abate Cesare Barcillon appaltò così a Bernardino Bareste di Mougins la gestione per cinque anni di una nuova zecca seborghina, dietro a un corrispettivo di 740 lire all’anno; l’appalto al Bareste si prolungherà poi fino al 1679. Nella zecca, situata nel Palazzo dei Monaci a Seborga, cominciarono così ad essere coniati i cosiddetti luigini, il cui nome si ispirava alla moneta corrente in Francia in quel tempo, il louis. Le monete recavano al dritto il busto di san Benedetto (ma taluni sostengono che si trattasse invece di Sant’Onorato) e al rovescio lo stemma ancora oggi utilizzato dall’Abbazia di Sant’Onorato di Lerins, sormontato da corona principesca. Sul contratto d’appalto sottoscritto nel 1666 era riportato che il fiduciario aveva l’obbligo di riportare sulle monete l’arma dell’Abbazia di Lerino e le iscrizioni relative al rango principesco del Principe-Abate, mentre gli veniva riconosciuta per il resto ampia facoltà di imprimervi “quant’altro di lecito gli fosse aggradato“. I luigini furono da subito malvisti dal Re di Sardegna e dal Re di Francia, che probabilmente volevano impedire la circolazione sul loro territorio di monete che sfuggivano al loro controllo e alle loro tasse. Inizialmente ebbero invece grande successo in Oriente, dove furono molto richiesti e ricercati per le loro caratteristiche di praticità; questo spinse i monaci ad aumentarne la produzione, riducendo però al contempo il loro quantitativo d’argento; col tempo, perciò, anche in Oriente i luigini di Seborga finirono col decadere. Nel 1679 al Bareste succedette Silvan Condaz e a quest’ultimo a sua volta, nel 1686, il coniatore Jean D’Abric. Quest’ultimo, tuttavia, venne accusato di fabbricare monete false e pertanto, dopo una protesta del Re di Francia, il conio delle monete fu sospeso e non riprese più. La Zecca del Principato di Seborga rimase perciò formalmente attiva dal dicembre 1666 all’ottobre 1687, anche se non sono noti luigini prodotti dopo il 1671. Il materiale atto alla coniazione delle monete fu poi ceduto nel 1719 dal Podestà di Seborga Giuseppe Antonio Biancheri alla Repubblica di Genova, a parziale rimborso di un precedente debito che i monaci avevano contratto proprio con quest’ultima nel 1584. Ai giorni nostri sono pervenuti soltanto dodici luigini, che sono classificati come “rarissimi” e riscuotono un grandissimo interesse numismatico. Quattro esemplari fanno parte della raccolta numismatica del Re Vittorio Emanuele III (si tratta delle monete che l’Avvocato Lea spedì al Re di Sardegna Vittorio Amedeo II nel 1729, quando, in relazione alla vendita del Principato ai Savoia, fece un sopralluogo a Seborga), uno si trova presso l’Archivio di Stato di Torino, due presso il Museo Imperiale di Vienna, uno all’Hôtel de Ville di Marsiglia, uno all’Hôtel de Ville di Lione e tre sono infine in possesso di privati. Luigino del 1667 Luigino del 1668 Luigino del 1669 Luigino del 1671 I luigini del Principe Giorgio I Un nuovo impulso all’attività numismatica e, stavolta, anche filatelica viene dato dal Principe Giorgio I, che nel 1995, con il decreto 28/02/95, ristabilisce l’antico diritto mai abrogato a coniare proprie monete. Al luigino viene attribuito il codice identificativo SPL. Il tasso di cambio è fissato in relazione al dollaro statunitense: 1 SPL = 6 USD (facendo clic qui è possibile accedere a un convertitore online che consente di calcolare il tasso di cambio del luigino con altre valute); secondo alcuni esperti questo farebbe del luigino l’unità monetaria con il più elevato valore al mondo. Il 12 marzo 1995 viene realizzata la prima emissione di 2500 prototipi di luigini numismatici con millesimo 1994. Il 23 aprile dello stesso anno viene invece emessa la serie circolante di monete con millesimo 1995, composta da 5 e 15 centesimi, da mezzo luigino e da 1 luigino. Ai votanti al Referendum del 23 aprile 1995 per l’approvazione degli Statuti Generali viene anche donato un luigino numismatico millesimo 1994. Il 14 giugno 1995, in occasione del compleanno del Principe Giorgio I, viene emessa una moneta da collezione da 7 luigini e mezzo. Tale moneta, realizzata in argento 999, ha un peso di 31,1 g, equivalente a un’oncia. Il 17 agosto 1997 viene emessa, sia in versione circolante sia in versione in argento 999, una nuova moneta da 2 luigini con millesimo 1996, celebrante la Proclamazione di Indipendenza del 20 agosto 1996. La moneta ha anche vinto un premio per l’effigie del Principe Giorgio I, realizzato con particolare realismo e in posizione frontale, scelta piuttosto rara in ambito numismatico. Sempre nel 1997 viene infine emessa, sia in versione circolante sia in versione in argento 999, una moneta da 10 centesimi in onore di San Bernardo di Clairvaux , fondatore della Povera Milizia di Cristo. La coniatura dei luigini è stata realizzata per conto del Principato di Seborga dalla Zecca di Verrès (Aosta). Riepilogo delle emissioni di luigini realizzate sotto il regno del Principe Giorgio I Emissione del Monete emesse Millesimo Note 12 marzo 1995 1 luigino 1994 Da collezione 23 aprile 1995 5 centesimi 15 centesimi mezzo luigino 1 luigino 1995 1995 1995 1995 Circolanti Circolanti Circolanti Circolanti 14 giugno 1995 7,50 luigini Riconii: 1 luigino 1995 – 1995 Da collezione – Da collezione 17 agosto 1997 2 luigini Riconii: 1 luigino 15 centesimi 1996 -k 1996 1996 Da collezione e circolanti – Da collezione e circolanti Circolanti ??? 1997 10 centesimi 1996 Da collezione e circolanti1 punto
-
Vi propongo un piccolo indovinello. Che edificio (e naturalmente di che città) è quello nella stampa che allego? Ma probabilmente questa domanda è facile per cui non mi accontento e voglio sapere a che servono i vari ambienti da A a N e i relativi macchinari in essi abbozzati?1 punto
-
Gettone della serie di gettoni franco-allegorici del 1589 a firma di Hans Krauwinckel II (master nel 1562) D/ Tisbe che si trafigge con una spada: di fronte il corpo steso a terra di Piramo giacente ai piedi di un gelso: in esergo: HANNS . KRAV PIRAMVS ET THISBE R/ Soldato con elmo (Cesare) in piedi a sinistra, armato di lancia: ai suoi piedi un trofeo: in esergo: H . K . AVT CAESAR AVT NIHIL. Rame: 4,928 g, 27,5 mm. Il gettone, che ha come tema il mito di Piramo e Tisbe, nella versione in ottone è pubblicato dal Mitchiner in Jetons, Medalets & Tokens – The medieval period and Nuremberg, Seaby 1988, vol. I, p. 455. apollonia1 punto
-
Salve a tutti, ho trovato un cavallo di Ferdinando I d'Aragona con la seguente iscrizione: D/: FERRANDVS ○○○○ REX; Re di profilo R/: EQVITAS ○ RE ○○ GNI; ❁ sopra cavallo; ❁ T ❁ in esergo Nel CNI ho trovato tantissime varianti ma non questa particolare variante. Quella che più si avvicina è: 1088: FERRANDVS ○ ○○○ REX / EQVITAS ○ RE ○○○ GNI ma con tre cerchietti invece che due tra "RE" e "GNI" e dello spazio tra il 1° e il 2° cerchietto al diritto. Pensate che questa particolare disposizione dei cerchietti sia un elemento di qualche interesse, o è irrilevante, vista la grande variabilità dell'iscrizione? Un saluto, Luca1 punto
-
mi date un parere sul grado di conservazione di questa moneta? grazie. saluti elio.1 punto
-
Buona sera a tutti. Posto di seguito la foto di una monetina in mistura che avrei classificato come nel titolo. Non essendo assolutamente esperto di questa monetazione, chiedo cortesemente conferma o suggerimenti. Colgo l'occasione anche per pareri sulla conservazione, che a me sembra un bel BB o poco più. Grazie. Cordialità. Renzo @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 punto
-
Da un noto commerciante,qualche giorno addietro ho visto quello bel asse di Domiziano raffigurante al rovescio la scena religiosa dei Ludi Saeculares dell'anno 88....sapete darmi maggiori informazioni dal punto di vista storico numismatico?grazie1 punto
-
@@iachille è una croce patente ancorata con globetti ad ogni estremità, mi sembra sia lo stesso esemplare del listino della num .Picena 3/2011 lotto456, R4, ti mando una mail, p.s. D.A. -1 punto
-
Buonasera, Premetto di essere totalmente inesperta di documenti antichi. Sperando di trovarmi nella sezione giusta?, Vorrei avere il vostro parere su questi antico documento datato 1797. Sembra autenticare quell'anello in pietra (forse alabastro) al cui è unito da unbastro. Allego foto1 punto
-
Lo crediamo in due allora!! Piccolo appunto: Pio VI, non IV.. Buona serata e benvenuto tra noi Alex! Antonio1 punto
-
@@dabbene mi fa molto piacere leggere che ti piacciano queste iconografie del 500/600 Fiorentine, come avraì notato la posa del San Giovanni in quella serie della piastra di Francesco rimane iconograficamente molto simile alle pose greche e di torsioni muscolose corporee simili al grande Michelangelo. se non ricordo male la tomba del Francesco dei medici riposta nella chiesa di San Lorenzo fu proprio fatta dal Michelangelo pochi anni dopo nel 1587. non finita mai del tutto pochi sanno questa cosa. Saluti Fofo1 punto
-
Ops, non credo di aver detto questo, devo essermi spiegato male. Le opinione di @@gigetto13 sono legittime ovviamente, ma non sono una conseguenza 'obbligata' di quanto volevo dire. Comunque la questione si sta facendo un po' troppo complessa per poter essere trattata in poche parole. Mi permetto solo alcune precisazioni, per evitare confusioni, innanzitutto Latisana era un feudo assegnato ai Conti di Gorizia dai Patriarchi di Aquileia, ma questo feudo non prevedeva il diritto di conio, ce lo dice un arbitrato del 1202, da me già citato sopra. Nessuna regalia inerente a questo feudo, comunque, poteva essere trasferita dai Conti ai 'Latisanotti', per la semplice ragione che questi ultimi non erano un'entità giuridica in grado di esercitare diritti feudali. Il diritto di conio, ancorché probabilmente usurpato, era evidentemente esercitato assieme agli altri diritti del feudo dai Conti attraverso propri funzionari, come a Lienz (v. emissioni con Liunzialis), dove i Conti risiedevano. Diritto di conio e appalto sono due cose totalmente diverse: il prima rappresentava il trasferimento revocabile di un diritto regale (regalia) ad una autorità periferica su concessione del re stesso o di un altro concessionario (qualora questa possibilità fosse prevista dalla concessione originale del re); il secondo è solo l'affidamento temporaneo a terzi, dietro compenso, di un'attività 'pubblica' da parte di di chi detiene i diritti di quell'attività (diritti che non vengono certo ceduti all'appaltatore); né più né meno degli appalti odierni da parte dello stato. Nel Medioevo normalemente le zecche erano appaltate a privati, con la grande eccezione di Venezia e Firenze Confermo quanto appena detto da Arka sul potere dei patriarchi nel territorio carinziano, anche se questi indubbiamente possedevano dei feudi in zona mineraria che garantivano loro rendite in argento (anche perché all'epoca provenivano da grandi famiglie feudali tedesche), ma nulla di paragonabile alle rendite el Vescovo di Salisburgo Forse non ho capito bene la distinzione fra germanici, cattolici, austriaci, che mi sembra adatta al periodo successivo alla Riforma ed al concilio di Trento, non al XII secolo. Allora e fino alla metà del XIII secolo i Patriarchi, gli Austriaci, i Goriziani, i feudatari friulani erano tutti tedeschi e cattolici, per quanto ne so. Saluti, Andreas1 punto
-
Sei già caduto credo.... Buon per te e benvenuto ! Bello ricevere un piccolo ma significativo regalo di questo genere, ciao.1 punto
-
Buona domenica E’ un tappo sigillo in buono stato di conservazione della teriaca che era dispensata dalla spezieria in Campo S. Lio, poco distante dal Ponte di Rialto, che nei test troviamo denominata ‘Il Pellegrin’ o ‘Al Pelegrino’ o ‘Del Pellegrino’. La raffigurazione frontale di un pellegrino si deduce dal cappello e dal bastone. La scritta non è chiaramente leggibile (sulla sinistra mi sembra di intravedere VENICIA). La farmacia oggi in attività in Campo S. Lio si chiama ‘Al Pellegrino’. apollonia1 punto
-
DUBOIS CHATELERAUX, Michel Gravures Réprésentant les differentes Machines servant à la Fabrication des monnoyes au Balancier, construites à Venise pour le service de la Serenissime République. Presentèes à S.A.R. Monseigneur l'Infant Dom Philippe Duc de Parme &c par l'Auteur Directeur Général des Monnoyes de Parme...1 punto
-
Cari tutti, io colleziono lire della Repubblica e mi ero posto proprio lo stesso dubbio di recente. In sintesi, reperendo pareri qua e là qui sul forum, mi azzardo a sintetizzare senza pretesa alcuna, solo per dare una mano a chi è più nuovo di me: - un orientamento di pensiero sostiene che i cataloghi fanno previsioni sull'andamento delle contrattazioni, cosa del resto ovvia perché alcuni di essi sono editi in luglio e non a chiusura di anno solare - es. un noto catalogo 2016 già è in vendita; - un'altra linea di appassionati, molto pratica, giudica che i valori, in sostanza, sono piuttosto dei massimi e vanno comunque quasi sempre presi "con le molle" - corollario di questa tendenza è che i valori esposti vadano decurtati, in media, del 30-40% all'atto pratico; - infine un orientamento è molto critico e afferma che, pur acquistando il catalogo per la validità delle informazioni in esso contenute, tuttavia non considerano i prezzi esposti. Quindi senza complicare troppo il discorso con considerazioni di microeconomia, editoria numismatica ecc. ecc. il vero problema secondo me è: quanto i valori di catalogo incidono sulle contrattazioni reali?? E qui non so assolutamente dare risposta, quindi lascio la parola agli esperti Saluti1 punto
-
Certamente argomento complesso ma per arrivare a delle conclusioni o ipotesi credo che la contrapposizione sia deleteria. Ringrazio Luciano Giannoni di averci esposto alcune argomentazioni, dove parla di verosimiglianza e verosimiglianza è un termine preciso. L' Elba ha una configurazione geografica e vicissitudini storiche che la portano ad essere al centro di tante situazione nel tempo, vicinanza al continente, le miniere, le rotte commerciali e anche di solo passaggio, i centri collocati su postazioni su rilievi per difendersi meglio, credo che non tutto sia ininfluente , se ci aggiungiamo che gli Appiani avevano due residenze una a Piombino e una all'Elba e che bisogna anche considerare i mezzi e il prestigio che avevano, ne esce un quadro che può offrire ulteriori fasi di approfondimento. La questione zecca, monete coniate dovrebbe essere di pertinenza o di numismatici o archeologi con specializzazione numismatica perché se è vero che non ci sono monete che portano espressamente leggende che ci fanno pensare a una coniazione in loco, il documento moneta è un documento che va interpretato in ogni, anche la più piccola componente, vedi segni, conii, iconografie e altro ancora....va letta e interpretata e quindi ci possono essere serie diverse e documentate e da studio e qualcosa è uscito anche qui sul forum. Poi ovviamente il dibattito scientifico, ma anche la ricerca di studiosi privati è auspicabile, le possibilità di ricerca si ampliano.... Detto questo mi limito a quello che so e leggo, a Lucia Travaini che nel suo recente libro sulle Zecche Italiane, alla voce Marciana riporta " Secondo Zanetti Marciana sarebbe stata sede di un'officina di zecca dei principi Ludovisi di Piombino nel XVII secolo , tale attività sarebbe supportata da altra documentazione citata da Bianchimani ( Liste p.96 ). Più che una sede di coniazione avrebbe potuto trattarsi di una sede per fasi preliminari di lavorazione dei metalli estratti nell'isola, prima dell'invio alla zecca." C'è anche da aggiungere come dice Giannoni che il rame però arrivava dal continente e che uno come Zanetti anche se nel 1700 si sbilanciò qualche cosa di concreto l'avrà pure avuto in mano... Mi fermo qui, credo che potrebbero esserci altre puntate, almeno me lo auguro, certamente va incoraggiato chi cerca di trovare altre fonti e che propone ipotesi ed evidenze...lo scambio e le informazioni per la ricerca devono essere sempre condivise e incoraggiate comunque sia...1 punto
-
in alta conservazione, a mio parere, non lo è di sicuro. I rilievi più alti sono usurati e qualche solchetto è presente1 punto
-
moneta compromessa aimè....miracoli nn si possono fare, ma mettila 3 giorni nell h2o distillata e poi spazzolala molto legermente, dopo attenta asciugatura mettila 3 giorni nell olio di vasellina, poi la asciughi e vedi il risultato. (dopo l'olio se vuoi puoi ulteriormente spazzolarla leggermente e pulirla con un panno...ma solo se serve) Consiglio personale. io userei solo acqua ossigenata 20 vol per togliere la terra in eccesso, e poi il procedimento che ti ho detto. Se la foto inganna e le incrostazioni non sono terra solidificata ma calcare verdognolo (oddio che termine "tecnico") fai cosi: Alcuni, a volte anche io devo essere sincero, le fanno fare dei bagni nell'EDTA, (anche se non in argento) ma OCCHIO.... tende a spatinare, quindi se proprio vuoi leggere qualcosa in piu sulla monetina fallo, ma solo su monete come queste che ormai.... Bagni di 5 o 6 minuti massimo.....e vedi come va.... Puoi anche lasciarla cosi e mettere solo un leggero strato di olio che ne risalta i contorni....e poi via nel portamonete (prima asciugala). ciaoooooooooooo ps: se vuoi rovinare la monetina dal tutto usa: aceto, limone, viakal, acido muriatico, paglietta in ferro, lima, cartavetrata, smerigliatrice, lapidello, e poi il cestino.... :crazy:1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
A me qualche dubbio resta... purtroppo giudicare una foto è sempre difficile. Arka1 punto
-
Ho aspettato qualche giorno prima di intervenire perchè sin dagli inizi di questa penosa querelle ho cercato di evitare di inserirmi in una polemica francamente sgradevole. Tuttavia, sia per la stima che ho per gli amici @@dabbene e @@margheludo, sia per non dare l'impressione di non avere argomenti per replicare, mi provo a scrivere, in breve sintesi, le ragioni per le quali ritengo che, con molta verosimiglianza, l'ambiente restaurato ed attrezzato come piccolo Museo didattico-numismatico facesse parte dell'officina monetaria marcianese. Ho sottolineato questo punto perchè lo Zecchini usa un suo metodo scorretto e assolutamente indegno per un auto proclamato "archeologo di fama internazionale" - e qui magari un pizzico di insperabile modestia non sarebbe male - consistente nel far dire all'interlocutore cosa mai dette, per poi contestarle. Un primo esempio (cito da margheludo): <la creazione di una zecca per battere moneta” si deve a Donna Paola Colonna, divenuta moglie di Gherardo Appiano nel 1396. La mia acculturazione è proseguita con la lettura dei documenti elaborati di recente per lo stesso Comune di Marciana dai suoi consulenti, i quali affermano che la zecca “è databile alla fine del XVI secolo”. È vero che fra queste due versioni c’è un po’ di bisticcio cronologico (più o meno 150 anni di differenza), ma evitiamo di spaccare il capello in due: l’importante è che la zecca ci sia stata>. Poichè in realtà sono io il soggetto degli strali dell' "archeologo di fama, vorrei aggiungere, planetaria", avendo fatto da consulente in materia per il Comune, mi preme precisare che mai ho scritto, sostenuto, sussurrato o anche solo pensato che la zecca si deve a Donna Paola. Se qualcuno, sul sito del Comune ha scritto una bischerata questa va presa per quello che è, un palese - e spero ingenuo - svarione. Altra "zecchinata". Nessuno ha mai detto che il supposto ipogeo fosse "l'officina della zecca" ma più ragionevolmente ho sempre sostenuto che facesse parte dei vari ambienti costituenti l'officina della zecca. E' vero, non esistono prove "dirette" dell'esistenza al piano terra del così detto Palazzo Appiani, a parte una persistente vox populi e le indicazioni del buon Zanetti che certamente non era quel coglionazzo come lo vorrebbe far apparire lo Zecchini (celeberrimo archeologo utriusque oceani). Esistono però due argomenti robustamente "indiziari" (ricordo che il processo indiziario è parte integrante del sistema processuale). Primo argomento. Poichè le monete battute dalla Zecca piombinese erano prevalentemente quattrini (CU), crazie (MI) e mezzi giulij (AR), mentre l'argento poteva essere reperito nelle due enclaves medicea (Cosmopoli)e spagnola (Longone) il rame veniva dal Continente e poichè la navigazione nel canale era piuttosto rischiosa sia per le condizioni del mare che per i vari pirati, furfanti e simile genia che infestavano quelle acque, era assai meno oneroso perdere una nave che portava all'Elba da Piombino del rame che non un carico di rame già monetato (le motivazioni sono ovvie e non mi ci dilungo). Secondo argomento. Se si escludono le grandi città o capitali (Venezia, Firenze, Milano, Roma, ecc.) nei piccoli staterelli l'officina della zecca era sempre all'interno del palazzo residenziale del Principe o Signore (anche qui è superfluo spiegare il perchè); caso appunto del Principato di Piombino che aveva due residenze: una a Piombino ed una - estiva - a Marciana. E veniamo al <fatto che nell’Archivio Storico di Marciana non sia stato rinvenuto alcun documento> in merito alla zecca e/o ai lavori. Un "archeologo di fama universale ed anche di più" dovrebbe sapere che la Zecca non era di pertinenza della Comunità, ma , come già detto,era proprietà personale del Principe; le vicende del Principato piombinese, se attentamente conosciute, chiariscono bene perchè tali documenti, assieme a tanti altri, siano andati dispersi. Non a caso nell'Archivio storico del Comune di Piombino, che contiene tutti i documenti relativi alle vicende e attività delle varie Comunità facenti parte del Principato, non esiste alcun documento relativo alla sede e/o all'attività della Zecca piombinese (che almeno quella c'era!). Con questo spero di non dovermi più occupare di polemizzare con il "più grande archeologo dell'Universo in espansione (come il suo Ego)" e continuare a ricercare documenti e pubblicare lavoretti sulla monetazione piombinese, su PANORAMA NUMISMATICO, IL GIORNALE DELLA NUMISMATICA e MARITIMA (così anch'io tento di aspirare almeno al titolo di "numismatico di fama rionale"! Non voglio dilungarmi troppo sulla questione "ipogeo etrusco" per non tediare, precisando solamente che nel catasto Leopoldino il toponimo "la tomba" si trova in un campo a sinistra ed in alto rispetto al palazzo dove i Principi risiedevano. Se poi non siete stati sommersi dalla noia e vorrete approfondire la cosa potete inviarmi la vostra mail e sarò lieto di fornirvi ampia documentazione.1 punto
-
In attesa degli esperti della monetazione, dico la mia impressione Petachina di Tommaso di Campofregoso 1436-42 http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-GEV18/6 non leggo la sigla1 punto
-
1 punto
-
Ciao sembra un Gloria exercitus..tipo questo di Costantino il Grande1 punto
-
1 punto
-
Leggo un sacco di interventi che non c'entrano nulla con tutto ciò che è stato chiesto all'inizio. Le leggi ci sono, sono chiare e sono state esposte, pertanto trovo inutile dover continuare a battibeccare sulle solite questioni. Ci sono troppi sordi e ci sono troppi chiacchieroni. Mi sembrate il videogioco "PONG" con un muro in mezzo. :D Diamoci una calmata, torniamo in tema, nessuno istighi a disobbedire alle leggi, nessuno derida chi OBBEDISCE alle leggi ecc ecc. Giusto per dare una nuova occasione a questa discussione, l'autore, lucarosina, che peraltro ha smesso di scrivere 5 pagine fa: Questa era la sua domanda. Tutto ciò che esulerà (lecita provenienza e blablbala) sarà oscurato per una maggiore comprensione futura di questa discussione riguardante QUESTO argomento sopra citato. Grazie a tutti per la comprensione.1 punto
-
Io non capisco il senso di iscriversi, fare una domanda e dopo 1 un minuto scollegarsi per poi sparire. Sempre più spesso vedo questi episodi, certo, ognuno può avere i suoi motivi per non collegarsi anche per mesi, ma queste situazioni non le ho ancora capite. Spero che ritorni l'utente a collegarsi così possiamo capire bene anche noi di che moneta si tratta, perché ritengo che sia interessante il ritrovamento di una proof in circolazione, se mai lo fosse.1 punto
-
Concordo con la classificazione già proferita, aggiungo soltanto che si tratta di una monetina rara, in quanto sono assenti le sigle "C/FC" al dritto (MIR 212/P-R n.20) , ed un giusto prezzo di acquisto, considerando la conservazione abbastanza sopra la media, sia compreso tra i 100 e i 130 euro.1 punto
-
1 punto
-
L'ho sempre detto, che con le commemorative: normali - argento - oro, chi ci guadagna è solo chi le emette. Perchè una volta acquistate è difficile rivenderle al prezzo d'acquisto. Almeno nella maggioranza dei casi.1 punto
-
Questo miracolo ha un evento similare anche nell'Italia Meridionale: la Madonna dell'Arco a sant'Anastasia, alle falde del Vesuvio e all'ombra del Monte Somma. L’inizio del culto è legato ad un episodio avvenuto il 6 aprile del 1450: il lunedì dopo Pasqua, il giorno della cosiddetta ‘Pasquetta’, giorno in cui si fa la gita “fuori porta” (una scampagnata con gli amici nelle vicinanze del paese), nei pressi di Pomigliano d’Arco, alcuni giovani stavano giocando a “palla a maglio” (attuale gioco delle bocce) e un giocatore durante la partita fece andare la palla finiva contro un tiglio, i cui rami ricoprivano in parte l’arco di acquedotto su cui era dipinta una immagine della Madonna con il Bambino Gesù (da questi archi vengono i nomi di Madonna dell’Arco e Pomigliano d’Arco), perdendo la partita e arrabbiatissimo prese la palla e bestemmiando la scagliò contro l’immagine sacra, colpendo la Madonna sulla guancia sinistra, che prese a sanguinare. Si gridò al miracolo e una moltitudine di gente accorse in zona. La notizia arrivò al conte di Sarno, che aveva il compito di "giustiziere" e dietro il furore del popolo processò e condannò il ragazzo all’impiccagione. Il giovane venne impiccato al tiglio vicino all’edicola, che due ore dopo, ancora con il corpo penzolante, rinsecchì sotto lo sguardo della folla sbigottita. Questo episodio miracoloso suscitò il culto alla Madonna dell’Arco, che si sparse subito in tutta l’Italia Meridionale; folle di fedeli accorrevano continuamente sul luogo del miracolo, per cui fu necessario costruire, con le offerte dei fedeli, una cappella Il 1° maggio 1593 fu posta la prima pietra dell’attuale Santuario e già dall’anno seguente subentrarono a gestirlo e lo sono tuttora, i padri Domenicani. Il tempio sorse tutto intorno alla cappellina della Madonna, la quale, nel 1621, fu restaurata ed abbellita con marmi; l’immagine dopo questi lavori, fu in parte coperta da un marmo, per cui rimase visibile solo la parte superiore dell’affresco, il mezzo busto della Madonna e del Bambino. Nel mese di marzo del 2000, al termine dei lavori di restauro dell'intero tempietto, è stato tolto il pannello di marmo, così è possibile di nuovo ammirare il dipinto nella sua interezza come doveva apparire la Madonna nel '400 ai viandanti che vi passavano dinnanzi. Il Santuario raccoglie nelle sue sale e sulle pareti, migliaia di ex voto d’argento, ma soprattutto migliaia di tavolette votive dipinte, rappresentanti i miracoli ricevuti dagli offerenti, che costituiscono oltre la testimonianza della devozione, una interessantissima carrellata storica e di costume del passato.1 punto
-
Una notizia per gli amici ‘triacanti’. Sapevate dell’esistenza di un timbro della teriaca? Io ne sono venuto a conoscenza solo ora. Questo timbro era usato con tutta probabiltà come sigillo per confermare che il farmaco era genuino. La scritta in alto sul timbro (in negativo) si legge sulla foto di destra e indica la spezieria teriacante. La scritta in basso sul timbro è “THERIACA FINA IN VENEZIA” e in seconda riga “Sopra il Campo di S. Bartolomeo”, quindi diversa da quella sulla foto che riporta il nome del titolare della farmacia. La raffigurazione è quella della Madonna con Gesù Bambino e ai lati i leoni alati di san Marco. Chissà se anche altre spezierie avevano il timbro con la loro insegna. apollonia1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?