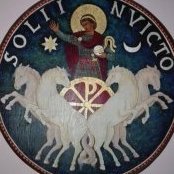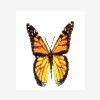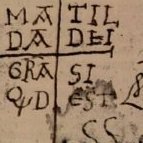Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 11/01/16 in Risposte
-
Voglio segnalare le rarissime monete genovesi con il motto IN HOC SALVS MVNDI che, secondo me, facevano il verso al motto coniato dai Savoia IN HOC EGO SPERABO. Genova aveva comprato segretamente il marchesato di Zuccarello e quando i Savoia ne vennero a conoscenza, infuriati scrissero una lettera minacciosa alla Repubblica di Genova nell’8 aprile 1624. Genova … secondo la mia ipotesi… con troppa spavalderia ignorò le minacce e per tutta risposta coniò una serie di monete con quella legenda, tutte datate 1624. L’anno seguente Carlo Emanuele I insieme ai Francesi attaccò, ma, per varie casualità favorevoli ai genovesi, fu inspiegabilmente sconfitto presso i Giovi il 10 maggio 1625.5 punti
-
Che piacere leggere le emozioni di tutti... Oggi offro anch'io la via per la conoscenza... MANTOVA Francesco III duca di Mantova II e marchese del Monferrato II, reggenza della madre Margherita Paleologo, 1540-1550. Testone leggero, AR 5,98 g. FRAN•DVX•MAN•II•ET•MAR•MON•F• Busto infantile a s. Rv. VIAS·TVAS·DOMINE·DEMOSTRA·MIHI trifoglio L’Arcangelo Raffaele reca per mano il piccolo Tobia, al quale indica la via da seguire; il fanciullo stringe nella s. un grosso pesce. CNI 13. ENH 246. Ravegnani Morosini 3. MIR 492 (R/4). Figlio di Federico II e di Margherita Paleologa, Francesco III aveva solo 7 anni quando, alla morte del padre, venne acclamato duca di Mantova. In attesa della maggiore età, il governo fu retto dalla madre Margherita Paleologa e dagli zii Ercole e Ferrante, nominati suoi tutori. L'imperatore Carlo V concesse l'investitura il 28 giugno 1543. Nella stessa occasione furono concordate le nozze del giovane duca con la nipote dell'imperatore, Caterina d'Asburgo, figlia di Ferdinando. Le nozze si svolsero il 22 ottobre 1549, al compimento dei 16 anni. Purtroppo la vita coniugale fu di breve durata: un paio di mesi dopo l'arrivo a Mantova di Caterina, durante una battuta di caccia il duca cadde nelle gelide acque del lago, ammalandosi di polmonite e di li a poco morì. La successione ducale passò a Guglielmo, fratello minore di Francesco, ancora sotto la tutela della madre e degli zii. VIAS·TVAS·DOMINE·DEMOSTRA·MIHI ( et semitas tuas edoce me ) : Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.... Io sono l'angelo Raffaele, uno dei sette che stanno davanti al Signore. È ormai tempo che io torni a Colui che mi ha mandato; voi dunque benedite Dio e fate conoscere a tutti le Sue meraviglie”. Eros4 punti
-
ah beh, Mario @dabbenemi inviti a nozze! Quando nel 1570 mancavano ormai poche settimane alla sconfitta totale e terribile dei Veneziani a Cipro, circondati da decine di migliaia di Turchi, il Bragadin volle far coniare una moneta di necessità, il Bisante, per i commerci interni di Famagosta. Sotto un genio alato, probabile ricordo della classicità dell'isola, si legge una frase che descrive benissimo lo stato d'animo degli assediati cristiani: VENETORUM FIDES INVIOLABILIS... come a dire: se anche ci abbatterete, la nostra fede rimane inviolabile. Per chi volesse saperne di più, nella Biblioteca del forum c'è un articolo che tratta di questo pezzo.3 punti
-
Buonasera mi piacerebbe leggere qualche vostro commento circa la conservazione e la tonalita' del colore saluti, Max2 punti
-
2 punti
-
Venezia volle il suo ducato in oro fino quanto e più del fiorino fiorentino. la marca di metallo doveva essere: "tam bona et fina per aurum, vel melior, ut est florenus". Il Papadopoli scrive che i saggi moderni (a cavallo del 1900) rendono un titolo di 0,997; quanto di meglio si riuscisse ad ottenere nel medioevo. Sul fiorino di firenze ho trovato in rete notizie abbastanza confuse: chi gli attribuisce un generico "24 carati", chi un titolo di 1000 (ns. catalogo), o generalmente d'oro puro. Credo comunque che fossero simili!2 punti
-
Riporto direttamente dal Muntoni "prima del deteriorameto del fiorino di Firenze i due nominali [fiorino e ducato] erano metrologicamente identici". Come intrinseco siamo in ambedue i casi intorno ai 998/1000.2 punti
-
So di navigare in acque perigliose, visto che sono ignorante di questa monetazione; però c'è un dettaglio che reputo importante, seppur indiretto. Non si tratta ovviamente di conoscenza specifica, ma forse più a logica ed è dettata da informazioni di circolazione monetaria del ducato veneziano. E' risaputo che il ducato vide la sua nascita in ritardo nel 1284, rispetto al genovino ed al fiorino e non fu subito ben accettato nelle transazioni importanti da altri stati, soprattutto quelli del centro/sud Italia. Dal libro di A. Stahl - La zecca di Venezia nell'età medioevale - possiamo leggere che nel 1339, gli esattori papali in Lombardia, riscossero decime per 2.500 ducati, ma li dovettero cambiare in fiorini, pagando un aggio, perché la Curia romana non accettava ducati! Se poi continuiamo la lettura, scopriamo che vescovi, arcivescovi, cardinali disseminati nell'Italia del nord, intorno al 1340, avevano un patrimonio censito in monete d'oro, dove la presenza del ducato veneziano era una piccola percentuale rispetto al fiorino. Allora come potrebbe essere che la Curia romana, in quest'epoca, non accettasse i ducati veneziani e pretendesse che fossero cambiati in fiorini, per poi mettersi a coniare un loro ducato imitativo del veneziano? Per questo motivo ritengo anch'io che il ducato senatoriale romano abbia visto la luce solo successivamente. saluti luciano2 punti
-
Buon pomeriggio Acch ..... siete andati a scovare i ducati a nome di uno dei dogi più controversi (e per me interessante e che mi "piace") e non solo sotto il profilo storico. Non darei per scontato che quello postato da @fabry61 e quello successivo postato da @rorey36 siano imititivi; credo anzi che meritino un supplemento di indagini, pur salvaguardando la loro diversità .... (in verità il primo mi da più dubbi del secondo ). La verità è che i ducati a nome dell'Agostino subirono una involuzione stilistica rispetto a quelli emessi dal suo predecessore e fratello Marco; diciamola tutta ..... sono bruttini e non solo; si vede anche una certa confusione di indirizzo, una indecisione.... nella gestione degli spazi per inserire il nome del doge. Dal mio scritto sul ducato: "Si veda la figura del Doge Marco nel Ducato; il viso è espressivo e più realistico, il “corno” ha assunto la sua forma definitiva e più conosciuta, i suoi paludamenti rispecchiano il costume simbolico che indossava nel XV secolo il Doge e che possiamo riassumere come segue: la tunica con le maniche alla “ducale”, cioè larghe e non più strette ai polsi; il lungo manto foderato di pelliccia; la “mozzetta” non è più uno stretto collare, ma diventa ben più lungo e avvolgente; è una vera “mantellina” in ermellino; la “rensa” si rimpicciolisce ed è assente il caratteristico fiocco che la lega sotto il mento; l’aureola del Cristo, nel rovescio, sembra coincidere con la “mandorla” ed in parte vi sta inscritta; i piedi sono ancora parzialmente all’esterno della stessa. Nel ducato del fratello Agostino Barbarigo (1486 – 1501), si nota un ritorno ai caratteri precedenti; il “corno” è approssimativo e la “rensa” torna ad essere inequivocabilmente annodata sotto il mento; torna anche la mozzetta nella sua forma arcaica al posto della “mantellina”. Al rovescio l’aureola del Cristo resta stabilmente all’interno della mandorla ed i piedi si sovrappongono ad essa". Di ducati a nome dell'Agostino, poi, ce ne sono più tipi; il primo riporta il suo nome abbreviato, come in quello postato da Fabrizio e che termina alle spalle del doge inginocchiato; c'è poi il tipo che il nome lo porta per intero, come già avvenuto ai tempi del doge Vendramin, costringendo il preparatore del conio ad elevare la figura del doge, rimpicciolire la bandierina in cima all'asta e permettere che il nome continui sotto la figura. C'è poi una "via di mezzo" come quella dell'asta Sincona postata da Roberto? In successione posto il ducato di Marco Barbarigo; quelli di Agostino li avete messi già, ma ne aggiungo un terzo, ancora differente.... saluti luciano2 punti
-
2 punti
-
Bhe, questo potrebbe averlo realizzato euaineto alle elementari, quando aveva 6/7 anni.... Faccio un salto nell altra discussione... Come già detto, è una moneta che mi sarei guardato con calma. Impossibilitato a ciò, non la comprerei ne su ebay ne altrove. Rispetto i vostri pareri,rispettate pure il mio.. Skuby2 punti
-
Niente da fare, per questa monetina nel web ho trovato solo falsi dell'introvabile 1913. http://www.lamoneta.it/topic/92074-a-nickels-story/ e a tal proposito2 punti
-
allego foto dello stemma mediceo coronato del mercato sotto le logge a Pisa voluto da Ferdinando dei Medici, foto del Granduca e descrizione del Di Giulio del periodo del suo Governo che fu indubbiamente il migliore e fiorente del periodo Toscano, sia per gli sviluppi economici che espansionistici, basti pensare che lui voleva conquistare e colonizzare l'America, importava il grano dall Egitto, sviluppo Livorno e bonificò molte paludi e terre. innumerevoli le statue a Pisa che lo ritraggono..2 punti
-
@babelone @gionnysicily Ok. Pace fatta, dai... nessunissima polemica e massimo rispetto per tutti. Devo anzi obiettivamente ammettere che gli ultimi post adducono argomenti veramente convincenti a favore della genuinità della moneta...2 punti
-
Ciao Mario Hai ragione sul fatto che le oselle degli ultimi decenni di vita della Serenissima, varrebbero una discussione specifica. Riguardo a quella che hai postato ha un "tranello", una sorta di messaggio subliminale a favore del nostro doge. Come altre volte è stato scritto, l'immagine del doge regnante o il suo scudo araldico, effigiati sulle monete, erano un "tabù" e lo stesso vigeva anche sulle oselle; però in queste ultime si concedeva la possibilità di richiamare, oltre al nome del doge, anche un elemento che ricordasse il suo casato ...... ma senza strafare e che non fosse troppo esplicito. Come non ricordare le varie rose esibite nelle oselle dei vari dogi Mocenigo, che avevano due rose nel loro stemma araldico? (vedi post 145) In questo caso l'acquila non è l'impersonificazione di Venezia (il leone marciano non poteva né aveva sostituiti, bastava e avanzava ..... ) l'aquila è il Valier e ci ricorda il suo stemma araldico. Il buon Bertucci ha fatto il "furbino" .... ha messo l'aquila del suo stemma a combattere contro il dragone, come dire ..... "Merito mio"! saluti luciano2 punti
-
Buona Giornata Grazie Alessio! Che si possa vedere solo un lato delle monete è un peccato ..... peraltro pochissimi musei espongono monete che si possono ammirare in entrambi i lati. In questo caso sarebbe stato tanto più importante, viste le caratteristiche di queste monete; ad esempio il SOLDO mostra il lato comune a tutti i soldi da 12 bagattini di questo tipo, la particolarità sta nell'altro lato, che non vede San Marco, ma la donna assisa in trono come si vede nella Gazzetta. Peraltro il Lazari adombra la possibilità che questo soldo (in verità esistono due esemplari al Correr) sia una sorta di prototipo che non ebbe seguito ...... eppure, guardando la moneta, non si direbbe, anzi a me pare proprio circolata ..... saluti luciano2 punti
-
Buongiorno a tutti, ritornando al mio quesito di un po' di tempo fa sulle monete di Francesco Molin per Candia citate dal Lazari (si veda post 136 di questa discussione), queste risultano esposte al Correr. Riporto di seguito le fotografie da me scattate durante la gita a Venezia di ieri. Ovviamente riporto solo il diritto di ciascuna dato che non è possibile vedere il rovescio. Ho comunque ricevuto dal museo le istruzioni per richiedere eventuali fotografie: nel caso vi terrò aggiornati.2 punti
-
IUSTITIA SUPREMA LEX ESTO La giustizia sia la legge suprema Giustizia e Libertà (Libertas) sono da secoli motivo di vanto per la più piccola nonchè la più antica Repubblica al mondo. Da sempre libera da vincoli, San Marino è tra le nazioni che non accettano la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite.2 punti
-
Non si può non mettere anche questa di osella che raccontava tramite simbologie gli avvenimenti del periodo, oggi diremmo" le grandi news ".... RESISTIT IMPAVIDE RESISTE IMPAVIDA Siamo col Doge Bertucci Valier, è una osella della NAC 43, anno I - 1656, vediamo un'aquila ad ali spiegate che attacca un drago. In realtà l'aquila è Venezia che lotta contro il drago che è l'Impero Ottomano, si allude alla lunga guerra tra veneziani e turchi e in particolare alla vittoria nei Dardanelli del 1656. E chi dubitava ancora che non raccontassero storia e avvenimenti qui deve arrendersi....2 punti
-
Ancora dello stesso Doge e sempre connessa alla guerra di successione spagnola: EMERGIT VIGILANTE LEONE - (la nave) emerge (dal mare) sotto la sorveglianza del Leone Osella da 4 zecchini (ma esiste anche in argento) Anno VII (1706) Ex NAC 36, lotto 463 Leone con spada e bandiera su nave da guerra. «Allude alle misure di difesa prese sul Lago di Garda durante la guerra di successione spagnola» (Traina, p. 127). «Dopo l'occupazione francese di Desenzano l'attenzione del Senato si concentrò in particolare sui territori attorno al Lago di Garda. Il Governo diede ordine al provveditore Giorgio Pasqualigo di armare tre navi da guerra da porre a difesa delle rive del lago» (Dal Catalogo d'Asta Ranieri 4, lotto 1786, pag. 307, dove era in vendita un esemplare in argento). Ha ragione Mario quando dice che tra le Oselle ci sarebbe da pescare. A questo proposito aggiungo un ricordo personale: nel 2011, a Vicenza, durante la kermesse che era il fiore all'occhiello della nostra numismatica e che invece, ormai, si è purtroppo conclusa, ebbi la fortuna di vedere dal vivo a Palazzo Thiene la straordinaria collezione di Oselle della Banca Popolare di Vicenza, probabilmente la più completa al mondo. Fortuna nella fortuna trovai a farmi da guida Luigino Rancan, autore del relativo catalogo, che accompagnò me e gli altri astanti in un "viaggio" indimenticabile. Di quel bel pomeriggio conservo il piacevolissimo ricordo e, appunto, il catalogo che mi fu donato da @Liutprand, allora presente con me. Chi, come me, non segue la monetazione veneziana ma ama le monete non può che restare affascinato da questi tondelli, dalla loro storia e dalla loro varietà. Se potete andate a vederle. Altrimenti, se lo trovate, procuratevi il catalogo perché con una spesa irrisoria metterà a vostra disposizione pagine di storia e di numismatica davvero suggestive. E ora anche io lascio spazio ad auspicabili interventi da parte di altri utenti sperando che questa bellissima discussione resti in alto, tra quelle da proporre anche come spot per la numismatica in generale e per il forum in particolare.2 punti
-
Carissim* seguo da lontano questa discussione e sopratutto questo pezzo, che sono mooolto interessanti! Come molti di voi sanno in questo periodo posso concedermi solo rare incursioni sul forum, e anche in questo caso dovrò essere sintetica. Per quanto mi riguarda le datazioni date da Toderi-Vannel Toderi & Co. alla monetazione senese fino al pieno Trecento sono assai discutibili e molte le ritengo errate. Senz'altro il MIR Toscana zecche minori / Siena, ovvero Montagano, per molte datazioni è più corretto, e probabilmente lo è in questo caso. In realtà, come ho detto in tempi recenti ad un paio di giovani studiosi secondo me la zecca di Siena per quanto concerne il medioevo aspetta ancora una monografia aggiornata e condotta con metodologia scientifica (i.e. verifica più capillare delle fonti medievali, oltre che dei ritrovamenti, analisi archeometriche del contenuto di fino e quant'altro...): speriamo che in futuro qualcuno possa occuparsene in questo senso. Sarebbe per ciò assai importante se si riuscisse a determinare con maggiore precisione quale altro grosso si può intravedere sotto il conio senese. Per quanto riguarda la frequenza delle ribattiture sulle monete medievali delle zecche dell'Italia centro-settentrionale e soprattutto sui versanti interni e tirrenici ho fatto uno studio (con censimento dei casi noti) che ho presentato in un poster allo scorso convegno internazionale di numismatica a Taormina e che dovrebbe essere pubblicato prossimamente negli atti: vi assicuro che i casi di ribattiture di monete grosse in argento sono parecchio rari così come per le monete in oro, mentre molto più comuni sono quelle riscontrabili tra le monete piccole in lega d'argento e mistura più o meno bassa (i.e. denari, quartari, quattrini, petachine o sesini et similia), in generale per motivi che penso sia facile immaginare, anche se ci sono dei casi particolari molto interessanti. Penso che la definizione della cronologia per questa ribattitura, oltre che della tipologia del grosso sottostante, potrebbe dare indizi interessanti anche sulle sue possibili motivazioni. Un caro saluto a tutt* MB2 punti
-
in ultimo, per rispondere all'altra domanda, mi pare doveroso citare un testo specifico .... http://www.arborsapientiae.com/libro/14566/rex-theodoricus-il-medaglione-d-oro-di-morro-d-alba-isbn-978-88-8444-104-1.html CITO dal sito Il Medaglione aureo con il ritratto di Teoderico venne presentato al mondo numismatico da Francesco Gnecchi (1850-1919) in un suo articolo pubblicato, nel 1895, sulla Rivista Italiana di Numismatica. Il monile era infatti entrato a far parte della raccolta del noto collezionista milanese; infine, nel 1923, venne acquistato dal Museo Nazionale Romano e, ancora oggi, è uno tra i reperti più significativi che vi sono conservati. Manufatto eccezionale sotto diversi punti di vista; ha un diametro di 33 mm, pesa 15,32 g con la chiusura a spilla saldata sul rovescio, risulta quindi essere un multiplo da tre solidi. Questo capolavoro dell’arte iconografia numismatica antica è l’unico documento che ci tramanda un’affascinante immagine di Teoderico e costituisce un unicum relativamente alla sua effige. Il celebre sovrano goto è ritratto di prospetto con sottili baffetti, il capo scoperto ornato da una lunga capigliatura liscia, arricciata alle punte. Dalle poche informazioni che ci sono pervenute, il ritrovamento è avvenuto in terra marchigiana, nel territorio di Morro d’Alba, in contrada Sant’Amico, nel podere Tognietti in un non meglio specificato deposito sepolcrale che venne sconvolto da lavori di scasso. Proprio il Medaglione d’oro di Morro d’Alba diventa stimolo per uno studio ed un approfondimento della figura di Teoderico e, più in generale, del regno dei Goti e dell’Italia ai suoi tempi. Questo volume raccoglie ben 29 contributi (al riguardo) raggruppati in quattro sezioni (Il Medaglione d’oro; L’Italia al tempo dei Goti; Ravenna; Il Mito di Teoderico). In particolare i saggi di Claudia Barsanti (Il Medaglione d’oro di Teoderico. Il ritrovamento), Roberta Pardi (Le monete dei Goti), Alessandra Serra (Una riflessione sul Medaglione di Teoderico) e Diletta Cherra (Ritratti della storia gotica) si occupano in modo specifico dei temi che riguardano il medaglione, le monete e la ritrattistica in epoca gotica. La data più probabile, secondo gli studiosi, per l’emissione di questo medaglione è da collocare nell’anno 500, quando Teoderico, all’apogeo della sua gloria, compì il suo viaggio trionfale a Roma per celebrare l’adventus. Esistono anche altre ipotesi: secondo Bernareggi andrebbe datato al 526, momento che vide deteriorarsi i rapporti fra Teodorico e l’imperatore bizantino, d’altra parte Grierson propone come probabile una datazione al tardo 509, momento della pace con Franchi e Burgundi. Seguono scritti che introducono ed illustrano il periodo storico (Mario Natali) o che trattano delle fonti e delle testimonianze archeologiche di Teoderico a Roma (Paola Quaranta), degli insediamenti Goti nell’Italia settentrionale (Basema Hamarneh) e centro-meridionale (Andrea Paribeni), del territorio piceno nel racconto di Procopio durante le guerre gotiche (Lorenzo Riccardi). Ampio spazio è dedicato a Ravenna la città che, più di ogni altra, conserva ricche tracce del popolo Goto e memoria del mitico re; diciassette sono i contributi. Molti, com’è logico, trattano dei celebri cicli musivi. Ad esempio Mauro Della Valle offre una precisa indagine dello stile dei mosaici del tempio di Teoderico, sono anche esaminati i mosaici di Sant’Apollinare Nuovo (Laura Leuzzi) ed il discusso ritratto musivo di Teoderico (Gabriella Bernardi), la Cappella privata dei vescovi di Ravenna (Simona Moretti), mentre Livia Bevilacqua si occupa dei mosaici pavimentali di età teodericiana a Ravenna e nell’area adriatica. Altri contributi si interessano della politica edilizia promossa a Ravenna e nel territorio da Teoderico (Paolo Novara), del complesso episcopale ariano (Giorgia Pellini), della vicenda architettonica di Sant’Apollinare Nuovo (Roberta Cerone), della fondazione di Sant’Agata Maggiore (Roberta Cerone), degli arredi architettonici e liturgici negli edifici di età teodericiana (Claudia Barsanti), fino ad arrivare all’enigmatico mausoleo del sovrano (Francesco Gangemi). L’austera ed imponente tomba del re goto possiede una copertura monolitica veramente impressionante, tale da suscitare ancora oggi grande stupore. Il gigantesco blocco di pietra, con un diametro di oltre 10 metri, si stima possa pesare 230 tonnellate. Il suo posizionamento costituisce un vero rompicapo, una sfida per chi si occupa della storia della tecnica, sicuramente è una fra le maggiori imprese dell’antichità. Agli aspetti legati alla ricchezza, al lusso, sono invece indirizzati i lavori di Manuela Gianandrea (Bagliori dei secoli bui. Corredi funerari e tesori ostrogoti in Italia) e Basema Hamarneh che affronta gli aspetti collegati al diadema aureo, noto come Corona Ferrea, custodito nel tesoro del duomo di Monza e che, nel tempo, ha alimentato non poche leggende collegate all’origine e alla sua destinazione. Claudia Quattrocchi, invece, si sofferma sul tema dei sarcofagi ravennati attribuiti all’epoca teodericiana, analizzando in particolare l’aspetto iconografico. Alla lingua gotica e alle sue problematiche è rivolto il saggio di Artemij Keidan mentre Giovanni Gasbarri si è occupato di Cassiodoro e del monastero di Vivarium e Manuela Gianandrea della cultura, dei libri e dei codici miniati alla corte di Teoderico. In conclusione, sono rivolti al mito di Teoderico i contributi di Silvia Pedone (Uniti nella pietra. L’incontro di Sant’Ilario e Teoderico nel rilievo di Galatea – “C’era una volta un re”. Appunti sul mito di Teoderico nella letteratura e nell’arte). Il volume, corredato da 212 illustrazioni in bianco e nero, avrebbe sicuramente meritato delle riproduzioni a colori di dimensioni maggiori, ma questo avrebbe inevitabilmente inciso sul costo dell’opera. Infine un’adeguata e ricchissima bibliografia con oltre 900 citazioni. Insomma una splendida opera che non solo analizza i celebri monumenti di Ravenna, ma che offre un panorama complessivo dell’Italia al tempo dei Goti esaminando aspetti storici, archeologici, artistici e numismatici utilizzando come filo conduttore proprio una moneta, il Medaglione d’oro di Morro d’Alba di Teoderico. di Gianni Graziosi Il volume raccoglie una serie di saggi di docenti, ricercatori e studenti universitari divisi in quattro paragrafi: IL MEDAGLIONE D’ORO - L’ITALIA AL TEMPO DEI GOTI - RAVENNA - IL MITO DI TEODERICO2 punti
-
Anni fa, quando le mie figlie erano ben più piccole raccontavo loro la storia dei corsari francesi delle isole Mascarenhas. Una storia di vascelli, pirati e tesori ... altro che i pirati dei Caraibi. Una storia che ci ha portato ad una delle monete napoleoniche che maggiormente mi affascina e mi stimola la fantasia. Le isole Mascarenhas sono un un piccolo arcipelago dell' Oceano Indiano situato a settecento chilometri ad Est al largo del Madacascar, e devono il loro nome da Pedro Mascarenhas, navigatore portoghese che le scoprì ai primi del XVI secolo. Sono in tutto tre isolotti e due isole più grandi : Isola Borbone (Ile Bonaparte poi Isola di Réunion) e Ile de France (in precedenza Ile Maurice). Un luogo ideale per i francesi per proseguire a migliaia e migliaia di chilometri dalla madre patria il conflitto con gli alleati. In un mondo esotico, e quanto mai umido la guarnigione imperiale agli ordini del Generale DECAEN dominava questo piccolo specchio di mare e di terra. Chiunque arrivasse a tiro del Vascello "L'Entreprenant" del comandante Pierre Bouvet pagava pegno. Una fresca mattina di aprile del 1810, L'Entreprenant incrocia a largo di Port Louis il vascello da carico OVIDOR che navigava per la Compagnia delle Indie, in breve gli fu addosso e ne depredò il carico. Ovidor di nome e di fatto, una gallina dalle uova d'oro, con un carico d'argento di tutto rispetto. Il bottino portato atterra fu rapidamente convertito in moneta sonante. Certo sull'isola non c'era una zecca e tanto meno la volontà di trasferire il "tesoro" sulla terra ferma correndo il rischio di perderlo. Decaen decise di affidare il lavoro di conversione all'unico orafo dell'isola; AVELINE. Dal tesoro razziato di battè moneta per 1.128.500 franchi, del 1.150.000 franchi in argento presente sulla Ovidor. Non fu un lavoro facile per l'orafo, ma considerato l'agio che gli fu garantito lavorò con buona lena ed in meno di due mesi produsse circa 200.000 piastre da 10 livres cadauna. E' una coniazione di necessità che rimase in auge ben poco tempo. Gli inglesi, dominatori dell'Oceano Indiano non potevano permettere l'avamposto francese, e l'8 luglio del 1810 mossero d'assedio all'isola che capitolò, dopo eroica resistenza il 3 dicembre dello stesso anno. La marina inglese requisì un'immensa quantità di munizioni, 5 grosse fregate, vari bastimenti da guerra e rientrò in possesso di ben 28 vascelli della Compagnia Inglese delle Indie, razziati dai francesi. Perso l'arcipelago ai francesi non restò più un solo vascello in tutto l'Oceano. Gli inglesi, considerato il valore strategico se ne guardarono bene di mollarne il possesso con il trattato di Parigi. Il disegno cui è tratto il diritto della piastra è opera di uno sconosciuto lavorante dell'orafo, fu presentato ed approvato al Generale Decaen in poco tempo, ed a qusti se ne doveva poi accompagnare la produzione di doppie in oro (mai battute a causa della caduta dell'Isola in mani inglesi). E' una piastra grezza, sia nella composizione sia nella realizzazione; leggermente lenticolare e con limiti tecnici piuttosto evidenti, al diritto nel piumaggio dell'aquila imperiale ed al rovescio sul valore DIX. La piastra "Decaen" così battezzata dagli isolani è piuttosto rara, gli inglesi nell'ordinanza del 25/11/1825 diedero un valore liberatorio di 4 scellini contro un intrinseco di 4 scellini e 7 penny decretando di fatto la fusione di quanti più pezzi in circolazione. Se ne salvarono quelli già in continente e poche decine sull'isola, ma oltre il 90% di quanto emesso fu rapidamente fuso. La moneta compare di tanto in tanto in asta, raramente in Italia, anche se ricordo un esemplare nella vendita Vitalini, uno da Varesi un paio di anni fa ed un terzo quest'anno da Negrini. E' una moneta ricercata in Francia, che rientra a pieno titolo nella monetazione napoleonica, in quella di necessità, e negli scudi, quindi di considerevole interesse collezionistico. Non avendo circolato molto gli esemplari che compaiono sul mercato sono generalmente in buona conservazione, tra il BB+ ed il q. SPL, ma sempre o quasi con i difetti di emissione già detti, quando questi non sono presenti il prezzo "schizza" !. Arcipelago delle isole Mascareigne Dix Livres 1810 Argento gr. 26,843, diametro 40,19 Zecca di Porto Louis a Reunion Incisore : Aveline D/ ILES DE FRANCE - ET BONAPARTE aquila coronata ad ali spiegate, sotto AVELINE (incisore e zecchiere) Rv. DIX / LIVRES tra due rami di alloro legato alla base con un nastro; in esergo 1810 Taglio rigato obliquo ↓ Rara, circa 200.000 esemplari battuti tra aprile e Giugno 1810. Riferimenti : De Mey- Poindessault Bruxelles 1971, n. 1045 V.G. - Versailles 1942, n. 2290 Maillet -Parigi 1886, n. 395 et Maillet, XXXIX, 1 Ad oggi ho potuto rilevare un solo conio.1 punto
-
Buonasera a tutti, erano mesi che non trovavo nulla di interessante su ebay. Negli ultimi tempi più che un sito di vendita all'asta sembra essersi trasformato in un sito di vendita dell'usato o del nuovo a prezzo fisso. Mi sono imbattuto in questa asta "vera" con partenza da 1 Euro con tre monete interessanti, due scudi papali purtroppo sfuggiti agli ultimi secondi e questo DENA Carlo Ludovico di Borbone. Mi piacerebbe un vostro parere riguardo il grado di conservazione e la quotazione secondo voi corretta per questo esemplare. Secondo il gigante 2017 ne sono stati coniati solo 3863 pezzi, possibile che sia classificata Comune? Grazie per l'attenzione ed a chiunque vorrà esprimere un parere. Saluti e buon Halloween! Silver1 punto
-
Firenze piastra Ferdinando dei Medici 1590 rara moneta di oltre 400 anni..1 punto
-
Buonasera ecco lista degli espositori che parteciperanno al VI Memorial Correale sabato 12 e domenica 13 novembre 2016, vi aspettiamo numerosi in un ambiente sicuro, saremo lieti d'accogliervi con la cortesia che ci contraddistingue da sempre. Per ulteriori informazioni sulla manifestazione, descrizione dettagliata dei partecipanti o interagire, seguiteci su Facebook alla pagina: Associazione Circolo Tempo Libero, grazie a tutti anticipatamente da Attilio Maglio per la collaborazione.1 punto
-
Il ducato che avevo postato è l'ultimo del post #12. @adolfos E' proprio per questo che questo ducato mi fa pensare... cosa vuol dire quella biscia/ondina? Anche perchè se teniamo buona la datazione della primissima emissione al 1350 ca. i Caetani al tempo dell'emissione del ducato "incriminato" si stavano già espandendo in area campana e guardavano all'Urbe relativamente da lontano. Mah, sul significato del simbolo io ora come ora sono a corto di idee... @417sonia Ciao Luciano, un intervento da parte tua ci voleva proprio visto l'argomento trattato. Spero che continuerai a seguirci Ottime le notizie estrapolate dallo Stahl! @rorey36 Gli ultimi due ducati che hai postato sono del terzo ed ultimo macrogruppo, in particolare quello con stemma Condulmer sotto all'asta del vessillo è l'ultimissima emissione; poi avremo la coniazione del ducato nuovo papale. Poi volendo ci sarebbero anche quelli con lettere come l'ultimo del post #12 (anche qui, almeno per me, c'è un bell'interrogativo circa il loro significato). Secondo me all'interno del primo macro-gruppo (quello con SEN dall'alto al basso per intenderci) le prime due emissioni sono quella del post di apertura e quella con l'ondina sotto al Senatore, che hanno in comune il Volto Santo di grande dimensioni e in verticale. Quindi segue l'emissione con Volto Santo che segue l'orientamento della legenda, come quello della Ranieri 9 che avevo tentato di proporvi, emissione che fa quindi da "ponte" con il secondo macro-gruppo dove la scritta SEN cambia orientamento (dal basso all'alto). Se straparlo fermatemi Antonio1 punto
-
Perdonatemi.... io sapevo che sul 1920 era liscio addiferenza del 1918 e del 1919 che sono stati fatti riutilizzando il conio precedente su questa moneta del 1920 era stato utilizzato un nuovo conio .... ora la mia presenta IL BORDO RIGATO 1920 TEVERE la classifica come r4 voi che valore gli attribute?1 punto
-
1 punto
-
Bene, vedo che iniziano a delinearsi le due correnti pricipali di datazione della prima emissione. Parto da quanto detto da @Ramossen : il ducato romano coniato prima del 1350. Questa tesi viene sottolineata anche da Ives, che riporta come la Tariffa Pegolotti comprenda "romanini d'oro a carati 23 e 3/4". Data la stesura certamente anteriore al 1350 (1340?) della Tariffa, Ives ipotizza un periodo di coniazione della prima emissione tra il 1317 (quando gli statuti dei Mercanti di Roma riportavano solo monete di mistura e argento) e il 1340 circa. Però a me lascia parecchio perplesso quel romanini d'oro dato che sappiamo che un romanino d'oro - quindi con medesima iconografia del romanino d'argento - è realmente esistito, seppur ad oggi non ne siano noti esemplari ma solo un disegno del Muratori. Credo che quindi Pegolotti potesse riferirsi proprio a quest'ultima moneta. Esiste poi una seconda corrente di pensiero (che, per quello che può valere, sposo anch'io; vedasi anche il mio intervento al convegno NIP di settembre) che data la prima emissione di ducati imitativi all'Anno Giubilare 1350. Sappiamo che in occasione di questo Giubileo venne ostentato per la prima volta il c.d. segno della Veronica, che troviamo sia sulle tessere/denari piccoli con SVDARIVS sia sui ducati oggetto di questa discussione. Come si sarebbe potuto apporre un simbolo rimandante chiaramente a qualcosa di mai visto (prima del 1350, s'intende)? Non mi convince, trovo certamente più solida l'ipotesi di datazione al 1350. Credo poi che in occasione del Giubileo una corposa emissione di moneta aurea fosse quasi d'obbligo, per prestigio e comodità, ma questa rimane solo un'ipotesi. Attendo vostri riscontri su quanto detto, ipotesi differenti... Antonio1 punto
-
1 punto
-
Il CNI recita: Ara cubica ornata di patera e lituo La patera era una coppa per versare liquidi durante i sacrifici. Il lituo era un bastone ricurvo in cima che veniva usato durante i riti romani come strumento di culto per ottenere auspici favorevoli. Cosa chiedere meglio della Provvidenza?1 punto
-
1 punto
-
Un ringraziamento a dux-sab per la sua gentilezza e un aneddoto:quando visitai la collezione reale,completamente rapito,cercavo comunque di seguire un percorso quantomeno cronologico,senza farmi distrarre dalle meraviglie che con la coda dell'occhio percepivo magari dall'altro lato della "corsia"e che mi chiamavano come sirene,arrivato al ripostiglio di Vicarello mi si avvicinò un custode del caveau,cosa già di per sé strana poiché di solito non sucito particolare simpatia nel prossimo soprattutto quando non voglio essere distratto mentre ammiro certe opere d'arte,comunque forse proprio per il mio atteggiamento attirai la sua attenzione e per premura o solo perche voleva fare lo splendido mi disse che se volevo vedere qualcosa di veramente eccezionale avrei dovuto seguirlo.incuriosito lo feci,tutto pimpante mi condusse in fondo alla stanza,alla teca delle barbariche-bizantine e mi indicò un solido bizantino,ora non ricordo esattamente di che tipologia fosse,bello ma niente di esagerato,allora gli feci notare che di splendido in quella vetrina c'era in primis il multiplo di Teodorico e gli spiegai la rava e la fava ,poi al limite tra le flavie longobarde gli feci notare l'unicum per Ivrea che purtoppo era esposto dal lato con il nome di Desiderio e non da quello peculiare della zecca. Il custode un po "interdetto"andò a confabulare con i colleghi presso l'ingresso tornando poco dopo dicendo"si,si, è quella li grossa la moneta importante" Che dire...l'entusiasmo fu veramente encomiabile,forse con un po'piu di preparazione il risultato...migliore.1 punto
-
Riguardo la rarità, la ricollegherei anche al ristretto periodo, 1609-1611, di compresenza, in zecca, di Fasulo e Giuno..saluti Eliodoro1 punto
-
Tra l'altro è completamente da escludere che vengano falsificate le monete da 2 centesimi, la produzione del falso avrebbe un costo superiore rispetto alla moneta da replicare.1 punto
-
Come sempre, o quasi, sono dannatamente stretti questi soldi!!! la conservazione lascia un po' a desiderare, ma la moneta è comunque quella... sarebbe meglio trovarli almeno con la data leggibile, ma proprio perché stretti e difficili da trovare in buona conservazione è cosa non facile sul valore non voglio esprimermi, possono essere anche cari in buona conservazione e con la data, in questo caso non penso abbia un grande valore, o almeno io non spenderei sicuramente molto per questa moneta, che comunque può essere collezionabile1 punto
-
Paragonatela con altri decadrachme : la moneta è perfettamente liscia. Non c'è una sola rottura o crepa sul tondello a causa del conio1 punto
-
Ciao Alessandro..complimenti per il mezzo carlino, peccato che la tosatura ha riguardato la data il 1611 Sulla rarità, non ti saprei dire..ho solo notato che tutte le monete siglate sia dal Fasulo che dal Giuno sono molto rare.. Saluti Eliodoro1 punto
-
Buonasera a voi, ringrazio l’amico @Poemenius per aver richiamato la mia attenzione su questa interessantissima discussione. Mi spiace molto non frequentare più il forum, ma credo sia meglio così... per tutti. Devo innanzitutto chiarire che in realtà non sono certo un esperto di monetazione longobarda né, a maggior ragione, delle cd. “silique di Pertarido”. Me ne occupai marginalmente quasi quindici anni fa, quando si trattò di segnalare l’esemplare con busto/monogramma citato al post #2. Dopodiché non me ne sono mai più interessato. Premesso ciò, a questo punto vorrei però provare a dare alcuni chiarimenti riguardo a quanto scrissi allora. La mia intenzione non era ovviamente quella di trovare la soluzione del busillis, ma di cercare di far notare alcune incongruenze in quelle che erano, fino a quel momento, le teorie che andavano per la maggiore. Quella che principalmente non mi tornava era l’idea di una successione cronologica di queste monete. Secondo la teoria canonica, che anche in seguito non mi pare sia stata messa in discussione da nessuno, le prime emissioni avrebbero avuto la doppia impronta busto/monogramma. Solo successivamente esse sarebbero state rimpiazzate da quelle ad una sola impronta, con monogramma rilievo/incuso. Non sto qui a rifare la storia degli studi riguardanti questi specifici pezzi, per la quale concedetemi di rimandare al mio articolino del 2003 (se no mi viene fuori un post di 12 pagine!!!). I testi fondamentali erano in primis quelli di Bernareggi del 1965/67, le cui tesi furono riprese in Id. 1983 e poi quanto rilevato da Grierson e Blackburn in MEC 1. Per farla breve, confrontando diversi esemplari illustrati in letteratura (soprattutto quelli pubblicati nello studio di Bernareggi 1965/67), mi sembrava che con le ipotesi fatte da quei grandi studiosi (sulle cui conoscenze e capacità non devo e non voglio certo discutere) i problemi invece di diminuire aumentassero. In primis l’evoluzione stilistica del monogramma (da dritto a curvo) riguardava sia esemplari a due impronte che pezzi ad una impronta; inoltre anche nella resa formale del busto io scorgevo, almeno apparentemente, una evoluzione stilistica che fino ad allora mi sembrava non fosse stata sufficientemente presa in considerazione. Anche la presenza o meno della corona mi sembrava non inquadrata correttamente. Essa si può infatti trovare su entrambe le tipologie di “silique” (si vedano per esempio i pezzi 17, 18 e 19 del Bernareggi 1965/67; nel mio articolo sono le figg. 6-8 di pag. 10) e lo stesso si può dire per il contorno lineare. Quindi anche da questo punto di vista non mi sembrava che quella fosse una differenza particolarmente significativa per valutare la recenziorità o, al contrario, l'anteriorità la di alcuni pezzi rispetto ad altri. Rilevato ciò, dopo un confronto dei pesi, progressivamente calanti in entrambe le tipologie, facevo notare infine come almeno parte di queste incongruenze cadessero se si prendeva in considerazione l’ipotesi di emissioni multiple e contemporanee di “silique” a due e a una impronta. In pratica a me pareva plausibile pensare che le due tipologie non fossero state emesse una di seguito all’altra ma che invece a partire dal regno di Pertarido fossero state emessi contemporaneamente due distinti nominali (forse dal valore di 1/8 di siliqua uno e di 1/16 l’altro) distinguibili immediatamente per avere due impronte il maggiore, e una sola quello minore. All’evolversi del primo, in termini di resa formale delle immagini, delle lettere, della corona, oltre che del peso e dell’intrinseco, avrebbe corrisposto un’analoga evoluzione sul secondo. Tutto ciò è comunque “ampliamente sviscerato” (citazione) nel mio articolino e a devo ahimè rimandare ancora una volta. Tornando ora al pezzo postato da @calippi , a me sembra che sia del tipo monogramma rilievo/incuso, con quest’ultimo di tipologia “araica”, cioè con la “P” dritta. La ghirlanda e il peso a mio parere ne potrebbero confermare l’attribuzione al tempo di Pertarido (c. 645-688). Riguardo alla presenza o meno dei globetti nella parte sinistra del blocco “PE”, essi variano da quattro a nessuno. In qualche caso al posto dei globetti c’è un piccolo tratto rettilineo. Nel 2003 proponevo di vedervi quello che rimaneva di una croce, proponendo di leggere complessivamente i due blocchi monogrammatici nel modo illustrato più sotto. Vedete voi cosa pensare di tutto quanto detto. Cordialmente, Teofrasto1 punto
-
1 punto
-
Caro @Legio II Italica , mi sono ricordato del hoard del IV secolo. Si tratta dell'Hoxne Hoard https://en.wikipedia.org/wiki/Hoxne_Hoard http://www.ancient.eu/article/932/ E' un deposito di emergenza, nel senso che rappresenta un accantonamento dei beni di una famiglia abbiente. Questo è un silver ingots (lingotto d'argento) dalla Irlanda del Nord. http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=95906&partId=1&searchText=silver+ingot+britain&page=2 http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=95897&partId=1&searchText=silver+ingot+britain&page=3 Questo dal Kent http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1375811&partId=1&searchText=silver+ingot+britain&page=2 http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1362011&partId=1&searchText=silver+ingot+britain&page=3 Tutti recano indicazioni circa l'officina di riferimento. L'ultimo riporta descrizione: Silver ingots like this were used to pay soldiers and civil servants in the Late Roman Empire. The stamped inscription reads EX OFFE HONORINI, which translates 'from the workshop of Honorinus'. It was found in 1777 with two gold coins of the emperor Arcadius (AD 395-408) and one of Honorius (AD 395-423), and dates to the end of the Roman period in Britain. The site, later to be occupied by the Norman Tower of London, lay inside the south-east corner of the Roman city wall, and it is possible that it had been a late Roman military stronghold. Ciao Illyricum1 punto
-
1 punto
-
Se poi ci addentrassimo nel mondo incredibile delle oselle, foriero di iconografie e messaggi simbolici eccezionali, forse faremmo Natale.... Lascio a voi eventualmente se trovarne altre, ne posto ancora una perché mi aveva incuriosito decisamente. Osella dogale e per Murano della NAC 43 del Doge Carlo Contarini, anno I, 1655, con questa rappresentazione di un girasole in piena fioritura. OCVLI MEI SEMPER AD DOMINVM I MIEI OCCHI RIVOLTI SEMPRE AL SIGNORE Qui c'è tutto, l'iconografia , la simbologia, il messaggio.... Come il girasole si volge sempre verso il Sole, così l'animo del Doge si rivolge sempre a Dio. Un girasole che sembra un occhio, un occhio verso il Signore, che protegge tutti ....la popolazione ,il Doge, Venezia....1 punto
-
Secondo me attendi, controlla sempre la mail dopo le 21,30 di sera.... Meglio evitare sia di telefonare che di contattarli tramite mail, intralcerebbe solo il loro operoso lavoro...!1 punto
-
o questa German States HESSE-CASSEL Heller KM# 401 1730-1743 1733 New World Price Guide Search *Image(s) not of exact coin1 punto
-
A mio parere sei troppo duro. Il forum può essere anche uno sfogo per chi, per motivi vari, le proprie monete non saprebbe proprio a chi mostrarle. Non mi sento di considerare esibizionista chi condivide i propri acquisti. Ad ogni modo, secondo me, più monete si vedono (quale che siano le motivazioni della condivisione non importa) meglio è. Tieni presente che molti di noi non hanno spesso la possibilità di vederle dal vivo e ammirarne le foto è sempre meglio di nulla. Ben vengano quindi le monete. Ricche, povere rare o comuni vanno ad alimentare curiosità e sete di conoscenza. Se chi le mostra ne racconta la storia è certamente meglio; in caso contrario potrà farlo chi è ferrato, i curatori o potremo documentarci da soli se il tondello ci ha incuriosito particolarmente. Insomma anche l'esibizionismo può portare indirettamente divulgazione e non generare solamente invidia. Ho visto discussioni interessantissime fiorire da una semplice richiesta circa l'autenticità oppure da un semplice: "vi piace il mio ultimo acquisto?". Ma questo è solo il mio pensiero. Buon week end a tutti. E.1 punto
-
No, ho risolto i miei dubbi, dopo il mio messaggio un paio di utenti mi hanno scritto in privato. Sto cercando di fare uno studio approfondito su Filippo II e ho capito come muovermi. Le monete che posto non hanno a che fare con la questione Filippo II, sono monete della mia collezione, mi fa piacere condividerle, tutto qui.1 punto
-
Vorrei fare un'intervento provocatorio.... Vedo gli utenti contenti e i commercianti un pò sul piede di guerra, per me siamo sulla strada giusta....1 punto
-
Ciao @@Georg! il discorso patina è un pò complicato dal mio punto di vista e meriterebbe un'analisi approfondita.. Comunque di discussioni su questo argomento ce ne sono decine sul forum.. Il fatto è questo; se la patina è leggera e delicata, o comunque esalta i rilievi della moneta, allora è un plus! E credo che sia universalmente condivisa come opinione.. :good: Però tante volte capita di trovare monete parzialmente patinate, sporche, scure (come quella in oggetto), beh, in questi casi la patina forse toglie qualcosa (e a volte maschera qualche difetto).. E quindi che fare? Bella domanda.. Io credo, visto che la moneta in mano tutto sommato mi piace, di lasciarla così, però la domanda è.. Se la spatino, la patina che andrà a formarsi nascerà migliore o peggiore di questa? completa o parziale? che tonalità prenderà? e potrei continuare.. Pertanto credo non sia da farci una malattia per la patina.. Se c'è ed è gradevole bene, se la moneta proprio non piace allora non si deve aver paura a toglierla. :good: Sul discorso patina originale e patina artificiale dico solo questo.. La mia 2 lire ha messo su quel tono in un anno.. Quindi mi viene da pensare che in cento anni dovrebbe essere completamente nera; pertanto, a meno che le monete super eccezionali non siano state inserite in bustine prive di plastificanti subito dopo essere state coniate (e non credo le avessero al tempo :rofl: ) quasi sicuramente sono state lavate; bada bene.. magari non ieri ma alcuni anni addietro, però la probabilità è alta.. Questo per le monete moderne.. Per le medievali il discorso è ancora diverso.. E stiamo parlando solo dell'argento; cosa dire del rame, del bronzo, ecc ecc.. :lazy:1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?












.thumb.jpg.0c713dd4d29897ec1aa5522233f464d8.jpg)
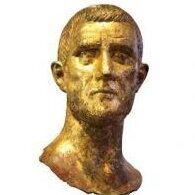





AdolfoViperetta.thumb.jpg.567df83d4aa18c98f435a6b9921cca31.jpg)