Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 11/12/16 in Risposte
-
Per carita' nessuno ti vuole cacciare Gionni non facciamo cacce ai fantasmi. La tua competenza e' sicuramente apprezzata in una materia difficile e scivolosa come il restauro delle monete. per un che ritiene che le monete non debbano MAI essere toccate il mondo del restauro rappresenta una dimensione aliena che ebbi comunque la fortuna di esplorare grazie all'amico Pippo di palermo, abilissimo restauratore che mi fecd vedere interventi sui bronzi stupefacenti. E' una materia chd richiede abilita' tecniche, conoscenze e occhio non comuni e che pochi solamente possono praticare. La discussione e' oltremodo interessante , si sono delineati due campi . Tinia dal canto suo e' un grande esperto con notevole esperienza in questo campo. Gli sviluppi saranno certamente interessanti anche se manchera' l'osservazione diretta dell'esemplare che potrebbe una volta per tutte dirimere la questione che finalmente si svolge con toni e rispetto piu' consoni come constato con soddisfazione4 punti
-
Alcune monete dei Giubilei ancora "inesplorati" in questa bella discussione: 1- Anno 1650 - papa Innocenzo X, quattrini per Gubbio con la Porta Santa aperta (M. 124a) e chiusa (M. 122): 2- Anno 1750 - papa Benedetto XIV, mezzo baiocco per Roma (M. 205): Grossi per Roma con la Porta Santa aperta (M. 53a) e chiusa (M. 54): 3- Anno 1775 - papa Pio VI, grosso per Roma (M. 50): e infine giulio per Roma (M. 49): Ciao, RCAMIL.3 punti
-
A suo tempo la presi perchè mi ha incuriosito molto il fatto che riportava una data diversa per faccia. Il 1816 in Europa e negli Stati Uniti fu chiamato “l'Anno senza estate ”, con neve a giugno, gelate in luglio e agosto ed inverno rigidissimo. Ci furono rivolte per il cibo in Gran Bretagna ed in Irlanda, molti si videro costretti a mangiare radici e ratti. Il clima causò la diffusione su larga scala di epidemie di tifo, andarono distrutti gran parte dei raccolti costringendo alla fame centinaia di migliaia di persone, per questo freddo micidiale si stimano 60.000 morti nel periodo 1816/17. Negli anni seguenti il terrore che un simile clima potesse ripresentarsi restò a lungo impresso. I contadini se la cavarono a stento sopravvivendo con le scorte delle annate precedenti. Una tessera per "un pane" - Germania: Città di Wuppertal-Elberfeld - 1 Brod 1816/1817 Tramite traduttore ho grossomodo ricavato le diciture, è stata coniata in un periodo di grave carestia, una testimonianza di lacrime, stenti e sofferenze. ASSOCIAZIONE DEL GRANO - ELBERFELDER (lato 1) ____COMPRATO IN TEMPO NELL'ANNO 1816 (lato 2) ____IN MODO DI AVERE IL NECESSARIO NEL 1817 (Le cause di questo clima micidiale furono dovute in parte alle gigantesche eruzioni vulcaniche avvenute negli anni precedenti, si erano accumulate nell'atmosfera immense quantità di polveri, a queste eruzioni si sommò quella dell'esplosione del vulcano Tambora avvenuta nel 1815, la spessa coltre di polveri rese meno incisiva la radiazione solare, tale azione si sommò ulteriormente alle condizioni atmosferiche particolarmente avverse di quegli anni)3 punti
-
Buonasera a tutti,innanzitutto complimenti per la discussione veramente interessante,a titolo informativo volevo ricordarvi che oltre a Filippo III anche Filippo IV ha coniato una moneta con cornucopie intrecciate,è il rarissimo 2 cavalli del 1632...2 punti
-
Nel famosissimo quarto di ducato di Clemente VII del giubileo del 1525 appaiono 2 motti: uno al dritto e quell'altro al rovescio. Quello al dritto è: HODIE SALVS LACTA EST MVNDO che significa OGGI LA SALVEZZA INCOMINCIA A SUCCHIARE IL LATTE vuol dire che è la giornata di natale e lo si deduce dal fatto che la salvezza è Gesù e succhiare il latte è quello che fanno i neonati quindi è il giorno in cui è nato Gesù (25 dicembre) Quello nel rovescio è: SVNT ET PORTAE CAELI APERTAE che significa:LA SANTA PORTA DEI CIELI APERTA Questa moneta fu coniata per il volere del papà che sperava nell'aiuto di Dio perchè in quel periodo c'erano molti conflitti politici e soprattutto religiosi ( causa soprattutto dalla riforma luterana) Immagine presa da numismatica ranieri2 punti
-
Chiedo scusa, ma ogni volta che cerco di fare "copia e incolla" mi si creano dei pastrocchi nel msg che non riesco a cancellare o a sistemare. I significati che sono stati attribuiti alle lettere PP sono molteplici : Patronus Primarius, Patronus o Protector Principalis, Patriarca Protettore, Perpetuus Patronus o Perpetuus Protector,.. e c'è anche chi sostiene che fosse l'abbreviazione di Pontefice. Non necessariamente però le lettere PP possono assumere lo stesso significato. Se ad es. come sostiene @teofrasto per Ascoli Piceno stanno a significare "Patrono e Protettore", credo che per Ancona il significato da attribuire sia diverso. Come già detto, ad Ancona esistono tre Santi Patroni: S. Ciriaco, S. Liberio e S. Marcellino. E S. Ciriaco è da tutti considerato il Patrono Principale. Questa attestazione la ritroviamo anche nella tomba del Santo che riporta: CORPVS SANCTI CYRIACI EPI ET MARTYRIS PATRONI PRINCIP. ANCONAE (Corpo di San Ciriaco Vescovo e Martire Patrono Principale di Ancona). Certamente si può obiettare che la tomba risale al settecento, ma credo che altri elementi possano portarci sempre al Patrono Principale. Non dimentichiamo che San Ciriaco era considerato, dopo S. Cleto, Protettore Principale dell'Ordine Religioso Cavalleresco dei Cruciferi, ordine che risale al XII secolo.2 punti
-
Questa discussione e' nata nel rispetto delle opinioni degli altri, quindi anche la tua sara' rispettata,ti faccio solo osservare che nel punto in cui tu parli di ossidazioni , si parla di corrosioni, termine totalmente diverso. le ossidazioni presentano caratteristiche diverse. Il fatto che tu non spenderesti piu' di 100 euro e' una tua scelta personale per contro, la gente puo' decidere di spendere 3350 euro perche' crede in quello che fa, oppure puo' anche buttare i soldi dalla finestra, anche queste sono scelte personali in cui nessuno di noi puo' entrare nel merito2 punti
-
Salve @margheludo, non credo che la moneta in questione sia originale. Come ho già scritto nel mio primo messaggio, le superfici non solo semplicemente porose a causa di ossidazioni o pulizia maldestra ed aggressiva, come sostieni tu, bensì si intravedono delle vere e proprie micro-bolle di fusione diffuse. Inoltre, cosa che io ho evidenziato nella mia risposta, ma non ho notato nella tua, non hai visto il bordo (o taglio) della moneta? Sembra sia stato abraso meccanicamente per eliminare i difetti (tipo codoli, linee di congiunzione e simili) dovuti alla fusione. Conclusione: per me, moneta falsa al di là di ogni dubbio. Attendiamo anche altri pareri, magari di chi è più esperto in tecniche produttive, così dissolviamo ogni dubbio.2 punti
-
Ciao @adolfos, ero in tutt'altre faccende affaccendato (ho una nipotina che mi gira per casa ed in contemporanea avrei voluto seguire un'asta, ma non c'è stato verso). Io sono uno di quelli che è rimasto nella convinzione che il D/ della moneta sia quello con l'indicazione della Località e nella fattispecie della mia zecca, quello di Ancona, e non piuttosto quello del Santo che la rappresenta, ma questa è un'altra storia, piena di valutazioni e convinzioni che cambiano anche nel tempo. Quindi per me DE ANCONA sta ad indicare che la moneta è di Ancona e S. Ciriaco è il Santo che la rappresenta come simbolo identificativo. Ci sono molte discussioni al riguardo, e qui non vorrei entrare nel merito. Per quanto riguarda invece il significato delle lettere PP che solitamente troviamo dinnanzi a S QVIRIACVS nel R/ della moneta, anche qui ci sono molte discussioni ed i pareri spesso similari e talora contrastanti, anche su questo forum, vedi ad esempio una delle ultime discussioni (nell'ultima pagina).2 punti
-
SAGUNTO. Sextante. A/ Cabeza femenina a dcha; delante SAG, detrás ¿clava?. R/ Caduceo alado, a izq. V a dcha. NT nexadas. C-63 (dice venera debajo SAG, pero si giramos 90º el anv. de la pieza fotografíada, vemos que se trata de una cabeza femenina y delante SAG como en el presente ejemplar. Creemos que tenía razón el maestro Villaronga al atribuir esta pieza a Sagunto, si bien pudo confundirle el efecto óptico, apreciando una venera).2 punti
-
Direi che la lista delle emissioni per quest'anno è completa, quindi possiamo fare un riepilogo. Cliccando su ogni moneta, potrete vederne dettagli e foto. Italia - 2200° anniversario della morte di Plauto - 550° anniversario della morte di Donatello San Marino - 550° anniversario della morte di Donatello - 400° anniversario della morte di William Shakespeare Vaticano - 200° anniversario della Gendarmeria - Giubileo straordinario per la misericordia Andorra - 150° anniversario della Nuova Riforma - 25° anniversario della radiotelevisione di Andorra Austria - 200° anniversario della banca centrale Belgio - Olimpiadi estive di Rio de Janeiro - Fondazione Child Focus Estonia - 100° anniversario della nascita di Paul Keres Finlandia - 90° anniversario della morte di Eino Leino - 100° anniversario della nascita di Georg Henrik von Wright Francia - François Mitterrand - Campionato europeo di calcio Germania - Zwinger, complesso barocco di Dresda Grecia - 120° anniversario della nascita di Dimitri Mitropoulos - 150° anniversario dell'olocausto del monastero di Arkadi Irlanda - 100° anniversario della rivolta di Pasqua Lettonia - Livonia - Mucca Lituania - Cultura baltica Lussemburgo - Ponte della granduchessa Carlotta Malta - Amore - Gigantia Monaco - 150° anniversario della fondazione di Montecarlo Portogallo - 50 anni del ponte 25 de Abril - Olimpiadi estive di Rio de Janeiro Slovacchia - Presidenza di turno del Consiglio Europeo Slovenia - 25° anniversario dell’indipendenza Spagna - Centro storico e acquedotto romano di Segovia2 punti
-
A me piace molto questa tipologia: Baudekin du 4ème type, Valenciennes.A/. Cavalier à droite, brandissant l’épée. Aigrette à six branches. Jambes du cheval entre E et n. R/. Double légende et petite croix cantonnée de croissants. COITISSA et ponctuation intérieure par : Références : Chalon, n° 15 – Duplessy, n° 1 – Lucas, n° 36 type 42 punti
-
Perché insistere, mettendo possibilmente a disagio, un utente che contribuisce come pochi al forum? Confrontiamoci sui contenuti... Ciao ES2 punti
-
Taglio: 1 euro Nazione: Cipro Anno: 2011 Tiratura: 200.000 Conservazione: BB+ Località: Castelletto Cervo (BI) Note: NEWS? Note2: questa è probabilmente la moneta più rara che io abbia mai trovato...avrei preferito una qualsiasi di Andorra o un ramato monegasco (che hanno tirature maggiori) ma vabbè!2 punti
-
Segue... (Inni o incitamenti alla carità) NE OBLIVISCARIS PAVPERVM, “non dimenticarti dei poveri”. È ancora Innocenzo XII a lasciare questa sollecitazione, in tal caso su un giulio. Sarà poi imitato dal successore Clemente XI, che la farà imprimere su un testone. Alla monetazione di quest’ultimo papa appartengono anche un grosso e la sua metà con la scritta PAVPERI PORRIGE MANVM TVAM, “stendi la tua mano al povero”, versione integrale di una legenda presente in forma ridotta anche su altri nominali dello stesso pontefice, nonché di suoi tre successori (nota 26). Fig. 29: Roma, Clemente XI (1700-1721), Grosso. Al R/: PAVPERI PORRIGE MANVM TVAM, in quattro righe. Da Internet (Rhinocoins). Ad Innocenzo XII si deve la riproposizione in moneta di un frammento del Libro di Giobbe (5, 16) riportato su sei tipi variati di grosso che presentano la dicitura EGENO SPES, “speranza per il bisognoso” , nonché quella del versetto del Deuteronomio (15, 11) EGENO ET PAVPERI, (porgi la mano) “al bisognoso e al povero”, visibile su un testone. Su quest’ultima moneta compare anche una bellissima rappresentazione: una donna, con una fiamma sul capo, che avanza tenendo una cornucopia capovolta dalla quale cadono più monete. Come spiega Traina nel magistrale volume ricordato all’inizio di questo lavoro, la fiamma è tradizionalmente simbolo di illuminazione, purificazione e amore spirituale, mentre la cornucopia è emblema di abbondanza, speranza e carità. Fig. 30: Roma, Innocenzo XII (1691-1700), Testone 1694. Al R/: EGENO ET PAVPERI, attorno a donna che avanza con fiamma sul capo e cornucopia in mano dalla quale cadono monete; in esergo la data. Ex Asta Nomisma 38, 2009, lotto n. 1364. Il mezzo grosso di Innocenzo XIII con IN EGENIS, “per i bisognosi” e il pezzo di valore doppio di Clemente XII con la scritta CVM EGENIS, “dalla parte dei poveri”, arricchiscono ulteriormente il panorama delle coniazioni di questo tipo. BEATVS QVI INTELLIGIT SVPER EGENVM, “beato chi comprende i bisogni del povero”. L’iscrizione appena citata da un giulio di Innocenzo XIII ricorda che non soltanto occorre individuare i bisognosi, ma anche saper discernere esattamente quali siano le loro effettive necessità. Non v’è dubbio che, tra queste, quella del cibo sia primaria ed è proprio a tale specifico aspetto che sono dedicate le parole leggibili su tre grossi (a volte con varianti) di due diversi pontefici: IN CIBOS PAVPERVM, “per i cibi dei poveri” (Clemente XII), EDENT PAVPERES ET SATVRABVNTVR, “i poveri mangeranno e saranno saziati”, e VT ALAT EOS IN FAME, “perché dia da mangiare agli affamati” (Benedetto XIV). Fig. 31: Roma, Benedetto XIV (1740-1758), Grosso. Al R/: EDENT PAVPERES ET SATVRABVNTVR, in quattro righe. Da Internet (Rhinocoins). Nel Vangelo di Luca è scritto PETENTI TRIBVE, “da’ a chi chiede” (6, 30), e, poco oltre, DATE ET DABITVR, “date e vi sarà dato” (6, 38). Entrambe le espressioni sono presenti pure su moneta: rispettivamente, su un mezzo grosso di Benedetto XIII e su un grosso di Clemente XI. Lette insieme, esse danno, ancora una volta, la certezza che la carità giova anche a chi la pratica e, soprattutto, che non lo impoverisce. La legenda QVI DAT PAVPERI NON INDIGEBIT, “chi dà al povero non andrà in rovina”, che Innocenzo XI pone su un giulio, può essere interpretata, allora, come una conferma di quella che si è voluta definire ‘doppia funzione salvifica’ della carità stessa. La conclusione di questo lungo percorso di ‘catechesi numismatica’ è forse quella che si può leggere tanto su un testone che su una quadrupla di papa Clemente XI: A DEO ET PRO DEO, “da Dio e per Dio”. Quasi per dire che la ricchezza viene dal Signore ed è a Lui che deve ritornare, attraverso l’attenzione verso i bisognosi che, come riscontrabile nelle Scritture sia vetero che neotestamentarie, godono della Sua predilezione. Fig. 32: Roma, Clemente XI (1700-1721), Testone. Al R/: A DEO ET PRO DEO, intorno a donna con un bimbo in braccio, tra due bambini che versano monete da due cornucopie. Da internet (Rhinocoins). L’invito è che ognuno, riconoscendo la verità di quanto appena affermato, possa andare incontro al prossimo che si trova nel bisogno con le parole che Pietro rivolse ad uno storpio che chiedeva l’elemosina davanti al tempio di Gerusalemme (cfr. Atti, 3, 6), e che Innocenzo XI ha voluto fossero impresse su un suo testone: QVOD HABEO TIBI DO, “quello che ho lo do a te”. Fig. 33: Roma, Innocenzo XI (1676-1689), Testone Anno II 1677. Al R/: QVOD HABEO TIBI DO, S. Pietro, stante a destra, aiuta lo storpio. NOTE : 26 - PAVPERI PORRIGE: Clemente XII, grosso. PAVPERI PORRIGE MANVM: Clemente XI, grosso, mezzo grosso; Clemente XII, grosso. Benedetto XIV, grosso (o mezzo paolo); Pio VII (Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti, 1800-1823), grosso. Quest’ultima moneta è stata coniata anche nella zecca di Bologna. BIBLIOGRAFIA Amisano G. 2009, Le monete della Bibbia e dei Vangeli con monete e parole, Cassino (FR), Editrice Diana. Andreau J., La cattiva reputazione dei pubblicani, in «Il Mondo della Bibbia», n. 2, marzo-aprile 2007, pp. 17-19. Colombo C. 2003, Trenta monete d’argento. Le monete nel Nuovo Testamento, Pessano (MI), Mimep-Docete (Bereshit; 1). Lémonon, J-P., La questione del denaro di Cesare, in «Il Mondo della Bibbia», n. 2, marzo-aprile 2007, pp. 21-24. Marguerat D., Dio e il denaro sono compatibili?, in «Il Mondo della Bibbia», n. 2, marzo-aprile 2007, pp. 5-9. Merlo G.G., Francesco d’Assisi e il denaro, in Travaini 2009, pp. 145-152. Monti A. 1883, Motti sopra alcune monete dei Pontefici, in «Periodico di numismatica e sfragistica per la storia d’italia», 1883, fasc. II e III. Muntoni F. 1972-1974, Le monete dei Papi e degli Stati Pontifici, Roma, P&P. Santamaria. Vol. I: Da Adriano I alla Sede Vacante 1559 (772-1559), Roma 1972; Vol. II: Da Pio IV alla Sede Vacante 1676 (1559-1676), Roma 1972; Vol. III: Da Innocenzo XI alla Sede Vacante 1758 (1676-1758), Roma 1973; Vol. IV: Da Clemente XV a Paolo VI (1758-1971), Roma 1974. Schmidt Heinrich e Margarethe 1988, Il linguaggio delle immagini. Iconografia cristiana, Roma, Città Nuova. Traina M. 2006, Il linguaggio delle monete. Motti, imprese e legende di monete italiane, Sesto Fiorentino (FI), Editoriale Olimpia. Travaini L. 2009 (a cura di), Valori e disvalori simbolici delle monete. I Trenta denari di Giuda, Roma, Quasar (Monete; 3). ***** Ecco... ho finito. L'articolo originale, in realtà, proseguiva con una piccola parte conclusiva che però, ai fini di questa discussione, può essere omessa. Mi scuso se la lettura potrà risultare un po' scomoda, ma il semplice allegare la scansione della rivista avrebbe impedito di vedere bene le immagini. @dabbene , al quale avevo chiesto preventivamente se poteva essere utile portare questo contributo, mi perdonerà se mi sono preso tutto questo spazio.2 punti
-
Salve a tutti. Con questa discussione volevo oggi focalizzare la vostra attenzione su una rarissima tipologia monetaria coniata a Napoli nei primi anni del regno di Filippo III d'Asburgo (1598-1621). Senza frapporre ulteriori indugi, passiamo alle descrizioni. 1. D/ PHILIPP. III. DG. REX. ARA. VT. SI. Busto radiato, corazzato e drappeggiato volto a sinistra. Sotto, una croce tra due globetti. R/ MARGARI + AVSTR + CONIVXIT Busti dei sovrani Filippo III e Margherita d’Austria affrontati, posti su due cornucopie intrecciate. Tra di loro, nel campo, una corona reale. Sotto, 16.. · M. Pannuti – V. Riccio, p. 140, n° 9 (fig. 1). · Coll. Sambon 1897, p. 89, n° 1099 (tav. VIII del catalogo di vendita) – fig. 2. · G. Bovi, Le monete napoletane di Filippo III, in BCNN, anno LII, 1967, p. 22, n° 3 (tav. I, n° 3, proveniente dalla Coll. Catemario con un peso di 5,92 g.) – fig. 3 e 3 bis. · A. D’Andrea – C. Andreani – S. Perfetto, Le monete napoletane da Filippo II a Carlo VI, Castellalto (TE), 2011, p. 183, n° 23 (rarità: R4). Fig. 1. Immagine tratta da Pannuti-Riccio, p. 140. Fig. 2. Immagine tratta dal catalogo di vendita della Collezione Sambon del 1897, tav. VIII. Fig. 3. Immagine tratta dall'articolo di G. Bovi del 1967 in BCNN, tav. I (ex Coll. Catemario). Fig. 3 bis. In questa immagine sembra che la moneta ritratta sia la stessa già appartenuta alla Coll. Catemario pubblicata dal Bovi e qui riportata in fig. 3. 2. D/ PHILIPP. III. DG. REX. ARA. VT. SI. Busto simile al numero precedente. Dietro il busto, sigla comunemente interpretata come G. R/ Del tutto simile al numero precedente. · M. Pannuti – V. Riccio, p. 140, n° 9a. · Coll. Sambon 1897, p. 89, n° 1100. · G. Bovi, Le monete napoletane di Filippo III, in BCNN, anno LII, 1967, manca. · A. D’Andrea – C. Andreani – S. Perfetto, Le monete napoletane da Filippo II a Carlo VI, Castellalto (TE), 2011, p. 184, n° 24 (rarità: R4). · CNI XX, p. 178, n° 27 (esemplare della Coll. Sambon). Al momento, l’unico pezzo conosciuto di questa varietà fu esitato nell’asta Varesi XXXIII Utriusque Siciliae del 30 maggio 2000, p. 63, lotto n° 316 (fig. 4). Il medesimo esemplare, prima di approdare in questa recente asta, era appartenuto a Giulio Sambon e dalla sua ditta fu venduto nel catalogo della sua collezione a Milano nel 1897. Successivamente, si registrò un altro passaggio in asta Ratto del 5 maggio 1959 (lotto n° 353), per concludere poi in asta Varesi. Fig. 4. Immagine tratta dal catalogo d'asta Varesi Utriusque Siciliae. Come si evince dal titolo, questa interessantissima moneta napoletana dal valore di un tarì (ovvero due carlini), oltre alla rarità e all’importanza numismatica, riveste anche un rilevante significato storico, espresso attraverso l’iconografia del rovescio. Il diritto non rileva nulla di eccezionalmente importante, fatto salvo per la sigla G dietro il busto della variante qui descritta al n° 2, ma che avremo modo di approfondire di qui a breve. Volevo quindi soffermarmi in particolare sul rovescio. La legenda è già di per sé molto eloquente, ricordando il matrimonio tra Filippo III e Margherita d’Austria. Quest’ultima (1584 – 1611) era figlia dell’Arciduca d’Austria Carlo II di Stiria (1540 – 1590) e nipote dell’Imperatore del Sacro Romano Impero Ferdinando I (1556 – 1564). Non era certo di bell’aspetto: i ritratti dell’epoca ce ne tramandando un’immagine caratterizzata dal celebre prognatismo asburgico, tuttavia era di carattere mite, molto religiosa (alcuni l’hanno definita addirittura bigotta) e tutt’altro disinteressata agli affari politici e alle celebrazioni di corte. Nel 1599 sposò il Re Filippo III per procura, portando alla Corona spagnola una dote di 100.000 ducati, e di lì a poco intraprese il viaggio verso la penisola iberica, dove la sua unione regale doveva essere confermata nella capitale Madrid. Durante il suo viaggio verso la Spagna, il corteo austriaco fece tappa a Milano dove, per celebrare la sosta della nuova Regina spagnola, fu inaugurata, nell’allora Palazzo Ducale, la prima sala cittadina predisposta all’esecuzione dell’opera, il cosiddetto Salone Margherita. Alla corte spagnola, Margherita divenne una donna molto potente: ella era affezionata al consorte, così come anche lui esprimeva un sincero sentimento nei suoi confronti, ma non disdegnava l’intromissione, quando era necessario, negli affari di Stato. Il legame tra i due regnanti è ben illustrato su questa moneta: l’unione matrimoniale è simboleggiata dalle cornucopie che s’intrecciano. Questo simbolismo di pace, amicizia e concordia era già stato adoperato nel mondo classico su alcune monete romane sorprendentemente simili, nell’iconografia, a quella in oggetto (fig. 5 e 6, per fare alcuni esempi). Non escludo che l’incisore che curò l’esecuzione dei conii di rovescio per questi tarì napoletani non abbia preso spunto diretto da una di queste due monete romane, forse presenti nelle raccolte reali partenopee già messe insieme dall’epoca aragonese per volere di Re Alfonso il Magnanimo. Fig. 5. Sesterzio coniato a Roma a nome di Druso, figlio dell'Imperatore Tiberio, intorno al 22 - 23 d.C. Le due teste che sormontano le cornucopie sono quelle dei nipoti di Tiberio e figli dello stesso Druso: Tiberio Gemello e Germanico Gemello. RIC I, n° 42 (under Tiberius). Ex NAC 51, lotto 171. Fig. 6. Sesterzio dell'Imperatore Antonino Pio coniato a Roma intorno al 149 d.C. I due bambini le cui teste sono poste sopra le cornucopie sono T. Elio Antonino e T. Aurelio Antonino, i due figli del futuro Imperatore Marco Aurelio e di sua moglie Faustina II, nati proprio nel 149 d.C. RIC III, n° 857. Ex CNG Triton VIII, lotto n° 1142. La Regina dimostrò molto peso nella scelta dei ministri e dei cortigiani che circondavano il sovrano, decretando la caduta di quelli a lei sfavorevoli ed incentivando l’ascesa di coloro che si rivelavano fedeli non solo alla Spagna, ma anche all’Austria, suo Paese d’origine. Era lei, infatti, che spesso decideva che poteva avere contatti con il Re e chi invece veniva escluso da questo rapporto privilegiato. Filippo, dal canto suo, era felice, non senza una punta di opportunismo, di condividere con la moglie i pesi della politica, sia interna che estera. La politica filo-austriaca di Filippo III si intensificò a partire dal 1600, quando, sotto l’influsso della zia Maria Imperatrice del Sacro Romano Impero, figlia di Carlo V, e della figlia di lei, monaca, il Re iniziò ad appoggiare finanziariamente la fazione cattolica attraverso l’Arciduca Ferdinando II d’Asburgo, futuro Imperatore (1619 – 1637) in quella che passerà alla storia come Guerra dei Trent’anni. Alla morte di Margherita, il 3 ottobre del 1611, Filippo, profondamente addolorato per la perdita, non si risposò più. Riprendendo il discorso sul tarì in questione, esso fu coniato a Napoli nell’anno 1600, come dimostra anche la dicitura del numerale 16.. espresso sotto le due cornucopie al rovescio. Ad un anno di distanza, quindi, dal matrimonio tra i sovrani che si era tenuto solo l’anno precedente. Secondo un’ipotesi, sicuramente attendibile, avanzata dal Sambon in occasione della vendita della sua collezione nel 1897, a proposito di queste monete, esse vennero battute per una visita che i Re di Spagna avevano progettato a Napoli proprio per quell’anno, ma che non si realizzò mai. Questi tarì dovevano quindi essere gettati al popolo durante la cavalcata dei Re in visita alla città. In previsione di un simile evento, il nuovo Viceré Fernando Ruiz de Castro Conte di Lemos, insediatosi a Napoli nell’ottobre del 1599 con la moglie Catalina de Zùniga ed il figlio Pedro Fernàndez che gli succederà poi nella medesima carica, ordinò, oltre alla coniazione di queste monete, anche la costruzione di un nuovo palazzo (l’odierno Palazzo Reale in Piazza Plebiscito) per ospitare il Re in visita con la consorte. A seguito dell’annullamento del viaggio reale a Napoli, la costruzione della nuova residenza continuò, mentre molti dei tarì di questo tipo già coniati vennero ritirati dalla circolazione e rifusi per recuperare il metallo in Zecca. In circolazione ne rimasero pochissimi, come ad esempio l’unico esemplare noto descritto qui al n° 2, che risulta anche tosato e che quindi testimonia una discreta quanto movimentata attività di circolazione. Questo provvedimento potrebbe spiegare anche l’eccellente livello di rarità raggiunto ad oggi da questi particolari tarì: partiamo dicendo che solo un esiguo numero di esemplari sfuggì al ritiro ed alla fusione e, per quelli che restarono in circolazione, non tutti sono pervenuti fino ai nostri giorni, il che porta ad abbassare drasticamente il numero di pezzi sopravvissuti alle vicissitudini storiche e quotidiane intercorse in un così lungo arco temporale. Da un primo confronto dei conii dei diversi esemplari qui illustrati, risulta facile notare come per il rovescio fossero stati preparati meno conii rispetto al diritto: le somiglianze tra i conii di rovescio, infatti, sono più strette e calzanti rispetto a quelle dei conii di diritto (in alcuni casi sembra sia stato usato proprio lo stesso conio, ma è difficile giudicare anche a causa della conservazione dei pezzi), il che fa presupporre che furono preparati più conii di diritto, ma, a confronto, pochi, se non pochissimi, di rovescio. Passiamo ora, finalmente, a parlare della sigla G che compare dietro il busto al diritto dell’esemplare n° 2, come già detto, conosciuto, al momento, solo in quest’unico pezzo. Nel periodo in cui furono coniati questi tarì, ovvero nell’anno 1600, nella Zecca partenopea lavorava Giovanni Antonio Fasulo come Maestro di Zecca. Costui, un banchiere di origini napoletane, aveva già ricoperto questa carica a partire dal 1594, sotto Filippo II, continuando a mantenerla anche sotto Filippo III fino al 6 settembre del 1611. Egli siglava le monete con le proprie iniziali: IAF, seguendo una dizione latina “Joannes (o Johannes) Antonius”, e GF, ovvero “Giovanni Fasulo” seguendo invece una dizione volgare, possiamo dire, se vogliamo, in termini più recenti, italiana. Entrambe le sigle sono espresse in monogramma. Nello stesso periodo, come Maestro di Prova, lavorava, accanto al Fasulo, Gaspare Giuno (o Juno), attivo già dal 1591 e risultante in carica fino al 6 giugno 1609. Egli siglava le monete con la lettera G o con GI in monogramma. Ora, nei testi, come ad esempio il CNI XX, viene riportato in merito a questo tarì con sigla, che la lettera G indicherebbe il Maestro di Prova Gaspare Giuno, ipotesi, questa, che è ancora tutt’oggi prevalente nel pensare comune quando si parla di tale moneta. Io, però, ho dei dubbi al riguardo: il solo Maestro di Prova, che, a differenza del Maestro di Zecca non aveva la responsabilità dell’intera attività monetale e non sempre era tenuto a siglare le monete a differenza, invece, del suo superiore, avrebbe potuto apporre la propria inziale omettendo, invece, quella del Maestro di Zecca? In realtà, a livello amministrativo, era quest’ultimo che rispondeva della qualità del lavoro in Zecca e dei prodotti monetari che vi uscivano, non il Maestro di Prova. Dunque, è più credibile che la sigla G non appartenga in realtà a Gaspare Giuno, come creduto finora, ma sia in realtà quella del Maestro di Zecca, ovvero di Giovanni Antonio Fasulo, responsabile della Zecca e, quindi, anche della coniazione di questo tarì commemorativo. Ne deriva che la sigla non può essere letta semplicemente come G, ma come GF (anche secondo criteri stilistici), il monogramma di Giovanni Antonio Fasulo, così come avviene ad esempio in altri nominali napoletani dello stesso periodo dove si ritrovano sullo stesso tondello le sigle GF e G (cfr. il carlino coevo con aquila e legenda di rovescio EGO + IN + FIDE del tipo Pannuti – Riccio, n° 16a). Anche se ci fosse stata la seconda sigla di Gaspare Giuno, essa sarebbe apparsa, probabilmente, sotto il busto del sovrano (come, ad esempio, nel tipo Pannuti-Riccio, n° 9 sotto il busto vi era una croce tra due globetti), come nel predetto carlino, in una parte della moneta che risulta purtroppo tosata. Infatti, non compare nessun’altra sigla nei campi, così come non possiamo immaginare che, in una coniazione ufficiale, appaia solo la sigla del Maestro di Prova, mentre viene omessa (per quale ragione plausibile poi?) quella più importante del Maestro di Zecca che garantiva, appunto, la bontà della moneta. In conclusione, secondo la mia opinione, la sigla che fino ad oggi si è malamente letta come G andrebbe letta per quello che in realtà è, cioè il monogramma GF del Maestro di Zecca dell’epoca. Ipotizzando la presenza della sigla G di Giuno, essa si sarebbe trovata sotto il busto, una parte della moneta purtroppo ad oggi perduta. Tale teoria sarebbe confermata se uscisse un secondo esemplare con la sigla dietro il busto ma con la parte sottostante non tosata. Per le sigle ho fatto molto affidamento su quanto pubblicato da P. Magliocca in Maestri di Zecca, di Prova ed Incisori della Zecca napoletana dal 1278 al 1734, Formia 2013. Ma ora lascio la parola a tutti coloro che vorranno intervenire con le proprie impressioni, commenti ed ipotesi: spero che anche questa discussione possa suscitare il vostro interesse.1 punto
-
E' un bel pò che non facciamo Concorsi, io direi riprendiamo, dopo diverse più belle proviamo a fare uno step in più... Tutto parte da questa discussione linkata sotto " Motti e legende nelle monete " della sezione Monete Moderne, discussione che diventa la più partecipata di tutta le sezione ma che alla quantità aggiunge la qualità. Perchè ? Perchègli utenti postano monete, quasi tutte bellissime di provenienza essenzialmente di aste, ma alla moneta associano il terzo lato della moneta, il messaggio. E' stata una cavalcata tra motti, legende, imprese, storie incredibili, messaggi, comunicazione, potere, propaganda, legittimazioni, sacro e profano, è il vedere la moneta con occhi diversi e qui troverete una rappresentazione incredibile di casi uno più interessante dell'altro... Più volte viene citato Mario Traina che di questo tema ne ha fatto uno splendido libro " Il linguaggio delle monete ", credo che anche lui avrebbe apprezzato....abbiamo fatto divulgazione con in più le immagini. Ma torniamo al Concorso ...cosa chiedo ? di leggere, se volete, la discussione sotto linkata che rimane comunque aperta nella sezione Monete Moderne per eventuali aggiunte e votare mettendo un mi piace al messaggio insito nella moneta che preferite o in più monete. Al 30 novembre chiuderò il voto, che come sempre sarà puramente simbolico, vedremo quali saranno state le tre monete che avranno attirato di più da punto di vista simbolico la vostra attenzione, un premio simbolico anche ai tre utenti che hanno postato le monete con tre, due, un mi piace ( escluso il sottoscitto ). E' una opportunità di conoscenza e divulgazione, tutto in modo semplice e ruspante, ma il contenuto e il messaggio sarà quello che conterà, andiamo oltre alla bellezza, anche la bellezza ci sarà anche, e vediamo cosa ci racconterà la moneta.... Buon concorso ! P.S. Eventuali aggiunte di monete coi loro messaggi vanno fatti nell'apposita discussione nella sezione Monete Moderne " Motti e legende nelle monete "1 punto
-
Ciao, visto il periodo di calma di questi giorni posto una discussione leggera, di intrattenimento. Diciamo per riderci un po’ su, anche se poi tanto da ridere non ci sarebbe per vari motivi… Come sapete tra i vari temi di mio interesse rientra la monetazione severiana e ciò mi porta ad effettuare ricerche sia di nuovi dati che di verifica degli esemplari in commercio. E compiendo queste ricerche ho avuto modo di notare qualcosa di … mah… buffo? Assurdo? Non saprei come definirlo… provateci voi! Quindi per palesare anche ai neofiti il tema, vi propongo questo esemplare: Caracalla AR antoninianus, 198-217 AD, 4.98gm, struck 215-217 AD, 24.0mm. Obv: ANTONINVS PIVS AVG GERM; radiate, draped, and cuirassed bust right. Rev: VENVS VICTRIX; Venus standing facing, head left, holding Victory and scepter, leaning on facing oval shield set on helmet. RIC IV P1 p259, 311c; RSC 608 . EF. https://www.vcoins.com/en/stores/apollo_numismatics/12/product/caracalla_ar_antoninianus__venus_victrix__ef/47300/Default.aspx Per approfondimento su questa tipologia vi rimando alla discussione http://www.lamoneta.it/topic/140719-caracalla-venus-victrix/#comment-1607914 https://it.wikipedia.org/wiki/Caracalla Scorrete la biografia e vi troverete questo esemplare ad identificare un suo antoniniano: ANTONINVS PIVS AVG(ustus) GERM(anicus), Busto di Caracalla radiato, paludato, corazzato rivolto a destra / VENVS VICTRIX, Venere paludata, elmata, regge con la mano sinistra una lancia e si poggia a uno scudo. AR Antoniniano, 5.10 g, Zecca Roma, 215 d.C. circa. A b o m i n i o !!!! Non solo una patacca ma di una fattura assolutamente pessima come qualità. Sempre per i neofiti, per i profani e… per i “cecati” (tra i quali posso annoverarmi ma non a tali livelli) eccole affiancate. Evidentemente: · colui che ha scritto il testo (e inserito l’immagine) non ha la pur minima idea della numismatica romana · è pure abbastanza sfortunato perché per beccare tra tutti gli antoniniani (non dico autentici ma almeno credibili) che escono ad una ricerca “Caracalla antoniniano” scegliere proprio questo… Per la cronaca basta andare sulla Baia per trovare dei confronti: www.ebay.it/itm/RICONIO-MONETA-IMPERO-ROMANO-CARACALLA-ANTONINVS-PIVS-AVG-VENVS-VICTRIX-/371785796545?hash=item5690290bc1:g:oRQAAOSwstxVeW8~ descritto come riconio http://www.ebay.it/itm/RICONIO-MONETA-IMPERO-ROMANO-ANTONINIANO-CARACALLA-E-VENERE-VITTORIOSA-215-D-c-/351901924154?hash=item51eefd3b3a:g:8PMAAOSwpDdU9OmH idem quindi debitamente denunciati come mere (e pessime) copie. A voi la parola per i commenti. Ciao Illyricum1 punto
-
Buonasera a tutti, posto gli acquisti di qualche giorno fa. Due coronati dello stasso tipo, zecca dell'Aquila, con piccole differenze di conio. Li ho comprati per la loro conservazione, penso abbiano circolato pochissimo. Vi piacciono?1 punto
-
Buonasera mi piacerebbe leggere qualche vostro commento circa la conservazione e la tonalita' del colore saluti, Max1 punto
-
Genny...grandissima moneta ... estremamente rara. Continuiamo ? .... per le ragioni esposte da Raffaele il tarì venne ritirato dalla circolazione e ripercosso con il conio di questo carlino....anch'egli con 2 cornucopie ai lati dell'aquila.1 punto
-
Portale una a una in tasca, o in valigia .. ( se non valgono più di 10.000€) massimo accettabile di asporto contanti , mi pare, .... se ti infili nella"burocrazia"........1 punto
-
Ciao, sono concorde con quanto afferma @grigioviola . Anch'io ci vedevo una sorta di palma stilizzata a sinistra e per fortuna qualcun'altro conferma questa mia impressione. Il ritratto mi pare radiato (e ciò rimanderebbe ancor di più ad una HILARITAS corrotta) ma spesso nelle imitative vi sono commistioni tra diritti e rovesci che non compaiono nella monetazione ufficiale. Personalmente inoltre trovo il rovescio proposto da @profausto molto calzante. In ultimo volevo rimarcare il diametro dell'esemplare, con 10 mm siamo tra i minimi/minimissimi per cui apre due interpretazioni: fase tarda del III secolo V secolo Alla luce di ciò, l'attribuzione cronologica abbraccia un periodo ampio con varie combinazioni di rovesci-campione usabili come prototipo. Solo per curiosità ed esulando parzialmente dal tema iniziale del "coniglio a rovescio" vi segnalo un link che presenta su una moneta di Viminacium un esemplare dove a rovescio compare un... coniglio (vedi figura 5 e descrizione sopra). http://www.cnvaldostano.it/la_zecca_di_viminacium.htm Ciao Illyricum1 punto
-
il contorno "limato" in alcuni punti bordo in rilievo +, mancanza anche minima di rilievi della legenda e aspetto generale, fanno propendere per un falso fuso.1 punto
-
Non per nulla avevo scritto "Sembrerebbe un Para ecc...." Comunque la moneta è questa di seguito, ti ho trovato la scheda, Impero Ottomano: http://en.numista.com/catalogue/pieces49196.html1 punto
-
Salve. Peso e diametro sono fondamentali in questi casi. A me, sinceramente, non dà una buona impressione, anzi, mi sembra un falso ottenuto per fusione: il taglio della moneta sembra manomesso intenzionalmente e la porosità diffusa non può essere dovuta solo ad una pulizia aggressiva, ma piuttosto al processo di fusione per la realizzazione della moneta stessa. Il prototipo che hanno cercato di riprodurre è un sesterzio di Caligola con la rappresentazione delle sue sorelle al rovescio, tipo questo: Caligola (37-41). Sesterzio. D/ C. CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT. Testa laureata a sinistra. R/ AGRIPPINA DRVSILLA IVLIA SC. Le tre sorelle di Gaio stanti di fronte: Agrippina tiene una cornucopia, Drusilla patera e cornucopia, Iulia timone e cornucopia. RIC I, 33. Si tratta di una moneta molto ricercata e per questo anche molto falsificata. Nota le differenze che intercorrono tra la moneta del tuo amico che hai postato e l'originale che compare nella foto qui sopra. Resto dell'idea, quindi, che l'oggetto che ci hai mostrato sia una riproduzione ottenuta per fusione senza alcun valore, né storico-numismatico, né economico.1 punto
-
Almeno abbiamo fatto in tempo a capire di che tipologia monetale si trattava.1 punto
-
Ciao @gianvi. Provo ad esprimere un mio parere per cercare di rispondere alle tue domande. Ultimamente, ho notato che sono apparse diverse, non molte però, di queste piastre di Francesco I con doppia ornatura al diritto. La tua qui in esame presenta un grado di conservazione che, secondo me, arriva ad un qBB. L'usura da circolazione è diffusa su entrambi i lati della moneta, ci sono segni da contatto e graffi di conio al rovescio. Per la rarità, ti assicuro che non è così comune trovare una piastra di questo tipo con la particolarità della doppia ornatura, però per sapere il grado di rarità preciso bisognerebbe consultare dei cataloghi come il Gigante che portano la suddetta varietà. Non so se sul MIR Napoli è riportata perché non ho il volume. I cataloghi descrittivi "canonici" come il Pannuti-Riccio o il CNI XX non contemplano questa variante. Sicuramente, a parer mio, non siamo al di sotto dell'R2.1 punto
-
Grazie @eliodoro per l'intervento. Per le tre cinquine, è giusto concludere che è visibile solo la lettera G del Maestro di Prova Giuno, mentre dall'altro lato, all'altezza della corona, non è visibile la sigla IAF e non perché la moneta sia stata tosata. L'ipotesi espressa da @Rex Neap per spiegare tale mancanza mi sembra convincente: se c'è la G ci doveva essere anche IAF è semplicemente stata messa più in basso, quindi non allineata con la G vicino alla corona. Può essere accaduto, quindi, che sia andata fuori tondello e non sia più visibile. D'altronde, il caso di @Fabrizio Proietti non è l'unico noto, com'è emerso da questa discussione. Resta comunque una moneta bella e particolare, sicuramente un ottimo acquisto partendo già dal fatto che non presenta tosature ed è quindi integra.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Anche mezzi baiocchi, in tante tante varianti: http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-BE14RA/3 Ciao, RCAMIL.1 punto
-
Concordo. Cerchiamo di rimanere nell'interessantissimo tema e di non divagare.... Mi sembra verosimile che il tondello del decadramma sia antico. Non credo nemmeno che sia stato utilizzato per ricavare una moderna versione. Si avrebbe una inevitabile "ricottura" del metallo, che qui non riesco a vedere. Per quanto sia possibile copiare una moneta antica tramite accurato calco e ricavare un esemplare fuso o pressofuso che poi viene sottoposto a oscena aggressione chimica, il risultato finale non mi sembra possibile, specie alla luce dell'ultima foto postata da Babelone. Naturalmente l'ultima parola è possibile solo con un buon esame diretto col microscopio proprio su questo bordo, per assicurarsi che effettivamente è argento antico coniato, poi "scorticato"....1 punto
-
Paradigmatico di questa discussione il portare a modello l'Eid Mar.1 punto
-
Quando un utente - a caso - piu' bravo di me in un settore mi fa capite che non sono un grande esperto per quello specifico settore posso sentirmi a disagio se lo fa con sarcasmo o con tono offensivo . se invece mi fa notare qualcosa che io non so e lo fa scevro da toni saccenti o sarcastici ma solo con l'intenzione di aiutarmi a comprendere meglio allora posso imparare. Vale per la tecnica delle coniazioni quanto per la fisica dei metalli quanto per la grammatica ....1 punto
-
DE GREGE EPICURI La foto mi pare scarsa, la moneta comunque è molto usurata; però sembrerebbe un sestante.1 punto
-
Mi fa molto piacere tutto questo...anche il fatto che non hai dimenticato questa monetazione, io mi sono invece appassionato a seguire un po' di più una moneta che era rimasta un po' indietro nelle discussioni e molto affascinante come il grosso tornese, certamente a questo punto fondamentale sarà leggere per tutti il MEC sia per Asti ma anche per le altre monetazioni....1 punto
-
Molto importante e' anche vedere sempre il peso, in questo caso solo quello ci porta in una direzione precisa... Io credo che uno che affronta all'inizio questa monetazione, ma vale per le medievali in genere, abbia delle oggettive difficoltà a capire le singole lettere, per chi ha occhio sembra semplice ma il parlare con alcuni che seguono monetazioni più recenti mi porta a questa conclusione. Ho molto apprezzato da questo punto di vista i libri che disegnano le singole lettere tipo Baldassarri per Pisa o Crippa con Milano, forse dovremmo fare anche questo ...a penna su foglio come leggere la N, la P, la S coricata, e' una idea...che butto li' poi certamente ci vuole anche qualcuno che legga ... Le discussioni lunghissime e importanti hanno grandi pregi ma poi la difficoltà di ripartire per uno che inizia, impossibile leggerle tutte, forse le tabelle più un tracciato epigrafico potrebbe aiutare e comunque essere un buon aiuto per tutti. Anche per prenderla allegramente sembriamo quei presentatori che vogliono aiutare a tutti i costi i concorrenti nel rispondere esattamente, solo che qui di concorrenti non ne vedo ....ma sono sempre ottimista, arriveranno......arriveranno...1 punto
-
Vai a finire in un pantano che non ne esci piu', questo e' garantito.1 punto
-
Ciao @babelone, mi avevi chiesto del denario falso di Bruto, ho assemblato alcune foto di come si presentava ossidato con clorargirice (cloruro e sedimenti) quando mi e stato chiesto per la pulitura un po di anni fa. Certamente un invecchiamento ingannevole , a pelle anche con lentino non dava tanti sospetti. Al primo bagnetto ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. Cominciò ad apparire un (vile) argento nuovo , che mi insospettì all'istante. Come vedi le foto parlano da sole , un denario di Bruto in argento a fusione.............Non si intravvedono corrosioni profonde e il colore ......non ha niente di antico. Il collezionista che lo aveva trattato , lo ha riconsegnato alla ditta che glie lo aveva ceduto. Il primo bagno per il rovescio l'ho fatto delicato, sul dritto ho usato un bagno più aggressivo. Come vedi le superfici non hanno corrosioni , questo e dovuto all'argento nuovo. Probabilmente sarebbe stato coniato con un denario originale e con questo tipo di invecchiamento , le corrosioni ci sarebbero state, anche se stilisticamente molto scadente.1 punto
-
Buon giorno a tutti. Nonostante scriva molto raramente, causa impegni sul lavoro e la classica fase della vita in cui si fanno 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, vi leggo con piacere e continuo a portare avanti la mia collezioncina di siciliane. Vi presento l'ultimo acquisto: preso un pò avventurosamente su ebay a 360 euro. Si tratta di un pierreale di Pietro Secondo D'aragona, moneta abbastanza rara anche se non rarissima, il cui acquisto è generalmente un terno al lotto. Il suo valore nelle aste, oscilla veramente tanto, per cui credo di averla grossomodo presa al valore di mercato, ma a riguardo gradirei il vostro parere. Il peso è di 3.1 grammi, perfettamente leggibile, centrata e con una bella patina, anche se presenta usura da circolazione abbastanza accentuata. Come grading sono indeciso tra il MB/ BB ed il qBB. la buona fattura della moneta mi porterebbe a propendere per il qBB. Le foto sono di bassa qualità, sono quelle del venditore ed io al momento non ho tempo per migliorarle. Spero siano sufficienti per una valutazione di massima1 punto
-
Grazie per la gentilissima risposta molto dettagliata. Effettivamente io faccio riferimento alle tre cinquine con scettro. Personalmente ne ho trovata una senza IAF ma solo G. ora provo a mandarti una foto. Inoltre chiedendo in giro ne è saltata un'altra fuori. in ogni caso in nessuna delle due si riscontra tosatura basandosi sul peso.1 punto
-
Ammonimenti o raccomandazioni Si è visto quanto sostanzialmente costante, pur nel succedersi sulla Cattedra di Pietro di diverse personalità, sia stato l’insegnamento dei papi menzionati a proposito della ricchezza e del giusto modo di rapportarsi ad essa; magistero espresso attraverso una lunga teoria di ‘massime’ inserite come legende sulle loro monete. Nulla di strano, perciò, nel fatto che tale originale forma di ‘catechesi’ sia stata impiegata per far circolare, insieme ai soldi, anche una altrettanto corposa serie di raccomandazioni o ammonimenti, nella speranza di far sì che nessuno, un giorno, debba sentirsi indirizzare le parole conclusive della parabola del ricco stolto; quelle stesse parole che si possono leggere sull’oro di una quadrupla di Alessandro VII: HAEC AVTEM QVAE PARASTI CVIVS ERVNT, “ma quanto hai procacciato di chi sarà”? Come quando si ricompone un puzzle mettendo insieme i vari pezzi, così ci si potrebbe divertire nel tentativo di riunire le legende utilizzate da diversi pontefici – magari a distanza di decenni – per costruirne altre di senso ancor più completo. Alcuni esempi potrebbero essere i seguenti: all’auspicio di Innocenzo XII che su un testone fa imprimere NON SIT TECVM IN PERDITIONEM (nota 16), (il denaro) “non sia con te nella perdizione”, si potrebbe far seguire l’invito di Benedetto XIII, che su un grosso comanda DA NE NOCEAT, “dallo perché non ti sia di danno”. Fig. 14: Roma, Innocenzo XII (1691-1700), Testone. Al R/: NON SIT TECVM IN PERDITIONEM, in quattro righe. Da Internet. (discussione su lamoneta.it) Oppure, il perentorio TOLLE ET PROICE, “prendi (il denaro) e dallo via”, presente su un grosso di Clemente XII può essere completato da NE FORTE OFFENDICVLVM FIAT, “perché non diventi un inciampo”, che lo stesso papa Corsini fa scrivere dai suoi maestri di zecca su un testone. Ancora, volendo sottolineare nuovamente che un corretto utilizzo del denaro può contribuire alla salvezza dell’uomo, si potrebbero leggere in sequenza le legende FAC VT IVVET, “fa che sia utile”, e PRO PRETIO ANIMAE, “per il riscatto dell’anima”, che Innocenzo XII e il suo omonimo XI fanno apporre, rispettivamente, su un mezzo grosso e su uno scudo d’oro. Fig. 15: Roma, Innocenzo XII (1691-1700), Mezzo grosso 1692. Al R/: FAC VT IVVET, in quattro righe con la data. Ex Asta Artemide XXIV, 2009, lotto n. 3316. Ben si prestano, infine, ad essere lette come una sola frase le due raccomandazioni NEQVE DIVITIAS (nota 17), “non le ricchezze”, e POSSIDE SAPIENTIAM, “possiedi la saggezza”, che Innocenzo XI fa brillare sull’oro con due differenti scudi. L’esercizio che si è voluto tentare manipolando le iscrizioni in esame può apparire, e forse realmente è, un po’ forzato. Meno azzardato sembra, invece, sostenere che molti dei pontefici di quel particolare periodo siano stati i compilatori di una sorta di ‘codice’, alla composizione del quale ciascuno ha contribuito dettando alcune ‘norme’. Queste ultime, scritte non su carta o pergamena, bensì sul metallo delle monete, si sostanziano in ‘raccomandazioni’ oppure in ‘ammonimenti’, a seconda che il loro contenuto si traduca, rispettivamente, in un invito ad un comportamento attivo o omissivo nei confronti del denaro; in altri termini a fare o non fare determinate cose. Proprio perché si è utilizzata l’immagine del codice, se ne dà conto qui di seguito in un elenco numerato, comprendente anche l’indicazione dei papi alla cui monetazione afferiscono i vari pezzi citati, partendo dalle legende che chiamano il fedele ad una condotta di tipo attivo. 1. DIVES IN HVMILITATE, “il ricco (si glori) della sua umiltà”. Innocenzo XI, 2 scudi d’oro (o doppia); legenda tratta dalla Lettera di Giacomo (1, 10). 2. TEMPERATO SPLENDEAT VSV, “risplenda (il denaro) con un uso moderato”. Alessandro VII, mezzo grosso. L’iscrizione, tratta da un verso delle Odi di Orazio (2, 2, 3), è la continuazione della legenda NVLLVS ARGENTO COLOR EST AVARIS già citata in precedenza da un testone di Innocenzo XIII, e bene esprime il contrasto tra il tener nascosta la propria ricchezza o il farla rilucere attraverso un suo giusto impiego. Fig. 16: Roma, Alessandro VII (1655-1667), Mezzo grosso. Al R/: TEMPERATO SPLENDEAT USV, in cinque righe. Ex Asta Nomisma 103, 2009, lotto n. 1132. 3. REDDE PROXIMO IN TEMPORE SVO, “rendi al prossimo a suo tempo” (i denari avuti in prestito). Due monete e due metalli per questa sollecitazione che papa Clemente XI fa apporre su una doppia d’oro e su un giulio. 4. IN TESTIMONIA TVA ET NON IN AVARITIAM, “verso le tue leggi e non verso l’avarizia”. Come la precedente, anche questa legenda afferisce alla monetazione di Clemente XI che, per la zecca di Ferrara, la fa apporre su uno scudo d’argento (nota 18). È tratta da un Salmo (118 o 119, v. 36) [nota 19] nel quale è preceduta dalle parole (rivolte al Signore): inclina cor meum, “piega il mio cuore”. Fig. 17: Ferrara, Clemente XI (1700-1721), Scudo d’argento 1709 A. IX. Al R/: IN TESTIMONIA TVA ET NON IN AVARITIAM, in quattro righe. Ex Asta Nomisma 39, 2009, lotto n. 2556 5. THESAVRIZATE IN COELIS, “accumulate tesori nei cieli”. Il versetto, tratto da una frase di Gesù riportata nel Vangelo di Matteo (6, 20), appare su un giulio di papa Clemente XIII (Carlo della Torre di Rezzonico, 1758-1769). È l’immediata continuazione di un altro invito fatto da Cristo (Matteo 6, 19) che costituisce, in questo elenco (vedi n. 6), il primo di quelli che, ai fini del presente lavoro, sono stati definiti ‘ammonimenti’. Fig. 18: Roma, Clemente XIII (1758-1769), Giulio 1761. Al R/: THESAVRIZATE IN COELIS, in quattro righe con la data. Ex Asta Nomisma 38, 2009, lotto n. 1428. Note 16 - La legenda è ispirata a un versetto degli Atti degli Apostoli (8, 20) costruito, in realtà, come una condanna. Pietro, infatti, ad un uomo che voleva acquistare col denaro il potere di dare lo Spirito Santo attraverso l’imposizione delle mani, indirizza questo anatema: pecunia tua tecum sit in perditione, il tuo danaro sia con te nella perdizione. Papa Innocenzo, invece, impostando la frase come negazione, sembra voler scongiurare la condanna. 17 - La legenda NEQVE DIVITIAS è stata utilizzata anche da Clemente XI su un mezzo grosso. 18 - La seconda parte della legenda, NON IN AVARITIAM, è presente su altre due monete di Clemente XI per Roma; più esattamente: mezzo scudo d’oro e grosso. 19 - I 150 salmi che compongono il Salterio hanno una numerazione diversa a seconda che facciano riferimento al testo ebraico masoretico (versione della Bibbia ufficialmente in uso tra gli Ebrei) o ai manoscritti greci. Segue...1 punto
-
@contemax67 @tonycamp1978 Questo è un qFdc/Fdc "Rame rosso" fate i confronti. Io poi l'ho tolta dalla plastica e l'ho messa in una bustina di acetato.1 punto
-
Proverbi o massime AERVGO ANIMI CVRA PECVLII, “l’amore del denaro (è) la ruggine dell’anima”. Non usa mezze misure papa Clemente XI (1700-1721), al secolo Giovanni Francesco Albani, quando fa imprimere questa legenda, ispirata ad un versetto (330) dell’Ars Poetica di Orazio, su un mezzo scudo d’argento (nota 10). Benedetto Odescalchi, invece, divenuto il 240° papa col nome di Innocenzo XI (1676-1689), sceglie il metallo più prezioso per far scrivere a chiare lettere dai suoi zecchieri su una doppia d’oro che QVI CONFIDIT IN DIVITIIS CORRVET, “chi confida nelle ricchezze andrà in rovina”. Concetto ribadito su un’altra doppia emessa a nome dello stesso pontefice sulla quale si può leggere MVLTOS PERDIDIT AVRVM, “l’oro ha mandato molti in rovina”, così come sul testone del già citato Clemente XI, sul quale la dicitura è MVLTOS PERDIDIT ARGENTVM (ove quest’ultimo vocabolo, oltre a riferirsi al metallo della moneta specifica, può essere tradotto anche semplicemente come denaro). In definitiva si potrebbe dire che FERRO NOCENTIVS AVRVM, “l’oro (è) più dannoso del ferro”, come sosteneva già Ovidio nelle Metamorfosi (1, 141) e come, evidentemente, pensava anche Clemente XI che fa imprimere tali parole sia su uno scudo d’oro che sul suo multiplo da due. Fig. 3: Roma, Clemente XI (1700-1721), Scudo d’oro A. XII. Al R/: FERRO NOCENTIVS AVRVM, in quattro righe (Da internet: rhinocoins). Sembra quasi che i due pontefici abbiano voluto fare a gara nel ricordare agli uomini i pericoli derivanti dal denaro, inteso come falso dio: così papa Albani ribadirà sull’oro (scudo) il versetto del Libro dei Proverbi (11,4) che recita DIVITIAE NON PRODERVNT, “le ricchezze non gioveranno”, che papa Odescalchi aveva già utilizzato su uno scudo d’argento con maggiore precisione: NON PRODERVNT IN DIE VLTIONIS, vale a dire “non gioveranno nel giorno del giudizio”. Fig. 4: Roma, Innocenzo XI (1676-1689), Scudo d’argento. Al R/: NON PRODERVNT IN DIE VLTIONIS, in quattro righe. Ex Asta Nomisma 39, 2009, lotto n. 2520. Infatti QVI AVRVM DILIGIT NON IVSTIFICABITVR, “chi ama l’oro non sarà giustificato”; questo è quello che Clemente XI fa imprimere ancora sull’oro (doppia). Il perché lo ricorda Antonio Pignatelli di Spinazzola, divenuto papa col nome di Innocenzo XII (1691-1700); questo pontefice pio e benevolo, che sarà ricordato anche per la sua forte presa di posizione contro il nepotismo nella Chiesa e per aver affermato “i poveri sono i miei nipoti”, prese in prestito dal Libro della Sapienza (7, 9) le parole che si possono leggere su un suo testone: TAMQVUAM LVTVM AESTIMABITVR (nota 11), (il denaro) “sarà valutato come fango” (nota 12). Le conclusioni di questa ‘catechesi’ impartita da ben suoi tre predecessori saranno poi tratte qualche anno più tardi da Lorenzo Corsini, papa Clemente XII (1730-1740), che su un grosso farà osservare ai fedeli che quelli che accumulano denaro sono IMPLETI ILLVSIONIBVS, “pieni di illusioni” (nota 13), su un’altra moneta col medesimo nominale ricorderà che il denaro, se non impiegato cristianamente, VANVM EST VOBIS, “è cosa vana per voi”. Fig. 5: Roma, Clemente XII (1730-1740), Grosso 1739. Al R/: IMPLETI ILLVSIONIBVS, in quattro righe con la data. Ex Asta Artemide XXV, 2009, lotto n. 1873. Del resto già i due papi che lo avevano preceduto dopo la morte del suo omonimo avevano in qualche misura espresso quest’ultimo concetto: Innocenzo XIII (Michelangelo Conti, 1721-1724), infatti, aveva fatto osservare con un mezzo grosso che il denaro SATIS AD NOCENDVM, “basta per nuocere”( nota 14); Benedetto XIII (Pietro Francesco Orsini, 1724-1730), a sua volta, aveva scelto il grosso per ribadire che (il denaro) IVVAT ET NOCET, “giova e nuoce”, a seconda, evidentemente, dell’uso che se ne fa. Fig. 6: Roma, Benedetto XIII (1724-1730), Grosso. Al R/: IVVAT ET NOCET, in tre righe. Ex Asta Negrini 31, 2010, lotto n. 1749. Cosa fare, allora, della propria ricchezza? Lo si vedrà meglio nella parte della trattazione riservata a quelle legende che sono state classificate come ammonimenti e raccomandazioni oppure come incitamenti alla carità. Qui si può invece dire cosa non fare del denaro, almeno secondo l’insegnamento lasciato dai pontefici sulle monete. Di sicuro non è il caso di pensare soltanto ad accumularlo, o perché poi ne godranno altri, oppure perché farà una fine diversa da quella auspicata: è Innocenzo XIII, infatti, che su un giulio fa imprimere QVI ACERVAT ALIIS CONGREGAT, “chi accumula ammucchia per gli altri”, mentre Clemente XI lascia detto su un mezzo grosso CONSERVATAE PEREVNT, ossia “conservate (le ricchezze) vanno in fumo”. Né va dimenticato che una gran bella moneta fatta coniare tempo prima da Fabio Chigi, una volta divenuto papa col nome di Alessandro VII (1655-1667), aveva già avvertito, non soltanto a parole, ma anche con l’immagine presente nel campo, della circostanza che la quantità di preoccupazioni è proporzionale a quella del denaro. Su un giulio, infatti, attorno alla rappresentazione di un tavolo sul quale sono ammucchiate delle monete, si può leggere il verso tratto dalle Odi di Orazio (3, 16,17) che recita: CRESCENTEM SEQVITVR CVRA PECVNIAM, “l’affanno segue l’aumento del denaro”. Fig. 7: Roma, Alessandro VII (1655-1667), Giulio. Al R/: CRESCENTEM SEQVITVR CVRA PECVNIAM, attorno a un tavolo, drappeggiato, con monete. Ex Asta Nomisma 38, 2009, lotto n. 1325. Mai prestare denaro con un tasso di interesse eccessivo! E’ Clemente XI, con una doppia d’oro, a riprendere un concetto già espresso in proposito da papa Leone I Magno (440-461) (nota 15): FOENVS PECVNIAE FVNVS EST ANIMAE, “l’usura è la morte dell’anima” . Tanto meno pare opportuno lasciarsi sopraffare da atteggiamenti quali la cupidigia o l’avarizia. La prima, infatti, è definita da Innocenzo XI, non a caso su un pezzo dal gran valore intrinseco (una quadrupla d’oro), e sulla scorta della Prima Lettera a Timoteo (6, 10), come RADIX OMNIVM MALORVM, “radice di tutti i mali”. Alla seconda sono dedicate numerose emissioni, proprio per sottolinearne la lontananza dalla morale cristiana; così, seguendo la successione cronologica dei papi, si possono ricavare diverse sentenze in proposito: Innocenzo XI fa apporre su un mezzo scudo la legenda AVARVS NON IMPLEBITVR, “l’avaro non sarà (mai) saziato” (dal denaro), mentre affida ad una doppia, dunque al metallo più pregiato, il messaggio NIHIL AVARO SCELESTIVS, “niente (è) più scellerato dell’avaro”. Fig. 8: Roma, Innocenzo XI (1676-1689), Mezzo Scudo A. VII. Al R/: AVARVS NON IMPLEBITVR, in tre righe. Ex Asta Künker 165, 2010, lotto n. 600. Clemente XI, questa volta dalla zecca di Ferrara, dedica due coniazioni al tema in esame; la dicitura SCELERVM MATER AVARITIA, “l’avarizia (è) madre di delitti”, ispira quasi ribrezzo in chi la legge su un testone, mentre un sentimento di commiserazione si può forse provare meditando sulle parole QVIS PAVPER? AVARVS, “chi è povero? l’avaro”, impresse su un analogo nominale, con tanto di punto interrogativo. Fig. 9 e 10, nell’ordine: Ferrara, Clemente XI (1700-1721), Testone 1717. Al R/: QVIS PAVPER? AVARVS, in quattro righe con la data; Testone 1717. Al R/: SCELERVM MATER AVARITIA, in quattro righe con la data. Ex Asta Nomisma 39, 2009, lotti 2557 e 2558. Innocenzo XIII, infine, ribadisce una sorta di senso di pena per chi si fa soggiogare da questa condotta perché, come riportato su un testone, NVLLVS ARGENTO COLOR EST AVARIS, “il denaro non ha luce per gli avari”, dato che lo tengono sempre nascosto. Volendo tirare le fila del discorso sin qui seguito, si potrebbe dire con due monete di Clemente XI – un testone e un giulio, rispettivamente – che il denaro, a seconda del rapporto che si instaura con esso, IMPERAT AVT SERVIT, “comanda o serve”, e che PRVDENTIA PRETIOSIOR EST ARGENTO, “la saggezza è più preziosa”. Fig. 11 e 12, nell’ordine: Roma, Clemente XI (1700-1721), Testone 1702. Al R/: tavolo con sacchetti di monete; intorno IMPERAT AVT SERVIT e la data. Da Internet (Rhinocoins); Giulio. Al R:/ PRVDENTIA PRETIOSIOR EST ARGENTO, in quattro righe. Ex Asta Negrini 31, 2010, lotto n. 1746. Ciò è talmente vero che, come ricorda Innocenzo XI sia su un grosso che sulla sua metà, la saggezza non è un bene acquistabile col denaro; la legenda QVID PRODEST STVLTO, “che giova allo stolto”, richiama infatti un passo del Libro dei Proverbi (17, 16) nel quale si legge: quid prodest stulto habere divitias, cum sapientiam edere non possit? E cioè: “che giova allo stolto avere ricchezze, dal momento che non può comprare la saggezza”? La conclusione, a questo punto, la si può ricavare da un testone del medesimo papa che, parafrasando una frase di Gesù ricordata negli Atti degli Apostoli (20, 35), riporta: MELIVS EST DARE QVAM ACCIPERE, “è meglio dare che ricevere”. Fig. 13: Roma, Innocenzo XI (1676-1689), Testone 1686. Al R/: MELIVS EST DARE QVAM ACCIPERE, in cinque righe con la data. Ex Asta Nomisma 39, 2009, lotto n. 2522. Note: 10 - Si approfitta di questa nota per dar conto al lettore di alcune avvertenze: i nomi attribuiti alle varie monete citate nel presente lavoro sono quelli per esse adoperati da Mario Traina nel volume Il Linguaggio delle monete; in alcuni casi, come correttamente lo stesso Autore di volta in volta indica, essi differiscono da quelli utilizzati da altri (es. Muntoni); lo stesso discorso vale per le traduzioni in italiano e per quelle che vengono indicate come fonti alle quali le legende si ispirano. A titolo di esempio, per il Muntoni, la moneta con la legenda AERVGO ANIMI… è una mezza piastra e si cita come fonte San Giovanni Crisostomo. Cfr. Muntoni 1972-1974, vol. IV, p. 295. 11 - Nel presente articolo le legende sono presentate nella oro forma completa e corretta con l’avvertenza che sulle monete esse potevano apparire in realtà variamente abbreviate o con diverse grafie. Nel caso di specie la moneta in questione presenta la parola TANQVAM (per TAMQVAM). 12 - Su uno scudo d’oro di Clemente XII si legge: DE LVTO FAECIS, “dal fango della feccia”; la legenda, tratta dal Salmo 39, sottintende “il Signore mi ha liberato” e, per Traina, è riferita appunto all’oro. Cfr. Traina 2006, cit., p. 85. 13 - Traina ricorda come la fonte biblica (Salmi 37,8: Lumbi mei impleti sunt illusionibus) sia di incerta interpretazione, tanto che la legenda presente sulla moneta viene tradotta in vari modi come, per esempio, “pieni di fiamme” o “pieni di ignominie”. Cfr. Traina 2006, cit., p. 198. 14 - Secondo alcuni, la legenda va interpretata nel senso che anche una piccola moneta, come appunto il mezzo grosso in questione, “basta a far male”. Cfr. Monti 1883, III, p. 181. Ciò a conferma di quanto già presente su altre monete di pontefici precedenti: tanto Innocenzo XI sul grosso e sulla sua metà, che Clemente XI sul mezzo grosso, avevano fatto scrivere NOCET MINVS, “fa meno danni”. L’Autore sostiene che “potendosi con il denaro commettere molto di male, esso nuoce meno quando la moneta è piccina, come appunto le monetuzze su cui è impressa questa sentenza, che furono sempre di modesto valore” (cfr. p. 175). 15 - Dottore della Chiesa. La citazione completa è in Traina 2006, cit., p. 168. segue... P.S.: continuerò più tardi col secondo argomento "ammonimenti o raccomandazioni) ... adesso la famiglia chiama1 punto
-
Tra elemosina e dannazione. La ricchezza nelle monete dei papi (versione pre-print di un articolo pubblicato in due puntate su «Cronaca Numismatica», nn. 232 e 233, settembre e ottobre 2010). Prima di affrontare l’oggetto della presente indagine, occorre subito precisare che la stesura della stessa è stata enormemente facilitata dalla possibilità di usufruire di un prezioso strumento di lavoro: il repertorio di motti, imprese e legende delle monete italiane costituito dal volume Il linguaggio delle monete di Mario Traina. Di questo libro è stato detto e scritto in numerose e più che positive recensioni, ma è certo che, al di là delle parole, la sua importanza e la sua utilità saranno sempre più rimarcate dagli studi che sarà possibile realizzare grazie ad esso e dalle tante citazioni che, per un lunghissimo futuro, questo volume inevitabilmente riceverà da parte di chi, trovandosi a scrivere di numismatica, non potrà che trarre giovamento dall’utilizzo di uno strumento che mette a disposizione, in un’unica fonte, una miriade di preziose indicazioni e informazioni. Fatta questa doverosa premessa, ci si può addentrare nel tema specifico della trattazione, ossia l’utilizzo delle monete come strumento per la trasmissione di determinati messaggi. Più nel dettaglio, saranno oggetto di questo articolo alcune monete papali, prevalentemente (ma non solo) emesse tra il pontificato di Innocenzo XI (1676-1689) e quello di Clemente XII (1730-1740), attraverso le quali i papi dell’epoca hanno voluto diffondere, mediante appropriate legende, alcuni specifici insegnamenti relativi al denaro. In particolare sembrerebbe di poter classificare queste coniazioni in tre tipologie a seconda che quanto su di esse iscritto (e in qualche caso effigiato) sia riconducibile a proverbi o massime, a insegnamenti o raccomandazioni relativi alla ricchezza, a incitamenti alla (o esaltazione della) carità. In sostanza si ritiene di poter individuare, anche per la contiguità cronologica, una sorta di fil rouge che, in quel determinato periodo della storia della Chiesa, ha accomunato diversi pontefici che hanno scientemente utilizzato le loro monete per realizzare una sorta di ‘catechismo numismatico’ volto a insegnare un uso corretto del denaro. La cosa non deve stupire perché molto spesso la moneta ha avuto, tra le sue funzioni, anche quella di mezzo di propaganda e di trasmissione di messaggi da parte di chi aveva l’autorità per coniarla a chi doveva riceverla e utilizzarla. L’esistenza di una tale funzione, sia pure accessoria, tra quelle assolte dalla moneta, è confermata anche dal fatto che in qualche caso si è verificato il processo contrario, ossia l’apposizione di segni dei quali l’autorità era non mittente, ma destinataria e bersaglio: è questo il caso, ad esempio, delle contromarche OLIM e BOMBA apposte su alcune piastre di Ferdinando II delle Due Sicilie, proprio per sfruttare le potenzialità ‘comunicative’ delle monete a scapito del monarca. Semmai, d’acchito, ci si potrebbe meravigliare del fatto che sia stata la Chiesa ad utilizzare il denaro, cioè, come lo definì Giovanni Papini, lo ‘sterco del demonio’, per la diffusione del proprio insegnamento. In effetti, se si pensa all’episodio di Gesù che scaccia i mercanti dal tempio di Gerusalemme – raccontato in tutti e quattro i Vangeli – si potrebbe essere tentati di concludere che Egli abbia inesorabilmente emesso una condanna senza appello nei confronti del denaro. Opinione, questa, che parrebbe rafforzata anche da alcune parole pronunciate da Gesù nei confronti dei ricchi, come quel “guai a voi” a loro indirizzato secondo quanto riportato dall’evangelista Luca, oppure il “voi non potete servire Dio e Mammona” di cui parla Matteo. Fig. 1: Roma, Clemente XIII (1758-1769), Mezzo Grosso 1761. Al R/: VAE VOBIS DIVITIBVS, “guai a voi ricchi”, in tre righe con la data. Ex Asta Nomisma 39, 2009, lotto n. 2588. Né può essere dimenticato che, nella storia del cristianesimo, si annoverano figure che hanno fatto del disprezzo del denaro una vera e propria norma di vita: il pensiero non può che correre a San Francesco che, nella sua Regola, ordinò fermamente ai suoi frati “di non accettare in alcun modo denari o pecunia per sé o per interposta persona” (nota 1). Tali considerazioni, tuttavia, non devono condurre automaticamente a concludere che sussista una incompatibilità assoluta tra l’essere buoni cristiani e l’agiatezza, perché ciò che viene condannato, in realtà, è il cattivo uso che può essere fatto della ricchezza e non la circostanza in sé di essere benestanti o, comunque, di avere del denaro. Già la Bibbia ebraica, infatti, non metteva in contrapposizione il possesso di beni col servizio a Dio; anzi conferiva alla ricchezza una dimensione teologica, configurandola come segno della benevolenza del Signore. Ciò che era richiesto al credente era l’offerta delle primizie del raccolto o dei primogeniti del gregge; egli doveva, cioè, separarsi da una parte del suo guadagno (non una parte qualsiasi, ma la prima) perché questo, oltre ad esprimere la riconoscenza verso Dio, rappresentava anche il fondamento teologico dell’elemosina. La condanna espressa dai profeti in diversi passi (nota 2) riguardava quindi non il possesso dei beni, ma il suo abuso, specialmente se si concretizzava in una spoliazione altrui. Gesù di Nazareth era un uomo, un ebreo, del tutto inserito nel contesto storico-geografico del suo tempo; ed era perfettamente a conoscenza delle Scritture e del loro significato più profondo. Perché, allora, sembra contraddire quanto rilevato poc’anzi, nel momento in cui lancia un’alternativa secca tra l’essere seguaci di Dio e la ricchezza, attribuendo a quest’ultima addirittura un nome? Eppure Gesù stesso ha dimostrato di conoscere ugualmente bene il denaro, tanto da utilizzarlo non solo come strumento per mettere a tacere i suoi detrattori nel famoso episodio della moneta di Cesare (nota 3), ma da citarlo, a volte con precisione, anche nelle sue parabole e nei suoi insegnamenti (nota 4). In realtà la contrapposizione è soltanto apparente o, meglio, c’è senz’altro, ma non è tra Dio e la ricchezza bensì tra la ‘deificazione’ di quest’ultima e Dio. Il denaro, Gesù ne è consapevole, può diventare in certe circostanze un dio, ecco perché gli attribuisce un nome, e come tale si contrappone inesorabilmente all’unico Signore. Anche la scelta dell’appellativo non è casuale: mammona, infatti, deriva dalla radice ebraica âman (nota 5), che indica la stabilità, la sicurezza, la solidità; dunque Mammona si offre come un dio che promette ai suoi adepti questi benefici, ma si rivela anche bugiardo perché non può liberare l’uomo dalla sua vera e più grande paura, che è quella della morte (nota 6). Il Vangelo però, dopo aver condannato questo falso dio, suggerisce anche la via giusta da seguire, che non coincide necessariamente col ripudio della ricchezza o con la rinuncia totale ad essa, bensì con il suo impiego ‘giusto’. L’episodio che conferma tutto ciò è quello di Zaccheo, il capo degli esattori inviso e odiato dai suoi concittadini di Gerico sia per le modalità della sua professione, sia per il fatto che essa lo rendeva complice (nota 7) dell’occupante romano: quando Gesù lo scorge in cima all’albero sul quale era salito per vederlo, gli domanda ospitalità; il pubblicano, pieno di gioia per questa richiesta e per l’incontro con Lui, non rinuncia al suo denaro né lascia la sua professione (come aveva fatto Lévi-Matteo e come farà Francesco d’Assisi) ma promette di dare la metà dei suoi beni ai bisognosi e di compensare i suoi torti finanziari rimborsando ben più di quanto aveva sottratto agli altri. Ecco dunque che il corretto uso del denaro e della ricchezza non si contrappone affatto all’essere un buon credente, anzi un buon cristiano, tanto che i propositi di Zaccheo sono così ben accolti e apprezzati da Gesù da fargli affermare: “oggi la salvezza è entrata in questa casa” (nota 8). In altri termini si può parlare di “libertà evangelica ” (nota 9) riguardo ai beni: si può decidere di fare una scelta radicale, come appunto quella di Matteo o di San Francesco, o di optare per una via meno definitiva, ma altrettanto valida, come quella di un utilizzo corretto della ricchezza, aperto, soprattutto, alla carità e alla costruzione della giustizia sociale. Tutto ciò premesso, non ci si deve stupire più del fatto che diversi pontefici abbiano voluto, in qualche misura, ribadire queste considerazioni facendo imprimere su alcune loro monete delle legende volte a istruire il popolo a un uso ‘cristiano’ del denaro, attraverso – come si diceva in apertura – proverbi, ammonizioni o raccomandazioni, inni alla carità. Fig. 2: Roma, Clemente XII (1730-1740), Testone. Al R/: DABIS DISCERNERE INTER MALVM ET BONVM, “darai la facoltà di distinguere il bene dal male”, in quattro righe. Ex Asta Artemide XXIII, 2008, lotto n. 414. Secondo Traina, la legenda, tratta da un versetto del Primo Libro dei Re si riferisce al denaro, che può essere usato a fin di bene o male; da qui l’appello affinché Dio ne conceda un giusto uso. Note: 1 - Precipio firmiter fratribus universis ut nullo modo denarios aut pecuniam recipiant per se vel per interpositam personam. Cfr. Merlo G.G., in Travaini 2009, p. 150. 2 - Cfr., ad es., Isaia 10, 1-3. 3 - Cfr. Lémonon in «Il Mondo della Bibbia», n. 2, marzo-aprile 2007, pp. 21-24. 4 - Sulle citazioni numismatiche fatte direttamente da Gesù o comunque presenti nel Vangelo, cfr. Colombo 2003 e Amisano 2009, nonché le relative indicazioni bibliografiche per trattazioni meno recenti di tale tematica. 5 - Queste considerazioni sul valore della ricchezza nell’Antico Testamento, sul significato del nome “Mammona” e sull’interpretazione delle parole di Gesù in proposito sono tratte da un saggio a sua volta contenuto in un fascicolo di una rivista religiosa dedicato in gran parte al tema del rapporto tra Dio e denaro. Cfr. Marguerat in «Il Mondo della Bibbia», n. 2, marzo-aprile 2007, pp. 5-9. 6 - Cfr. la parabola del ricco proprietario in Luca 12, 16-20, che si conclude con le parole “stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. V. infra. 7 - Cfr. Andreau, in «Il Mondo della Bibbia», n. 2, marzo-aprile 2007, pp. 17-19. 8 - Cfr. Luca 19, 1-10. La “salvezza” deriva a Zaccheo dall’aver saputo capovolgere, grazie all’incontro con Gesù, il suo rapporto col denaro: prima era quest’ultimo a scandire la sua vita causandogli invidie e isolamento e perciò distruggendo le sue relazioni; ora è lui a dominarlo e a decidere della sua funzione e, quindi, a costruire grazie ad esso dei ‘ponti’ verso gli altri. 9 - Cfr. Marguerat, cit., p. 9. segue...1 punto
-
Clemente VII, mezzo giulio per Piacenza coniato in occasione del Giubileo del 1525. Interessante come la moneta sia anonima (non riporta infatti il nome del pontefice) ma l'attribuzione comunque possibile ed univoca: la legenda del diritto riporta "REGNANS APERIT CLAVDIT", durante il suo regno aprì e chiuse [l'Anno Giubilare]. Buona giornata, Antonio1 punto
-
FORTITUDO MEA IN BRACHIO Nessuno ha mai sentito parlare di Zanen de la bala? Risale tutto a parecchi secoli fa, quando Cremona era sotto il dominio del Sacro Romano Impero. Ogni anno, come leggenda narra, la città era obbligata a pagare all'imperatore un tributo consistente in una palla d'oro. Questa vessazione si prolungò fino a quando un baldo gonfaloniere, certo Giovanni Baldesio, sconfisse in duello il figlio di Enrico IV, fuori porta Mosa, liberando così i cittadini dal pesante tributo. Benché la leggenda sia in buona parte avvolta nel mistero, la palla è simbolo che tutt'oggi riecheggia in giro per la città, dalla sommità del Torrazzo all'emblema posto sulla statua sotto la loggia dei Militi: Osservatela nel suo "splendore" terminato due estati fa, oggi è purtroppo decapitata, le manca la corona che un altrettanto baldo turista ha fatto cadere mentre ci si arrampicava sopra.... Giovanni, soprannominato appunto Zanen de la bala, è una delle figure più note localmente. Oltre alla statua proposta (in cui si può apprezzare appunto l'emblema della città), esiste anche una statua sulla cattedrale, l'unica che lo raffiguri: La posa, come forse alcuni noteranno, ricorda un giocatore di bocce. Tempo or sono lessi di un'altra tesi che riconsiderava la sfida come una semplice partita a bocce... ma per Bacco, il solo pensiero mi fa venire in mente i pensionati che d'estate occupano il settore bocciofilo delle canottieri (una delle quali dedicata proprio a Baldesio)..... di gran lunga meglio la versione popolare! Passando agli aspetti prettamente numismatici, andrei cauto a definire "moneta" l'esemplare sopra proposto. È purtroppo un pezzo di tale rarità che non ho potuto far di meglio, o scansionavo l'esemplare del Fenti o quello dell'asta Milani (finito a 3200 euro diritti esclusi). Purtroppo, essendo così rara, non è stata studiata a fondo e il Fenti stesso la definisce in modo abbastanza fantasioso e poco attendibile. Resta senz'altro una moneta/medaglia molto affascinante e sicuramente ricca di storia, un tangibile pezzo di storia locale. P.S. Mi congratulo per l'interessante discussione, l'ho scoperta solo stasera e mi sono ritagliato appositamente un po' di tempo....1 punto
-
Ecco un'altra napoletana: piastra di Carlo di Borbone per Napoli. DE SOCIO PRINCEPS Da alleato a principe Nel 1734 Carlo conquista il Regno di Napoli rendendolo, dopo oltre due secoli di dominazione straniera, indipendente. La legenda, impressa sulla piastra e sulla mezza piastra, testimonia come il Regno – rappresentato dal Sebeto – da stato alleato sia diventato stato sovrano. N.B. Nell’antica Roma gli alleati erano le popolazioni assoggettate all’Urbe e stanziate tra la Calabria e il fiume Rubicone e Magra.1 punto
-
Clemente XI, grosso per Roma, 1710 DATE ET DABI:TVR Citazione dal Vangelo di Luca, 6:38 Date et dabitur vobis mensuram bonam confersam et coagitatam et supereffluentem dabunt in sinum vestrum eadem quippe mensura qua mensi fueritis remetietur vobis. "Date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi" petronius1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?










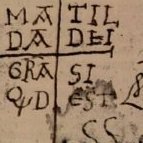


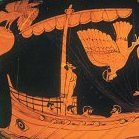






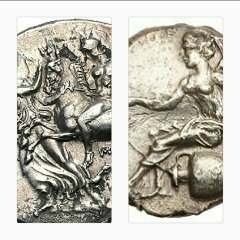





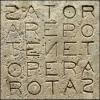
.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)
