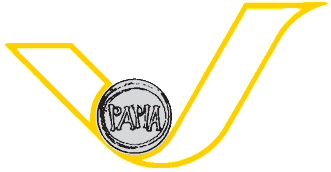Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 04/28/17 in Risposte
-
Arrivato finalmente anche a me, l'ho letteralmente divorato, non posso che ringraziare di nuovo Mario @dabbene e aggiungermi alla lista, già lunghissima, di quanti hanno apprezzato questa straordinaria iniziativa. E' difficile trovare le parole per dire cose che non siano già state dette, mi fa piacere apprendere che è quasi pronto un secondo numero, mentre questo primo sta avendo una grande diffusione...che altro dire dunque, se non ad maiora? petronius4 punti
-
Impero bizantino,Leone VI il Saggio 886-912, Follis https://it.wikipedia.org/wiki/Leone_VI_il_Saggio3 punti
-
@Tinia Numismatica, le lettere S e C risultano molto più in rilievo rispetto al resto della figura dell'imperatore (sfumata) che sottomette il fiume Reno. Questo è un segnale evidente che la moneta è stata ritoccata. Poi è sempre molto difficile giudicare una moneta da una fotografia..., le monete bisogna averle in mano per poterle giudicare bene. Caro Silvio (spero di poterti dare del tu), non me ne volere, ma non mi sentirei neanche di escludere la possibilità che il tuo sesterzio sia in realtà un padovanino della scuola di Cavino. Potrei sbagliarmi, ma (dalle foto che hai postato) qualche dubbio in proposito mi è venuto.3 punti
-
ciao provo a chiarire il senso del post di Asclepia al nostro amico francese ! (ci provo solo per le mie origini Venete, anche se da tempo non torno in quella magnifica terra che è il veneto) Mona è una tipica espressione dialettale veneta che si una un po' come intercalare e che indica l'organo genitale femminile. E' molto utilizzata - sempre in termine amichevole - per mandarsi a quel paese (c'est a dire un peu " mis en boite"), o per indicare che tutto va a rotoli ("detruire une situation") o per essersi rincitrullito ("divenir foulle) Quindi Asclepia ti chiedeva se sei un Veneto che prova a dire una monada (in veneto) traducendolo in italiano, per cui la D spesso si trasforma in T giocando sul fatto che hai tradotto male monEta con monAta (che quindi è una italianizzazione di monADa = una schiocchezza) A bientot copiglute ! Massa Forte Asclepia ! ciao a tutti. Scusate la follia del mio post dettato dal fatto che oggi mi sono alzato presto Ma se podemo far un goto de vin avec le Pastis !! Un'ombreta de Pastis non ho resistito neanche io ......3 punti
-
Carissim* volevo invitarvi tutti alla prossima inaugurazione della mostra "Zecche e monete nella Toscana del Trecento" che si terrà sabato 13 maggio p.v. alle ore 11,00 a Massa Marittima presso il complesso museale di San Paolo all'Orto. La mostra è stata organizzata nell'ambito dei festeggiamenti per ricordare il VII centenario della prima coniazione delle monete massetane (1317-1319). Per tale motivo saranno esposti i conii della zecca di Massa, normalmente conservati presso i musei di Volterra e di Siena, alcuni splendidi esemplari di grossi massetani, oltre ad una rilevante selezione di monete delle zecche toscane, emesse tra a fine del Duecento ed il pieno Trecento. Spero che nonostante gli impegni del periodo possiate partecipare numerosi! Un caro saluto a tutt* MB2 punti
-
Grazie a te invece perché il piacere e' poi nel darlo e comunicarlo, quindi più persone riusciamo a raggiungere e più l'intento originario e lo scopo per cui viene fatto trovano il loro sbocco naturale. Verona sarà il punto di arrivo di questo primo numero e poi passeremo al digitale, ma il fatto per me sorprendente e' vedere con che passione, amore e volontà da parte di molti del nostro forum sta nascendo e quasi ultimandosi questo secondo numero che io trovo più ricco e completo. Credo che se ci credi tutto diventa più facile e leggero, certo devi dare fiducia e una possibilità agli autori , ogni idea, ipotesi, riflessione, spunto merita , se l'autore lo desidera, di essere messo nero su bianco e poi divulgato, ne parleremo anche al pranzo di Verona volentieri con chi ci sarà e vorrà ...2 punti
-
In campo di ricerche...(almeno da parte mia) non ci sono segreti...non c'è problema; rendiamo così partecipi tutti gli altri utenti che ci seguono in maniera costante e vogliosi di apprendere. Caro @Rocco68..ti avevo fatto queste richieste perchè devo e voglio studiare fino in fondo il rame repubblicano; detto questo è da un pò che mi chiedevo (alcune risposte le ho già avute) del perchè (almeno per quello che tu hai verificato, ma l'avevo fatto anch'io, ma non ne ho abbastanza come te) se tutti i grani dal 88 al 93 avessero il taglio liscio.....per adesso mi fido del tuo occhio su tutti i tuoi bei grani.....e del perchè su quelli del 97 ( 3 tipologie diverse) hanno la treccia...e credo anche il 98 (purtroppo questi ultimi non hanno un bell'aspetto, ma credo che abbiano la treccia) ......l'800 torna liscio (per ovvi motivi). Tu dai un'occhiata ai cataloghi attuali...e vedi cosa riportano; ma il problema, per me che continuamente faccio ricerche, è capire del perchè troviamo i Grani lisci/poi a treccia. Qualcosa ho messo da parte....ma ci vogliono sempre e più conferme. Tutto qui !! ... mi stò facendo un "maz...." che poco basta...ma mi piace un sacco....ah...ahah...ah...2 punti
-
Ciao rieccomi qui ho avuto da fare, vediamo di rispondere a qualche domanda lasciata in sospeso, per il tu non ci sono problemi anzi, di Padovanino non ha niente partendo dallo stile incisorio ,poi basta conoscere un po’ le monete antiche per escluderlo, ho guardato la moneta con lo stereomicroscopio e quelle incrostazioni intorno alla C sono residui della vecchia patina, che si trovano anche in altre parti, guardando tutte le lettere a forte ingrandimento non si notano segni di ritocco le lettere risultano tutte uguali, alcune sono meno evidenti, probabilmente dovuto all’usura e alla spatinatura, SC risultano sempre più evidenti delle figure visto che non hanno un piano netto come le lettere ma sono lavorate a tuttotondo e l’incisore doveva mettere in evidenza primo la grandezza di Traiano rispetto al Reno e secondo, lo stesso Reno doveva apparire in secondo piano per dare profondità all’incisione, per rendere tridimensionale l’insieme. Poi una cosa semplice quale falsario come ho detto in precedenza metterebbe in risalto due semplici lettere e non ritoccherebbe sia il dritto che il rovescio nelle parti più importanti. Mi sembra di avere detto tutto se mi sono dimenticato qualcosa chiedete. Vi posto la foto di una sua sorella coniata per lo stesso motivo nello stesso anno ma con la patina sana. PS sempre se vi piacciono certe patine. Silvio2 punti
-
Finalmente hanno messo qualche moneta bizantina su Numista: https://en.numista.com/catalogue/pieces19712.html2 punti
-
Salve a tutti, aggiungo a questa vecchia discussione un articolo che mi era sfuggito, di un mio caro amico storico e profondo conoscitore della val di chiana, che ha pubblicato numerosi libri. sperando di fare cosa gradita, un saluto a tutti.2 punti
-
Ieri non avendo trovato nulla per la mia collezione dei Conti di Savoia ho colto l'occasione di tappare qualche buco di quella delle decimali : 1 Lira 1835 Genova Carlo Alberto (1831-1849) D/ CAR ALBERTVS D G REX SARD CYP ET HIER - Testa a destra , sul taglio del collo F in basso la data 1838 R/ DVX SAB GENVAE ET MONTISF PRINC PED & - Scudo Sabaudo semplice coronato , con il Collare attorno , tra due rami d' alloro ; nell' esergo il valore tra i segni di zecca T/ FERT FERT FERT in incuso tra nodi e rosette Argento 900/.. , diametro 23 mm. , peso gr. 5 , incisore : Giuseppe Ferraris tiratura : 22.909 Mir Savoia 1049h1 punto
-
Il titolo del Post non ha allusioni verso altri , ma riguarda principalmente me stesso ; genericamente parlando , rimane comunque un valido invito a chi volesse approfondire determinati fatti su cui si nutrono motivi di incertezza . Finalmente dopo anni di perplessita’ ho risolto un mio dubbio che riguardava l’ iconografia di una particolare moneta di Consacrazione che al rovescio presenta una Pira , dubbio finalmente risolto a favore di questa , contrariamente a quanto sospettavo che rappresentasse invece il Mausoleo di Adriano ; in teoria potrei anche forse salvarmi , per dirla in un termine calcistico , “in calcio d’ angolo” , pensando che la ormai accertata Pira , fosse stata realizzata nella moneta come una ridotta imitazione di quel famoso monumento , il che spiegherebbe anche perche’ la Pira compare nelle monete di Consacrazione solo e non prima , a partire da Antonino Pio ; inoltre la presenza della Pira e’ attestata da Erodiano essere costruita in Campo Marzio , forse in prossimita’ del Tevere vicino al Mausoleo di Adriano , essendo questa una zona del Campo Marzio abbastanza libera da grandi costruzioni e dove gia’ esistevano diverse importanti sepolture , vedi quelle di Aulo Irzio , di Vibio Pansa , di Vipsanio Agrippa , di Silla , ecc. , tanto per citare le piu’ conosciute . Il testo che recentemente ho letto , anzi riletto dopo tantissimi anni e del quale avevo dimenticato un passaggio come di tanti altri , ora lo trascrivo ad uso di chi non ha il libro , come determinante testimonianza storica ; il passo piuttosto lungo e’ tratto dall’ opera di Erodiano : Storia dell’ Impero Romano dopo Marco Aurelio , libro IV , tomo II , riguarda i funerali di Stato di Settimio Severo a Roma con la sua Apoteosi ; del testo di Erodiano , che fu testimone dei fatti narrati , ho inserito anche il lungo preambolo alla descrizione della Pira , che e’ indispensabile per capire bene tutta la scenografia della cerimonia dell’ Apoteosi , eccolo : “ E’ infatti costume dei Romani celebrare l’ avvento tra gli dei di quegli imperatori che muoiono lasciando i propri figli sul trono ; questo rito si chiama Apoteosi e nel corso di esso puo’ notarsi in tutta la citta’ un miscuglio di lutto e di cerimonie festive . Infatti si seppelliscono con un solenne funerale i resti del defunto seguendo il rito usato per gli uomini comuni ; inoltre si prepara una figura di cera identica al personaggio onorato e la si espone elevata in alto sopra un grandissimo letto di avorio nel vestibolo del palazzo imperiale , avvolgendola in abiti trapunti d’ oro . La figura ha un colorito pallido e sta distesa come quella di un malato ; intorno al letto siedono per gran parte del giorno , a sinistra tutti i Senatori avvolti in veste nere , a destra tutte le donne cui le magistrature del marito o del padre conferiscono particolare prestigio . Nessuna si adorna d’oro o porta collane , indossano invece semplici veste bianche e stanno in atteggiamento di cordoglio . Questa parte del rito dura sette giorni , nel frattempo i medici avvicinandosi frequentemente al letto esaminano il malato e annunciano ogni volta che le condizioni sono peggiori . Quando si ritiene che sia giunto il momento della morte , i piu’ nobili dell’ ordine equestre e alcuni giovani scelti tra i Senatori , sollevano il letto sulle spalle e lo portano lungo la Via Sacra fino al Foro Antico che e’ il luogo dove i magistrati romani depongono la carica . Il letto viene quindi collocato fra le due tribune a forma di gratinate . Sopra una di queste prende posto un coro di fanciulli scelti fra le piu’ nobili famiglie senatorie ; sull’ altra un coro di donne anch’ esse nobili ; ambedue i cori intonano in onore del defunto inni e peani , composti secondo un ritmo solenne e triste . Quindi il letto viene di nuovo sollevato e portato fuori dalla Citta’ fino al cosi’ detto Campo Marzio . Ivi nel punto in cui piu’ larga si estende la pianura , sorge una costruzione a base quadrata , in forma di tenda militare , fatta soltanto di grandi travi lignee , a esclusione di qualsiasi altro materiale . Questa e’ riempita internamente di legna da ardere e all’ estrerno e’ adorna di drappi intessuti a fili d’ oro , sculture in avorio , quadri variamente colorati . Su questo edificio ne sorge un altro , simile nella forma e negli ornamenti , ma piu’ piccolo , con varie aperture a guisa di porta ; quindi un terzo e un quarto , ciascuno piu’ piccolo del precedente , fino all’ ultimo che e’ piccolissimo . La forma di tutto l’ edificio potrebbe paragonarsi a quelle torri che sorgono presso i porti e di notte mediante un fuoco acceso , indicano alle navi la rotta piu’ sicura ; generalmente sono chiamate fari . Il letto viene posto nel secondo ripiano insieme con tutti gli aromi e gli incensi che produce la Terra , inoltre vi si aggiunge ogni sorta di altre sostanze profumate : frutti , erbe , succhi , tutto gettato alla rinfusa . Non vi e’ infatti ne’ provincia , ne’ citta’ , ne’ alto magistrato che non faccia a gara nel mandare queste funebri offerte per onorare l’ imperatore . Quando si e’ raccolto un ingente cumulo di aromi e tutto l’ edificio ne e’ pieno si svolge intorno a esso un corteo a cavallo e tutto l’ ordine equestre sfila in giro secondo una norma prestabilita cavalcando al ritmo di una marcia guerriera . Sfilano poi sempre attenendosi ad un ordine determinato , dei cocchi su cui stanno cittadini in toga pretesta , con maschere che rappresentano le fattezze dei piu’ gloriosi generali e imperatori romani . Compiuta questa cerimonia il successore al trono prende una fiaccola e l’ accosta all’ edificio ; quindi anche gli altri presenti , da ogni parte avvicinano le fiaccole e tutta la costruzione con grande facilita’ si infiamma per la moltitudine di sostanze aromatiche e la legna che contiene . Dalla piu’ alta e piu’ piccola sezione che fa da culmine all’ edificio , viene lasciata libera un’ aquila che sale nell’ etere insieme con le fiamme ; i Romani credono che essa porti dalla Terra al cielo l’ anima dell’ imperatore , il quale da quel giorno in poi riceve culto come gli altri dei” Da questo lungo passo di Erodiano che descrive tutta la scenografia della cerimonia dell’ Apoteosi degli imperatori e della Pira come edificio ligneo , risulta come la struttura presente nel rovescio della moneta di Consacrazione corrisponda in “quasi” tutto al passo citato , “quasi” , perche’ Erodiano stranamente , nella descrizione della Pira non cita la quadriga in cima alla struttura , posta sopra l’ ultimo gradino della Pira , come invece risulta essere presente nelle tipologie di questa moneta ; eppure Erodiano avrebbe dovuto citarla , come ha citato altri particolari meno vistosi della Pira , questa “dimenticanza” risulta alquanto strana per essere un particolare piuttosto importante e ben visibile ; una spiegazione potrebbe essere che la quadriga sia una aggiunta inventata dagli incisori , oppure che quando Erodiano vide dal vivo la Pira , la quadriga gia’ non veniva piu’ montata in cima all’ ultimo piano della Pira . In foto un Sesterzio di Giulia Mesa con al rovescio la Pira ; presente in cima la quadriga , tipica di queste emissioni di Consacrazione , che stranamente non viene menzionata da Erodiano .1 punto
-
Buon giorno a tutti, posto le foto di un half penny del Regno Unito, Giorgio IV, 1826. A vostro avviso, supera come conservazione il BB? Grazie per le vostre risposte.1 punto
-
1 punto
-
Tra le monete che preferisco primeggia "L'ANGELO CHE LIBERA S.PIETRO DALLA CELLA", questo rovescio e' stato utilizzato sia per uno dei testoni di Roma della S.V. 1590 sia che per un testone di Gregorio XIII. e il testone della S.V. 1591 con il RE DAVID inginocchiato sull'altare......1 punto
-
eri tu l'altro offerente del grano? ......non sapevo, altrimenti avrei lasciato a te la moneta.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Hahahahaha......lo sapevo, anzi ne ero certo.... @Rocco68 lo hai chiesto a tutti, figurati se non lo avresti chiesto a me che ti dato tantissimi "mi piace" sulle Piastre di Ferdinando I . Infatti non a caso comprai questa Piastra. Non te lo dico, adesso ti posto le foto del suo suo taglio.....poi mi fai sapere.1 punto
-
Grazie per il riscontro e per l'incoraggiamento @petronius arbiter. Il n. 2/2017 è ormai quasi concluso nella sua struttura di base, certamente sarà disponibile dopo l'estate... Aggiungo che a breve (fine maggio) il n. 1/2017 verrà reso disponibile gratuitamente in formato digitale per raggiungere proprio tutti gli appassionati Un caro saluto, Antonio1 punto
-
Grazie per il chiarimento @Rex Neap e quindi il 5T del 98 dell'amico Ambrogino che misura a sua detta 25,5mm può essere ho uno 5T con P sotto lo stemma o un 5T senza P (per problema tecnico). Mò vediamo se arrivano foto migliori giusto per chiudere il post.1 punto
-
Ciao perché quando vedo questo tipo di patina inizio a preoccuparmi ? Silvio1 punto
-
@Asclepia, ciao .... ecco come gli ho studiati: Per il 1797 non abbiamo un mm. 29/30 Per il 1798 ho notato P sotto lo stemma e senza la P, a partire da 26 mm. fino a un max di 27,5 - P sotto i rami, 29 mm Poi....aggiungo che il fatto che non si vede la lettera P, è dovuto ad un problema tecnico; Praticamente, non è una sigla mancante (voluta) dall'incisore....e per me queste monete non aumentano per niente ne la rarità ne il valore, anzi...... !! I 5 T. sono in tutto TRE...e non tutti quelli che vediamo catalogati.1 punto
-
Ciao @clairdelunee grazie del tuo unico intervento al post . Alla giusta domanda che poni posso solo esprimere un parere personale in quanto certezza non c'e' , comunque le ipotesi penso che possano essere soltanto tre : 1 Erodiano sembra che abbia assistito personalmente all' Apoteosi di Settimio Severo , per cui dobbiamo fare affidamento a quanto ha scritto e che in effetti corrisponde perfettamente alla iconografia della Pira della moneta postata di Giulia Mesa , tranne che per la quadriga che Erodiano non cita . 2 E' anche possibile che la Pira abbia subito trasformazioni di struttura nel corso del tempo , come risulterebbe dal rarissimo sesterzio postato di Faustina moglie di Antonino Pio e del particolare della porta presente sul sesterzio del marito 3 Potrebbe essere anche una interpretazione "a distanza" degli incisori , come giustamente proponi tu Ciao1 punto
-
1 punto
-
Nuovamente salve... ho appena acquistato 4 piastre di Ferdinando iv Ferdinando ii e Francesco ii le ho pagate 80 tutte, credo di averle pagate bene però gradirei un vostro parere, inoltre volevo sapere se a vostro parere sono state ripulite. Sempre grazie 21 punto
-
Cari amici, sono lieto di invitarvi alla presentazione del volume Archeologia e numismatica in Val di Sole, che si terrà venerdì 28 aprile a Ossana (TN), nella sala arancio del Comune, alle 20.30. Il volume, nato dalla collaborazione tra Centro Studi per la Val di Sole, Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia autonoma di Trento e museo Castello del Buonconsiglio, ripercorre relativamente al territorio della Val di Sole, due secoli di letteratura numismatica, le vicende della circolazione monetaria nell'antichità e fino al medioevo, presenta gli esemplari conservati nel museo Castello del Buonconsiglio e gli esiti di alcuni scavi archeologici in chiese e castelli recentemente effettuati in valle. Il volume è a cura di Alberto Mosca e Nicoletta Pisu, con contributi di Michele Asolati e Beata T. Marcinik, oltre che dei curatori. La prefazione è di Andrea Saccocci.1 punto
-
.....detto questo, e per ritornare alla tua richiesta, ti faccio vedere la mia preferita di Ferdinando I ..... lato A1 punto
-
Dal confronto direi che si tratta proprio di un elmo, e con tutta probabilità, chi lo riceve è Alessandro.1 punto
-
Caro Matteo, mi dispiace che non potrai essere dei nostri, ma capisco. L'inaugurazione è stata fissata piuttosto tardi nella mattinata (alle 11,00 e quindi alle 11.15 circa ;)) per consentire di venire anche a chi abita un poco più lontano, ma più di tanto con le varie esigenze anche locali da incrociare, non si poteva fare. A seguire ci saranno un breve intervento musicale e un aperitivo. Se qualcuno ha necessità di organizzarsi per pranzare in zona fatemi sapere, in modo che possa chiedere all'Assessore se ci sono posti buoni e a buon prezzo dove poter andare magari insieme. Se tu non potrai venire il 13 avrai comunque tempo in seguito, visto che la mostra si protrarrà sino alla fine dell'anno, anche se al momento dell'inaugurazione saremo presenti io e Sozzi tra i numismatici ed altri storici che potranno spiegare meglio le scelte fatte e dare qualche nuova informazione. Per il momento non è previsto un catalogo, bensì un convegno di approfondimento sui temi delle zecche e delle monete nella Toscana medievale che sarà celebrato nel prossimo ottobre. Appena avrò un programma definitivo lo posterò ovviamente. Secondo me cose secondo me più interessanti della mostra - e del convegno che ne seguirà - sono essenzialmente tre: 1) poter vedere diversi conii medievali di zecca ufficiale (grazie al lavoro di ricerca di Sozzi) e insieme alle monete che da questi sono state prodotte e, quindi, poter riparlare della tecnica di coniazione; 2) cercare di contestualizzare il fatto che in un certo momento una realtà comunale decidesse di aprire una propria zecca e coniasse una propria moneta, per capire più a fondo le motivazioni e i meccanismi (l’esposizione è completata anche dalla pergamena di istituzione della zecca, datata 11 aprile 1317 ); 3) riaccendere il dibattito sui mutamenti che avvennero nelle varie monetazioni medievali nel corso del Trecento e, soprattutto, della prima metà del secolo. Spero con questo di aver incuriosito/ stimolato anche qualcun altro a venire a visitare la mostra il 13 maggio o nel periodo successivo :). Un caro saluto MB1 punto
-
Si non si intende molto di numismatica, però conosce molto bene gli archivi storici della zona. Un saluto.1 punto
-
Swaziland, 2 cents 1975, km22, FAO. Al dritto : re Sobhuza II (1899-1982) Il suo regno complessivo è durato oltre 80 anni, questo lo rende il sovrano che ha regnato più a lungo (finora) tra quelli storicamente accertati e datati. Lo Swaziland è tuttora una monarchia assoluta.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Dopo il refrendum sulla concentrazione totale dei poteri in mano al presidente, vinto da Erdoğan di misura e con molti dubbi sulla regolarità della consultazione, e l'ultima tornata di arresti di oppositori politici in Turchia, si chiede da più parti la sospensione anche formale del processo di adesione. Il governo austriaco e il Gruppo Socialisti & Democratici del Parlamento europeo l'hanno già chiesta ufficialmente al Consiglio europeo. Il sultano oltre al suo solito abbaiare ha detto che in Turchia si terrà un referendum sulla continuazione dei negoziati.1 punto
-
Buonasera @calicola74, per le monete Napoletane e Siciliane c'è l'apposita sezione....ricorda per le prossime discussioni. Riguardo le tue Piastre......spero non le abbia pulite tu! È rimasto su tutte le facce delle quattro monete ancora il "prodotto" usato per pulirle (quel materiale biancastro intorno alle lettere). Chi lo ha fatto......le ha deprezzate di molto. Saluti, Rocco.1 punto
-
Sisto IV, da 10 fiorini di camera... tutte le volte che sfoglio il Muntoni se mi capita sott'occhio resto incantato!1 punto
-
@scacchi Rotazione di conio nel dritto? Che ne pensi? Sentiamo anche altri pareri. Saluti1 punto
-
Complimenti @MezzaPiastraPupillare e allora per non farla sentire sola permettimi di affiancarle la mia1 punto
-
1 punto
-
Come al solito saprò solo all'ultimo momento se posso venire .... ma spero e conto di esserci. Per il pranzo ovviamente. La volta scorsa @roth37 non sono neppure riuscito a salutarti, speriamo di chiacchierare un po' in questa occasione.1 punto
-
Ciao @dupondio Cominciamo a togliere il Sig. che non mi piace dal vivo tantomeno in un forum, l’effetto che dici tu ( ti posso dare del tu? ) dove intorno alle lettere la superficie sembra più liscia è dovuta dal fatto che è una delle parti più protette da usura selle monete, e di conseguenza dopo la spatinatura risultano le più lisce e una volta ripatinate mantengono questa caretteristica, (particolare già notato su altre monete con la stessa patina) per il colore della patina vale lo stesso discorso, anche perché vista dal vivo non c’è tutta quella differenza, dovuta dalla luce dello scanner , differenza di colore che si nota su tutti i rilievi della moneta. Vari particolare con la moneta in mano evidenziano che (per il mio parere ) la moneta non è stata ritoccata, non avrebbe avuto senso ritoccare solo alcune lettere e altre come la A di Domitian no pur essendo la meno evidente, o altri particolari come l’egida o i nastri che non si vedono molto, senza parlare del retro che avrebbe dato più lustro alla moneta. Come dico sempre questi sono alcune mie osservazioni poi posso essere benissimo corretto. Silvio1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Mi spiace leggere che il buon godovski sia rimasto deluso, generalmente faccio il possibile per accontentare i clienti. Ebbene sì, la "ottimissima" casa d'aste (grazie don Stefano) è la mia. Facciamo il punto della situazione. mi viene proposta la banconota da mettere in asta; banconota che, a detta di un collezionista esperto del forum, avrebbe un valore di 1200 euro. mi documento, essendo ignorante in materia, e chiedo anche al mio consulente per le banconote il quale mi dice che il valore è più teorico che pratico, essendoci pochissimi collezionisti di tale tipologia e pertanto lui la farebbe partire da 200-250 euro. Quando la banconota mi viene consegnata faccio presente queste cose e si concorda quindi una base d'asta di euro 300, che è poi il prezzo indicato in catalogo. all'uscita del catalogo on line l'amico godovski mi fa presente che il prezzo sui siti è di 1200 euro (mea culpa, nella fretta di redigere il catalogo non avevo corretto la base d'asta sul mio file) e, testualmente, mi scrive "...con mia grande sorpresa scopro che come cifra di partenza hanno messo € 1.200!! (mentre tu hai messo giustamente 300...).A me non dispiace se viene comprata a quella cifra!!! Ma magari se parte da quella cifra... nessuno la compra!!! Vedi tu... cosa fare! Grazie." ovviamente ho dovuto allineare i prezzi sui siti a quello di catalogo, non essendo possibile il contrario (il catalogo era stampato) da parte mia quindi massima trasparenza e correttezza ma rimango comunque dispiaciuto nel constatare la delusione di un conferente (e bravissima persona). Però ascriverei la colpa di tale delusione ad una aspettativa ingiustificata, più che ad un esito poco felice della vendita; anche se la cartamoneta non ha certo brillato, posso assicurare che i maggiori commercianti del settore hanno ricevuto il datalogo e se hanno fatto offerte su altri pezzi e non su quello un motivo ci sarà. Visti i mugugni genovesi non toglierò un solo centesimo dal realizzo. sperando che in futuro l'amico godovski voglia continuare a preferirmi a Catawiki (almeno io le sue banconote non le ho rifiutate, don ) lo saluto amichevolmente. Alberto1 punto
-
Ciao che la moneta sia stata a suo tempo ripatinata non ho grossi dubbi in quanto ai ritocchi non ne ho visto, e in quanto, si è già detto parecchie volte in varie discussioni è corretto spiegare le proprie opinioni, non basta dire è falsa è ritoccata è spatinata, bisognerebbe spiegarne il motivo per cui si fa un'affermazione, altrimenti sono solo parole. Silvio1 punto
-
Prima o poi uscirà un nuovo aggiornamento, non è ancora chiaro con quali modalità. Ci sono già pronte quasi 80 pagine di Addenda & Corrigenda (tavole escluse), grazie all'incredibile attivismo del Prof. Ted Buttrey (ha quasi 88 anni, che Dio lo conservi!). Ciao1 punto
-
Sono stato abbastanza fortunato da trovare questa coppia in una casella di posta indesiderata ieri pomeriggio tardivo, un 1920 10-centavo (tiratura 20.000) e un 20-centavo (tiratura 10.000) dal lebbrosario di Culion nelle isole Filippine. L'alluminio in queste monete è stato sostituito da inizio di rame-nichel in ‘22—alluminio solo non reggono quando sottoposto ai prodotti chimici utilizzati per la disinfezione di monetazione di Culion. v. ------------------------------------------------------- I was lucky enough to find this pair in a junk-box yesterday late afternoon, a 1920 10-centavo (mintage 20,000) and a 20-centavo (mintage 10,000) from the Culion Leper Colony in the Philippine Islands. The aluminum in these coins was replaced by copper-nickel beginning in ’22—aluminum just didn’t hold up when subjected to the chemicals used to disinfect Culion’s coinage. v.1 punto
-
L'attribuzione a Vejove è resa incerta anche dal fatto che l'unica statua di attribuzione certa, rivenuta nella cella del tempio sul Campidoglio, è acefala e priva delle mani con gli attributi. Vejove era una divinità autoctona essenzialmente infernale, identificata come la potenza distruttrice della natura, che presiedeva alle paludi e agli eventi vulcanici ed assordava col fulmine. Una radicata tradizione (accolta dal Grimal) ritiene che, in epoca tarda, sia stato assimilato ad Apollo, di cui sarebbe la manifestazione più oscura, con l'attributo di Apollo Vejovis. Secondo Kerényi, tuttavia, gli scrittori antichi parlavano sempre di Vejove in antitesi a Giove, e più precisamente la parte più oscura di Giove, che trova un parallelo con Zeus Katachthonios ("Sotterraneo"). Malgrado numerosi punti di contatto con Apollo, i Romani lo ritennero sempre Ve-Jovis (ove il prefisso può essere interpretato come diminutivo, seguendo Ovidio, "Piccolo Giove", o come negazione del valore semantico, seguendo Gellio, "Giove che non aiuta"), una versione in negativo della divinità, che bisogna placare. Rappresentazione della parte ctonia del grande dio a compendio della sua natura celeste, Vejove è un dio romano, probabilmente assimilato da una divinità italica giovanile, forse etrusca. Aveva come attributi un pilum e una capra, il primo come riferimento a Pilumnus e rappresentazione delle saette, la seconda come simbolo della fertilità e collegata al culto di Fauno e Fauna (solitamente Vejove veniva placato mediante un rito apotropaico di espiazione, consistente nel sacrificio proprio di una capra). Fu protettore del bosco sacro (l'Asylum) tra il Capitolium e l'Arx, dove la leggenda vuole che Romolo abbia ospitato e protetto tutti coloro che chiedevano "asilo" nella Roma neonata. Nella stessa area sorse il tempio dedicato a Vejove, tra quelli di Giunone Moneta e di Giove Capitolino, fondato nel 196 da L. Furio Purpureo come scioglimento di un voto fatto durante la battaglia di Cremona del 200 contro i Boi. La statua di culto è descritta da Aulo Gellio come quella di un dio giovane, laureato, "simulacrum dei Vedjovis, quod est in aede... sagittas tenet" con accanto una capra, probabile offerta sacrificale per il culto della divinità. L'alloro e le frecce richiamano le raffigurazioni di Apollo, di cui però Vejove sarebbe un predecessore, essendo questa divinità molto più antica in terra italica. Tra frecce e saette il passo è breve, a conferma del riconoscimento di Vejove come rappresentazione del lato infero del grande dio. Altro elemento a supporto di una parziale sovrapposizione tra le due divinità è la presenza della capra, legata a Giove come Amaltea (cui il dio stacca un corno per creare la cornucopia, che rimane però in terra italica attributo esclusivo delle dee, da Cerere a Opi, da Pomona a Fortuna). Ulteriore collegamento tra Vejove e il mondo vegetale e naturale è il tempio che sorse sull'isola Tiberina nel 194 affiancato a quello di Fauno. A lato fu poi edificato, su ordine dei decemviri sacris faciundis, anche il tempio del "greco" Esculapio (culto importato da Epidauro), allo scopo di "spuntare" le frecce del dio, debellando la peste che affliggeva l'Urbe. Entrambi dei italici, Fauno legato al soprasuolo come dio benevolo protettore delle greggi e dei pastori e Vejove collegato al sottosuolo, all'oltretomba, ai fulmini e alle acque. La festività della divinità venerata all'isola tiberina cadeva il 1° gennaio; il Vejove del Campidoglio invece veniva venerato alle none di marzo (mese dedicato a Marte). Secondo il Sabbatucci la doppia festa di Vejove riproduce il doppio capodanno che delimitava il periodo d'incubazione del nuovo anno o la sua fase preparatoria, posta tra il solstizio invernale e l'equinozio primaverile; giorni oscuri ove è decisamente logico onorare e placare una divinità potenzialmente così malevola. Il calendario venosino cita il nome di Vedjove in associazione anche agli Agonalia del 21 maggio, ma non si è certi che si tratti dello stesso dio; in caso affermativo il riferimento sarebbe al ciclo vitale delle stagioni, colla morte e resurrezione del dio in primavera. Durante la Seconda Guerra Punica, con Annibale alle porte di Roma, le divinità tradizionali parevano aver abbandonato i romani: i pontefici e la religione tradizionale non erano riusciti a ristabilire la pax deorum. E' in un simile contesto che trova spazio un Apollo guerriero, divinità chiamata in causa al fine di rimediare alla latitanza funzionale degli dei tradizionali, Marte in particolare. In questa fase è ad Apollo che si chiede la distruzione dell'esercito cartaginese. Durante la Terza Guerra Punica invece, per lo stesso scopo, Scipione Africano Minore, come riportato da Macrobio, invoca Vejove. Roma assediata, che perde fiducia verso i suoi culti tradizionali, si rifà ad Apollo; Roma che assedia, in un impeto di forza, invoca la divinità più antica. Durante l'assedio di Cartagine, Vejove viene invocato per assolvere la sua funzione tradizionale, ovvero quella ctonia ed in grado di arrecare un danno potenzialmente fatale: non è semplice guerra, quella appartiene a Marte, è la fine di un ciclo, è la cancellazione dei Cartaginesi. Secondo Varrone (De Lingua Latina, libro V, X) fu il re sabino Tito Tazio a introdurre a Roma il culto di Vejove; al riguardo, George Dumézil inquadra questa divinità "di importazione" nella terza funzione (secondo la tripartizione sovranità magica e giuridica / forza guerriera / fecondità), quella decisamente più complessa da tracciare. Più che di fecondità sarebbe meglio parlare di prosperità e di produzione-riproduzione, quindi di cicli, vitali, umani e naturali. Secondo Dumézil tale vastità trova riscontro sia nell'operato del flamine quirinale che in quello dei dodici flamini minori, il cui sacerdozio è riconducibile a divinità presiedenti a minuziosi e capillari aspetti, sempre riconducibili alla terza funzione. Al riguardo, i principali parallelismi tra il tessuto religioso, quello storico e quello sacerdotale sono: sovranità giuridica: Giove - Romolo - Flamen Dialis; sovranità magica: Giove - Numa Pompilio - Flamen Dialis; forza guerriera: Marte - Tullo Ostilio - Flamen Martialis; fecondità: Quirino - Anco Marcio - Flamen Quirinalis. Gli dei della terza funzione "si spartiscono le componenti, i corollari, gli annessi, dell'ambito della prosperità e della fecondità, e Quirino è solo un elemento di tale grande famiglia". Ops, Flora, Saturnus, Terminus, Vortumnus, Volcanus ed i Lari sono figure divine il cui culto è legato all'agricoltura ed al terreno, Diana e Lucina favoriscono le nascite, Sol e Luna hanno la funzione di regolare stagioni e mesi, Vejove, Larunda e Summano hanno un rapporto col mondo infero e sotterraneo: inizio, sviluppo e conclusione dei cicli vitali.1 punto
-
I ritratti balcanici di Domiziano hanno una fisionomia inconfondibile, assai diversa da quelli di conio romano. Posto per un confronto due esemplari coevi coniati sotto Tito rispettivamente in Tracia (proprio RIC 507) e a Roma (RIC 300 non ho il 288). Nell'esemplare che hai postato non mi sembra di vedere le caratteristiche delle emissioni balcaniche, ma potrebbe essere anche a causa della conservazione non ottimale. Quanto alla rarità è vero che ultimamente vengono proposti con una certa frequenza esemplari balcanici e quindi il grading del RIC, pur uscito nel 2007, per queste monete andrebbe forse rivisto.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?

















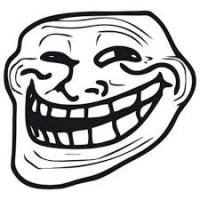






AdolfoViperetta.thumb.jpg.567df83d4aa18c98f435a6b9921cca31.jpg)