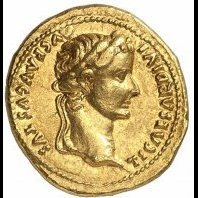Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 04/19/20 in Risposte
-
Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi il mio primo acquisto, per il mio compleanno. È stato fatto poche ore prima del lockdown per il Coronavirus e quindi la spedizione è avvenuta giustamente ed ovviamente con un mese di ritardo (grazie, Tinia Numismatica!). È una moneta comune, ma mi ha dato subito delle belle sensazioni, e l'ho acquistata. È dotata di certificato. Dati: Denario di Adriano (RIC 83) Materiale: Argento Diritto: IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG, busto laureato e drappeggiato. Rovescio: P M TR P COS III - Felicitas con caduceo e cornucopia Coniazione: dal 119 al 125 dC Peso: 3,45 gr. Diametro: 18 mm Sto preparando un book di schede con tutte le monete che erano state ereditate ed ora posso finalmente aggiungere questa. VI allego un paio di foto.6 punti
-
Repubblica di Venezia Leonardo Loredan (1501-1521) Ducato Oro Peso: 3,51 Diametro: 21 mm D/ LEONAR LAVRED S M VENETI, S. Marco stante e il doge inginocchiato reggono il vessillo, lungo l'asta DVX R/ SIT T XPE DAT Q TV REGIS ISTE DVCAT, il Redentore in mandorla stellata Rif.: Zub-Luciani 122.28 Ecco un esempio di ritratto sul ducato. Se si confronta il ritratto che il Bellini fece a Leonardo Loredan diventa subito evidente che quello rappresentato su questo ducato è proprio il Loredan. Ma è l'intera immagine che ormai è diventata rinascimentale. Il pavimento leggermente obliquo rende un senso di profondità e l'immagine diventa quasi tridimensionale. Le vesti si coprono di pieghe e cadono morbide lungo la figura. Insomma credo che sia un piccolo capolavoro. Arka Diligite iustitiam5 punti
-
Buongiorno a tutti. Complimenti per questa interessante discussione, alla quale aggiungo un esemplare certamente non bellissimo: Era stato classificato tra quelli con la "C", è corretto secondo voi?4 punti
-
Buon pomeriggio posseggo questo documento del Regno delle due Sicilie (ho conosciuto lo stemma ) vorrei gentilmente chiedere agli esperti in cartofilia ad aiutarmi a decifrare qualche rigo.Grazie a chi può rispondermi.3 punti
-
L'aquilino di Merano è già apparso, ma vi propongo comunque questo esemplare, meno frequente per via dei tre globetti in legenda, in luogo delle due rosette...3 punti
-
Sempre un quattro soldi di Leonardo Loredan, ma diverso. Al dritto infatti sia le figure che le legende sono invertite. S. Marco è qui seduto a d. e l legenda LEO LAVRED parte da ore 1 (sopra invece da ore 8 ). Da notare anche il diverso nimbo di S. Marco nelle due monete e la diversa posizione delle braccia. Anche la legenda del rovescio parte in modo differente, manca la scritta IC - XC e ci sono tre stelle sopra e sotto al Redentore. Infine il braccio destro di Cristo è alzato lontano dal corpo. Qui ci troviamo proprio di fronte a una moneta diversa. Arka Diligite iustitiam3 punti
-
Ecco il nuovo quattro soldi di Leonardo Loredan. Questa è la moneta che ha sostituito il grosso o grossetto. La nuova iconografia vede S. Marco seduto a d. con il doge in ginocchi davanti a lui. In esergo le iniziali del massaro. Sul rovescio la consueta ormai legenda TIBI SOLI GLORIA con un lungo busto del redentore posato su nuvole appena accennate. Del Primo grosso qui è rimasta la scritta IC - XC ai lati di Cristo. La moneta pesa 1,20 grammi e misura 21 millimetri. Arka Diligite iustitiam3 punti
-
Signoria di Padova Jacopo II da Carrara (1345-1350) Denaro piccolo Mistura D/ + (globetto) CIVITAS (globetto), lettera I R/ + P A D V A, stella a sei punte intersecante la legenda Rif.: CNI VI, 21 Questo è il denaro piccolo di Jacopo II. Ricalca perfettamente quello di Ubertino cambiando ovviamente l'iniziale al dritto, ovvero la lettera I resa in una bella forma ornamentale. Arka Diligite iustitiam3 punti
-
Ben ritrovati, appassionati del regno di Westphalia! Prima di iniziare, vorrei scusarmi con tutti voi per la prolungata assenza ma negli ultimi giorni sono stato abbastanza indaffarato. Siccome questa discussione è un progetto a cui tengo molto e a cui ho dedicato particolari cure ed attenzioni, mi è sembrato più corretto posticipare il tutto anziché tirare via gli ultimi argomenti rimasti, abbassando la qualità complessiva del lavoro. Bene. Chiusa questa mia parentesi, direi di cominciare! Quest'oggi tratteremo gli ultimi sottomultipli di tallero rimasti, ovvero gli esemplari da 1/6, 1/12 e 1/24 di tallero. L'1/6 di tallero è sicuramente il più interessante. Di questa moneta esistono due tipologie che, come vedremo, differiscono in tutto: peso, purezza del metallo, zecca e disegno. Ma facciamo un passo alla volta. La prima tipologia venne coniata a Brunswick e Cassel dal 1808 al 1813 (saltando il 1811). Le rispettive zecche sono riconoscibili dalla sigla al rovescio: B per Brunswick e C o F per Cassel. Probabilmente vi chiederete perché mai una singola zecca abbia usato due sigle diverse. In realtà, non si ha ancora una risposta certa a riguardo. Personalmente, ipotizzo che la C volesse indicare una coniazione avvenuta realmente a Cassel, mentre la F una coniazione avvenuta (totalmente o in parte) in Francia. Ma, ovviamente, questa è soltanto una mia ipotesi, quindi prendetela come tale... Tornando a noi, la moneta in questione pesa 5,85 grammi d'argento 500 millesimi. Il dritto ricorda molto quello del 10 talleri in oro di 1° tipologia, con lo stemma coronato del reame di Westphalia. Il rovescio presenta, invece, due scritte. La prima, centrale, indica il valore nominale: “VI einen thaler”, ovvero “6 unità di tallero”. La seconda, circolare, rappresenta, invece, il valore effettivo della moneta. Difatti, possiamo osservare che la legenda reca: “80 stück eine mark fein iustirt”, traducibile in “Regolato come 80 unità di marco puro”. Ciò vuol dire che sarebbero state necessarie 80 di queste monete per raggiungere il corrispettivo di un marco d'argento puro. E, in effetti, è proprio così: 80 x 5,85 x 0,5 (purezza) = 234 grammi. Dunque, ricordando che un tallero di convenzione contiene 1/10 dell'argento di un marco puro, sarebbe stato più opportuno definire questa moneta come 1/8 di tallero. Invece, all'epoca si preferì tenere questa “discrepanza” tra valore nominale e valore effettivo... Passiamo ora alla 2° tipologia (coniata esclusivamente a Clausthal). Dal modico peso di 3,26 grammi d'argento 994 millesimi (lo stesso argento utilizzato proprio a Clausthal anche per la coniazione dei 2/3 di tallero), questo esemplare di 1/6 di tallero presenta un dritto identico alla tipologia precedente. Il rovescio, invece, ricorda molto lo stile dei 2/3 di tallero già trattati. Anche qui troviamo, infatti, il valore nominale campeggiante a caratteri cubitali, accompagnato da due legende circolari. Quella più interna (in senso antiorario) reca: “N D R F F silb”, un acronimo che starebbe per “Nach dem reichs fuss feine silber”. Sostanzialmente, ci dice che la moneta è stata battuta “a piede dell'Impero”. Ora che sappiamo bene a quale metodo ponderale fa riferimento la zecca di Clausthal, non dobbiamo più “spaventarci” di fronte a simili diciture. Diversamente dalla tipologia precedente, in questo caso valore nominale e valore effettivo combaciano. Calcoliamolo assieme: 6 x 3,26 x 0,994 x 12 (numero di talleri “di Lipsia” necessari ad ottenere un marco puro d'argento) = 233,3 grammi (ovviamente, un minimo margine d'errore è ammissibile). La legenda più esterna (in senso orario) presenta, invece, il classico “Koenig von Westphalen F P”. Le ultime due monete rimaste, personalmente, non mi hanno mai entusiasmato. Le tratterò, quindi, in modo rapido e un po' distaccato. L'1/12 di tallero venne coniato a Clausthal dal 1808 al 1810. Pesa 3,34 grammi ed è fatto d'argento 437 millesimi (possiamo considerarla tranquillamente una moneta in mistura). Se facessimo i calcoli, noteremmo che contiene un po' meno della metà dell'argento puro presente nell'1/6 di tallero di 2° tipologia (coniato sempre a Clausthal). Tuttavia, si tratta di quantità d'argento talmente irrisorie che, francamente, credo possano ritenersi trascurabili... Al dritto troviamo il monogramma HN coronato e, in basso, la C di Clausthal. Al rovescio, invece, osserviamo la scritta “12 einen thaler”, accompagnata dall'ormai classica legenda “Nach dem reichs fuss”. A concludere la sterile esecuzione, possiamo osservare un fiorellino ad ore 12, elemento decorativo tipico della zecca di Clausthal. Se notate, infatti, lo ritroviamo anche nei 2/3 di tallero e nell'1/6 di tallero di 2° tipologia. Eccoci, infine, arrivati all'1/24 di tallero, moneta coniata a Cassel dal 1807 al 1809. Anche qui possiamo trovare o la F o la C come simboli di zecca (la F è più comune). Il dritto è pressoché identico al precedente, sennonché la corona presenta dei festoni ai lati. Al rovescio troviamo, invece, un semplice “24 einen thaler”. Come potete voi stessi constatare, sono entrambe monete eseguite in modo alquanto banale e prive di chissà quale estro creativo... In termini generali, le monete trattate quest'oggi sono tra le più comuni del Regno di Westphalia e sul mercato viaggiano tra le decine e le centinaia di euro (dipendentemente dalle condizioni, ovviamente). Quindi, per una volta, si tratta di monete alla portata di tutti Bene. Anche per oggi abbiamo finito. Spero che abbiate gradito questo mio ritorno. Il prossimo appuntamento, purtroppo, sarà l'ultimo di questo lungo viaggio...3 punti
-
Ciao a tutti. Desidero condividere con tutti voi una delle monete preferite della mia collezione: il raro giulio di Giulio II coniato a Bologna con conii attribuite a Francesco Raibolini chiamato Francia. Secondo Vasari (di cui non ci si può fidare in ogni dettaglio): Ma quello che gli dilettò sopra modo, fu il fare i conii per le medaglie, i quali da nessuno meglio che dal Francia furono fatti ne' tempi suoi, come apparisce ancora in alcune medaglie fatte da lui naturalissime della testa di Papa Iulio II che stettono a paragone di quelle di Caradosso. Oltra che fece le medaglie del Signor Giovanni Bentivogli che par vivo e d'infiniti principi, i quali nel passaggio di Bologna si fermavano, et egli faceva le medaglie ritratte in cera, e poi finite le madri de' conii, le mandava loro; di che, oltra la immortalità della fama, trasse ancora presenti grandissimi. Tenne continuamente mentre che e' visse la Zecca di Bologna; e fece le stampe di tutti i conii per quella, nel tempo che i Bentivogli reggevano; e poi che se n'andorono, ancora mentre che visse Papa Iulio, come ne rendono chiarezza le monete che il papa gittò nella entrata sua, dove era da una banda la sua testa naturale, e da l'altra queste lettere: Bononia per Iulium a tyranno liberata. E fu talmente tenuto eccellente in questo mestiero, che durò a far le stampe delle monete fino a 'l tempo di Papa Leone; e tanto sono in pregio le 'npronte de' conii suoi, che chi ne ha le stima assai, né per danari se ne possono avere.2 punti
-
La visione di quest'ultima permette di capire perchè quella di Filippo Pellizzaro (discussione postata da me) è qFdC. Nel complesso quella di Pellizzaro ha un conio un pò stanco al rovescio, i cui effetti si notano nei dettali della figura al rovescio (ad esempio il viso). Quella di Pellizzaro è non circolata, ma qFdC in quanto non rappresenta il meglio che poteva uscire da una data coniazione (se si segue questa definizione di FdC). La tua moneta quindi, all'emissione, era di qualità eccelsa, migliore di quella di Pellizzaro. Vi sono però dei leggeri segni di circolazione che mostrano che la moneta anche se per poco tempo è passata di mano. Questi segni, seppur leggerissimi, si notano sulle zone più esposte della moneta (spalla, mano, punta della corona, ecc.). I fondi sono praticamente perfetti. Penso quindi che la conservazione sia tra lo Spl+ e lo Spl/FdC. Disquisire tra quale delle due sia la conservazione più opportuna credo sia complesso. La qualità del coniazione spinge nettamente verso lo Spl-FdC, il fatto che abbia dei residui che impediscono la visione di alcuni dettagli verso lo Spl+. Questione di lana caprina. Moneta eccezionale per qualità. Hai messo assieme veramente una bella collezione.2 punti
-
Buonasera @petronius arbiter Non avevo letto questa discussione, a metà del 2012 non conoscevo il sito... ma negli anni ho seguito questa serie dedicata ai nativi d'America. In ricordo della scultrice che è venuta tristemente a mancare si potrebbe proseguire spiegando le restanti monete della serie dal 2013 fino al 2019. saluti miza2 punti
-
Eccoci di nuovo qui. Come già anticipato, questo sarà l'ultimo appuntamento del nostro fantastico viaggio alla scoperta della storia e delle monete del Regno di Westphalia. Purtroppo, ci resta una manciata di monete da trattare, di cui solo una realmente interessante. Le altre, come vedremo, sono i classici “spiccioli” recanti al dritto il monogramma HN coronato e, al rovescio, il valore nominale. L'unica moneta (a mio avviso) degna di nota è il cosiddetto 24 mariengroschen. I cataloghi riportano una coniazione avvenuta sia a Brunswick (B) che a Cassel (F) ma, francamente, tutti gli esemplari che mi è capitato di osservare erano sempre e solo di Brunswick... La moneta pesa all'incirca 17,30 grammi ed è fatta d'argento 750 millesimi. Al dritto possiamo osservare il classico stemma reale coronato, accompagnato dalla legenda “Hieronymus Napoleon”. Tutto nella norma, sennonché, affianco alla Legion d'onore in basso, possiamo notare un elemento inusuale e alquanto criptico: “2/3 ST”. Si tratta di un'indicazione del valore della moneta ed è l'unico caso di moneta westphaliana a recare il proprio valore sia al dritto che al rovescio. Difatti, quella scritta sottolinea che lo scudo da 24 mariengroschen equivale ad un 2/3 di tallero. A dimostrazione di ciò, ricordando che il 2/3 di tallero ha un contenuto d'argento puro pari a circa 13 grammi, possiamo fare un veloce calcolo: 17,3 x 0,75 = 12,98 grammi. Al rovescio, invece, possiamo notare il valore nominale (“XXIIII marien grosch”) e più in basso la legenda “Nach d Leipz fus”, che sottolinea come questa moneta faccia riferimento al sistema ponderale in uso a Lipsia (come il 2/3 di tallero, d'altronde). Più in basso, troviamo la B maiuscola della zecca di Brunswick. Delle restanti monete, sinceramente, c'è veramente poco da dire. Sono monete estremamente comuni, specie in bassa conservazione. Solitamente vengono vendute nelle ciotole dei mercatini tedeschi a pochi euro ciascuna oppure si possono trovare in alcuni lotti di monete sfuse nelle aste di “serie B”. Onestamente, non sono nemmeno riuscito a trovare delle immagini decenti per gli esemplari da 1, 2 e 4 penny. Non avrò, quindi, il piacere di potervele mostrare ma vi assicuro che non vi state perdendo nulla di così clamoroso... L'unica foto carina che sono riuscito a reperire è quella di un mariengroschen, moneta in argento povero (mistura). Al dritto, presenta il monotono monogramma coronato di re Girolamo. Al rovescio, invece, troviamo il valore nominale (“1 marien gros”) accompagnato dall'immancabile “Nach dem reichs fuss”. Wow! Che fantasia... Il 4 penni è praticamente identico: sempre in mistura e con lo stesso disegno sia al dritto che al rovescio. Cambia soltanto un po' il diametro ed il peso (è una moneta più piccola del mariengroschen). L'1 ed il 2 penny, infine, sono in rame. Il dritto è sempre lo stesso e il rovescio è caratterizzato (guarda un po'...) dal valore nominale, riportato come “I (o II) pfenning scheide-müntz”. Tutti questi “spiccioli” vennero coniati a Clausthal solamente nei primi anni del regno. La loro produzione venne, infatti, interrotta già dalla fine del 1810. Perfetto! Con ciò, abbiamo definitivamente terminato. Spero vivamente che abbiate gradito questa mia piccola trattazione e mi auguro di avervi fatto appassionare un minimo a questa monetazione così di nicchia. Ovviamente, resto sempre a disposizione per eventuali domande o curiosità. Alla prossima, Luca2 punti
-
Certamente che se ne può parlare, spero sempre che dai confronti nasca qualcosa di positivo (critiche, consigli, proposte) che possa tornare utile. Credevamo inizialmente di riuscire a condensare la monetazione papale in 4 volumi ma, nonostante il consistente numero di pagine dei 2 tomi già editi, appare evidente che si tratta di un obiettivo difficilmente raggiungibile. Purtroppo siamo costretti a rivedere l’organizzazione dell'opera in fase di stesura dei singoli volumi e pianificare numero dei tomi e loro contenuto non è facile; certo è che non vorremmo "tirarla per le lunghe " ma nemmeno tralasciare parte della monetazione, come quella da Pio VII in poi. vero è che i preziari già la includono, ma i MIR nascono con lo scopo di elencare le monete italiane dal medioevo all'unità d’Italia e, se proprio si deve derogare a tale linea editoriale, tanto vale farlo per abbondare, come nel caso del volume dei Savoia che arriva fino al 1946. Il buon Toffanin è alle fasi finali del terzo tomo, alle bozze. Purtroppo le limitazioni alla mobilità personale hanno ritardato i lavori e l’uscita del volume, prevista per fine maggio, è rinviata a fine agosto, in concomitanza con il convegno numismatico di Riccione. Se ci sarà......2 punti
-
@ottone Così, senza sforzo alcuno, hai una nuova moneta nella collezione di Padova. E comunque è grazie a te che ho avuto l'occasione per spiegare la differenza tra i denari di padre e figlio. Arka Diligite iustitiam2 punti
-
Un denaro di Volrico, vescovo di Trieste, simile a quello postato a pag. 3 di questa discussione da @ak72 , ma con la porta al centro delle mura chiusa. Arka Diligite iustitiam2 punti
-
Buongiorno @paoloilmarinaio a me piacciono molto gli editti borbonici, (i decreti) apprezzo molto i contenuti, la carta, la filigrana, gli stemmi e i caratteri con i quali si scriveva. Ne posseggo una decina di quasi tutti i regnanti Borbonici. Il manoscritto postato da te è un atto giudiziario, come si evince dal timbro in basso della seconda pagina, forse un esproprio o un pignoramento. Questo, come gli atti notarili, sono documenti molto comuni. Purtroppo però non ti posso aiutare perchè anche ingrandendo l'immagine, la scrittura si sgrana troppo e non riesco a decifrare nulla. Mi dispiace. Ciao, Sergio.2 punti
-
2 punti
-
Buongiorno, scusate, non volevo essere maleducato. Sono stato solo imbranato. Ho inviato il messaggio per errore prima di scrivere il testo e caricare la foto. Grazie, Gianfranco2 punti
-
2 punti
-
Ciao, ho scansionato il libro e l'ho inserito nella Sezione Libri del Forum. Chi è interessato può eseguire liberamente il download. Saluti a Tutti Beppe2 punti
-
Mi sembra che non ci sia molto da aggiungere: L. Licinio Lucullo ha già ben confrontato la sua moneta con gli stili noti di ogni variante. Tenendo conto che al R/ non sembrano esserci simboli, l’unica opzione è la 550/2b, anche se lo stile della crocchia di capelli sulla nuca è differente dal tipo noto. Non ho trovato immagini di questo conio differente. Però nella scheda manca(va)no le foto di due varianti. Di una, la 550/2f, forse ho trovato la moneta a cui il Crawford fa riferimento: “Berlin”. Grazie alla recente digitalizzazione dell’archivio del museo tedesco, online c’è questa: https://ikmk.smb.museum/object?lang=en&id=18228319&view=vs (che ho aggiunto al catalogo), anche se i curatori non sono nemmeno sicuri che lo sia mettendoci un bel punto interrogativo sulla scheda. Però si vede chiaramente che le trecce dei capelli sono dello stesso stile della 550/2d e 550/2e. Non rimane quindi che la 550/2a. Purtroppo qui l’immagine è pubblicata su un articolo dell’Alfoldi del 1966 “Commandants de la flotte romaine stationnée a Cyrene sous Pompée, Cesar et Octavien” in Mélanges … Carcopino. Tenendo conto che sul davanti della moneta di L. Licinio Lucullo non si comprende che simbolo ci sia (crescente ? o stella nel crescente ?) sarebbe da reperire quest’immagine (della 550/2a) per vedere il tipo di crocchia dei capelli.2 punti
-
Non colleziono il tipo ma acquistare da un privato in Italia su eBay è sicuramente da evitare. Forse la ragione dell'invenduto è questa.2 punti
-
Grazie dell'intervento @azaad---come scrivi non è facile valutare il rame del periodo...io un po' di pezzi li ho in collezione, ma ancora oggi tentenno e chiedo l'aiuto del forum per valutare...quello che citi tu è un 5 gran magnifico, venduto da Cavaliere e giudicato qfdc...anche se onestamente vista la moneta il fdc ci starebbe tutto....io ho questa in collezione presa l'anno scorso che si avvicina alla moneta da te citata, ma anche li' come giudicarla? io nel cartellino ho scritto spl/fdc...eccola2 punti
-
Segnalo questa novità bibliografica della Basilicata University Press Alessandro Di Muro, La terra, il mercante e il sovrano Uno spaccato dell'Italia longobarda dell'VIII secolo. In particolare segnalo il Cap. II dal titolo Mercanti, moneta e società1 punto
-
In questi termini si, allora mi scuso Ma mi pareva giusto specificarlo, perché poi la direzione diventa "false" e migliaia di fuse sono antiche e per molti aspetti storico numismatici più interessanti delle "vere"1 punto
-
Eccomi, questo è l'assegnato di cui parlavo prima: ...e questo il "certificato": Da notare anche qui il riferimento allo Stato Pontificio, con specifica attribuzione a Pio VI (che stava invece morendo in Francia... ?) -la data di emissione, che diventa addirittura il 9 agosto... - il numero di serie, che da 414128 diventa un criptico 4/4/n8 (a questo proposito, racconto che scrissi diverse volte con insistenza a Crapanzano e a Vendemia per chiedere lumi sulla lettura dei numeri di serie, specialmente di quello strano 2 che si ritrova spessissimo su tutti gli assegnati di ogni taglio: finalmente, dopo che la mia insistenza si fece quasi stalking, ebbi una risposta secca e scarna da Vendemia che mi scrisse, testualmente: "la 'sua' N è in realtà un 2". Grazieeeeeee!!) - infine, notare che il Crapanzano qui è diventato CAPRAnzano!!! Personalmente, ho mooooolte riserve sulla competenza di certi sedicenti "esperti". In ultimo vorrei far notare la presenza sulla banconota di un timbro circolare in basso a sinistra con la scritta "Mostra della Rivoluzione Fascista": probabilmente questo pezzo fu esposto alla mostra in questione negli anni 30 ma sul certificato non vi si fa menzione (anche se per me è valso l'acquisto...)1 punto
-
DE GREGE EPICURI Raccomando a tutti gli iscritti a questo gruppo di dare ogni tanto un'occhiata alle discussioni: ci saranno degli avvisi, o altro, e sarebbe complicato citare tutti ogni volta per richiamare la loro attenzione.1 punto
-
1 punto
-
Sempre virtuose e importanti queste iniziative concrete verso i giovani laureati , un bel ricordo del grande Mario Traina !1 punto
-
Buona Domenica Soldino "LAVS TIBI SOLI" gr 0,30 Bagattino per Padova in ottone saluti luciano1 punto
-
Massimo Lucà Dazio di Castelnuovo, Storia del Regno delle Due Sicilie attraverso le sue medaglie.1 punto
-
Anche sotto il dogado di Leonardo Loredan (1501-1521) la zecca di Venezia conia nuovi nominali. Qui è illustrato il 16 soldi. Sul dritto S. Marco è rappresentato seduto su un alto trono e il doge come al solito in ginocchio davanti a lui. Sul rovescio invece la scena ricorda molto quella del rovescio del marcello con la legenda GLORIA TIBI SOLI. Il peso è di 4,84 grammi circe e il diametro di 28 millimetri (rif.: Zub-Luciani 86.1). Il 16 soldi fu coniato anche da Antonio Grimani e Andrea Gritti. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
E ci sono tanti altri interessanti libri. https://www.lamoneta.it/files/ Consiglio a tutti di farci un giro... Saluti Simone1 punto
-
Grazie per i denari @ottone . La differenza fra questi due denari piccoli sta soprattutto nella diversa attribuzione. Infatti solo quello sotto è di Francesco I. In denaro illustrato sopra, invece, appartiene a Francesco II Novello. La distinzione è soprattutto nel tondello. Quelli di Francesco I sono sempre scodellati e molto leggeri. Quelli di Francesco II invece sono piatti e di norma più larghi e pesanti, poichè hanno un contenuto di metallo nobile molto più basso. Un'altra distinzione è nella lettera F. L'iniziale di Francesco I è sempre accompagnata da molti globetti ornamentali, quella del figlio è molto più sobria. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
Mi daresti il link di dove lo hai postato, nel frattempo ne ho visto alcuni disponibili su Ebay dove ne ordinerò sicuramente uno...grazie in anticipo per il lavoro fatto e la disponibilità.1 punto
-
1 punto
-
ps - In catalogo c'è già la scheda della presente, se vuoi puoi inserire anche le tue foto (possibilmente schiarite un po) ecco il link: https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME66A/1931 punto
-
1 punto
-
Ciao, il rovescio rappresenta Traiano a cavallo che trafigge un guerriero dacico davanti ad esso. Come detto non abbiamo il peso e le legende sono poco leggibili. In base al rovescio si può provare a fare delle ipotesi: Se fosse un asse potrebbe trattarsi del RIC II Traiano 540: http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.tr.540 Se fosse un sesterzio potrebbe essere il RIC II Traiano 534: http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.tr.534 Che dite? potrebbe essere? Ciao da Stilicho1 punto
-
Ciao Jaconico. Ecco un esempio di come si può costruire una collezione, interessante e piacevole, al di là dei "ma quanto vale?" , "quanto costa ?" e senza dover acquistare - come per troppo tempo è accaduto - francobolli e monete vendute sotto vuoto - protetti come se fossero reliquie sacre - , robaccia sulla quale oggi non vale nemmeno la pena di chiedersi "quanto vale ?" perché nessuno la vuole e la compra. Ti sei dato un obiettivo, hai definito i criteri della ricerca che ritieni più giusti, ora avrai il grande piacere di mettere assieme uno dopo l'altro tante banconote che ad una ad una andranno a riempire la tua raccolta. Il "piacere della ricerca" : un elemento basilare, stimolante, indispensabile per ogni collezionista. Durante questa ricerca magari ti potrà capitare di sostituire una banconota con un'altra dello stesso Stato ma in migliori condizioni, oppure se ti sembrerà più bella, più significativa. Mi piacerebbe sapere come procederà nel tempo : e sono certo che ti darà delle soddisfazioni, a prescindere dal suo ipotetico controvalore commerciale, visto che la raccolta l'hai iniziata per te. Un saluto cordiale. @jaconico1 punto
-
CALZIFICIO SANTAGOSTINO, nasce a Milano nel 1876 e successivamente si trasferirà in provincia di Brescia, con sede a Quinzano d'Oglio1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Un bell’esemplare, decisamente sopra media di ciò che si trova in ciotola per questa tipologia (almeno per la mia esperienza)...1 punto
-
Non ricordo dove sono....qualcuno potrebbe cortesemente postare in questa discussione un po' di tagli di monete da 8 - 5 - 4 e 6 Tornesi di Ferdinando IV ? Ricordo che ci sono...ma non riesco a trovarli.... Grazie a tutti.....1 punto
-
Se vorresti ricercare tutte le varianti di Ferdinando II di Borbone.....credo che non ti basterà tutta la vita......non immagini nemmeno quante ve ne sono. A proposito.....hai qualche lavoro dove sono state elencate ?1 punto
-
Esemplare meglio conservato del precedente in http://www.acsearch.info/search.html?id=2396884 Crete, Aptera AR Stater. Signed by Pythodoros. Circa 4th century BC. Α[ΠΤAΡΑΙΩΝ] around head of Artemis Aptera to right, with hair elaborately curled upwards around a stephane ornamented with palmettes; she wears an elaborate crescent and solar-disk pendant earring with three drops and a pearl necklace; to right in smaller letters the artist’s signature: ΠΥΘΟΔΟΡΟΥ / Warrior hero Apteros, called Ptolioikos, standing facing, his bearded head left, wearing crested helmet and cuirass, holding in his left hand a spear and shield decorated with a sunburst, his right is raised towards a sacred fir tree in left field; ΠΤΟΛΙΟΙΚΟΣ around. Le Rider, Monnaies crétoises, p. 36, 269-70, pl. 9, 11-12; Svoronos, Crète, p. 15, pl. 1, 10 (same dies); BMC 1, pl. 2, 3 (same dies); BMFA Suppl. 108 (same dies); LIMC VII/1, p. 588, VII/2, sv. Ptolioikos 2 (same rev. die); for the engraver’s signature see L. Forrer, Notes sur les signatures de graveurs sur les monnaies grecques, Bruxelles 1906, pp. 277-284. 11.78g, 24mm, 12h. Extremely Fine. Extremely Rare. Of exceptionally fine style and quality, and among the finest of the very few known examples. From the Eckenheimer Collection. The stunningly beautiful obverse female portrait is that of Artemis Aptera (or Aptara as inscribed on the coins, a local form of the Cretan Artemis Diktynna), the patron goddess of the city. Before her image in small characters proudly appears the name of the artist Pythodoros, a master die-engraver who also worked at Polyrherion on the equally beautifully styled female head which has been defined as that of Britomartis, ‘sweet maiden’ in the Cretan dialect. Also identified as Artemis Diktynna, Britomartis in Cretan myth was caught in a fisherman’s net (diktyon) while trying to escape the advances of Poseidon, and was the subject of several Cretan coin types inspired by a statue then attributed to Daedalos, who was reputed to be the father of Cretan art (cf. Le Rider pp. 114-6, 3-6 pl. 28, 19-38; Svoronos 15-16, pl. 26, 4-5; Traité pl. 261, 25; BMC 1-2). Both images are very much influenced by the Sicilian school of die engraving as epitomised by the celebrated artists such as Kimon, Phrygillos, Eukleidas, Euainetos and Eumenes. The reverse type is of no less mythological and historic interest; the warrior in question is Apteros, called Ptolioikos, a title literally meaning ‘dweller in the city’. He is shown saluting a tree, a scene which can be interpreted as a rendering of what must surely be a now lost myth concerning the oiktistes or founder of the city. The fine remains of the ancient polis of Aptera or Aptara (IACP 947), the modern Palaiokastro, are situated near the Minoan site of Megala Chorapia on the south side of Suda Bay, the safest anchorage in Crete throughout Greek, Venetian and Ottoman times, and which is today an important NATO naval base. Eusebius informs us that the city was founded by an eponymous hero, Apteros in the year 1503 BC (Chronicon 44c). The first historical mention of Aptera dates from the 7th century BC when a contingent of archers is reported to have fought along with Spartans in the war against Messene (Pausanius, Description of Greece IV 20, 8). Various attemps in antiquity were made to explain the city’s name: notably, that it was the site of the song contest of the Muses and Sirens. In this story the latter lost their wings in a fight that ensued after their defeat (Stephen of Byzantium sv. Aptera; ‘aptera’ = ‘wingless’). The city’s name most likely derives from one of the epithets of Artemis, Aπτερα (cf. Inscriptionis Cretae 2), similar to that of the statue in the temple of Athena Nike on the Acropolis at Athens, which later took on the name of Nike Apteros, meaning ‘wingless’ Nike. From the fourth century BC Aptera produced coins on the Aiginetan weight standard, but by later Hellenistic times it gradually declined in favour of its powerful neighbour Kydonia and was finally absorbed by Rome in 67 BC. apollonia1 punto
-
Francè.....è da ieri che mi stai facendo ammattì su queste "c" speculari :( :( ma prorpio non riesco a venirne a capo. E comunque dacci un pò di tempo....no....mica siamo maghi qui :P :P1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?











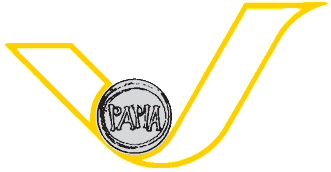



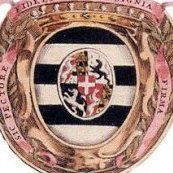


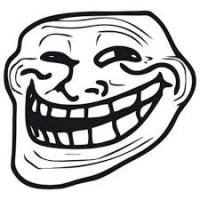


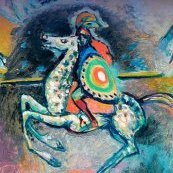



.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)