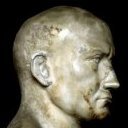Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 04/27/20 in Risposte
-
Ravvivo la sezione con l'ultima arrivata, presa in asta su ebay dal buon Luca Iacovino Non rara ma affatto male, e decisamente migliore dal vivo che in foto6 punti
-
1933 Cile - 10 Centavos L'autore del condor cileno è lo stesso artista che ha creato la famosissima 'seminatrice" francese. (Louis-Oscar Roty)5 punti
-
taglio 2 euro TDR paese Finlandia anno 2007 tiratura 1.367.900 condizioni bb città Milano4 punti
-
Ma scusate, per capire eh, ma con chi ce l'avete ? Io ho visto (in tv) Mattarella portare la corona sull'Altare della patria da solo. Niente feste, niente celebrazioni. Cosa c'entra poi la messa ? Mi risulta che gli antipecoristi sfoggino rosari ad ogni pie' sospinto, ma a messa ci vadano poco e niente. Comunque si cerca maldestramente di mettere i 'cattolici' contro i 'comunisti', il tutto condito con un po' di antipolitica che scalda sempre gli animi.4 punti
-
Io pur essendo un bibliofilo non condivido questa impostazione, le ristampe hanno un loro valore bibliografico e collezionistico, non sono semplici copie ma prodotti editoriali distinti, in alcuni casi presentano dei pregi materiali per la fattura della carta e rilegatura, non poche volte possono assumere carattere di rarità o presentare elementi testuali aggiuntivi (prefazioni, introduzioni) di notevole interesse scientifico, vi sono poi ristampe fondamentali che permettono il possesso e la consultazione in formato tradizionale di opere estremamente difficili a reperirsi, un esempio classico in merito è la grande opera del Rizzo sulle monete della Sicilia greca, quando la si trova in originale è spesso in condizioni piuttosto vissute ed a prezzi proibitivi, l'unico modo alternativo per averla senza svenarsi è ricorrere alla ristampa Forni che nonostante la differenza qualitativa rispetto all'originale pure spunta prezzi non proprio per tutti. L'ideale a mio avviso è di possedere gli originali insieme alle varie ristampe in modo da ricreare in biblioteca la storia bibliografica dell'opera, chiaro che la mia è un'impostazione particolare che si basa su un criterio bibliografico e privilegia la coerenza scientifica di una biblioteca rispetto al possesso di singoli pezzi di pregio...io stesso l'ho applicata solo per alcune opere di riferimento come lo Spahr e il Sabatier sulle monete bizantine.4 punti
-
Buonasera a tutti... posto anch io la mia 1840 con taglio del collo del 30 ducati o 10 tornesi 1839/1840...! Comunque @Rocco68, dopo aver visto la foto con tutti quei mostri messi assieme, mi viene voglia di non postare nulla più ☺️☺️☺️... una buona serata a tutti...!4 punti
-
3 punti
-
Non essendo un collezionista di libri, a me interessa il contenuto, non la tiratura, per cui il problema di prendere l'originale o la ristampa non me lo pongo. Non mi interessa la rarità o il suo valore collezionistico, lo devo leggere il libro, non tenerlo da parte. Se capisco la tesi dell'importanza dell'originale, non condivido la comparazione della ristampa con un riconio di una moneta che è semplice gadget, mente la ristampa contiene tutto ciò che interessa al lettore, meno molto spesso, se non quasi sempre, il valore collezionistico. Questa discussione nacque per mostrare libri in possesso agli altri utenti che, in tal modo, avrebbero potuto chiedere informazioni o notizie sugli stessi, non, almeno credo, per una mera esibizione muscolare di rarità collezionistiche.3 punti
-
2 punti
-
Jim Thorpe "Signore, lei è il più grande atleta del mondo", così avrebbe detto re Gustavo di Svezia a Jim Thorpe, consegnandogli le due medaglie d'oro vinte alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912. Jacobus Franciscus Thorpe, detto Jim, è stato in effetti uno degli atleti più completi delle sport moderno. Giocatore di football americano e di baseball, eccelleva anche in tutte le discipline dell'atletica leggera, tanto da vincere, nelle Olimpiadi del 1912, le competizioni di pentathlon e decathlon, con risultati che in almeno 4 gare su 10 del decathlon lo avrebbero portato a vincere medaglie anche nelle singole specialità. Nato nel 1887 (secondo altre fonti nel 1888) in una riserva indiana dell'Oklahoma da genitori di sangue misto, fu allevato come un Nativo americano. Il suo nome indiano era Wa-Tho-Huk, che significa Sentiero Lucente. Narra la leggenda che tutto cominciò un giorno del 1907 a Carlisle, quando Thorpe si improvvisò saltatore in alto e, con addosso i calzoni normali, batté tutti gli altri studenti con la misura di 1,85 m. Non si sa se quest'episodio sia vero, ma è certo che i primi risultati ufficiali di Jim Thorpe risalgono proprio al 1907. Thorpe non si limitava alla sola atletica leggera: mentre frequentava la scuola di Carlisle praticò anche il football americano, il baseball, e persino il ballo da sala. Si propose all'attenzione nazionale per la prima volta nel 1911. Giocava come running back nella squadra di football americano della scuola, e in una partita contro Harvard finita 18-13 segnò tutti i punti. Il football americano era, e sempre fu, il suo sport preferito, all'atletica leggera si dedicava sporadicamente, anche se fu quella che gli diede maggior fama. Giusto, quindi, mostrarlo in tenuta da giocatore di football. Il programma dei Giochi Olimpici del 1912 prevedeva due nuove prove multiple, il pentathlon e il decathlon. Ai Giochi intermedi del 1906 si era già svolta una competizione ispirata al pentathlon dell'antica Grecia, ma le cinque prove di Stoccolma sarebbero state salto in lungo, lancio del giavellotto, 200 m. piani, lancio del disco e 1500 m. Il decathlon invece era un evento completamente nuovo, anche se negli Stati Uniti già dagli anni 1880 si organizzava una competizione su dieci prove nei meeting di atletica leggera, chiamata All around. Le prove del nuovo decathlon olimpico erano però leggermente diverse dalla versione statunitense. Thorpe partecipò a entrambe le competizioni, vincendo quattro gare su cinque nel pentathlon (arrivò terzo nel giavellotto, che praticava solo da poco), e classificandosi tra i primi quattro in tutte e dieci le prove del decathlon, distaccando di oltre 700 punti il secondo classificato. Partecipò anche alle gare individuali di salto in alto, dove sfiorò la medaglia arrivando quarto, e di salto in lungo, dove si classificò al settimo posto. Oltre alle gare di atletica leggera, ai giochi olimpici Thorpe partecipò anche a una partita dimostrativa di baseball tra due squadre formate dagli atleti della nazionale americana. Non era la prima volta che giocava a baseball, come presto avrebbe scoperto tutto il mondo. Verso la fine di gennaio del 1913, i giornali americani riportarono la notizia che Thorpe aveva giocato a baseball da professionista, e l'Amateur Athletic Union (AAU) prese il caso molto sul serio. Thorpe scrisse loro una lettera in cui ammise di aver giocato a livello semi-professionistico: "...spero verrò scusato almeno in parte dal fatto che ero semplicemente uno studente indiano e non sapevo tutto quello che c'era da sapere. Davvero, non sapevo che stavo facendo una cosa sbagliata, perché sapevo che molti altri studenti avevano fatto lo stesso, solo che loro non avevano usato i loro veri nomi..." La lettera non fu di grande aiuto. L'AAU decise di revocargli con effetto retroattivo lo status da dilettante, e chiese al CIO di fare altrettanto. Quello stesso anno il CIO all'unanimità dichiarò Thorpe professionista, e decise di privarlo dei titoli olimpici, delle medaglie e dei premi Nessuno mosse un dito per difendere il pellerossa Thorpe, nonostante episodi di “professionismo” più o meno mascherato fossero già allora tollerati. Ma il clima olimpico era ben diverso da quell’ideale di “fratellanza” attribuito a De Coubertin e soci: soprattutto non piacquero agli organizzatori delle Olimpiadi le vittorie di neri, indiani e di un hawaiano contro i bianchi, al punto che gli USA ritirarono dalla finale dei 100 metri di Stoccolma il più veloce, un afroamericano, per far vincere il connazionale bianco. Lo stesso clima si respirava ancora nel 1936, con il grande Jesse Owens osteggiato forse più dai colleghi della sua squadra che dai tedeschi, per il suo essere nero (si veda il bel film Race - Il colore della vittoria). Thorpe a quel punto diventò professionista per davvero, giocando in diverse squadre di baseball e di football, sport nel quale, nel 2009, fu classificato al numero 37 tra i migliori cento giocatori di tutti i tempi. Ma terminata, a 41 anni, la carriera sportiva, la vita per lui si fece sempre più difficile e complicata, a causa, anche della grande depressione del 1929. Faceva fatica a trovare un lavoro fuori dal mondo dello sport, e non riusciva a mantenere un impiego a lungo. Così si adattò ai mestieri più disparati, la comparsa nei film western (di solito nella parte del capo indiano), il muratore, il buttafuori, il marinaio. Incominciò a bere. Nel 1952, colpito da un tumore alla bocca fu ricoverato in ospedale, che poté pagare solo grazie alla beneficenza. Nel 1953 ebbe un infarto miocardico (il terzo) mentre cenava con la terza moglie, Patricia Askew, nella roulotte in cui viveva a Lomita, in California. Fu rianimato con la respirazione artificiale, ma perse conoscenza poco dopo e morì, all'età di 65 anni. Negli anni vennero fatti diversi tentativi, soprattutto da parte dei figli, per ottenere la restituzione dei titoli olimpici, e finalmente nell'ottobre del 1982 il comitato esecutivo del CIO approvò la riabilitazione di Thorpe. Con una decisione insolita, non tolsero i titoli a Bie e Wieslander, i secondi classificati che erano stati dichiarati vincitori del pentathlon e del decathlon dopo la squalifica di Thorpe, ma semplicemente lo dichiararono co-campione olimpico assieme agli altri due, anche se questi avevano sempre riconosciuto Thorpe come il vero vincitore sul campo. Le medaglie vennero riconsegnate ai figli di Thorpe in una cerimonia commemorativa il 18 gennaio 1983. Non erano le medaglie originali, perché quelle erano finite tempo prima in un museo, da cui erano poi state rubate e mai più ritrovate. Nel 1998, gli Stati Uniti dedicarono a Thorpe un francobollo commemorativo da 32 cents, e nel 2018 la moneta oggetto di questo post. Disegnata e incisa da Michael Gaudioso, raffigura l'atleta con in primo piano gli elementi che mettono in risalto i suoi successi olimpici e nel football. Sulla moneta sono riportati entrambi i suoi nomi, quello, più conosciuto di Jim Thorpe, e quello Nativo di Wa-Tho-Huk. Tiratura di 1.400.000 esemplari per Philadelphia e Denver, e 849.374 per la zecca di San Francisco, petronius2 punti
-
Leverei tranquillamente il forse. La cosiddetta "alta polarizzazione" delle opinioni è uno dei maggiori obiettivi che si tenta di raggiungere nella PsyWarfare/IW (guerra psicologica e dell'informazione) moderna, il cui obiettivo principale è di cercare di seminare più confusione possibile nel campo avversario, sia cercando di modificare a proprio favore ed interesse la percezione delle cose (la cosiddetta "infromation awareness", consapevolezza dell'informazione) sia nel cercare di tenere più divisa e litigiosa possibile l'opinione pubblica avversaria. Il classico "seminar zizzania" che c'è sempre stato, ma grazie a Internet e a tecniche sempre più moderne oggi avviene in modo sempre più massiccio ed efficace. E' una grossa minaccia ancora decisamente sottovalutata.2 punti
-
2 punti
-
2 punti
-
2 punti
-
Naturalmente le impostazioni e i criteri seguiti in ogni tipo di collezionismo sono del tutto personali e anche la bibliofilia non fa eccezioni, nel mio caso, pur essendo sensibile ai pregi materiali ed estetici di una bella edizione, seguo un criterio che privilegi il valore scientifico del contenuto, vale a dire che tra un volume antico, uno bello editorialmente e uno moderno in semplice brossura ma con un contenuto di rilevanza scientifica superiore ai primi due esempi sceglierò quest' ultimo, la semplice antichità di un volume non è un elemento per me dirimente, le opere antiche o originali a cui sono interessato devono possedere il carattere di perdurante valore o utilità scientifica o essere stati comunque dei riferimenti centrali nella bibliografia sul tema, per fare degli esempi il Corpus fa parte di quelle opere che vorrei possedere anche in originale per il suo carattere di opera fondamentale negli studi di numismatica italiana. Riguardo alle biblioteche dei grandi numismatici non credo che questi disdegnino ristampe o fotocopie, in futuro abbonderanno anche le biblioteche digitali fatte di PDF, anch'io ne sto creando una specializzata in determinati ambiti e trovo il digitale di estrema praticità e utilità nella ricerca scientifica, i numismatici sono in primo luogo studiosi e le loro biblioteche hanno fini scientifici.2 punti
-
2 punti
-
La 826 non so che collezione sia. La 843 era una buona parte della collezione Curti. La 700 aveva una collezione di oselle e una di zecchini, credo nessuna delle due appartenente a Curti. Arka Diligite iustitiam2 punti
-
2 punti
-
Questo è solo superficialmente un “fuori tema”. Il giugno scorso ho partecipato a Milano a un convegno sull’arbitrato. Erano tutti cattedratici di fama. Certo non si prendevano a male parole,ma menavano come fabbri. Ricordo uno dei maggiori processualcivilisti italiani indirizzarsi al curatore di in trattato (in fieri) di 15 tomi con queste parole: “spero ardentemente che possa essere portato a compimento”. Le letture del commento erano due: 1) non ce la fai; 2) muori prima. La domanda è questa: ma cosa ci sta capitando ? Perche’ il dissenso non si può esprimere con quello che dalle parti mie si chiama “gentile fermezza” .2 punti
-
Premetto che non sono un grande esperto del volto di Claudio, ma a me sembra molto fuori stile dalla mascella, al collo, al pomo d'adamo, alla guancia, all'occhio. Mi sbagliero' ma proprio non mi piace. saluti maumo2 punti
-
Buongiorno, da collezionista di libri (prevalentemente antichi), oltre che di monete, condivido in parte ciò che scrive fedafa. Come collezionista di libri non posso accontentarmi di una copia, di una ristampa o di una edizione dozzinale ma sono sempre alla ricerca dell'originale (naturalmente compatibilmente con le mie finanze, proprio come accade quando decido di acquisire una nuova moneta). Questo non significa che se tra i miei libri vi sono alcune cinquecentine mi astenga dal consultarle, dal leggerle integralmente o parzialmente, dallo sfogliarle periodicamente, dal sentire l'odore delle pagine (o la "puzza", per come la vede mia moglie). Lo faccio con tutti gli accorgimenti del caso. Proprio come faccio per le monete (che mai mi sognerei di chiudere in quelle algide bustine periziate con sigilli, ma sono gusti). Chi acquista un libro (antico o moderno che sia) per lasciarlo depositato su uno scaffale a raccogliere polvere per paura di sciuparlo (ignorando che così facendo il danno sarà maggiore di quello che potrebbe recare un contatto "umano") non è il collezionista ma l'arredatore. E' vero, ci sono alcune edizioni originali che, per la loro estrema delicatezza (parliamo sempre di carta), si prestano poco al contatto: in questo caso una copia per uso studio diventa indispensabile come l'originale (ma non collezionabile, almeno per me). Saluti.2 punti
-
Se si collezionano libri è ovvio che si cerca l'originale. Se si collezionano monete (o le si studiano) ci si "accontenta" anche di una copia anastatica. Non esiste il giusto o sbagliato in questo caso. Ognuno segue la sua regola o passione. Io personalmente non spenderei mai 500 € per un testo se posso averne la copia anastatica a 20. Perchè a me quel libro serve aprirlo, leggerlo, studiarlo (qualcuno si accontenta anche solo di sfogliarlo) e domani tornare a riprenderlo, riaprirlo e rileggerlo di nuovo. Tutti passaggi che su un testo originale fanno venire i brividi ma i libri sono nati per questo. Nonostante tutto qualche testo originale lo possiedo e non nego che molti di loro sono pieni di sottolineature, appunti e note a margine. Sono i miei preferiti perchè significa che chi li ha avuti prima di me li ha usati e non messi su uno scaffale a raccogliere la polvere. A mio avviso è solo una questione di gusti e di esigenze e per fortuna ognuno è ancora libero di scegliere. Mia opinione ovviamente e, pur non condividendo alcuni paragoni letti, massimo rispetto per le opinioni altrui.2 punti
-
Ciao! Ecco il mio 40 Soldi (o 2 Lire) - gr 8,90 La particolarità di questo pezzo, già mostrato tempo addietro e che qualcuno ha definito "imbarazzante", è che mostra chiaramente il segno nel conio usato per puntare il compasso che è servito a tracciare la rotondità della moneta ed il cerchio di perline al rovescio; questo ha determinato la presenza di un attributo improprio alla povera Giustina. Il Massaro (BP) è Benetto Pisani, che assunse la carica circa due anni dopo lo Stae Duodo e possiamo vedere, rispetto all'esemplare precedente, delle differenze nei conii; ad esempio: Al diritto vediamo subito che alla dogalina del Doge mancano i 3 bottoni; la figura di san Marco è leggermente spostata verso sinistra, tanto che la manica della tunica del suo braccio destro, svolazza oltre il cerchio di perline e questo comporta che anche il leone, accucciato al suo fianco, risulti un po' più esterno alla stessa. Sono anche sparite le stelline che delimitano le iniziali del Massaro ed al loro posto sono stati messi dei puntini. Compare poi un basamento al trono, sul quale poggiano i piedi del santo assiso, ben distaccato dalla linea dell'esergo; nel pezzo precedente manca o - forse - i due tratti sono sovrapposti. Al rovescio, tra le parole TVI e IVSTINA, proprio sopra il capo della santa, prende posto una grande stellina a sei punte, assente nel pezzo precedente. saluti luciano2 punti
-
Chiaramente ognuno ha le sue idee. Io fui molto addolorato quando la Forni chiuse i battenti. Ho molte loro ristampe anastatiche di opere che ormai non avrei mai trovato in originale, se non a prezzi proibitivi che traghetterebbero la bibliofilia nella bibliomania.2 punti
-
2 punti
-
Mi chiedo quanti di questi "non greggisti" avrebbero la possibilità di scrivere se ci fosse un regime. Parole sante quelle di Galimberti......2 punti
-
Medaglia devozionale, bronzo/ottone, con appendici globulari o pomellate, del XVII sec. (primo quarto) , probabile produzione romana.- D/ Madonna d'Itria, sorretta da due monaci calogeriani. Molto venerata nel Santuario di Cirò Marina (Catanzaro). R/ S. Giacinto di Polonia in abiti domenicani, in ginocchio, guarda in alto verso la statuetta della Madonna da cui scende una banderuola con scritta, a dx stemmino araldico? E patrono della Lituania, canonizzato da papa Clemente VIII nel 1594. Non comune.- Ciao Borgho2 punti
-
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_festa_liberazione_2020.pdf Non mi soffermo sul merito: il Viminale, d’intesa con Palazzo Chigi, ritiene che, nonostante l’emergenza, siano consentite le celebrazioni dell’anniversario, e che a esse prendano parte anche le Associazioni partigiane e combattentistiche, col doveroso rispetto delle regole del distanziamento. La Presidenza del Consiglio peraltro, con un comunicato sempre del 22 aprile, rispondendo all’ANPI-ass.partigiani d’Italia, ha voluto rimarcare che dalle cerimonie l’Associazione non è in alcun modo esclusa. Non mi soffermo sul merito, pur se vi sarebbe da osservare che ai cattolici italiani è stata preclusa pochi giorni fa qualsiasi memoria pubblica della loro festa più importante, la Pasqua, senza tentare di conciliare la partecipazione alla Messa col possibile rispetto delle regole di distanziamento e di igiene (per non dire delle celebrazioni interrotte dalle forze di polizia). E che non solo ai cattolici ma a tutti gli italiani è preclusa da due mesi, a norma di decreto legge e di dPCM, di assistere alla cerimonia cui ogni civiltà collega il commiato con un proprio caro: per un funerale non sono permesse neanche dieci persone in una chiesa che ne contenga trecento. È vietato e non si discute! Mi soffermo su due aspetti non di merito, ma non per questo non marginali del provvedimento. Il primo. Una circolare di un Ufficio di Gabinetto deroga a due chiarissime norme a essa sovraordinate, che prescrivono il contrario. L’art. 1 comma 2 lett. h) del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 include espressamente fra le misure di contenimento la “sospensione delle cerimonie civili e religiose”. In attuazione di tale disposizione l’art. 1 comma 1 lett. i) ultimo periodo del dPCM 10 aprile 2020 conferma che “sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”. La parola chiave è “cerimonie”; non vi è eccezione fra “civili” o “religiose”: sono tutte inderogabilmente “sospese”, al punto che – come è accaduto – se un prete celebra la Messa davanti a 13 persone distanziate metri l’una l’altra intervengono i Carabinieri. La medesima parola chiave “cerimonia” compare nella circolare del Viminale: “si potranno (…) ritenere consentite forme di celebrazione della tradizionale cerimonia di deposizione di corone ecc.”. Quelle “cerimonie”, che un atto avente forza di legge e un dPCM espressamente “sospendono”, una circolare del Gabinetto del ministro dell’Interno consente, con l’avallo della Presidenza del Consiglio. Secondo aspetto. Riprendo il passaggio appena riportato senza saltare alcun termine: “si potranno, in qualche modo, ritenere consentite forme di celebrazione della tradizionale cerimonia ecc.”. “In qualche modo”? Qual è il senso giuridico dell’espressione “in qualche modo”? Una condotta o è permessa, o è vietata, o è permessa nel rispetto di condizioni che però vanno esplicitate: “in qualche modo” pare rientrare nella terza categoria, ma qual è il “modo”? Ciascun prefetto viene delegato a far svolgere cerimonie vietate da una norma di legge, secondo modalità che – certo col necessario distanziamento – potranno variare per ognuna delle cento province d’Italia.https://www.centrostudilivatino.it/liberazione-in-qualche-modo-come-una-circolare-del-viminale-sul-25-aprile-libera-dal-diritto/ https://live.sloode.com/Video/rete7/49a71a1e-bd36-4d5d-b04d-46b6402bae3e_16_9.mp4 L’inerzia del carabinieri di ieri stride terribilmente con l’arroganza del militare che sale sull’altare per impedire a don Lino Viola di celebrare Messa. È evidente che il problema non sono i carabinieri, ma gli ordini di scuderia che essi hanno ricevuto ed è evidente che la tolleranza rispetto all’inosservanza della legge è stata decisa per via politica. L’effetto è sgradevole: nel giorno della libertà si certifica che c’è qualcuno più libero di altri. Conte, Zingaretti, Renzi, Di Maio… c’è qualcuno che dopo aver finito la spaghettata antifascista ha voglia di dirci qualcosa? https://lanuovabq.it/it/loro-in-piazza-noi-a-casa-senza-liberta-prove-di-regime Nel giorno della libertà si certifica che c’è qualcuno più libero di altri.Cruda verità2 punti
-
«Decidemmo (Minucio,Ottavio,Cecilio) di recarci a Ostia, piacevolissima città, affinché i bagni di mare fungessero da blanda cura adatta a prosciugare gli umori del mio corpo… In quel momento infatti, superato il solstizio d'estate, l'autunno volgeva ad un clima più temperato. All’alba dunque ci dirigemmo al mare per passeggiate su e giù sulla spiaggia, affinché l’aria, spirando dolcemente, vivificasse le nostre membra, e per provare il grande piacere di sentire la sabbia cedere mollemente sotto i nostri passi... Attraversato ormai lo spazio interno della Città ci trovammo sul libero lido. Lá un’onda leggera si distendeva bagnando l’estremo lembo sabbioso della spiaggia, e quasi livellandolo per la nostra passeggiata. Così, camminando lentamente e tranquillamente, costeggiavamo il litorale appena incurvato, ingannando la via con racconti... Ma una volta consumato uno spazio di cammino bastante al nostro discorso, volti indietro i passi ripercorremmo la stessa strada: e giunti dove alcune piccole imbarcazioni, tratte in secca, riposavano poggiate su travi di quercia perché il contatto con la sabbia umida non le rovinasse, vedemmo dei bambini che, gesticolando, facevano a gara nel gioco del lancio dei cocci in mare». A questo punto Cecilio propone: «Ora sediamoci su questi frangiflutti di pietre costruiti per proteggere le terme e protesi in profondità verso il mare: potremo così riposarci del cammino e discutere più seriamente» Alcuni cenni Leggendo il testo in apertura che io tanto amo e spesso cito (lo avevo fatto anche in un altro post su Ostia che però non trovo) molti che vivono a poco distanza dal mare potranno riconoscere come le abitudini antiche siano come quelle attuali, una passeggiata in spiaggia respirando brezza marina, affondando i piedi nella sabbia e guardando bambini giocare con l’acqua. La città costiera ha vissuto alterne fortune, anche successivamente all’apertura di Portus che ne ridimensionò l’importanza come porto relegandola a un ruolo amministrativo. Nelle sue vie risiedevano quelle gilde, corporazioni e uffici di rappresentanza che permettevano gli scambi commerciali tra le varie provincie e Roma. Ostia ha permesso uno studio diverso rispetto a Pompei, la seconda è rimasta sigillata a quell’autunno del 79 d.C. lasciando più o meno intatto tutto fino a quel fatidico momento, Ostia invece ci permette di viverne le alterne vicissitudini fino al decadimento completo. La zecca Nonostante Meiggs ritenga che Ostia abbia battuto monete a ridosso della seconda guerra punica con certezza possiamo solo affermare che la zecca è stata attiva per quasi un quinquennio tra il 308 e il 313 d.C. La zecca venne qui stabilita per coniare in un luogo lontano dai tumulti interni, lontano dagli insicuri confini e sicuramente per finanziare la campagna militare contro Domizio Alessandro. I motivi quindi appaiono svariati, l’iconografia con busti militari fu presente sin da subito proprio per la remunerazione delle truppe, la necessità di avere un luogo sicuro lontano dalla tumultuosa Roma in cui coniare moneta in metallo nobile trova riscontro nella sequenza delle emissioni dove appare evidente che inizialmente venisse coniato solo oro e argento entrambi con marchio di zecca POST, nella seconda emissione gli argentei successivamente mutano dall’iniziale POST(delta) a MOSTB, MOST(gamma) e MOST(delta), segno di zecca presente poi nelle primissime emissioni bronzee. Le maestranze ostiensi non provenivano da Cartagine come saltuariamente viene riportato, ci sono evidenti differenze sia stilistiche che produttive con la zecca africana, il personale che operò a Ostia proveniva da Roma, zecca con la quale lavorerà in stretta collaborazione pur rimanendo comunque completamente autonoma. Vienne, Kunsthistorisches Museum, Münzkabinett, 25338. Londres, The British Museum, Department of Coins and Medals, R 0137. La zecca operò in tre distinte fasi, la prima in cui conio solo aurei e argentei, la seconda in cui coniò tutti e tre i metalli e la terza più duratura in cui la produzione si attesto su moneta aurea e bronzea. L’ubicazione della zecca è ancora oggi a noi sconosciuta, probabilmente ubicata all’interno delle vecchie mura della città, sarebbe plausibile immaginarla sotto al tempio capitolino, dove il tesoro cittadino veniva conservato ma tesi comunque difficile accettare se si pensa al caos che il centro cittadino doveva generare. Le quattro officine ostiensi batterono indistintamente moneta bronzea e argentea mentre la moneta aurea venne coniata esclusivamente dalla prima officina. L’iconografia dominante nella monetazione ostiense di Massenzio, tipologia emessa per tutto il periodo, è rappresentata dai Dioscuri con legenda AETERNITAS AVG N, riferimenti alla tradizione navale della città quali protettori dei marinai e riferimento a quella propaganda messenziana che enfatizza i simboli di Roma, restituzione dei principi classici da parte dell’imperatore. La produzione monetaria di Massenzio si concentrava su due tipi principali, AETERNITAS AVG N per Ostia e CONSERV VRB SVAE per Roma. Diritto: IMP C MAXENTIVS P F AVG, busto nudo con lancia e scudo visto da dietro. Rovescio: AETE-RNITAS AVG N, I Dioscuri Castor e Polluce l’uno di fronte all’altro tengono i cavalli per briglie, all'esergo MOSTQ. RIC VI Ostia - (2 esemplari censiti) L’iconografia come accennato in precedenza è fortemente incentrata sin dall’inizio sulla campagna militare e rappresentata da busti militari e sin dal 309 d.C. appare la FIDES sui rovesci argentiferi cosa che non avviene a Roma nel medesimo periodo, coniazioni destinate al pagamento dei soldati e alla costruzione della flotta per la campagna militare. Diritto: IMP C MAXENTIVS P F AVG, testa laureata rivolta a destra. Rovescio: AETERN-I-T-AS AVG N, la Fides stante a sinistra tiene due stendardi, all'esergo MOSTS. RIC VI Ostia 43 Massenzio non abbracciò la riforma monetaria attuata da Constantino in Gallia nel 310 d.C. che porto il nummo argentifero a 1/72 di libbra romana, mantenne un peso teorico di circa 6 grammi con un modulo di circa 24mm equivalente a 1/48 di libbra romana. Altri due nominali bronzei si affiancavano alla produzione di nummi argentiferi, una moneta dal peso teorico di 3,25 grammi che potremmo definire mezzo follis e quello che viene oggi chiamato terzo di follis con peso che arrivava a quasi 2 grammi. Nel secondo periodo il mezzo follis ostiense è conosciuto con la raffigurazione di Massenzio in pelle leonina, è un nominale coniato limitatamente ed è completamente assente il modulo più piccolo. Nel terzo periodo invece il mezzo follis è piuttosto frequente, ipotizziamo un valore di 12,5 denari comuni ma qui fa la sua apparizione il terzo di follis che a sua volta è piuttosto raro. Personali conclusioni mi portano a fare due riflessioni, il circolante nel primo periodo non necessitava di nominali più piccoli, veniva largamente utilizzato il nummo argentifero e sporadicamente si aveva bisogno di moneta di taglio inferiore come il mezzo follis forse perché era ancora largamente circolante la frazione radiata diocleziana, immediatamente dopo però si è avuta la necessità di coniare un modulo più piccolo, forse per un livellamento dei prezzi al ribasso, come potrebbe essere per la documentata carestia che si ebbe nel 309 causata dalla mancanza di approvvigionamento di grano da parte dell’africa, si ha quindi necessità di circolante per quei servizi essenziali come le terme o le latrine e sulle quali sarà importante tornare più avanti. La penisola italica si presenta ancora instabile e tumultuosa, dal 310 d.C. vediamo un tentativo di Massenzio di legittimare la porpora imperiale agli occhi del popolo con delle emissioni di consacrazione dinastiche in cui vengono rappresentati i legami con il padre Massimiano, il genero Galerio e il cognato Constanzo. Diritto: DIVO MAXIMIANO PATRI MAXENTIVS AVG, testa velata rivolta a destra. Rovescio: AETERNA MEMORIA , un'aquila rivolta a destra sulla cupola del tempio esastilo, porta destra aperta, all'esergo MOSTT. RIC VI Ostia 25 Dopo la morte di Massenzio la zecca continuò a operare sotto Costantino per ancora qualche mese coniando moneta aurea e bronzea a 1/72 di libbra romana quindi adeguandosi alla riforma monetaria costantiniana attuata nel 310 d.C. I nummi argentiferi vengono coniati per i tre augusti, Costantino, Licinio e Massimino, rappresentati con busti Laureati e corazzati, laureati drappeggiati e corazzati e laureti drappeggiati e corazzati visti da dietro. Il RIC riporta anche un quarto busto laureato e drappeggiato accoppiato al rovescio GENIO POP ROM presente nell’ANS ma del quale non si trova traccia. C’è pero un quinto busto (o quarto se non si considera quello ANS) laureato e corazzato visto da tre quarti che ho iniziato a catalogare differentemente nonostante i testi non riportino tale variante, ha una rappresentazione stilistica differente sia nella ritrattistica sia appunto per il busto leggermente spostato. Sulla sinistra dell'immagine seguente sono riportati i busti canonici più comuni, sulla destra la variante. I rovesci coniati sono principalmente GENIO POP ROM, SOLI INVICTO COMITI e S P Q R OPTIMO PRINCIPI quest’ultimo tipo forse per riconoscenza verso Domizio Alessandro con il quale Costantino aveva stretto un’alleanza contro Massenzio qualche anno prima. Queste tre coniazioni sono piuttosto abbondanti e presentano alcune varianti stilistiche. La chiusura della zecca avvenne nel 313 d.C. con la necessità di Costantino di decentralizzare la produzione e di onorare il supporto della provincia Gallica aprendo nella città una nuova zecca. Arles celebra l’avvenimento con due belle monete in cui viene rappresentata la partenza e l’arrivo della moneta in città. E’ importante sottolineare come si possa notare che venga rappresentata Roma che lascia partire la moneta, questo sottolinea la visione dell’amministrazione costantiniana che vedeva nella zecca di Ostia una succursale di quella di Roma, proprio contrariamente a quanto aveva fatto Massenzio. Arles quindi batte moneta stilisticamente di scuola italiana, le maestranze ostiensi infatti raggiunsero in parte Arles e in parte Roma mentre il maestro di zecca continuò a lavorare a Ticinum. Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des monnaies, médailles et antiques, acq. 1985/380. Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des monnaies, médailles et antiques, acq. 2005/211. Ma cosa circolava, come si viveva, come si spendeva e risparmiava a Ostia? Lo vedremo più avanti.2 punti
-
1 punto
-
Dalle Americhe passiamo all'Oceania e precisamente alla Nuova Zelanda a trattare dei Moriori ( e non Maori come fra poco scoprirete. " Il genocidio dei Moriori, episodio imbarazzante per la cultura “politically correct” Di Francesco Lamendola Il 19 novembre del 1835, a bordo del brigantino europeo «Lord Rodney», un gruppo di circa 500 Maori provenienti dalla regione di Taranaki (nella zona occidentale dell’Isola del Nord), sbarcarono sulle Isole Chatham (o Warekauri: dieci isole, delle quali solo le due maggiori abitate, Chatham e Pitt, per una superficie totale di poco meno di 1.000 kmq), abitate dai pacifici Moriori, situate a circa 800 km. a Est della Nuova Zelanda, armati di scure e, soprattutto, di fucili. Fu, quello, l’inizio di una pagina tremenda, e pochissimo conosciuta in Occidente, nella storia dell’arcipelago: da quell’impatto, anzi, da quella invasione, ebbe inizio lo sterminio del popolo moriori, che si sarebbe concluso con l’estinzione totale, nel 1933, allorché avvenne la morte dell’ultimo indigeno di sangue puro. Una seconda nave carica di Maori, circa 400 persone, sopraggiunse un paio di settimane dopo, e gettò l’ancora il 5 dicembre, rafforzando ulteriormente i nuovi arrivati. Adesso gli invasori erano abbastanza numerosi da abbandonare ogni ritegno e da procedere senz’altro all’asservimento o alla eliminazione sistematica di quegli isolani, la cui vita, ai loro occhi, non valeva nulla, poiché essi conoscevano solo la legge del più forte ed erano abituati alla guerra e al cannibalismo, come condizioni pressoché normali della loro esistenza. In quel momento, gli Europei non avevano ancora conquistato la Nuova Zelanda – il trattato di Waitangi, che vide l’inizio del dominio inglese, sarebbe stato firmato solo cinque anni più tardi, il 6 febbraio 1840 – e non pochi essi avevano già sperimentato la crudele bellicosità dei guerrieri maori. Si ricordano, in particolare, parecchi uomini dello scopritore dell’arcipelago neozelandese, l’olandese Abel Tasman, nel 1642, e il navigatore francese Marion Du Fresne con alcuni dei suoi marinai, approdati nel 1772: erano stati tutti uccisi a tradimento e mangiati. I Britannici, in seguito, per poter attuare concretamente il loro protettorato, dovettero sostenere due dure campagne militari contro i Maori, nel 1842-46 e nel 1865-72; nel corso della seconda trovò la morte anche un notevole personaggio venuto dall’Europa, Gustavus von Tempsky (1828-1868), strana figura di avventuriero, artista (per la precisione, acquarellista), giornalista e scrittore prussiano, originario dalla lontanissima Masuria e unitosi alle truppe inglesi nelle operazioni belliche (cfr. il nostro saggio: «La guerra antimissionaria e antibritannica dei Maori della Nuova Zelanda (1865-72)», pubblicato sul sito di Arianna Editrice in data 14/01/2009). I Maori presero possesso delle isole Chatham secondo le loro consuetudini di guerra: considerando come loro assoluta proprietà sia la terra che i suoi abitanti. I Moriori, miti e pressoché indifesi, non tentarono nemmeno di opporre una resistenza organizzata; nondimeno, davanti alle usurpazioni delle loro terre e al rapimento delle loro donne, alcuni di essi accennarono una reazione. La risposta degli invasori fu immediata e consistette nell’uccisione di centinaia di uomini, donne e bambini, i cui cadaveri vennero immediatamente squartati, cucinati e consumati nel corso di grandi banchetti cannibaleschi. Molti Moriori, terrorizzati, fuggirono nella foresta e cercarono scampo nelle grotte, ma fu tutto inutile: vennero immediatamente squartati, cucinati e consumati nel corso di grandi banchetti cannibaleschi. Molti Moriori, terrorizzati, fuggirono nella foresta e cercarono scampo nelle grotte, ma fu tutto inutile: vennero inseguiti, braccati come animali, rintracciati e uccisi, senza distinzione di sesso o di età. Solo le donne in età di partorire vennero risparmiate e divennero le schiave dei nuovi padroni, che le misero incinte per ripopolare l’arcipelago. Si calcola che, alla fine del XVIII secolo, la popolazione moriori assommasse a circa 2.000 unità; nel 1862, i sopravvissuti erano esattamente 101. Solo individui di sangue misto, figli degli invasori e delle donne isolane, esistono ancora oggi, sia sulle Chatham che in Nuova Zelanda. Scrivono Peter Turner e gli altri autori dell’esauriente volume «Nuova Zelanda» (titolo originale: «New Zealand», Victoria, Australia, Lonely Planet Publications, 1998; traduzione dall’inglese di Rosanna Ammendolia, Torino, E. D. T., 1999, p. 746): «Uno degli aspetti più affascinanti delle Chatham è il retaggio culturale lasciato dai Moriori. Sulle isole vivono ancora i discendenti di questo gruppo e si trovano e tracce della loro cultura un tempo fiorente. Molte discussioni sono state fatte in merito alla loro provenienza. Oggi, si tende ad accreditare l’ipotesi che fossero polinesiani, come i Maori, giunti alle Chatham navigando dalla Nuova Zelanda. La data del loro arrivo, tuttavia, è incerta a causa della scarsità di reperti archeologici, anche se si ritiene che si possa stabilire tra il 900 e il 1.500 d. C. Una volta raggiunto l’arcipelago, essi iniziarono a sviluppare un’identità separata da quella dei Maori della terraferma. Non mantennero rigide divisioni di classe, posero fine al guerreggiare, preferirono lasciare che le parti in causa risolvessero le dispute con lotte corpo a corpo, e il loro linguaggio iniziò a differenziarsi leggermente. Il loro lascito più degno di nota, sono i simboli incisi sugli alberi (“dendroglyphs”) e sulle rocce che orlano la The Whanga Lagoon (“petroglyphs”). Quando il vascello “Chatham” giunse all’isola nel 1791 si pensò che i Moriori presenti sull’arcipelago fossero circa 2.000. Dal novembre del 1835 circa, gruppi di Maori iniziarono ad approdare alle Chatham e in breve tempo vi furono 900 nuovi residenti tra Ngati Tama e Ngati Mutinga di Taranaki Ati Awa. I Maori cominciarono ad appropriarsi della terra in un processo noto come “takahi”. I Moriori che opposero resistenza, circa 300, furono uccisi e gli altri ridotti in schiavitù. Nel 1841, si calcolò che il numero dei Moriori fosse sceso a 160 e quello dei Maori salito a oltre 400 e fu solo due anni più tardi che i Maori rilasciarono l’ultimo degli schiavi Moriori. Nel 1870, le native Land Court Hearing riconobbero ai Maori la sovranità sul 97% delle isole e piccole riserve furono create per i 90 Moriori sopravvissuti. Nel tempo i matrimoni tra i due gruppi portarono lentamente alla scomparsa della peculiare identità moriori. La loro lingua morì nel 1900 con l’ultimo degli studiosi moriori, Hirawanu Tapu. All’epoca erano solo 12 i Moriori di razza pura rimasti. L’ultimo fu Tommy Solomon, che si spense nel 1933. La sua morte fu vista come la fine di una razza particolare, ma era ben lontana dall’esserlo. I suoi tre figli e le due figlie sono ritenuti Moriori puri e c’erano molte famiglie che rivendicavano un lignaggio moriori. Oggi si ritiene che vi siano più di 300 discendenti di questo gruppo e c’è stata una rinascita della coscienza moriori, in particolare dopo la costruzione del monumento a Solomon presso il Manukau Point, vicino a Owenga, nella parte sud-orientale del’isola. Adesso, Moriori, Maori e Pakeha vivono fianco a fianco come isolani.» Sebbene questo brano di prosa tradisca una certa tendenza, tipica della cultura contemporanea politically correct, a minimizzare in vario modo l’atrocità di quella pagina di storia, per la sola ragione che essa è stata scritta in caratteri di sangue non dai soliti bianchi malvagi, venuti per portare sfruttamento e rapina, ma da indigeni extra-europei a danno di altri indigeni, più deboli di loro e praticamente indifesi, resta il fatto eloquente che, sulle isole Chatham, ebbe luogo uno sterminio irreparabile, dal quale il piccolo popolo dei Moriori non si riprese mai più. La tendenza di cui sopra testimonia la tenace persistenza del mito del “buon selvaggio” e non si arrende neppure davanti all’evidenza; oggi, un suo tipico rappresentante è il biologo statunitense Jared Diamond, col suo libro di successo «Guns, Germs and Steel: the Fate of Human Siocietes» («Armi, acciaio e malattie», apparso nel 1997 e vincitire del Premio Pulitzer l’anno dopo, del quale ci siamo occupati in un articolo di otto anni fa (cfr. «L’equivoco di fondo dei volonterosi antropologi anti-razzisti», pubblicato sul sito di Arianna Editrice in data 12/11/2007). In effetti, ci sembra che sia molto fuorviante sia evitare la parola “genocidio” e tentar di limitare le cifre dei Moriroi uccisi e cannibalizzati, mediante una avara contabilità al ribasso, sia, soprattutto, suggerire che vi sia stata una sorta di “rinascita” della cultura moriori, perché quel popolo si è definitivamente estinto: il semi-trionfalismo con cui si dice che alcuni indigeni puri erano ancor vivi dopo il 1933 ci appare del tutto fuori luogo. Ancor più sconcertante è il fatto che la pubblicazione del libro dello studioso Michael King, «Moriori: a People Rediscovered» («Moriori: un popolo riscoperto»; Viking Press, 2000; ma l’edizione originale è del 1989) sia stata salutata con un evidente di respiro di sollievo da parte della cultura “indigenista”. Infatti, ai primi del 2000 il salotto buono della cultura neozelandese – e, di riflesso, britannica, quindi mondiale – era stato turbato da una ipotesi politicamente scorrettissima: che i Moriori fossero di origine melanesiana, ossia che fossero di pelle scura e statura relativamente bassa, il che – orrore degli orrori – avrebbe fatto dei Maori, che sono polinesiani di pelle chiara e di statura piuttosto alta, degli sterminatori di tipo razzista, simili, nelle motivazioni “ideologiche”, ai teorici nazisti della “soluzione finale”. In altre parole: la cosa realmente grave, anzi, se vera, addirittura inconcepibile, non era che i Maori avessero sterminato e schiavizzato i Moriori, per poi mangiarseli, ma che lo avessero fatto per abiette ragioni di superiorità razziale. Un fremito di sdegno e di angoscia percorse tutti i disorientati nipotini delle teorie di Rousseau e compagni sul “buon selvaggio”: dunque anche nelle meravigliose isole del Pacifico, prima e indipendentemente dall’arrivo dei bianchi, esisteva il cattivo seme del razzismo? Non era, essa, una scoperta e una peculiarità esclusiva degli uomini bianchi? Certo, si poteva ben evidenziare che fu per mezzo di velieri europei che ebbe luogo l’invasione delle Chatham; e, più ancora, che i Maori erano armati di fucili europei, tanto che l’intera faccenda si può considerare come un episodio particolare delle cosiddette “guerre del moschetto”, espressione con cui gli storici neozelandesi odierni indicano le selvagge guerre tribali che si riaccesero fra i Maori della Nuova Zelanda fra il 1807 e il 1845, ossia dopo che vi furono sbarcati i primi bianchi, e che questi ultimi vi ebbero introdotto, per ragioni di commercio, le prime armi da fuoco. Tuttavia, non è chi non veda come questi argomenti potevano “discolpare” solo parzialmente i Maori; senza contare la loro palese pretestuosità. Sarebbe come sostenere che Irochesi ed Huroni del Canada si massacrarono a vicenda a causa delle armi importate dai commercianti inglesi e francesi nell’America Settentrionale: quasi che, prima dell’arrivo dei bianchi, le relazioni fra quei due popoli fossero state di natura idillica. Le tribù neozelandesi erano dedite alla guerra e al cannibalismo da sempre, tanto è vero che si diedero a uccidere e cannibalizzare i primi Europei che sbarcarono sulle loro coste, prima ancora d’aver subito da essi il benché minimo torto: nel caso del povero Marion Du Fresne, al contrario, non ricevettero che cortesie e prove di amicizia e di fiducia (quei disgraziati Francesi, provenienti dalla patria di Voltaire e di Rousseau, con l’inchiostro della «Encyclopèdie» ancora fresco, si presentarono in Nuova Zelanda animati dalle migliori intenzioni e si comportarono in maniera addirittura ingenua, offrendo ai loro perfidi ospiti l’opportunità di preparare con tutta calma il tradimento e il massacro ai propri danni). La dimostrazione che i Moriori erano, anch’essi, di origine polinesiana, anzi, che erano discendenti degli stessi Maori, i quali, verso il 1500, avevano lasciato la Nuova Zelanda per popolare le Isole Chatham, permetteva a tutti i terzomondisti, agli indigenisti e ai buonisti d’ogni specie e tendenza, purché odiatori della civiltà europea, di esorcizzare il terribile spettro di un “razzismo” indigeno e di ristabilire la prospettiva del politicamente corretto. L’esclusiva del razzismo genocida rimaneva tutta agli Europei; quanto allo sterminio dei Moriori, non si era trattato di una guerra di sterminio condotta da indigeni alti e con la pelle chiara ai danni di indigeni bassi e con la pelle scura, ma, a ben guardare, di una faccenda tutta interna ai Maori: un regolamento di conti inter-tribale. Avranno o non avranno il diritto di ammazzarsi e divorarsi fra di loro, i popoli extra-europei, senza che vengano sempre gli uomini bianchi a ficcare il naso e a far loro la morale? Un po’ come nel caso dei sacrifici umani di massa in uso fra gli Aztechi del Messico: sì, è vero, migliaia e migliaia di cuori venivano offerti dai sacerdoti del dio Huitzilopochtli, al punto che quel popolo era sempre in guerra coi vicini appunto per procurarsi le vittime necessarie alla bisogna; ma gli Spagnoli non avevano alcun diritto di criticarli, visti i misfatti di cui si macchiarono a loro volta. Sarà, ma questo genere di ragionamenti non ci convince. Troviamo, anzi, assai triste che la pelle chiara e l’alta statura dei Moriori diventino “attenuanti” del loro genocidio. Senza voler assolvere i bianchi dalle loro colpe storiche, resta il fatto che essi non possiedono l’esclusiva della malvagità..." http://www.accademianuovaitalia.it/index.php/storia-e-identita/storia-dei-genocidi/3423-il-genocidio-dei-moriori1 punto
-
Buonasera La moneta non mi sembra un testa grossa,propendo per un falso. Se ci fossero foto fuori perizia sarebbe meglio. Marco1 punto
-
A nome della Contea di Gorizia Massimiliano fece battere nella zecca di St. Veit dei mezzi batzen. Sul dritto è rappresentato lo stemma di Carinzia e sul rovescio lo stemma di Gorizia sormontato da elmo con cimiero. Su questa emissione c'è anche la data ed è 1519. Il peso è di circa 2 grammi e il diametro di 22 millimetri (rif.: Passera 97; MIR Triveneto 142). Arka Diligite iustitiam1 punto
-
Ed ecco il vierer sempre di Massimiliano I. Sul dritto è rappresentato lo scudo fasciato d'Austria e sul rovescio lo stemma di Gorizia. Questa scelta è dovuta al fatto che l'autorità emittente più importante è l'Arciduca d'Austria che è anche Conte di Gorizia. Il peso si aggira intorno a 0,45 grammi e misura 15 millimatri (rif.: Passera 78; MIR Triveneto 139). Arka Diligite iustitiam1 punto
-
La bibliomania come dice il vocabolario è patologica, compulsiva, e non si misura nella quantità di denaro che uno spende. A parte il fatto che tutte le forme di collezionismo hanno alla base una minima forma di compulsione, io non mi sento un bibliomane, perche so che tutto dipende da quanto spendo e da "come". L'importante è non andare oltre le proprie possibilità, come per le monete... Per me avere un'edizione originale in biblioteca è un piacere inpagabile, le ristampe le lascio con piacere a chi non si può permettere gli originali1 punto
-
Decisamente hai fatto un po' di confusione. Come ti è stato detto, la moneta che hai postato è del 1996 e non ha particolari varianti. Mentre la data che hai indicato ha - sempre come ti è già stato illustrato - una varianza nelle firme dell'incisore Laura Cretara. La moneta che ha una varietà di teste al D/ è quella del 1991 e, qui sotto, ti posto quelle che possiedo (se noti, sembra che il conio si sia "dilatato", basta guardare la legenda fra testa grande e quella piccola):1 punto
-
Iraq, 4 fils 1933-1352. al dritto : Faisal I° Re dell'Iraq Al rovesco: Regno dell'Iraq, 4 fils1 punto
-
Per il piacere tuo e di chi seguirà questa discussione, ti posto il mio miglior esemplare e una visione d'insieme della mia raccolta: :-)1 punto
-
Non trovo granchè in merito, solo accenni su testi datati... Ciao Illyricum1 punto
-
SICILIA - Panormos - Quadrante - Testa velata di Demetra a s. - R/ Cornucopia -1 punto
-
Fagiolino lungi da me cancellare il tuo intervento. Però capisci bene che dare delle pecore a chi non la pensa come te è semplicemente offensivo. Dato che non sei capace di discutere serenamente di questo periodo storico mi sembra il caso che tu lasci questa discussione.1 punto
-
Non lo trovi online. E' un volume edito dall'Istituto Italiano di Numismatica, Annali 29 del 1982 http://www.istitutoitalianonumismatica.it/pubblicazioni.asp Allego l'indice. Per chi fosse interessato ricordo che fino al 15 maggio c'è uno sconto del 50% (in questo caso) o del 30% al prezzo di listino.1 punto
-
10. La monetazione di Vyner Brooke. Come abbiamo anticipato, Vyner Brooke, salì al trono nel 1917, in piena Prima Guerra Mondiale. Durante il conflitto va ricordato anche che egli si arruolò, in incognito, nella marina britannica per proseguire la tradizione iniziata con James Brooke. Premetto con il dirvi che, le monete di Vyner sono le più comuni e facilmente reperibili sul mercato, anche se non mancano di certo le date rare, pertanto, i tondelli emessi sotto questo Rajah, costituiscono sicuramente la via più semplice per iniziare a collezionare le monete di Sarawak. Le prime monete con la sua effigie furono coniate a partire dal 1920. Come avvenuto anche nel Regno Unito, vista la scarsezza di metallo prezioso alla fine della Prima Guerra Mondiale, venne diminuito il titolo di argento nella monetazione. Molto presto i tagli da 5 e 10 cents furono sostituiti da analoghi esemplari in rame-nickel e soltanto i 20 ed i 50 cents rimasero in argento, ma furono ridotti peso e diametro, inoltre venne diminuito considerevolmente anche il titolo passando ad una lega in argento '400 (argento '500 solo per i 50 cents). Inizialmente anche la moneta da 1 cent, fortemente rimpicciolita rispetto al passato, fu coniata in rame-nickel, tuttavia, in seguito, si tornarono ad emettere centesimi in rame che riprendevano, fedelmente, l'iconografia delle monete emesse dai precedenti Rajah. Come abbiamo già raccontato all'inizio di questa narrazione, dopo lo scoppio della II Guerra Mondiale, nel dicembre del 1941, Sarawak fu invaso dalle forze giapponesi, mentre Vyner Brooke si trovava in visita di stato in Australia, egli pertanto rimase con la famiglia in esilio a Sidney per tutta la durata del conflitto. Oltre che sul rarissimo pezzo da 1 cent del 1941 (conosciuto in soli 50 esemplari), la guerra incise anche sul centesimo del 1942, che, secondo i registri annuali della Royal Mint, sarebbe stato coniato in 1.002.227 esemplari presso la zecca di Birmingham; tuttavia, ad oggi, nessun esemplare con tale data è mai stato rinvenuto, si pensa quindi che furono tutti fusi per il riutilizzo del metallo a scopi bellici, oppure che la tiratura vada ricompresa in quella del millesimo precedente. Con la fine dell'occupazione giapponese e l'abdicazione di Vyner, che, come abbiamo già visto cedette il suo regno alla Gran Bretagna, che lo trasformò in una colonia, si concluse la dinastia dei Brooke, che aveva regnato su Sarawak per oltre un secolo. La monetazione dei Rajah continuò ad essere utilizzata ancora per qualche tempo, soltanto a partire dal 1953, infatti, venne ritirata dalla circolazione e sostituita con le nuove monete emesse con l'effigie della regina Elisabetta II e la denominazione "Malaya and British Borneo". Siamo giunti, dunque, alla fine della nostra narrazione, anche se proseguirò ancora, nei prossimi giorni, mostrandovi qualche altro esemplare proveniente dalla mia collezione. Spero che questa storia, tanto poco conosciuta quanto ricca di fascino, vi abbia appassionato come ha fatto con me e che abbiate apprezzato la relativa monetazione. (Un esemplare del nuovo 10 cents con il ritratto della regina Elisabetta II e la denominazione Malaya and British Borneo).1 punto
-
Buonasera a tutti. Oggi voglio condividere con voi la storia di un falso venuto male. Ferdinando IV 10 Tornesi 1798 Lega di metalli bianchi Peso grammi 13,80 Questo pezzo particolare ci fa comprendere cosa poteva succedere durante la fase di colatura della lega metallica : La rottura dell' ingresso nello stampo e la conseguente massa di metallo che ne deforma il bordo del pezzo stesso. Il falso non ebbe poi la sua "rifinitura" in quanto nel togliere la massa fuoriuscita... In alcuni punti con la lima e in altri con tenaglia suppongo, si deformo' il tondello e tutto fu lasciato nello stato in cui è giunto a noi. Particolare molto significativo è il segno di giuntura degli stampi (le due facce in negativo) nel taglio. Un ringraziamento fraterno all'Amico @giovanni0770per avermelo donato.1 punto
-
Taglio: 2€ cc Nazione: Lussemburgo Anno: 2008 Descrizione: Chateau de Berg Tiratura: 1.042.000 Condizioni: BB Città: Milano Taglio: 2€ Nazione: Lussemburgo Anno: 2013 Tiratura: 3.120.000 Condizioni: BB Città: Milano Taglio: 2€ Nazione: Lussemburgo Anno: 2015 Tiratura: 4.000.000 Condizioni: BB Città: Milano1 punto
-
Native Hospitality Il tema completo del dollaro 2014 sarebbe "Native Hospitality ensured the success of the Lewis and Clark expedition" ovvero, l'ospitalità dei Nativi ha assicurato il successo della spedizione di Lewis e Clark. Come è noto, quella guidata da Meriwether Lewis e William Clark fu la prima spedizione organizzata a raggiungere, nel 1806 dopo due anni di viaggio, la costa americana del Pacifico via terra. Fortemente voluta dal presidente Jefferson dopo l'acquisto dai francesi della Louisiana, un territorio immenso, e allora quasi completamente inesplorato (in verde nella cartina). Non è del tutto vero che durante il viaggio i Nativi furono sempre ospitali, come ricordato sulla moneta, Anche se l'unico vero episodio di violenza si verificò durante il viaggio di ritorno, un tentativo di furto delle armi da parte di un gruppo di indiani Piedi Neri che comportò l'uccisione di due di essi da parte degli uomini della spedizione, non tutte le tribù incontrate durante il tragitto si mostrarono entusiaste di conoscere questi strani uomini arrivati da chissà dove: forse presagivano quel che sarebbe avvenuto poi Ma ci fu almeno una persona tra i Nativi che diede, e ricevette, sincera amicizia da Lewis e Clark. Si tratta, naturalmente, di Sacagawea, la ragazza della tribù degli Shoshoni che accompagnò per un lungo tratto la spedizione, dal Nord Dakota all'Oregon, facendo da guida e da interprete. Di lei in verità non si sa molto, oltre a quanto riportato nei diari di Meriwether Lewis, e forse proprio per questo si è guadagnata un posto importante nell'immaginario americano. Importanza consacrata, a partire dai primi anni del XX secolo, da numerose statue e targhe a lei dedicate dalle prime organizzazioni femministe, e infine, all'inizio del nuovo millennio, dalla moneta che la ritrae. Moneta che, per l'emissione del 2014, mostra al rovescio un Nativo che offre una pipa della pace (il famoso calumet), mentre sua moglie dona provviste di pesce, mais, radici e zucche. Sullo sfondo, un disegno stilizzato della bussola di Clark che evidenzia NW, nordovest. Il valore e la legenda UNITED STATES OF AMERICA nel giro, completano il tutto. Disegnata al rovescio da Chris Costello e incisa da Joseph Menna, la moneta è stata coniata in 3.080.000 esemplari per Philadelphia, 5.600.000 per Denver, e 665.100 per la zecca di San Francisco. petronius1 punto
-
Non capisco perchè quando spariscono monete dai musei si usa il termine "disperse"....... A casa mia si dice rubate..... sembra che si voglia in qualche modo minimizzare la cosa come se si dovesse parare il sedere a qualcuno. Maurizio1 punto
-
The Delaware Treaty Il dollaro del 2013 è tutto al femminile, disegnato al rovescio da Susan Gamble (al dritto, naturalmente, c'è il ritratto di Sacagawea della Goodacre) e inciso da Phebe Hemphill, e celebra il Trattato con i Delaware, il primo formale con una nazione indiana da parte del Congresso Continentale degli Stati Uniti, nel 1778. La moneta raffigura un tacchino, un lupo ululante, e una tartaruga, tutti animali-simbolo dei clan dei Delawares, con un anello di 13 stelle, rappresentanti le 13 colonie. Il disegno è completato dal valore, $ 1, e dalle iscrizioni TREATY WITH THE DELAWARES 1778 e UNITED STATES OF AMERICA. La tiratura è di 1.820.000 esemplari per le zecche di Philadelphia e Denver e di 1.192.690 per quella di San Francisco. Il 17 settembre 1778, il nuovo Congresso Continentale degli Stati Uniti inviò una commissione alla confluenza dei fiumi Monongahela e Allegheny per negoziare il primo trattato di pace con una tribù indiana, che sarebbe diventato noto come il Trattato di Fort Pitt. I negoziati a Fort Pitt si svolsero durante i primi anni della guerra d'indipendenza, dopo che molte nazioni indiane si erano alleate con gli inglesi. Gli americani cercavano la sicurezza, l'assistenza e il commercio con i Delaware. I Delaware, volevano proteggere le loro nuove terre nel Territorio dell'Ohio e rafforzare la loro posizione nella regione. Gli obiettivi delle due nazioni spiccano chiaramente nel trattato. Il primo articolo invita entrambe le parti a perdonare eventuali lamentele tra di loro. Il secondo si riferisce alla loro "pace e amicizia perpetue" da lì in avanti, e afferma che le due nazioni si aiuteranno a vicenda se una delle due dovesse essere "impegnata in una guerra giusta e necessaria con qualsiasi altra nazione o nazioni". Il terzo e più lungo articolo del trattato si riferisce alla guerra degli Stati Uniti contro l'Inghilterra. Specifica che i Delaware consentiranno alle truppe americane un passaggio sicuro attraverso le loro terre per attaccare le postazioni e i forti occidentali della Gran Bretagna, forniranno agli americani cibo e provviste, compresi i cavalli, per un ragionevole compenso, e assisteranno le forze americane "con un numero dei loro guerrieri migliori e più esperti che possono offrire, coerentemente con la propria sicurezza". Il quarto articolo chiede la risoluzione di future controversie tra le due nazioni e i loro cittadini attraverso negoziati e tribunali che rispettino le "leggi, i costumi e gli usi" di entrambi i popoli, nonché la "legge naturale". Richiede anche l'arresto e l'estradizione di "fuggitivi, servi o schiavi criminali". Il quinto articolo riconosce che l'alleanza rende impossibile per il popolo del Delaware continuare a commerciare con gli inglesi e i loro alleati e chiede l'istituzione "per quanto gli Stati Uniti possano avere in loro potere" di un commercio equo e ben regolamentato tra gli Stati Uniti e la nazione del Delaware. Nell'ultimo articolo del trattato, gli Stati Uniti riconoscono la sovranità del Delaware. La nuova nazione promette di "garantire alla suddetta nazione dei Delawares e ai loro eredi tutti i loro diritti territoriali nel modo più completo e più ampio, e di mantienere forte la catena di amicizia ora entrata in atto." L'articolo suggerisce inoltre, "se fosse favorevole all'interesse reciproco di entrambe le parti", che i Delaware "possono invitare qualsiasi altra tribù che sia amica dell'interesse degli Stati Uniti" a unirsi a una confederazione guidata dal Delaware che sarebbe diventata, con l'approvazione del Congresso, un nuovo stato con rappresentanza al Congresso degli Stati Uniti. Parole, le ultime, scritte nel vento. non è mai esistito uno stato indiano riconosciuto dal governo degli Stati Uniti. Il Trattato di Fort Pitt, fece la fine di tutti quelli successivi tra americani e indiani. Alla fine della guerra d'indipendenza, sotto la crescente pressione dei bianchi, sostenuta da nuovi trattati e leggi, i Delaware furono costretti a spostarsi sempre più a ovest, nell'Indiana, poi nel Missouri, nel Kansas e infine nell'odierno Oklahoma, dove risiede oggi la maggior parte dei discendeti della tribù, e dove ha sede l'organizzazione della Delaware Nation, che ne cura gli interessi e ne preserva la storia e le tradizioni. petronius1 punto
-
3 - James Brooke, il grande avventuriero. Riprendiamo la nostra disamina per parlare di colui che diede vita a tutto questo. Sir James Brooke nacque in India nel 1803, da genitori inglesi. Egli era di famiglia nobile, tuttavia, come spesso capita, i nobili natali non sempre coincidono con grandi ricchezze. Perciò il nostro James fu ben presto costretto a prendere la via del mare, imbarcandosi in molteplici spedizioni commerciali e militari. In seguito alla classica eredità lasciata da un lontano parente, nel 1836 egli potè acquistare una nave da guerra propria, la Royalist, che fu parte integrante delle sue successive fortune, A partire dal 1839 si trovò, quasi per caso, ad aiutare il Sultano del Brunei, nel fronteggiare una serie di gravi rivolte interne. Brooke riuscì ad avere la meglio sugli oppositori del Sultano, anche grazie alle truppe coloniali britanniche, ed in seguito, egli svolse un importante opera di repressione anche contro i pirati che infestavano le acque della Malesia. Nel 1841, come premio per i suoi servigi, il Sultano gli regalò dei territori nella regione denominata Sarawak ed il titolo di Rajah (equivalente al nostro Re). Inizialmente il territorio in dotazione era piuttosto limitato, ma ben presto l'abile avventuriero riuscì ad ampliarlo sensibilmente, spesso proprio a discapito del Sultanato del Brunei, un tempo potente ma all'epoca in forte decadenza. I legami con l'impero britannico furono sempre molto stretti, difatti nel 1846 Brooke si fece da tramite tra la Regina Vittoria ed il Sultano del Brunei per la firma di un trattato che prevedeva la cessione dell'isola di Labuan all'Inghilterra, di cui lui stesso venne poi nominato governatore. Durante il suo regno, James si diede da fare per organizzare una entità statuale sul modello occidentale e malgrado venne aspramente criticato in patria per i suoi metodi di brutale repressione contro i pirati ed i cacciatori di teste, va detto anche che, nei confronti degli indigeni di Sarawak, la sua fu una politica paternalistica e non di mero sfruttamento. Il primo Rajah bianco morì nel 1868, dopo essere sopravvissuto a diversi intrighi e tentativi di colpo di stato, da ultimo anche da parte del nipote John, inizialmente indicato come suo erede. Gli successe pertanto un altro nipote Charles, di cui avremo modo di parlare in seguito. (un ritratto giovanile di James Brooke come primo Rajah di Sarawak)1 punto
-
@@francesco77 ... certo che sono daccordo !! Avevo sottotitolato il periodo 1734-1861..perchè questa era riferita a questo periodo, per quello precedente, portato a termine su carta, c'è ne era un' altra http://www.lamoneta.it/topic/81166-maestri-di-zecca-di-prova-e-incisori/ Adesso vedi un po te come potresti agire. Ciao e buon lavoro.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?









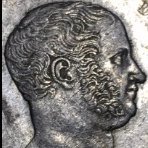






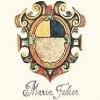
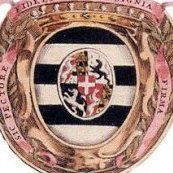
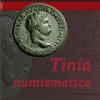


copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)