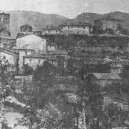Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 05/16/20 in Risposte
-
Buonasera. Voglio condividere questa mia piastra 1816 Ferdinando IV Grazie ad un amico del forum , ho scoperto che si tratta di una variante rara, per la presenza del punto (rombo) dopo REX, al dritto. Sono graditi i vostri interventi, magari anche postando il vostro esemplare.5 punti
-
Ecco un ducatone con Santa Giustina di Ludovico Manin (1789-1797). Rif.: Zub-Luciani 109.29. Arka Diligite iustitiam5 punti
-
Tornando per un momento oltremare, il mio trittico Leone da 80 soldi, mezzo da 40 e quarto da 20 per Dalmazia e Albania (manca, e temo mancherà per un bel po', il 10). Monete che hanno circolato moltissimo - e si vede - ma che conservo con affetto. Massari BC e BC2 (per il 40 soldi). rif.: Zub-Luciani 160, 165, 1714 punti
-
Buonasera e buon weekend. Di recente ho migliorato l'esemplare che avevo in collezione...è la prima volta che cambio una moneta per migliorarla con Modena ma quando l'ho vista non ho potuto dire di no. Questa è una delle poche tipologie collezionabili di questo duca, in mistura. Il dritto risulta di conio un po più stanco a mio avviso, alcune lettere della legenda sono ribattute come se ci fosse stato un doppio colpo in fase di coniazione ed il conio risulti leggermente traslato....qualche traccia di nero al bordo, ossidazione da ritrovamento in un muro di casa a mio modo di vedere. Il vero punto di forza però è il rovescio....un'aquila davvero ben impressa, completa e ben centrata ed un'argentatura completa. Cosa ne pensate? Grazie a tutti quelli che lasceranno un parere o un commento e un saluto a tutti. Marco3 punti
-
Bravo @gennydbmoney ? Vorrei anche io scrivere qualcosa a @mariarosaria Leggendo ho notato una tua sana passione per le monete che proponi, quasi tutte borboniche; bene ….. non vederle però solo come un oggetto metallico, ma sappi cogliere quello che ognuna di essa esprime, rappresenta; le monete sono la storia e questa bisogna un po' conoscerla per comprendere al meglio perchè alcune venivano coniate, quali occasioni, quali accadimenti ecc.ecc. Detto questo, ritorn al discoro della data 1859 sulle monete di Francesco II, la faccenda è ben documentata in tutti i passaggi, per quello quello che accadde, ma sommariamente riassumo, altrimenti ci perderemmo tra tante righe un po' più complesse. Preparare un conio è un’operazione che comunque richiede tempo, soprattutto, quando avveniva il passaggio dell'eredità, il sovrano che prende il posto sul trono, doveva sempre concedere una posa all'incisore per fare in modo che il suo ritratto venisse rappresentato poi sulla moneta. Ferdinando II morì improvvisamente e tutti i preparativi per rendere necessari i cambiamenti del tipo delle monete (nuove), con l’impronta di Francesco II, andarono molto per le lunghe. Nel mese di luglio del 1859 ancora si preparavano solo i modelli in cera con il nuovo ritratto che questa volta veniva rivolto verso sinistra e non verso destra. In considerazione di queste lungaggini, e accertato che per la fine dell’anno 1859 non si sarebbero riusciti ad ottenre i nuovi coni, si decise, in zecca, di continuare a preparare liberate di monete ancora con l’effige di Ferdinando II e solo il 4 febbraio del 1860 quando alcuni coni furono pronti uscirono dalla zecca monete di Francesco II, ma non in tutti i tagli previsti dal decreto. Ovviamente sulle monete anche se in ritardo, venne messa la data 1859, data che doveva coincidere con l’anno dell’assunzione al trono di Francesco. Ma questo non è tutto: tutti conosciamo gli avvenimenti dell’anno 1860, purtroppo, e il 17 settembre anche dopo il cambiamento del governo si propose di continuare a coniare moneta nella zecca di Napoli, sempre con l’effige di Francesco II, ma questa volta con la data 1860. Ma in una nota del 20 settembre diretta al responsabile della zecca veniva fatto osservare che questo non poteva eseguirsi perché Garibaldi aveva dato ordini che lo stemma dei Borbone doveva essere sostituito ovunque, nei luoghi e anche sulle monete, con lo stemma dei Savoia. In pratica non potevano uscire dalla zecca monete di Francesco II con la data 1860 e per ovviare a questo, anche queste successive liberate di monete ebbero la data impressa 1859. Questo è quanto.3 punti
-
Ed ecco anche un po' di schede di diverse ditte per test telefonici e sperimentazioni varie di tecnologie e materiali. Sono fra quelle che più mi affascinano (e, naturalmente, quasi sempre le più costose...). Le prime due ce le ho.3 punti
-
Giusta osservazione! @VALTERI riguardo ai forellini ci viene in soccorso l'antropologia, probabilmente servivano ad appenderci campanellini , strisce di stoffa, code di scoiattolo e pelli di mustelidi vari...3 punti
-
Buongiorno a tutti, colgo l'occasione per presentarvi nuovo arrivato in Collezione Litra68. È il mio primo Tornese 1 di Ferdinando II Millesimo 1858 Saluti Alberto3 punti
-
DE GREGE EPICURI Altra monetina riemersa in questo periodo di reclusione e revisione delle collezioni... Mi pare in argento basso, pesa 1,3 g. e misura 15 mm. Al D una testa verso destra, mi pare con un berrrettino o una cuffietta; capelli lunghi, non vedo lettere. Al R altra testa più piccola, sempre a destra, con capelli più lunghi. Qui si notano tracce di lettere. La moneta rientra nelle emissioni degli Himyariti, localizzati nella ARABIA FELIX, e più precisamente nell'attuale Yemen, sul Mar Rosso e di fronte alle costa somale. Queste emissioni spaziano dal 2° secolo a.C. al 2° secolo d.C., sono tutte in argento e vanno da 0,7 g. a 3,5 g. Non è facilissimo classificare con esattezza le singole monete, e questa ad es. non so bene come collocarla. Questa popolazione era molto importante per i traffici carovanieri verso Palestina e Siria e verso la foce di Eufrate/Tigri, ma anche verso le coste africane prospicienti; non fu mai sottomessa da Roma, forse perchè troppo "lontana" e perchè abitante in zone impervie.3 punti
-
Sono stato lontano dal forum per molti mesi, spero di ritornare un po' più attivo. Intanto ho trovato un piccolo pezzetto di storia che indipendentemente dal credo politico, ha portato anche alla nazione che abbiamo (con i suoi pregi e difetti). Un vicino di casa mi ha regalato il solito barattolo da 5 chili di 10 lire spiga con la scusa, a te piacciono, io non ci faccio nulla. In mezzo c'era pure questa medaglietta della CGIL, 1° Congresso Nazionale Unitario, Firenze 1-7 giugno 1947. Piccolina, circa 21 mm di diametro e 3,56 gr di peso. L'ho cercata in rete e non ne ho trovate altre, non so se è rara o se può essere richiesta dai collezionisti, però al momento è un pezzetto di storia che credo vada conservata Grazie a tutti per l'attenzione2 punti
-
Carissimi, avrei necessità di un vostro parere su questo gigliato di Roberto d'angiò. Zecca Napoli Roberto d'Angiò (1309-1343) Gigliato - Ag D/ ROBERT-DEI-GRA-IERL-ET-SICIL-REX coronato seduto frontalmente, tra due protomi di leoni con scettro gigliato e globo crucifero R/ hONOR-REGIS-IUDICIU-DILIGIT Non mi pare un falso. Forse una produzione tarda?2 punti
-
Posto un ducatello a cui tengo particolarmente pur essendo di qualità media, dovevo già presentarlo qualche tempo fa' quando Arka postò un magnifico scudo della croce sempre di Silvestro Valier poi però mi sono perso altrove... Come detto già più volte i ducatelli di alta qualità sono abbastanza ostici e difficili da reperire, ecco quindi che personalmente pur essendo costato un " tantin massa " lo comprai per la collezione. Io poi in tutta onestà non mi sento di considerarlo comune il Valier.2 punti
-
Anzitutto grazie per l'articolo che mi hai mandato. Lo leggero' stasera stessa con molto interesse. Il valore commerciale e' ben lungi dai miei propositi . Si tratta di valori affettivi trasmessi da quel grand'uomo di mio nonno, ai quali mi attengo e mi atterro' scrupolosamente.egli ,per tutta la vita ha collezionato con amore tante monete alle quali saroì legata anchio,indipendentemente dal loro valore intrinseco. Inoltre ti faccio i miei complimenti per il tuo manuale che e' riferimento sicuro per tutti i collezionisti di numismatica del Regno di Napoli !2 punti
-
Si, certo...sui mezzi di comunicazione sono pienamente daccordo... ma se all'epoca la si cercava, non la si trovava. Pura caso, io ho scritto un articolo su questo tipo di moneta....(e sono i 2 esemplari di cui ti accennavo), ti do da leggere per domani?, se ne hai tempo libero e voglia..... ma sappi che leggere è importante?, e non pensare al principio e spesso alla rarità...e al valore commerciale; la cultura ha sempre un costo maggiore !! http://www.ilportaledelsud.org/25-28 Magliocca Carlino inedito.pdf2 punti
-
si,hai ragione,nella foga ho scritto male,ma sono ovviamente tornesi. ne ho diverse. mo' ti posto due interessanti carlini di Filippo II: uno del II e l'altro del III tipo l'ho trovato gia' scritto cosi'2 punti
-
Eccola, ma non mi ero appuntato la data ma solo la variante, è un 1815 e non 1816... Chiedo scusa per il disguido...2 punti
-
Ciao @r.tino , questo dato è inoppugnabile, Tu ( possiamo darci del Tu ? ) essendo un Professionista hai la situazione "in mano", quindi prendo atto che attualmente la situazione non solo è favorevole, ma addirittura effervescente ( ho seguito giorno per giorno l'Asta Inasta che ha avuto un riscontro notevole, come tutte le ultime Aste ). Però non ti sembra che dire " la tendenza è questa " sia un'affermazione perlomeno temporanea? La tendenza si vede a medio-lungo termine e segue delle regole di psicologia di massa che possiamo solo pronosticare in base ai riscontri storici. In tempi di grave crisi, sicuramente la prima fase è quella della "negazione" alla quale segue una breve fase di "euforia". Poi arriva la realtà della situazione e le cose cambiano. Sarei contento che il mercato numismatico tenesse, non fosse altro per il fatto che le nostre collezioni manterrebbero il loro valore, ma sinceramente non ci credo. In un post precedente hai detto che l'unico problema per i Professionisti è che, attualmente in fase di Lock Down, non riescono a reperire monete a fronte di una domanda molto forte. Vedrai che tra qualche mese cominceranno ad arrivare frotte di "modesti" collezionisti che cercheranno di vendere le loro "modeste" monete. Magari arriveranno anche quei Professionisti che hanno un negozio e che non riescono più a sostenere le spese. Quindi aspettiamo, il tempo dirà quale sarà il futuro del mercato numismatico, ma non si è mai visto storicamente che un periodo di grave crisi abbia portato al benessere della maggioranza della popolazione. Ciao Beppe2 punti
-
Prezzo US$0.05--Revolutionary Mexico, 1914 5-centavos:2 punti
-
Complimenti! Un rovescio davvero notevole, mi verrebbe da dire praticamente in stato Zecca. Peccato quelle ossidazioni al diritto, ma tondello regolare e centrato. Chi non colleziona Modena potrebbe arricciare il naso, ma questo è un esemplare, sia pure abbastanza comune per tiratura, davvero di grande rarità per conservazione. Allego il mio, ben più tristarello, con le sue debolezze ed il suo tondello irregolare e non centratissimo.2 punti
-
Ho elaborato una teoria tutta personale, basandomi sulle foto e sulla ricostruzione grafica di @ARES III e appurando che l'oggetto è decorato su entrambi i lati, presupponendo quindi che debba essere visibile a tuttotondo, ho pensato che potrebbe trattarsi di un piccolo "stendardo" o "insegna" (o parte di essa) da montare su di un'asta tramite il perno triangolare presente appunto su uno solo degli ipotetici tre cerchi che lo componevano. Lo stile "floreale" dei decori mi spinge ragionevolmente verso gli Ungari piuttosto che gli Avari ma tutto può essere. Di seguito una ipotetica ricostruzione dello "stendardo".2 punti
-
Buonasera, la prima liberata di monete da 120 e 20 grana e 10 e 2 tornesi ci fu il 4 Febbraio 1860 ma con data 1859 come a rispettare il primo anno di regno del nuovo Re... Nel corso del 1860 le cose cambiarono ma per non fermare la zecca, in attesa di coniare le nuove monete di rame e d'argento di Vittorio Emanuele II, si decise di continuare a coniare monete a nome di Francesco II ma sempre con data 1859, perché nel 1860 lo stemma borbonico doveva essere già stato sostituito con quello dei Savoia in ogni luogo ...2 punti
-
The coin shortage mentioned by Petronius caused the U.S. to suspend the production of proof sets during the years 1965/1966/1967. In their stead came sets of better-quality circulation coins called "Special Mint Sets." Perhaps these SMS coins led to this question? Two other things might make this coin somewhat special, although neither adds any monetary value to this 5-cent piece--which, again as Petronius has said, is its 5-cent face value: 1. 1965 Jeffs were the last of the series without the designer's initials FS below the portrait; and 2. while the mintage of the 1965 Jeff was large in absolute terms, it was dwarfed by the enormous production of 1964 nickels. I remember as a boy, looking for the new 1965 nickels, that they seemed difficult to find in circulation. v.2 punti
-
E' sicuramente VICTORIAE DD NN AVG ET CAES, perchè nell'altro caso ci deve pure essere un altare. Qui invece potrebbe esserci una stella sotto la corona. Quindi l'imperatore è Costante o Costanzo II. Arka Diligite iustitiam2 punti
-
alle aste citate , aggiungerei anche Bertolami, Artemide, Inasta....in ogni asta la tendenza e' al rialzo Solo per fare un semplicissimo esempio (ma c'e' ne sarebbero tantissimi altri) una moneta che ho seguito, battuta 1 anno e mezzo fa in sala in un asta (gremita di collezionisti e commercianti) con materiale prestigioso , aveva realizzato 900 euro piu' diritti......ieri il risultato e' stato questo...... https://www.biddr.com/auctions/gadoury/browse?a=1076&l=1148455 Poi se qualcuno vuol continuare a dire che non sono risultati veritieri del mercato, libero di farlo....ma quando ogni asta che viene esitata ormai dimostra un'impennata dei prezzi , io comincerei a prendere in considerazione che la tendenza e' questa2 punti
-
Nell'attesa di cercare nei documenti di Michele Paone indicazioni sulla sua convinzione della presenza delle monete nel Museo di Taranto, ricapitolo le informazioni accertate: 113 monete rimaste ad Achille De Donno, 180 monete vendute a Oronzo Gasparro di Lecce rivendute sul mercato di Napoli, 80 monete a Giuseppe Nervegna, non si sa se le conservo' (era un esperto e colezionista di monete di epoca messapica) il quale nel maggio 1907 vendette tutta la sua collezione a privati , forse sul mercato di Roma (alla galleria Sangiorgi) (per limiti di caricamento si puo' vedere il testo completo : lettera completa di Quagliati gennaio 1908 ) Chiedo gentilmente se qualche utente esperto avesse i cataloghi dell'epoca della Galleria Sangiorgi di Roma per appurare se tra le monete vendute risultassero anche le monete in oggetto. Buona giornata2 punti
-
Approfitto della discussione di @mariarosariaper aggiungere gli altri Tornesi 1858 della mia Collezione. Inizio con lo stesso pezzi che ha condiviso Alberto @Litra68. Simbolo stella a 5 punte e bordo perlinato su entrambe le facce.2 punti
-
Buongiorno, la problematica è piuttosto complessa ed è impossibile offrire una risposta esauriente in un post. Ogni pubblicazione, infatti, dovrebbe essere oggetto di specifica valutazione. Il rispetto delle condizioni riportate nel suo post, da solo, potrebbe non risultare sufficiente a evitare di incorrere in problemi con l’autore o con il titolare dei diritti di sfruttamento economico di ciascuna opera letteraria/articolo riprodotto. Il fatto che siano già disponibili gratuitamente on-line non significa assolutamente che possano essere riprodotte senza limiti ovunque. Il mio invito, quindi, se posso permettermi, è quello a prestare la massima attenzione prima di procedere, svolgendo una preliminare e attenta valutazione (degli aspetti legali) per ogni testo che si desidera pubblicare. Saluti.2 punti
-
Dopo aver analizzato la patina di un’oncia USA, esame dal quale si è evidenziato in particolare lo spessore della stessa e la sua curiosa struttura, il passo successivo è stato quello di prendere in esame un altro tipo di moneta e l’occasione si è presentata con l’acquisizione di un esemplare di 2Kr Svezia 1879, coniato per celebrare il Giubileo d’argento del Re Oscar II. La moneta presenta una bella patina, maturata per diversi anni in un monetiere fiorentino, con numerose presenze di iridescenza, ed è proprio in uno di questi punti che si è concentrata la nostra attenzione. L’esame al microscopio metallografico è stato eseguito in un punto con la maggiore iridescenza (vedi foto) a 50-100-200 e 400X e successivamente abbiamo confrontato le immagini con quelle dell’oncia USA. Come è evidente dalle immagini che alleghiamo, si nota subito la diversa struttura delle due patine, delle quali si percepisce anche il diverso spessore, particolare che viene messo in maggiore evidenza dalle foto elaborate graficamente.2 punti
-
Anche dopo la caduta dei Borbone si continuò a coniare moneta in rame per non lasciare la zecca inoperosa... Archivio di stato di Napoli, Ministero di Agricoltura, industria e commercio, fasc. 496.Consigliere per le finanze Laterza al Segretario di Stato Nigra, Napoli 26 Gennaio 1861.2 punti
-
2 punti
-
Ciao a me pare questa: Aurelian and Vabalathus BI Tetradrachm of Alexandria, Egypt. Dated RY 1 and RY 4 = AD 270/1. AVT K Λ Δ AVPHΛIANOC CЄB, laureate, draped and cuirassed bust right; L-A (date) across fields / I A C OVABAΛΛAΘOC AΘHNO V AVT C PѠ, laureate, diademed, draped and cuirassed bust right, L-Δ (date) across fields. Emmett 3914; Dattari (Savio) 5422. 8.71g, 21mm, 12h.2 punti
-
2 punti
-
Buonasera, io condivido il mio umile littore, in attesa di qualche altro argento gratificante2 punti
-
Buongiorno a tutti, avendo una casa al pian terreno, sono sempre stato un pò preoccupato per il fattore umidità nella conservazione delle monete. Ho cercato in giro tra tutte le discussioni sul forum e ho trovato numerosi riferimenti in cui si diceva, riassumendo molto grossolanamente, che effettivamente l'umidità fa male. Tuttavia, da buon ingegnere, volevo aggiungere qualche numero a queste (in generale corrette) affermazioni. Mi sono basato sulla lettura di questo articolo: https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1.2127403 Cerco di riassumere brevemente le conclusioni dello studio scientifico riportato sopra, che analizza per via sperimentale l'effetto di vari fattori (umidità relativa, presenza di H2S, acido solfidrico, O3, ozono, e altri inquinanti) che possono influenzare il processo di corrosione (ovvero "formazione di patine") dell'argento e del rame: - per quanto riguarda l'argento (che personalmente, al momento, è il metallo a cui sono più interessato), la rapidità di corrosione è sostanzialmente indipendente dal livello di umidità, ovvero resta praticamente costante al variare dell'umidità anche oltre 80%; - per quanto riguarda il rame, come si sa, è presente invece una sensitività molto maggiore della reazione chimica al livello di umidità. Tuttavia, un dato che mi sembra interessante è il seguente. La rapidità di corrosione resta abbastanza uniforme per tutti i valori di umidità fino al 60%, mentre poi ha un salto veramente notevole passando da 60% a 70%. Al 70% di umidità il rame si corrode più di 6 volte più velocemente che al 60%; - l'ammoniaca accelera notevolmente la formazione di patina su argento, mentre lascia abbastanza inalterata la reazione per il rame. L'ozono, che è anche sicuramente più facile da ottenere e gestire, aumenta (leggermente) la velocità di entrambe le reazioni; - (questa conclusione dovrebbe essere abbastanza ovvia). In un ambiente interno il rame si corrode 100 volte più lentamente che all'aperto; - (questa invece, forse, è interessante). L'argento si corrode più rapidamente (anche di un fattore 2 o 3) in un ambiente interno piuttosto che lasciato all'aperto. Spero che le conclusioni possano essere utili anche a qualcun altro! Saluti1 punto
-
Buongiorno a tutti, Scusate "l'intrusione" in questa sezione, fino ad ora ho sempre frequentato la sezione Regno d'Italia... Ma curiosando nel forum tempo fa, guardando la monetazione imperiale mi sono innamorato letteralmente della serie Fel Temp Reparatio... Dopo aver letto tutti i post concernenti ed essermi documentato sulle monetazione romana e sul periodo storico ho deciso di cominciare, in punta di piedi e molto umilmente, una piccola collezione su questa affascinante tematica... Voglio cosi condividere con voi il mio primo piccolo bronzo, ringraziandovi anticipatamente per i vostri pareri. Zecca Aquileia Peso. 4,03 grammi Diam. 21,23 mm Rif. 103 Saluti ( spero non aver fatto errori, sono ancora un neofita ? Dritto1 punto
-
1 punto
-
Non è corretto.....il tuo Carlino ha le sigle IAF/G....conosco solo 2 esemplari di questa moneta (in casa di due collezionisti), ed eccone un terzo !! Complimenti !! quella che vedi dietro ed è chiara è una lettera G ed è sottostante alle IAF1 punto
-
Sperando di fare cosa gradita, segnalo questa raccolta di articoli intitolata “Italy and the origins of capitalism“, resa disponibile sul sito della Cambridge university. Lo conoscevate già? Qualche commento? https://www.cambridge.org/core/journals/business-history-review/issue/71903D93C1E7F3E85BCFB40155314D75?utm_source=hootsuite&utm_medium=Facebook&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=BHR_ITALYSPEICIAL_MAY20_FB1 punto
-
1 punto
-
Buon pomeriggio E' una impresa non da poco riuscire a trovare cataloghi così datati che, ormai, sono argomento di antiquariato; in rete ci sono alcune indicazioni di dove trovare alcuni cataloghi di questa Galleria Sangiorgi di Roma, ma dai titoli (e dalle date) non mi pare riguardino la collezione in parola. Sempre che la collezione Nervegna sia transitata attraverso questa Galleria. Proviamo a coinvolgere alcuni utenti che so essere anche appassionati bibliofili; non sia mai che la fortuna ci metta lo zampino e si riesca a recuperarlo. Certamente ne dimenticherò qualcuno e chiedo venia. @piergi00, @giamba54, @numa numa, @legionario, @snam, @acraf saluti luciano1 punto
-
@aratro Nella discussione Collezionare monete di Venezia ho postato un grosso di terzo tipo di Antonio Venier con stelle a cinque punte. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
Con questo post chiudo il cerchio. Ho iniziato con i lavori dell'artista durante il lockdown per passare al tributo fatto a tutti gli operatori della sanità impegnati nella lotta contro i virus... Per gli appassionati come me del writer inglese, segnalo che a partire dal 29 maggio fino al 27 settembre si inaugura a Palazzo dei Diamanti, in quel di Ferrara la mostra dedicata a Banksy. Sgarbi l'ha definita la più bella mostra della riapertura, personalmente spero che sia la più bella mostra prima di un rapido ritorno alla normalità.1 punto
-
@Chiappara Fabio La tua moneta mi piace, in particolare il rovescio. Del dritto però mi ha colpito un particolare: Costanzo II ha in mano un globo. Ciao da Stilicho1 punto
-
1 punto
-
1849 Magliocca 799 (cifra 1 corretta) R2 Non avevo mai fatto caso alla forma del simbolo in questo mezzo tornese..... Non ha la solita impostazione degli altri.1 punto
-
@tonycamp1978, @giuseppe ballauritemo che a lungo andare mi faranno il foglio di via dalla sezione Napoletana, ovviamente scherzo su questo aspetto, diciamo che mi piace spaziare in più campi, ovviamente non si può avere la conoscenza di tutto, ma amo soprattutto fare aggregazione, e invogliare alla partecipazione, e alla condivisione, tutto sommato ci piace mostrare le nostre monete e osservare quelle degli altri, ci piace leggere i commenti di apprezzamento e farne altrettanto, e sopra di ogni cosa imparare un pezzetto alla volta quello che ognuno di noi condivide, anche dal semplice confronto e scambio di consigli sul come ottenere una bella foto, o come conservare al meglio le nostre monete, e come eventualmente pulirle. ?1 punto
-
una delle opzioni accettabili https://www.ebay.com/itm/Mikhail-Fedorovich-Romanov-Russia-Silver-Kopek-Beautiful-Tsar-Coin-Rare/174206137866?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D226724%26meid%3D01e2d28ebb564565b1eea59bb53d4501%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D174087934240%26itm%3D174206137866%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV1&_trksid=p2047675.c100005.m18511 punto
-
Salve Dipende tutto da cosa vuole collezionare... il Regno D'italia è abbastanza falsificato ma alla fine si tratta sempre e solo quasi dei pezzi più di valore e rari come le 5 lire 1914; 5 lire 1901; 5 lire 1911; 20 lire "littore"; 20 lire "elmetto o cappellone"; 20 lire quadriga lenta; 2 lire aquila sabauda 1901/1902/1903/1904; 10 cent ape 1919; 5 cent 1913 (senza punto nella legenda); 2 centesimi 1907; 1 centesimo 1902; 5 lire 1878 Umberto I; Tallero 1891 Umberto I Eritrea; 5 lire Vittorio Emanuele II 1872 zecca Roma. ecco in linea di massima questi sono i pezzi più falsificati in assoluto che mi sono venuti in mente.. è chiaro che l'aspettativa di trovarci di fronte ad un falso dipende anche e sopratutto da cosa ci troviamo davanti; se parliamo di una moneta comunissima è chiaro che nessuno la falsificherebbe mai. Il Regno d'Italia come collezione è in parte costituito da pezzi di valore bassissimo e comunissimi per cui ebay non vale la pena perchè solo per le spese di spedizione ci rimetterebbe (che potrai trovare ai mercatini a prezzi davvero irrisori come questa lira del 1940 che con un po' di fortuna potresti acquistare per 10/20 cent) in parte da pezzi di valore medio, li potrebbe essere più utile ebay rispetto ai primi dove ci si rimette rispetto ai mercatini e in parte infine di valore alto o molto alto. Poi dipende anche dallo stato di conservazione che si vuole scegliere però ho visto nei mercatini monete anche ben conservate a prezzi minori di quelle di ebay. Io per parte mia ho scelto di iniziare a collezionare solo le monete che hanno circolato effettivamente in modo da creare una collezione coerente ma non al di fuori delle mie possibilità economiche ma poi ognuno si regola come preferisce con la sua collezione. Comunque in linea di massima un modo per individuare un falso è il confronto con immagini della moneta autentica..anche se alla fine l'abilità nel riconoscere un falso è una questione di esperienza e familiarità con la moneta stessa data dall'averne visti diversi esemplari. Nel catalogo del forum trova in ogni scheda delle monete oltre alla rarità anche a fine pagina una piccola raccolta di immagini di falsi, se ne sono attestati per quella tipologia, si può allenare l'occhio con un piccolo confronto tra le immagini dei falsi e di quelle autentiche e allo stesso tempo si farà facilmente un'idea di quali pezzi e quali millesimi siano più falsificati: qui ad esempio i pezzi di Vittorio Emanuele III https://numismatica-italiana.lamoneta.it/cat/W-VE31 punto
-
Ho preso dei cavalli ultimamente, man mano che arrivano ve li posto: Cavallo con legenda, Ferrandvs D.G.Rex ed, al rovescio anelletto sotto la zampa e T in esergo, MIR 85/17, R2 Saluti Eliodoro1 punto
-
A proposito di rovesci con templi multipli. Medaglione di commemorazione della visita di Caracalla a Pergamo, Mysia. Passato alla CNG Triton VI. AE42, 47,97g Al rovescio tre templi, uno in prospettiva frontale con Esculapio seduto. Sear 25341 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?















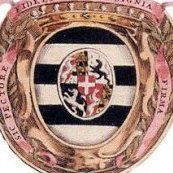





.thumb.jpg.fa45b3a528f4cce9b26ee49997e7894d.jpg)