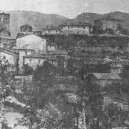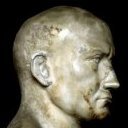Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 06/23/20 in Risposte
-
Buon giorno a tutti, anche se non credo ci sia qualcosa di interessante mi permetto di inserire qualche immagine:5 punti
-
Buonasera a tutti, posto nuova arrivata in collezione Litra68 Piastra Reimpressa 1818 Ferdinando I Mi farebbe piacere leggere vostri commenti. Saluti Alberto4 punti
-
3 punti
-
Dal mio libro di Sogni Dopo esserti perduto nei dettagli delle infinite solitudini della superficie del mondo, ferma i tuoi occhi e il respiro nel coltivare i tuoi sogni, come mago e alchimista abbandonati a loro. Allora l'intimo dell'anima tua aprirà la sua piccola porta nascosta verso la notte cosmica e vivrai nell'intimo concreti e reali i tuoi sogni di sempre. Sarai Lancelot palpitante d'Amore, Parsifal alla ricerca del Sacro Graal Erec stretto alla sua Enide Pericle tra le braccia di Aspasia perfino Baccone rapito da Ismenodora. E la maga etera amante dei sogni, che vive tra i monti dei briganti, per te si farà Ginevra e Sacro Graal, Enide ed Aspasia ed anche Ismenodora, l'impudica.3 punti
-
Per gli appassionati di tondelli, segnalo la scoperta di tre diverse varianti di tondello da 500 lire Quirinale che dipendono dai diversi sistemi di aggraffaggio utilizzati dalla Zecca italiana per unire il tondello interno in bronzital con l’anello esterno in acmonital. In particolare, il primo tipo di tondello presenta otto dentini di metallo posti nell’anello di calettamento a 45° e che penetravano nel tondello interno in fase di assemblaggio. I dentini si possono quindi apprezzare solo nell’anello non assemblato. Questo tondello risulta essere stato utilizzato dalla Zecca nei primi anni ’80. Intorno al 1985/1986 è stato modificato il metodo di aggraffaggio e sono stati introdotti gli slot o cavette, vale a dire delle piccole scanalature poste lungo l’anello di calettamento. Si conosco due tipologie di tondelli con slot/cavette: tondello con tre slot posti a 120° e tondello con due slot posti a 180°. Nelle monete con uno spazio tra i due tondelli si possono vedere gli slot (cfr. immagine)2 punti
-
Buongiorno, è di questi giorni la notizia che un noto ricercatore subacqueo croato ha rinvenuto nei fondali quarnerini, nei pressi dell'Isola di Veglia, il relitto di una nave romana. L'esatta localizzazione è stata tenuta segreta per evitare episodi di trafugamento del carico. L'area marina è stata nei tempi antichi pericolosa a causa dei venti e delle forti correnti, nonostante la relativa vicinanza alla costa (la navigazione in epoca romana era tendenzialmente pericostiera, dove possibile). Personalmente sorrido all'affermazione che "... è cosa nota che le navi di quell’epoca viaggiavano dalla Dalmazia verso Venezia... " ... Venezia in epoca romana... magari Aquileia... ... senza voler toglier niente alla Serenissima... https://lavoce.hr/attualita/eccezionale-scoperta-ritrovata-una-nave-risalente-allepoca-romana-foto Ciao Illyricum2 punti
-
Il bezzo da 6 falso è una della monete di cui ci si chiede il senso. Perchè contraffare una tale moneta di piccolo taglio? Gli amanti di tutte le monetazioni sicuramente argomentano molto facilmente. La percentuale di argento contenuto permetteva di avere un ottimo guadagno stampando una moneta di solo rame. Un esempio semplice è dato (per il periodo) dalle varie contraffazioni dei soldi da 12 bagattini. Viceversa è stato difficile trovare un bezzo da 6 bagattini che pur avendo la stessa quantità (teorica di argento) a quanto pare non attirava gli interessi dei falsari. In questo caso la risposta è facile: molto più conveniente economicamente stampare una moneta da 12 bagattini che non 2 da 6 bagattini. Per il bezzo anonimo in questione si pone la stessa domanda. Ne valeva la pena? La risposta è veloce : sì. Il guadagno sul mezzo soldo era allettante così come era per i sesini, per i quattrini ed addirittura per i bagattini. Inoltre stampare tali monete era più semplice. D'altra parte tali monete erano molte conosciute visto la grande quantità di conii e tondelli in circolazione a Venezia. Ma nei territori di terraferma? o nei territori confinati? Ecco quindi che come nel caso dei sesini stmpati nelle zecche di furbi Principi, tali monete potevano essere scambiate in zone dove la conoscenza stessa della moneta non era propriamente perfetta. Il guadagno in primis e poi chi avrebbe potuto arrestare il malfattore? Sicuramente con la lunghezza delle indagini non sarebbe stato possibile riuscire ad incastrare una veloce ed inaspettata produzione di monete false. Che così, a volte sfuggiva agli "artigli del leone". Artigli molto ben affilati.2 punti
-
E’ arrivato il lupo giallo E’ arrivato il lupo giallo col bastone di cristallo canta sempre come un gallo, ma è soltanto un lupo giallo. In vacanza va a San Gallo, delle noci mangia il mallo... c’è una lupa su a Varallo che vuol bene al lupo giallo. Quando piove va a cavallo, così non resta mai in stallo. Con la lupa si fa un ballo perché è un dolce lupo giallo. Questa canzoncina è per mia figlia, l’ho scritta quando lei aveva nove anni...2 punti
-
1841 5 Centimes Colonie Francesi 1841 emissione per Guadalupe (o quel che ne resta!?)2 punti
-
dal mio libro 'parlo con un angelo femmina' ............... cosa succede a Torino, quando la notte è fonda e il mattino incombe? “Ti racconto una notte d’inverno a Torino. Non si è ancora fatta l'alba. Fuori fa freddo, ma c'è quasi silenzio. Questo significa che qualche nottambulo sta rientrando. Qualche perdinotte, imbottito di alcol o dell'odore di una femmina, torna a casa. Chi lo attende? La sua donna, i suoi figli, oppure un letto vuoto? Freddo e vuoto, forse, ma zeppo di ricordi. Bisognerebbe svuotare quel letto e riempirlo di futuro. Ci vorrebbe una femmina. Basterebbe farci l’amore. Basterebbe non amarla. Basterebbe rincorrere la vita per non farsi superare dalla morte. “Immagini un po’ dark. E la tua notte, cosa cerca la tua notte? “La mia notte raccoglie poesie e pensieri. Vuoi un pensiero? Eccolo. Chi sei, anima mia? Dove siete, anime figlie del passato, smarrite fra i carruggi della speranza, chiglie sfasciate contro gli scogli del disamore? Parlami, dolce femmina, dimmi se abbracci la dolcezza o se ti aggrappi agli scogli della burrasca. Sai bene che è meglio la burrasca della bonaccia. Apri gli occhi, fallo anche per i miei. E’ appannato il mio sguardo. Sarà la nebbia, la nebbia dell'anticamera dell'inverno...2 punti
-
2 punti
-
Taglio: 2€ cc Nazione: Estonia Anno: 2019 A Tiratura: 987.500 Condizioni: Spl Città: Bologna Fatto.2 punti
-
2 punti
-
2 punti
-
Di recente, grazie a @Scipio, siamo tornati a leggere i bellissimi saggi che Pedroni scrisse oltre 20 anni fa per dare una sistemazione teorica alle prime emissioni di Roma (Ricerche sulla prima monetazione di Roma, 1993 e Nuove ricerche sulla prima monetazione di Roma, 1996). Si tratta di tesi molto affascinanti, ancorché un po' ribassiste, perché hanno il pregio di disegnare una costruzione coerente, appoggiata su tutti i dati noti (letterari e archeologici) e ben inserita, con logica consequenzialità, in un contesto italico e siceliota omogeneo dal punto di vista iconografico e, soprattutto, ponderale. Nessuna affermazione è apodittica, tutte sono spiegate e, quando si tratta di mere supposizioni, viene esplicitato. Provo qui a riassumerne le idee afferenti strettamente al problema della cronologia, sperando di stimolare alla lettura di questi saggi, decisamente molto belli. Preciso che gli errori, tanto di comprensione quanto di digitazione, sono tutti miei, pregando che Pedroni non me ne voglia ...1 punto
-
Verrebbe logico pensare a un fiore stilizzato. Però, sarà l'ora tarda dopo una giornata di lavoro, mi sembra tanto una stella marina... ?1 punto
-
Ci sto pensando e tra le ipotesi avanzate c'è anche quella che gli addetti alla coniazione avessero alzato il gomito ?1 punto
-
E questo è l’asse Castore/Apollo 19/1 https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-RRB3/11 punto
-
Invece io credo che l’opera di Pedroni faccia giustizia sull’uso delle fonti letterarie, ingiustamente dismesso da Crawford, e costituisca un tentativo ben riuscito di coniugarle con le evidenze archeologiche. Mi sembra molto convincente il ruolo che attribuisce ai censori e si inserisce molto bene nelle recenti argomentazioni sul ruolo del bottino di guerra nell’alimentazione dell’erario e sulla partecipazione della plebe al bottino stesso; infine, e non è poco, sul valore “democratico” del conio della moneta come strumento di accesso alla ricchezza da parte della plebe. Voglio ancora ricordare come Pedroni riesce a motivare, dare coerenza e inserire in un contesto storico molto credibile le scelte iconografiche dell’oro del giuramento, del quadrigato e del denario di Veturio (il primo a discostarsi dal canone Roma-Dioscuri/Biga)1 punto
-
Buona sera a tutti, @Litra68complimenti una piastra stupenda e molto rara. Ti faccio i miei complimenti. Saluti Raffaele.1 punto
-
Ciao @giollo2, diversi cavalli interessanti, il secondo centrale ( prime due file ) di zecca napoletana. Bello quello aquilano con la A capovolta invece della V e, mi sembra la I al posto della S. Federico D'Aragona ha un bel ritratto, molto più rinascimentale e meno spigoloso del normale. Saluti Eliodoro1 punto
-
PREMESSA Pedroni ritiene che le prime iconografie valessero a identificare l’origine della ricchezza monetata, tenuto conto che le prime monete romane nacquero per redistruibuire la preda bellica secondo due canali differenti: - i fusi, a cura dei censori (in anni censorî, quindi), per restituire ai cittadini almeno in parte il tributum; - le monete coniate, a cura dai comandanti militari, per gratificare le truppe. Probabilmente le zecche erano vicino ai luoghi ove era stato reperito bottino (ma quello di Taranto fu monetato ad Alessandria per Cr. 21/1). Per penetrare mercati allogeni fu adottata la metrologia magno-greca e tipologie “ibride”, con tipi “romani” su una faccia e “locali” (spesso, il fondatore mitico della città debellata) sull’altra. Nel 269 fu attivata la zecca urbana (Zonara collega l’evento con l’afflusso di ingenti ricchezze, che un passo di Dionigi di Alicarnasso permette di identificare nel bottino di Reggio); nell’occasione la legenda cambiò da ROMANO a ROMA (a decorrere da Cr. 25/1) e furono restituiti alcuni tipi tradizionali, sui quali la funzione identificativa fu assolta da un simbolo (falcetto, clava, ghianda). Da quella data il tributum fu restituito anche con l’argento. Tanto premesso, la cronologia deve essere compatibile con tre considerazioni: - le tradizioni storiche datano l’argentum signatum del populus Romanus al 275 (Plinio 42), il primo nummus argenteus di Roma al 272 (fonti derivate da Eusebio di Cesarea) e l’argentum signatum al 269 (Plinio 44, Livio e Zonara); - le riduzioni ponderali del bronzo non potevano non cadere in anni censorî (perché le svalutazioni comportavano ineluttabilmente la revisione delle liste di censori); - lo standard della didracma varia da 6,5 scrupoli (Cr. 13/1) a 5,75 (Cr. 22/1) e infine 6 (Cr. 25/1). L'AES GRAVE E LA MONETAZIONE ROMANO-CAMPANA Per Cr. 1/1 la data proposta da Mommsen e Sambon (338) appare preferibile: la moneta sarebbe stata emessa da Campani che avevano appena ricevuto la civitas, probabilmente sine suffragio, per commerciare con Neapolis. Nel medesimo contesto si inserirebbe il lingotto Cr. 3/1. Nel 289, con l’istituzione dei tresviri monetales, furono emesse le prime serie fuse su standard di 300 scrupoli. Che tale fosse lo standard romano dell’epoca è confermato dalla sua riproposizione nelle serie fuse delle colonie di Luceria (fatta colonia nel 313) e Venusia (dedotta nel 291), seppur frazionate su base decimale[1]. La prima in assoluto potrebbe essere stata Cr. 19, perché la raffigurazione di Castore sull’asse (che ricorda la battaglia del Lago Regillo) e del Tevere sul semisse potrebbero alludere alla conquista, nel 290, dell’Alta Sabina, dalle cui ricchezze quindi potrebbe derivare il metallo monetato. Cr. 18 sarebbe successiva al 289 e precedente al 275. Si potrebbe datarla al 277, quando fu presa Crotonem, cui i tipi apollinei potrebbero alludere, ma non fu anno censorio. Appare allora più probabile il 282, quando i consoli C. Fabrizio Luscino[2] e Q. Emilio Papo sconfissero, rispettivamente, città sannite e lucane e i Galli Boi, anche se risulta arduo individuare una connessione con i tipi delle monete. La didracma Cr. 13/1, con standard di 6,5 scrupoli viene datata al 275 e attribuita alla zecca di Metaponto. È coniata sul piede campano di circa 7,30 g per renderla accettabile al mercato, benché forse fosse già in vigore quello magno-greco ribassato di 6,6 g. Contemporaneamente furono emesse la litra argentea Cr. 13/2 (0,65 scrupoli) e la mezza litra enea Cr. 17/1 (4,5 scrupoli); di quest’ultima esiste un riconiatura su moneta siracusana databile al 280, nonché l’identità stilistica con i bronzi (HN Italy 210-211) di Cosa, colonia dedotta nel 273, per la quale è plausibile che la colonia abbia copiato l’emissione della metropoli, precedente di due anni, in segno di devozione politica. Contemporaneamente, nel 275, fu emessa la serie fusa Cr. 14, con standard di 288 scrupoli[3]. I tipi adottati, Giano e Mercurio, sono gli dei tutelari dei patti e del commercio, riferimento coerente a una tematica nazionale; potrebbe significare che per questi bronzi fu monetato il metallo dell’Erario. È probabile che in quest’epoca fosse fissata una parità metallica (con rapporto 1:132) per cui la didracma (da 6,5 scupoli, suddivisa in 10 litre argentee) valeva 3 assi oppure 96 litre enee (forse corrispondenti a 480 chalkoi); da ciò deriverebbe la riduzione dello standard da 300 a 288 scrupoli. È significativo che i nominali più bassi pesino, in proporzione, di più dell’asse: forse la riduzione non fu applicata ad essi per non svantaggiare i ceti meno abbienti e i commerci più minuti. Per la didracma Cr. 15/1, con standard di 6,4 scrupoli (pari a 6,5 ribassati), viene proposta la data del 274 e la zecca di Arpi (anticamente Argo Ippio), forse evocata dal tipo del R/, che peraltro emise argenti proprî di peso medio analogo (6,92 g secondo Thomsen). Si collocherebbe in serie con la litra in bronzo, Cr. 2/1. Contemporaneamente fu emessa la litra enea Cr. 2/1. La didracma Cr. 20/1, con standard di 6,25 scrupoli (pari a 6,5 ribassati), viene datata al 273 supponendosi che fossero monetarî Q. Ogulnio Gallo e N. Fabio Pittore, componenti (forse proprio per la carica rivestita) dell’ambasceria ad Alessandria, e abbiano commemorato la statua della lupa collocata nel 296 dai fratelli Q. e Cn. Ogulnio e il dio ritenuto antenato dei Fabii. Viene attribuita alla zecca di Eraclea, richiamata dal tipo del D/ (Cicerone accenna a un trattato tra le due città, che potrebbe datarsi proprio al 273). Fu anche emessa la litra enea Cr. 16/1. Nel 273/272 non furono emesse monete fuse, per cui probabilmente il cambio teorico rimase fissato nel rapporto di 1:3 con l’asse Cr. 14/1. La didracma Cr. 22/1, con standard di 5,75 scrupoli (pari a 6 ribassati) presenta peculiarità stilistiche e marchi di controllo mai più presentatisi sulle monete di Roma, ma affini a quelli in uso alla zecca di Alessandria, cui pertanto viene attribuita. Peraltro, il piede tolematico era compatibile col peso di queste monete. Mattingly ha proposto la data del 273, in occasione dell’ambasceria romana a Tolomeo Filadelfo, ma è più probabile il 272 (data per questo tramandata da Eusebio di Cesarea), dopo la presa di Taranto (probabilmente ricordata dal tipo al R/) che averebbe fornito il metallo da monetare. L’aggio elevato (0,25 scrupoli) si spiegherebbe con le spese di trasporto per e dall’Egitto. Contemporaneamente fu emessa la doppia litra enea Cr. 23/1 e probabilmente la serie fusa Cr. 21, che presenta la medesima, peculiare raffigurazione della dea Roma. Il peso medio dell’asse, 240 scrupoli, malgrado fosse in vigore uno standard di 252 scrupoli (meglio che 250 scrupoli, valore riconosciuto dagli studiosi per quest’epoca) si spiegherebbe per mantenere il rapporto di cambio 1:3 pur adottando la parità di 1:126, affine a quella tolemaica di 1:125. Alla zecca di Roma e, quindi, alla data del 269 va attribuita la serie Cr. 25, la prima a legenda Roma, comprendente tanto la didracma (su standard di 6 scrupoli) che i fusi (su standard di 252 scrupoli). Fu probabilmente coniata monetando il bottino di Reggio (cui il falcetto alluderebbe, essendo stata Reggio fondata da coloni di Messina-Zancle). È significativo che vengano riproposti i tipi della prima didracma (Cr. 13/1) e dell’asse Cr. 14/1, a conferma che anch’essi erano contemporanei. La serie comprende anche una mezza quartoncia, Cr. 25/3. Sempre nel 269, a fini commemorativi, le zecche esterne all’Urbe emisero, sempre sullo standard di 252 scrupoli, l’asse Cr. 37/1. Nella serie Cr. 26 il simbolo è presente esclusivamente sui fusi: potrebbe dedursene che argento e bronzo avessero provenienze diverse. Il simbolo (ghianda, connessa con il culto di marte) rimanda alla liberazione di Messana (264/263), sottratta appunto ai Mamertini. Lo standard del bronzo è ancora di 252 scrupoli. La serie comprende anche una mezza quartoncia, Cr. 26/3. Tra il 263 e il 258 lo standard del bronzo fu abbassato a 240 scrupoli, presente nelle emissioni Cr. 24, 27, 35 (con significativi ribassi) e 36 (con ribassi ancora più sensibili). Nel 258, quando era censore C. Duilio, fu emessa la serie fusa della prora (Cr. 35) per commemorare il primo trionfo navale, da lui stesso conseguito nel 260 dopo la vittoria di Mylae: tipi innovativi per un evento unico. Giano richiama il tempio che egli fece erigere nel Foro Olitorio. Sappiamo peraltro dal suo elogio funebre[4] che “praedad popolom (donavet)”, verosimilmente quindi proprio con questi bronzi. La serie Cr. 27 presenta una clava e, quindi, rinvia alla conquista di una città chiamata Eraclea: forse Drepanon (nella Sicilia occidentale), conquistata nel 242, supponendo che possa essere la prima “Eraclea” fondata da Dorieo di cui parla Diodoro Siculo (IV, 23, 3). La serie va allora datata al 242/241 e comprende anche una mezza quartoncia, Cr. 27/2, e due monete di taglio anomalo (forse 1/40 e 1/80 di asse), Cr. 27/3 e 27/4, probabilmente emesse per supplire all’esigenza di numerario in terre sottratte ai Punici (fra cui Lilibeo ed Erice). La serie con la ruota (Cr. 24) presenta una struttura analoga, con un tipo innovativo e fisso al retro. Potrebbe riferirsi all’inaugurazione della strada militare Agrigento-Palermo, che un miliario rinvenuto nel 1958 attribuisce a C. Aurelio Cotta. Questi fu console nel 252 e nel 248; nella prima occasione (anno censorio) celebrò un trionfo de Poenis et Siculeis dopo aver conquistato Lipara e Thermae e forse avviato la realizzazione della strada. Notevole l’emissione straordinaria del tressis (Cr. 24/1), a indicare che era ancora in essere il cambio 1:3; si tratterebbe pertanto di una “didracma di bronzo”. A questa serie va probabilmente collegato il piccolo bronzo di taglio anomalo Cr. 26/4, che ne riprende l’iconografia sia al dritto che al retro; forse si trattava di un terzo di quartoncia (peso teorico 1,66 scrupoli, peso medio degli esemplari censiti 1,46 scrupoli). __________________ [1] Pedroni osserva che furono tuttavia emesse monete su standard di 336 scrupoli e suddivisione decimale, con legende in lettere latine, da Hatria (colonia dedotta nel 289) e dai Vestini (alleatisi con Roma nel 301), nonché - senza legenda - da Ariminum; quest’ultima serie deve essere precedente alla costituzione in colonia (datata al 268) perché una semioncia è stata rinvenuta in strati relativi alle mura della colonia stessa (come riferito da Balbi de Caro). Lo studioso ne deduce che nel medesimo periodo (inizî III secolo) Roma spingeva le colonie apule a monetare con il proprio standard per occupare un mercato ove i fusi non erano ancora presenti, quella adriatica e gli alleati Vestini con lo standard gallico (autonomamente in uso ad Ariminum) per indebolire l’economia gallica in vista dello scontro decisivo (al lago Vadimone nel 284/283). [2] Secondo Dionigi di Alicarnasso, egli si vantò con gli ambasciatori di Pirro che da console (nel 282) con il bottino sottratto a Sanniti e Lucani aveva non solo arricchito l’armata, ma anche restituito il tributum. [3] Una glossa di Festo ci riferisce che quell’anno una legge o plebiscito diminuì il librario (misura dei liquidi), e quindi probabilmente la libbra, da 480 a 288 scrupoli: potrebbe trattarsi di un ultimo tentativo di mantenere l’aggancio tra libbra e asse, malgrado le progressive svalutazioni di quest’ultimo. [4] Tramandatoci dall’iscrizione ILLRP 319, di età imperiale.1 punto
-
Proseguendo: RRC 7/1 - Scudo/Scudo https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-AESS/5 Haeberlin riporta 3 esemplari completi. Secondo alcuni studiosi le due figure alluderebbero allo scudo gallico che aveva appunto una forma ellittica, una spina verticale e l'impugnatura orizzontale. Per la presenza degli stessi simboli sui bronzi fusi di Ariminium si ritiene che commemorino una vittoria dei Romani in Italia centrale contro tribù galliche: Sentinum del 294 (combattuta contro i Galli coalizzati con gli Etruschi, gli Umbri e i Sanniti) o Lago Vadimone del 284 (combattuta contro i Galli Senoni). Pedroni propone la seconda (perché alla prima ricollega il lingotto spada/fodero) e data il lingotto all’anno seguente (283). Per altri studiosi l'attribuzione è incerta perché anche i Romani hanno usato questo scudo di forma ovale Sullo stesso tema: RRC 8/1 - Spada/Fodero https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-AESS/6 Haeberlin riporta 2 esemplari completi. Anche questi tipi, come quelli del precedente lingotto, compaiono sui bronzi fusi di Ariminium, per cui è stato ipotizzato che alludano ad una battaglia avvenuta in Italia centrale contro tribù galliche, Sentinum del 294 o Lago Vadimone del 284. Pedroni preferisce la prima, perché fu combattuta sul fiume Aesis (il cui nome assomiglia all’aes usato per le spade), e data il lingotto al 294 Il ricordo delle guerre pirriche: RRC 9/1 - Elefante/Scrofa https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-AESS/7 Haeberlin riporta un solo esemplare completo (quello del British Museum); un altro si trova al National Museum of Copenhagen. Eliano ricorda che contro Pirro i Romani riuscirono ad aver ragione degli elefanti mandando loro incontro dei maialini, il cui grugnito li terrorizzò; resta da accertare se la narrazione non nasconda il ricordo di una legione contrassegnata dal simbolo del maiale. Consegue che il lingotto sia collegato a una vittoria contro Pirro: Ausculum 279 (ipotesi preferita da Pedroni) o Maleventum 275 Il mare: RRC 10/1 - Ancora/Tripode https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-AESS/8 Gli studiosi associano questo lingotto e i successivi due per i riferimenti al mare. Crawford li data tutti e tre al 260, anno della vittoria di Gaio Duilio a Mylae (Milazzo), per la quale fu celebrato il primo trionfo navale dei Romani, e ritiene che alludano a un successo navale della Prima Guerra Punica. Per Haeberlin l'ancora allude alla flotta o ne è proprio il simbolo, il tripode a un rito sacro connesso colla navigazione. Per Kondratieff (The column and coinage of C. Duilius, “Scripta Classica Israelitica” 2004) e Rowan (The profits of war and cultural capital, “Historia” 2013) potrebbero essere stati coniati proprio con il bronzo sottratto ai Cartaginesi. Per Coarelli, che data l’aes signatum al 375-325 circa, questa emissione potrebbe alludere alla riforma, nel 367, del collegium sacris faciundis, i cui membri furono portati a 2 a 10, o alla susseguente ricostruzione del tempio di Apollo, nel 353. Pedroni, che collega i simboli apollinei alla gens Cornelia, data l’emissione al 289/288 e ipotizza che commemori la storica fondazione della colonia di Hatria, primo sbocco romano sull’Adriatico (le cui once librali, non a caso, riportano l’ancora), avvenuta tra il 290, sotto il consolato di P. Cornelio Rufo (lo stesso che avrebbe ispirato i tipi apollinei di Cr. 18/1 e 19/1) e il 288, quando era console un altro membro della gens, P. Cornelio Arvina1 punto
-
Ma vediamoli nel dettaglio. Il primo è RRC 3/1 - Cornucopia/Ramoscello. https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-AESS/1 Nel 1927 presso Santa Marinella, fu rinvenuto a poca profondità dal livello del suolo, entro un vaso fittile la cui parte superiore era mancante, un tesoretto consistente in 17 aera grava e un frammento di questo rarissimo aes signatum (primo frammento illustrato). Thomsen interpreta il D/ come un viticcio o tralcio, Crawford e Pedroni come due cornucopie in incuso affiancate. Pedroni inoltre ne evidenzia l’arcaicità, confermata anche da una derivazione stilistica del ramo d’ulivo dal “ramo secco”. Per Coarelli, l’aes signatum doveva essere in uso nel corso del IV secolo, ma prima della coniazione dell’aes grave (che l’autore colloca all’ultimo quarto del secolo). Deve, quindi, ascendere al 375-325 circa. Pedroni osserva che i lingotti con legenda dovevano essere destinati a Romani residenti fuori dall’Urbe; questo in particolare potrebbe essere stato consegnato ai Campani (alla cui prosperità alluderebbero le cornucopie) e conseguentemente datato al 339, quando non solo fu loro concessa la civitas, ma fu anche imposta l’assegnazione di una delle cariche censorie ai plebei (alla concordia derivatane alluderebbe l’ulivo) Il pezzo più bello di tutta la numismatica: RRC 4/1 - Aquila/Pegaso https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-AESS/2 L'esemplare della collezione Garrett è composto da due parti, di cui solo il frammento più grande (133x97 mm, 1240 g) è originale: Haeberlin decise di pubblicare solo la parte originale, Sidenham riporta invece l'esemplare completo del restauro (168x97 mm, 1.875 g). Italo Vecchi (Italian Cast Coinage 2013, p. 29) nota che l'aquila di Giove su fulmine simboleggia la guerra mentre Pegaso la gloria, il potere e la velocità così come l'immaginazione. Coarelli, che data l’aes signatum al 375-325 circa, evidenzia come questo lingotto non possa non essere anteriore alla didracma Cr. 13/1 (databile al 326-312), portando una legenda più arcaica. Pedroni osserva che i lingotti con legenda dovevano essere destinati a Romani residenti fuori dall’Urbe; questo in particolare potrebbe essere stato consegnato agli ambasciatori recatisi ad Alessandria nel 272 (in conseguenza del trattato di alleanza del 273) per avviare l’appalto a quella zecca di una serie monetale composta da Cr. 22/1 e 23/1, la seconda delle quali presenta proprio l’aquila su fulmine Poi abbiamo RRC 5/1 - Toro/Toro https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-AESS/3 Haeberlin riporta 5 esemplari completi e 17 spezzati di varie grandezze. Per Haeberlin e Grueber questo quadrilatero ricorderebbe la sottomissione del Sannio avvenuta nel 290 poiché il toro, come dimostrerebbero i denarî della guerra sociale, sarebbe il simbolo dei Sanniti; c'è da dire però che è solo in età molto più tarda che avviene l'identificazione toro-Sannio. Per Mattingly sarebbe solo un richiamo alla pecunia. Per Benucci potrebbe trattarsi di una forma di tesaurizzazione del bestiame di un santuario. Panvini Rosati ricollega il lingotto all’equivalenza fra bestiame e aes sancita dalle XII tavole. Pedroni sposa la tesi di Mattingly e lo collega all’attivazione della zecca di Roma, datandolo per conseguenza al 269. Il secondo esemplare raffigurato, oggi allo Staatliche Museum di berlino, fu acquistato nel 1907 da Haeberlin che riferisce che era stato da poco rinvenuto in un bosco nei pressi di Cità di Castello. Misura 173x92 mm, è spesso 13-23 mm e pesa 1.624,5 g Ancora: RRC 6/1 - Spiga/Tripode https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-AESS/4 Quattro esemplari conosciuti: uno riportato da Haeberlin, uno da Crawford, uno venduto all'asta Münzen & Medaillen 47 (l'unico completo) e uno venduto all'asta NAC 9. Le due figure sono state considerate da Haeberlin, Thomsen e Zehnacker come simboli divini allusivi ad Apollo (il tripode) e a Cerere (la spiga di grano). Comparette ha evidenziato che erano epìsema rispettivamente delle città di Crotone e Metaponto; su questa scia Nenci ha proposto che commemori la caduta di Crotone (277). Pedroni invece riferisce l’emissione alla cattura di Metaponto (275), osservando che un piccolo bronzo di quella città (SGN Cop. 1250) riporta inusulamente proprio questi tipi, e ritiene che i simboli apollinei siano riconducibili alla gens Cornelia (nel 275 era console L. Cornelio lentulo Caudino, che trionfò sui Lucani)1 punto
-
Certo che anche il “Lato A” di Venere, valorizzato dall’atteggiamento pudico con cui la dea copre le nudità, non è da meno del “Lato B”. Piuttosto intrigante è invece l’atteggiamento dei due venti Zefiro e, forse, Aura, che l’hanno sospinta sull’isola di Cipro, avvinghiati uno all’altra come in un amplesso. Secondo Esiodo Afrodite, la dea della bellezza e dell'amore identificata con Venere dai Romani era nata in primavera dalla spuma del mare fecondata dai genitali di Urano che Cronos aveva scagliato in mare dopo la ribellione contro il padre. Afrodite, dal greco afros, la spuma, aveva anche l'appellativo di Urania, perché anche figlia del Cielo. Appena emerse dalle onde su una conchiglia di madreperla, Zefiro l'aveva spinta sulla riva dell'isola di Cipro: da qui gli appellativi di Anadiomene, l'emersa, e di Ciprigna. Appena la dea mosse i primi passi sulla spiaggia, i fiori sbocciarono sotto i suoi piedi e subito le vennero incontro le Ore, le Cariti, Peito, la persuasione, Potos, il desiderio, Himeros, la brama, per accoglierla, onorarla e servirla. La vestirono con un vestito bellissimo e una cintura, le misero boccole d'oro e di gemme alle orecchie, braccialetti ai polsi e una collana splendente al collo. Dal cielo arrivò un carro di gemme, tirato da due colombe, sul quale la dea salì e fu così assunta in Cielo. Zeus la diede in moglie ad Efesto, ma la sua idea non fu delle più felici; non si può unire in matrimonio la dea più bella con il dio più brutto. Afrodite veniva rappresentata nel fiore della sua giovinezza, avvenente, graziosa, tutta ingioiellata e sorridente. Il suo volto era ovale, delicato e gentile; i suoi occhi grandi, tremuli, avevano uno sguardo soave e languido che ispiravano tanta dolcezza. Sopra il vestito portava una cintura magica dove erano raccolti tutti i vezzi, le grazie, il sorriso che promette ogni gioia, i teneri dialoghi degli innamorati, i sospiri che persuadono e il silenzio espressivo. Erano sacri ad Afrodite tra le piante il mirto, la rosa, il melo, il papavero; tra gli animali il passero, la lepre, il cigno, il delfino e soprattutto la colomba. Dalle sue varie unioni ebbe alcuni figli: dal troiano Anchise ebbe Enea; dal dio Dioniso ebbe Imene, il dio delle feste nuziali; da Ares ebbe due figli terribili, Eros, amore, e Anteros. I poeti greci raccontano che quando Afrodite ebbe Eros, si lamentò con la dea Temi perchè il figlio non cresceva; Temi le rispose che il bambino non sarebbe cresciuto finchè non avesse avuto un fratello. Allora Afrodite diede vita ad Anteros che significa "colui che ricambia l'amore". Così i poeti, con questa graziosa leggenda, hanno voluto dire che l'amore, per poter crescere, deve essere ricambiato. Fonte http://mitologiagreca.blogspot.com/2007/07/afrodite.html#:~:text=Afrodite%2C la dea della bellezza,la ribellione contro il padre. apollonia1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Bellissime monete, complimenti. Però mi sembra che quelle immagini e la tematica stessa possano urtare o turbare l'animo di qualche minore ! ( O anche qualche anima pia, ma qui penso che la cerchia sia un tantino più striminzita) Ricordiamoci che ci sono molti minori che ci leggono e ci seguono, quindi evitiamo che questi ragazzini diventino collezionisti di monete solo per ammirare un bel panorama. Poi la scusa di invitare qualche ragazza ad entrare nella loro camera per mostrargli la collezione di farfalle diventerà quella dei denari imperiali ! Collezione più virile ma anche più esplicita!1 punto
-
1 punto
-
Scusa @Scipio. Avevo frainteso lo sgomento, pensavo che fosse diretto alla mia reazione. Come non avessi detto, meglio scritto niente.1 punto
-
Ciao Fausto Qui siamo nel difficile.. Per me ci sono un paio di alternative. Primo caso: mi sembra di intravedere i contorni di una rosetta intorno alla F, potrebbe quindi essere una moneta riconiata su una precedente (ad Aosta capitava su alcuni quarti) e il vuoto della rosetta ha impedito di coprire una lettera della moneta precedente. Altra possibilità ma non penso, una contraffazione di Guastalla, che presenta la F in quella posizione, ma non vedo traccia della A sul gambo della seconda lettera. Altra opzione, un falso o una contraffazione, ma non ne ho viste altre così. La F non è una sigla di zecca utilizzata, quindi o è stata messa in caso di contraffazione oppure era già lì.. Il periodo di Carlo Emanuele era pieno di monete piccole non buone, quindi ci riserva ancora dei misteri1 punto
-
Ciao Fausto Veramente difficile da trovare questa moneta con questa data! La mia è messa sicuramente peggio, si può vedere sul catalogo.. e non mi è capitato di vederne molte, quindi buon acquisto!!1 punto
-
Credo che anche il Banco di Roma facesse qualcosa di simile, ricordo che me ne aveva dato qualcuno mio padre per una vacanza nei primi anni '80... tutti restituiti, senza spenderne neanche una lira petronius1 punto
-
Riporto le scansioni di due monete d’oro (peso e diametro nella norma) del lascito con gli scudi di Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II riconosciuti falsi, che ora tengo in ufficio con l’etichetta “Timeo Danaos et dona ferentes”. Vittorio Emanuele II - Regno d’Italia: 20 Lire1862 TO e 20 Lire 1865 TO1 punto
-
1 punto
-
Si, ovviamente l'errore è nella numerazione della foto....capita, ma quando al post 7 scrivevo di ritratto simile, mi riferivo proprio a quel 3 Cavalli. Bravi ragazzi.... @gennydbmoney, @doppiopunto ... ?1 punto
-
@okt avevo scritto CONSTANTINUS MAGNUS invece che CONSTANTINVS MAGNVS ? meglio ancora MAXIMVS1 punto
-
Aggiungo che dire "follis" per questa e per altre monete non è esatto, come non esatta potrebbe essere la classificazione in "billon reduced centenionalis", seguita dal Sear. La migliore classificazione, nella totale incertezza sui contenuti delle riforme monetarie dell'epoca, è riferirsi al modulo della moneta e quindi definirla come una "AE3" (diametro 17-21 mm).1 punto
-
Buonasera, credo si tratti di questo "follis" in biglione di Costantino il Grande: Zecca di Siscia, prima officina. Sear 16351A1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Buongiorno, giustissimo, i pallini sotto il busto indicano a Cizico l'officina. Due pallini --> seconda. Tre--> terza (vedi sotto). Questa iconografia riprende quella di poco precedente emessa da Gallieno. E poi... e poi... ... poi ci sono le iconografie delle Vittorie di Claudio II più comuni ... Ciao Illyricum1 punto
-
1 punto
-
Il giudizio di Paride sul rovescio di un bronzo di Massimino I: Afrodite è l'unica delle tre dee nuda come Zeus l'ha fatta. Sale: Triton V, 16 January 2002, Lot: 1755. Estimate $2000. Sold For $1750. CILICIA, Tarsus. Maximinus I. 235-238 AD. Æ 36mm (23.56 gm). AVT K G IOV OVH MAXIMEINOC, radiate, draped and cuirassed bust right, seen from behind; P P across field / The Judgement of Paris: TAPCOV, MHTPOP in exergue, Paris seated left on rock, wearing Phrygian cap and holding apple in right hand and lagobolon in left, facing Aphrodite, nude, standing left, drawing drapery from shoulder, Hera enthroned left, and Athena standing left, resting shield on ground before her and holding spear in left hand; AMK above, B to right. SNG Levante -; SNG Levante suppl. -; SNG France 1587 (same dies); SNG von Aulock -; BMC Lycaonia, etc. pg. 205, 223; Cornell 117 (this coin). VF, brown patina with sandy highlights. ($2000) From the David Simpson Collection. Ex Classical Numismatic Group Auction XXIV (9 December 1992), lot 497.1 punto
-
Exceptional Avaric anthropomorphic belt buckle Hungary, 8th century AD Gilded bronze – Height: 5 cm. Provenance: Collection A. Jansen, Geldrop, Netherlands 1969, then Collection K. S., Nijmegen, The Netherlands1 punto
-
Ciao! Non posso escludere che l'uso fraudolento di una matrice possa essere avvenuto, soprattutto se tale matrice è in mani private ..... chi lo sa? Nel qual caso la bolla prodotta sarebbe indistinguibile dall'originale (forse facendo analisi sul piombo usato si scoprirebbe la magagna). Dal testo di Bescapè si legge al riguardo: "Alla morte del Doge il Bollatore (funzionario che sovrintendeva alla bollatura dei documenti) doveva spezzare le matrici della bolla dogale e anche l'anello-sigillo personale del defunto e consegnare i frammenti alla famiglia per garanzia". Nel Cerimoniale della Cancelleria Ducale, riguardo all'anello sigillo si legge: Annulus Domini ducis cum S. Marci imagine que ipsi duci vexillum tradit et litteris circum VOLUNTAS DUCIS , subito confringitur. Il Rizzoli ed il Cecchetti, riguardo alla distruzione di tali anelli, esprimono perplessità, giacché taluni sono arrivati a noi integri. Uno si trova al Museo Bottacin. saluti luciano1 punto
-
Taglio: 2€ Nazione: Irlanda Anno: 2011 Tiratura: 998.141 Condizioni: BB Città: Milano Taglio: 1 euro Nazione: Irlanda Anno: 2003 Tiratura: 2.455.700 Condizioni: BB Città: Milano Note: 2 monete Taglio: 1 euro Nazione: Irlanda Anno: 2007 Tiratura: 3.942.582 Condizioni: BB Città: Milano Note: 2 monete Taglio: 1 euro Nazione: Irlanda Anno: 2011 Tiratura: 1.094.970 Condizioni: BB Città: Milano Taglio: 1 euro Nazione: Irlanda Anno: 2013 Tiratura: 966.472 Condizioni: BB Città: Milano1 punto
-
Buonasera Gennydbmoney, moneta visionata di persona , le posso garantire che al verso tra la R ( di T O R ) e ( N E S I ) vi è la scritta (anche se evanescente e le foto non aiutano molto) " T O R " a caratteri più piccoli corrispondenti a quelli del. 6 tornesi della Repubblica Napoletana. oltre alla ribattitura che precede la sigla P, il punto in incuso dietro di essa. (sembrerebbe un colpo di punteruolo ,ma non lo è). purtroppo il tentativo maldestro di pulizia ha penalizzato molto la moneta. per me è un gran pezzo di storia. saluti Michele1 punto
-
LIBERAZIONE DI VENEZIA, VESSILLO DI VITTORIA D/ INDIPENDENZA ITALIANA - al centro Leone di S. Marco alato, seduto con la zampa sinistra sulle tavole del vangelo PAX / TIBI / MAR / DE - EVAN / GELI / STA / MEVS R/ VESSILLO DI VITTORIA 1848 - al centro Croce raggiata, trilobata Bronzo, mm 25,71 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?








.thumb.jpg.ae694d43dad26808f483a70d749ce2f0.jpg)