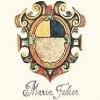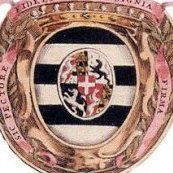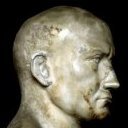Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 12/30/20 in Risposte
-
Scusate l' --------- ma penso che sia lei il mio migliore acquisto per il 20207 punti
-
Grano Cavalli 1790 A P Moneta che già avevo, ma ho deciso di riportarla a casa da Tenerife.6 punti
-
Con Giovanna II, comincia la decadenza degli Angioini; la Regina, pur avendo avuto una vita licenziosa, non aveva avuto figli, per cui in un primo tempo adottò Alfonso V d'Aragona, per poi pentirsi. Ma, ormai, il guasto era stato fatto, il Regno di Napoli, divenne nuovamente teatro di una guerra civile tra la fazione angioina e quella aragonese che, alla fine, uscì vincitrice: Per le vicende storiche, rimando a quest'ottimo articolo pubblicato sul Portale del Sud http://www.ilportaledelsud.org/alfonsoI.htm Con Alfonso d'Aragona Napoli visse un periodo di rinascita Ad Alfonso successe il figlio illegittimo Ferdinando che trovò la fiera opposizione papale e della fazione angioina da sempre presente nel Regno: https://cosedinapoli.com/curiosita/la-congiura-dei-baroni/ Tra gli elementi di spicco della fazione angioina vi fu Cola Monforte, conte di Campobasso https://www.treccani.it/enciclopedia/cola-di-monforte_(Dizionario-Biografico)/ che coniò, come già detto da @fedafa, un denaro tornese ad imitazione di quello della Grecia Franca Tempo fa @odjob fece a Campobasso una bellissima mostra su tale monetazione.5 punti
-
Riuscii a fare la mostra appena in tempo,prima che vi fu il lockdown per covid(dal 15 gennaio al 5 febbraio vi fu la mostra ed il lockdown iniziò appena un mese dopo la conclusione della mostra).Ad aprile- maggio di quest'anno sarebbe dovuta partire un'altra mostra insieme all'Archivio di Stato ma è tutto fermo per COVID:aspettiamo tempi migliori. Bella giornata fu quella,bella anche perchè senza mascherine. Approfitto per pubblicizzare il mio BLOG che ho dato vita da pochissimi giorni:intendo inserirvici contenuti spessissimo. https://numismaticameridionale.altervista.org Salutoni odjob4 punti
-
Buonasera! Questo è forse il miglior acquisto del 2020. Quarto di scudo della croce coniato a Venezia sotto il dogado di Marco Foscarini. Q fdc. E con pedegree importante. Ex collezione Zoppola e ex collezione Gnecchi, asta Hamburger 1903. Patina di medagliere su fondi lucenti. Non particolarmente raro, (R2) ma moneta molto intrigante. Non se ne vedono molte di questa conservazione. Saluti.4 punti
-
Personalmente, dei tre pezzi aggiunti quest'anno in collezione, reputo questo come il migliore per rarità e stato di conservazione. Trattasi della medaglia premio alle alunne dell'Istituto Salesiano in argento, un esemplare che cercavo già da tempo e che nel 2019 mi sfuggì di mano nella celebre asta NAC Varesi.4 punti
-
salve a tutti, quest'anno ho fatto pochissimi (4 monete....) acquisti ma tutti di grande rarità.....sono indeciso perchè mi piacciono tutte in quanto acquisizioni "fuori dalle aspettative"...... quindi posto quella con la più alta conservazione di cui non ho alcun passaggio in asta o listini di vendita (se qualcuno l'avesse prego segnalarmelo...) : Lira di Bologna da 20 Bolognini, Sede Vacante 1730. Auguri a Tutti Daniele4 punti
-
Il denaro tornese... una moneta particolare e con caratteristiche iconografiche invariate nel tempo nonostante fosse coniata in diverse zecche e per molto tempo (considerando anche le numerose contraffazioni). Forse proprio questo immobilismo iconografico ha fatto sì che il più delle volte essa venga "snobbata" dai collezionisti... ed in parte anche dagli studiosi. Eppure si tratta di un nominale molto importante per il nostro Meridione dove ha circolato tranquillamente e per molto tempo. I motivi della sua presenza sono molteplici ma sicuramente il motivo principale va ricercato nel fatto che, trattandosi di emissioni anche a nome dei sovrani angioini, sicuramente otteneva quel grado di "ufficialità" che ne permetteva lo scambio sul suolo italico. Un motivo ulteriore e non secondario fu certamente anche il fatto, concordando con quanto scritto dalla Travaini (Denari "tornesi" nella circolazione monetaria dell'Italia meridionale tra XIII e XV secolo), che questa moneta andò a trovare posto tra il carlino d'argento ed il denaro gherardino facilitando di molto gli scambi commerciali. Sotto Carlo I d'Angiò, infatti, i denari tornesi venivano scambiati al numero di 20 per tarì (Soluta est pecuniain tournensis parvulis ad rationem tornnensium 20 pro tareno) quindi con un controvalore per denaro tornese pari ad un grano. Appare quindi evidente la comodità di avere in tasca una moneta che, pari al valore del grano, poteva essere scambiata al numero di 10 pezzi per un carlino mentre per lo stesso carlino, a partire da Carlo II, necessitavano almeno 60 denari gherardini. Un nominale tra l'altro che proprio sotto Carlo II si cercò di battere anche a Napoli, assieme alla sua metà ed al suo quarto... coniazione che però pare sia rimasta sulla carta. Tra alti e bassi nei cambi comunque la presenza di questo nominale nella circolazione monetaria del Regno è sempre documentata durante il periodo angioino ed il fatto che durante la congiura dei baroni (quindi periodo aragonese) uno dei ribelli al sovrano (Cola di Monforte conte di Campobasso) sceglie di battere questo nominale fa supporre che questa moneta circolasse ancora nei territori regnicoli. Una moneta forse immeritatamente poco considerata ma che ha tutto il diritto di essere annoverata fra quelle presenti e circolanti nel Regno di Napoli. Complimenti ad Eliodoro per il pezzo che si presenta con una conservazione di molto superiore alla media. Perfettamente leggibile ed integra.4 punti
-
REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE II° - 20 LIRE 1868 TO3 punti
-
3 punti
-
Secondo Pedroni (Ricerche sulla prima monetazione di Roma, 1993), queste monete rispondono invece all’esigenza di emettere nominali che, alla data a cui vengonpo emessi, siano compatibili per peso sia con la metrologia romana che con le coeve emissioni magno-greche o siceliote. Ad esempio, TORO/ROMANO era una litra da 8,9 scrupoli, ma corrispondeva anche all’incirca a 1/32 dell’asse coevo, che pesava 288 scrupoli. TORO/PΩMAIΩN si daterebbe al 339/338, sulla base di un confronto ponderale con emissioni neapolitane, e costituirebbe un’emissione isolata, per i commerci dei cittadini di Capua (forse appena fatti civites sine suffragio) con il capoluogo partenopeo; ne deriverebbe "l’ipotesi senza dubbio affascinante che vedrebbe nella presenza romana in Campania, attestata formalmente da quel momento, l’impulso all’emissione da parte di Neapolis di monete bronzee”. Successivamente, le emissioni sono espresse in litre e si susseguono una all’anno, ciascuna associata a una didracma (bronzo e argento sono coniati nella medesima zecca). L’ordine è: - 275 a.C. PROTOME (mezza litra di 4,5 scrupoli) con la didracma Marte/protome equina (RRC 13/1), entrambe coniate a Metaponto. Contemporaneamente veniva emesso l’asse fuso di 288 scrupoli, Giano e Mercurio (RRC 14/1), per cui la mezza litra valeva 1/64 dell’asse; - 274 a.C. TORO/ROMANO (litra di 8,9 scrupoli) con la didracma Apollo/cavallo con stella (RRC 15/1), entrambe coniate ad Arpi; - 273 a.C. LEONE (litra di 8,9 scrupoli) con la didracma Ercole/lupa (RRC 20/1), entrambe coniate a Eraclea; - 272 a.C. AQUILA (doppia litra di 16,8 scrupoli) con la didracma Roma/Vittoria (RRC 22/1), entrambe coniate ad Alessandria d’Egitto. Dovrebbe essere contemporaneo l’asse fuso Roma/Roma, che presenta un peso medio di 240 scrupoli; tuttavia l’autore ritiene che si trattasse di un peso ribassato rispetto allo standard allora in vigore, pari a 252 scrupoli per asse, talché la doppia litra verrebbe a valere 1/15 di asse. Nel 269 le emissioni si spostano alla neoistituita zecca di Roma. La legenda cambia allora dal genitivo plurale al nominativo e i nominali non sono più attagliati sulla litra, ma su frazioni dell’oncia. PROTOME/FALCETTO è una mezza quartoncia (1/96 di asse di 252 scrupoli) ed è stata emessa con la didracma Marte / cavallo con falcetto (RRC 25/1). Si data, appunto, al 269 a.C. Il simbolo caratterizzante di questa serie, il falcetto, allude forse a Reggio (per il fatto che era stata fondata da coloni provenienti da Messana-Zancle), il cui bottino potrebbe essere stato monetato per ottenere questa emissione. Anche CAVALLO è una mezza quartoncia (1/96 di asse di 252 scrupoli) ed è stata emessa con la didracma Apollo / cavallo (RRC 26/1) e l’asse fuso Apollo / Apollo con ghianda (RRC 26/5). È forse databile al 264-263 a.C., in concomitanza con la liberazione di Messana dai Mamertini (la ghianda era simbolo di marte, quindi dei Mamertini). CAVALLO/CLAVA presenta un peso standard di 2,6 scrupoli; si tratta quindi di una mezza quartoncia (1/96 di asse di 240 scrupoli - teorico 2,5 scrupoli) e appartiene alla celeberrima serie della proro, il cui asse fuso reca per la prima volta il tipo di Giano (RRC 35/1), datata al 258 a.C. Alla stessa serie appartengono due nominali anonimi, PEGASO/CLAVA che presentando uno standard ponderale di 6 scrupoli corrisponde a 1/40 di asse e PEGASO/ARCO di 3 scrupoli, quindi 1/80 di asse. L’anomalia consiste nel fatto che i sottomultipli dell’asse si calcolavano su base duodecimale, non decimale; probabilmente queste monete furono emesse per adeguarsi alla metrologia di un’area recentemente conquistata, forse i territorî punici in Sicilia occidentale. CANE presenta un peso medio di 1,5 scrupoli che potrebbe rappresentare, per arrotondamento, un quarto di quartoncia (1/192 di asse di 240 scrupoli - teorico 1,25 scrupoli) o più probabilmente un terzo di quartoncia (1/144 di asse di 240 scrupoli - teorico 1,66 scrupoli). Si colloca probabilmente in serie con l’asse fuso Roma/ruota (RRC 24/3) datato al 252 a.C. Il cane in particolare potrebbe richiamare le origini puniche di una città conquistata, forse Panormo, o rinviare alla sconfitta di Segesta (sulle cui emissioni esso rappresentava il simbolo cittadino), conquistata nel 260 dalle truppe di C. Duilio. La SERIE COLLATERALE costituisce infine un’emissione a sé stante del 217 a.C., in occasione dei Ludi Maximi.3 punti
-
Quindi quella moneta non è una prova scientificamente accettabile. È rimarchevole il fatto che in una ventina di anni, in epoca moderna, si sono accumulate, per distrazione, sciatteria se non malafede, una serie di conclusioni che hanno portato a considerare per acquisita una evidenza che non lo era. Pensiamo cosa può essere successo in duemila anni alla definizione della data da parte di Plinio.3 punti
-
Senza avere la pretesa di essere il solo possessore della Verità, vi dico il mio punto di vista sulla terminologia relativa al conio ed alla moneta. Per il conio secondo me (con riferimento alla moneta postata da un Carlino 1834) il termine più corretto è quello usato da @Rocco68 , cioè conio lesionato. Una piccola lesione sul conio madre ha causato il difetto sulla moneta in questione. Il conio fratturato dovrebbe comportare, in teoria, difetti più macroscopici (sempre che sia ancora adatto alla coniazione). Con il conio rotto, invece, a rigor di logica, non si può produrre nessuna moneta, quindi mi sembra il termine meno corretto. Con riferimento alle monete in generale ii termine taglio e contorno sono equivalenti ed entrambi corretti e si riferiscono (cito Gigante) "alla parte esterna circolare, compresa tra le due facce, che costituisce lo spessore della moneta". Il termine bordo, che pure è usato per indicare la stessa parte della moneta, dovrebbe indicare più genericamente il margine esterno della moneta.3 punti
-
Le prove, o diciamo solo gli elementi, che collocano l'eruzione al 24 ottobre del 79, piuttosto che al 24 agosto sono molteplici. Dal famoso graffito a carboncino alla presenza di frutti autunnali, di frutti estivi secchi, del mosto già preparato, ai braceri accesi... Il denario di Tito sembra invece essere stato classificato in maniera errata, come dimostra l'ottimo articolo, che riporto sotto, di Umberto Moruzzi: https://www.cronacanumismatica.com/verita-numismatica-e-fake-news-esiste-la-moneta-che-riscrive-la-data-delleruzione-del-vesuvio/3 punti
-
Complimenti a voi tutti per le splendide monete. Mi permetto di partecipare a questa discussione anche se mi sto appassionando alla numismatica da due mesi o poco più e, al momento, sto imparando come distinguere il falso dal vero ? So che ha tante ferite e difetti ma, ciononostante, vi mostro la mia Civetta:3 punti
-
E' dagli anni Settanta che è ampiamente dimostrato che la datazione tradizionale pliniana è sbagliata, e tra i documenti inconfutabili c'è il ritrovamento numismatico del denario di Tito. Se trovi una moneta emessa a settembre, è semplicemente impossibile che il sito sia stato sigillato ad agosto, non si scappa. E i paleografi hanno dimostrato come l'errore non sia stato di Plinio - che ovviamente sapeva benissimo che l'eruzione era avvenuta a ottobre - ma con tutta probabilità sia dovuto a un copista che ha trasmesso il testo nel medioevo.3 punti
-
La moneta di @Rocco68 sembra avere la cifra 3 della data un po' più grande o comunque diversa. Posto il mio 5 Tornesi 18433 punti
-
Io quest’anno sono riuscito a prendere questo triente della serie semilibrale anomala Crawford 39/1: in asta passa di rado e quasi mai in conservazione accettabile e prezzo accessibile. La trovo una moneta affascinante come del resto tutta la serie. Mi manca ancora il quadrante.3 punti
-
Buonasera a tutti, anche se di scarsa conservazione posto anche il mio esemplare se può essere utile. ? Saluti Alberto3 punti
-
Bella moneta @Rocco68 per confronto posto la mia, molto più modesta. Buona Serata3 punti
-
Buongiorno, condivido una moneta di Carlo di Borbone: Piastra da 120 Grana "Sebeto" 17343 punti
-
Esistono differenti teorie sull’interpretazione della cosiddetta monetazione romano-campana in bronzo, un insieme di monete (la maggior parte, monetine) che costituiscono il primo bronzo coniato di Roma. Per discutere di queste monete tralasciando la classificazione di Crawford, che a causa della sequenza numerica potrebbe a volte disorientare, vorrei assegnare loro dei nomi convenzionali basati sul tipo del rovescio. Propongo allora di elencare così le monete: Con legenda al genitivo plurale (PΩMAIΩN o ROMANO) TORO/PΩMAIΩN apollo / toro androposopo (RRC 1/1, 17-18 mm, 2,22-4,85 g, https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-RC/1) TORO/ROMANO Minerva / toro androposopo (RRC 2/1, 19 mm, 6,14 g, https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-RC/2) LEONE testa femminile / leone (RRC 16/1, 17-26 mm, 5,39-13,73 g, https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-RC/6) PROTOME Minerva / protome equina (RRC 17/1, 16-18 mm, 2,64-8,57 g, https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-RC/7) Esiste una variante con Marte non censita in RRC (18 mm, 8,4 g; vd. Pietro Luigi Garavelli e Alessandro Vanni, Una inedita litra romano-campana, “Panorama Numismatico” 2013) AQUILA Minerva / aquila (RRC 23/1, 25-29 mm, 12,8-19 g, https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-RC/10) Con legenda al nominativo singolare (ROMA) PROTOME/FALCETTO Marte / protome equina e falcetto (RRC 25/3, 15-16 mm, 2,34-4,22 g, https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-RC/13) CAVALLO Apollo / cavallo (RRC 26/3, 15-16 mm, 2,4-4,14 g, https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-RC/16) CANE Roma / cane (RRC 26/4, 11-12 mm, 1,07-2,35 g, https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-RC/17) CAVALLO/CLAVA Marte / cavallo e clava (RRC 27/2, 15-18 mm, 2,44-4,05 g, https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-RC/19) PEGASO/CLAVA Ercole / Pegaso e clava (RRC 27/3, 18-20 mm, 4,2-8,3 g, https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-RC/20) PEGASO/ARCO Ercole / Pegaso e arco oppure sigma (RRC 27/4, 16 mm, 3,27-3,63 g, https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-RC/21) SERIE COLLATERALE (RRC 39, http://numismatica-classica.lamoneta.it/cat/R-RRB12) Preciso, per chi è meno tecnico, che nel prosieguo parlerò di: - “scrupoli”, misura peso romana. Equivaleva a 1/288 di libbra “classica”; essendoci incertezza su quest’ultima, si discute se pesasse 1,125 g oppure, come i pi a.C. ritengono, 1,137 g; - “litre”, nominale siceliota (in Magna Grecia si usava dividere lo statere in 12 oboli, in Sicilia in 10 litre). Sappiamo che durante la guerra pirrica l’obolo magno-greco pesava 7,33 scrupoli, per cui nella medesima data la litra doveva pesare 8,9 scrupoli.2 punti
-
Ciao a tutti. L'acquisto (in senso lato, essendo un regalo) migliore del 2020 per me è questo!2 punti
-
2 punti
-
2 punti
-
Ho seguito con attenzione il documentario, trovandolo un esempio lodevole (e per me davvero appassionante) di divulgazione scientifica in merito a ricerche tuttora in corso: un documentario non scolastico, che a mio giudizio aiuta un pubblico medio colto a farsi un'idea del lavoro dell'archeologo. Peraltro i reperti artistici (mosaici e dipinti) portati alla luce sono davvero eccezionali. Complimenti al dott. Osanna e agli archeologi della sua équipe.2 punti
-
2 punti
-
Ormai sapete come prendermi per la gola... Appena citato il denaro tornese di Cola Monforte ecco che eliodoro ce ne propone uno. Una moneta "ribelle" coniata in gran quantità per poter affrontare le spese di guerra ma in pratica a corso forzoso essendo coniata con una lega a bassissimo contenuto di fino e sbiancata per ingannare chi la usava. Lo dimostrano gli esemplari giunti fino a noi che spesso ancora portano i segni della sbiancatura ma che, a causa della cattiva lega, si mostrano con tutti i segni dell'età. Ma la prova che anche all'epoca queste monete venissero poco apprezzate lo troviamo in una lettera di Antonio da Trezzo, ambasciatore a Napoli per gli Sforza, che scrive a Francesco Sforza nell'ottobre del 1461, in piena congiura: "Lo conte de Campobasso già ha facto instantia de andarsene et così Jacomo Galiota et Jacopuzo da Montagano, perché non hanno portato altra moneta che tornesi novi, li quali esso Conte per forza faceva spendere in le terre sue et qua non ne possono alcuno, per il che già se è fuggito una grande parte della fanteria che menò con sé esso conte". Avendo questi condottieri ai loro ordini truppe mercenarie è facile immaginare come questi soldati, essendo pagati con moneta che non potevano utilizzare, preferissero abbandonare il campo di battaglia. Discorso diverso invece per i territori sotto il dominio del Monforte dove questi denari venivano fatti circolare per forza... Magari sarà stato proprio quest'obbligo di circolazione forzosa imposto dal conte Cola a favorire poi il perdono concesso da Ferdinando I d'Aragona: " ...in tempo et sub dominio de lo excellente signor Conte Cola de Campobasso sono stati soi officiali presertim tempore presentis guerre, tenore presentis capituli concedere venia indulgentia ita quod presens capitulum sit eis et uniquique ipsorum plenissimum et autenticum indultum et plenissima remissio de omni et singulo delicto malefitio crimine et omicidio etiam de crimine lese maiestatis in primo secundo sive tertio capite per ipsi o alcuno de ipsi commissi consentuti et partecipati et similiter de le false monete et denari quovismodo per ipsi prenominati facti, cugnati et expesi, non obstante quod de torniensibus alias factis penes aliquos adhuc quantitas aliqua reperiatur et forte in futurum reperiretur..." (da G. Scaramella, Un privilegio Aragonese a favore di Campobasso, Maddaloni 1902). Non fu solo Campobasso a battere denari tornesi ma la loro produzione nell'area molisana pare si sia divisa in diverse zecche (qualcuna itinerante?) e recenti scoperte proprio su questi nominali non mettono ancora la parola fine al loro studio. Un ultimo pensiero alla già citata mostra realizzata a Campobasso da @odjob. Un progetto realizzato da chi ama il proprio territorio ed ha cercato di divulgarne la storia attraverso le monete. Io ed Eliodoro fummo suoi ospiti e ci fece anche da guida nel visitare la città, castello compreso. Ovviamente con l'immancabile pranzo a base di prodotti locali... la buona tavola è una caratteristica che accomuna tutti i Numismatici.2 punti
-
Come ho già detto moltissime volte, l’impressione fotografica lascia sempre molti dubbi (specie su monete di un certo peso). Io vedo hairlines da pulitura nei campi, avvalorato da un netto cambio di colore tra la zona della legenda e il campo aperto. Francamente non mi fa una bella impressione, e credo che ci sia stata, più che poca oculatezza nella scelta, solo tanta fretta di acquistare: questa serie è sempre afflitta da molti segni di contatto, e visti gli importanti acquisti già fatti, al tuo posto avrei selezionato questo pezzo con maggiore attenzione. Anzi, a dirla tutta, al tuo posto invece di mettere mano agli acquisti avrei speso un po più di tempo nel capire alcuni concetti valutativi che mi sembra ancora non siano stati recepiti.2 punti
-
2 punti
-
2 punti
-
2 punti
-
_________________________________________________________________________________________________ Secondo voi posso lavarla e stirarla? _________________________________________________________________________________________________ Le banconote non si lavano e non si stirano mai! _________________________________________________________________________________________________ @nikita_ ...in questo specifico caso però poi puzzano…! _________________________________________________________________________________________________2 punti
-
2 punti
-
Grazie mille @mariov60, speravo proprio in un tuo intervento, che come sempre si è rivelato molto interessante! In effetti con così poche informazioni e senza poter avere nemmeno una foto di altri esemplari simili, considerare la mia moneta un'inedito solo per la legenda potrebbe essere esagerato, tenendo conto in particolare di quanti errori venivano commessi all'epoca nella zecca modenese. Grazie anche per i complimenti, ho avuto la fortuna di scovare questa monetina in un lotto di monete tutte in bassa conservazione... a breve aprirò una nuova discussione per chiedere informazioni su un sesino di Francesco I particolare... spero potrai intervenire anche lì! Intanto grazie e buon anno!2 punti
-
2 punti
-
Mai sentito "rottura di conio" in 30 anni sempre "frattura di conio". Comunque il senso è quello. https://www.erroridiconiazione.com/c-1-frattura-del-conio/2 punti
-
Basta postare delle foto decenti e ben a fuoco. Ma della moneta, non dell'asse. Per identificare l'asse c'è il falegname.2 punti
-
2 punti
-
2 punti
-
Buona sera Collezionisti, studiosi o semplici visitatori. Napoletana di oggi è questo 5 Tornesi 1843 di Ferdinando II. Che io sappia questi conii del 43 non dovrebbero avere varianti. Un caro saluto a tutti voi, Rocco.2 punti
-
1 punto
-
Buonasera ai Medaglisti. Anche io conservo una medaglia della battaglia di Cassino, una commemorativa. La comprai molti anni fa in un mercatino, mi colpì subito e la portai a casa, la pagai poco. Ho visto che su ebay ogni tanto ne esce qualcuna, sembra che sia molto simile a quella del 44. Cosa ne pensi? @sandokan1 punto
-
È vero...il peso non corrisponde. Ma non sono convinto neanche della segnalazione di ALEXANDR5555. L'obolo dell'Istria è comunque con 2 facce diverse e distinte, mentre la mia ha su entrambi i versi la stessa croce... Finirò l'anno con questo dubbio?? A tal proposito, un buon inizio a tutti voi.1 punto
-
Per prima cosa, ringrazio l'amico @Hirpini per la considerazione ? A dire il vero, non mi è mai capitato di vedere qualcosa del genere e sarei quasi tentato a pensare a qualcosa di fantasioso, tuttavia sotto il monogramma IHS mi sembra di scorgere una data, 1665 e questo in relazione alla lettera A e i numeri VII (I?) nel campo dell'altro lato, potrebbe avere un senso.....infatti Papa Alessandro VII nel 1665 era ancora papa. In ogni caso, se originale, sembrerebbe una produzione artigianale che difficilmente avrebbe riscontri. Per curiosità, forse @Carinto782 potrebbe indicarci il materiale di cui è composto, perchè dalla prima foto sembra rame o sua lega, mentre nella seconda sembrerebbe piombo.1 punto
-
Buongiorno, per passare meglio questo periodo di fine anno (visto che devo stare a casa), due settimane fa, ho comprato a peso un grande accumulo di monete varie, straniere, italiane e vaticano. Con mia grande sorpresa, spulciando a una a una, tra le tante monete "da ciotola" è saltata fuori questa da 50 centesimi 1943.... Vorrei condividere con voi questa (inaspettata) botta di fortuna...di fine anno.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Ciao @Numismatico 007 e ciao a tutti,colgo l'occasione per rifar gli auguri e ripostare( è giá presente nella discussione "una napoletana al giorno")questa bella Piastra 120 grana Ferdinando ll,regalo di Natale di mia moglie! Salutoni ??1 punto
-
Ciao, anno, numismaticamente parlando, molto interessante. Il mio miglior acquisto 2020 è stato sicuramente il tempo dedicato a studiare, osservare, leggere, ascoltare persone esperte e preparate. E, soprattutto, il capire come leggere le monete. Questo mi ha permesso di collezionare esemplari che considero tutti miei preferiti. Se devo condividere una moneta, quindi, vado in ordine puramente cronologico e scelgo l’ultima entrata, link: 60 Grana Complimenti per i vostri acquisti presenti in questa discussione!1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?





copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)

.thumb.jpg.49bf7893ab8deb0b9efbfc02c41b7421.jpg)