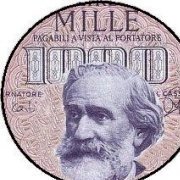Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 02/16/21 in Risposte
-
Come accennato nella mia precedente discussione ([una moneta e una storia] Maxentivs pro Vrbe Sva - Monete Romane Imperiali - Lamoneta.it - Numismatica, monete, collezionismo), lo scontro tra Massenzio e Costantino fu presto inevitabile ed avvenne al Ponte Milvio, il 28 ottobre del 312. La vittoria, come sappiamo, arrise a Costantino. Massenzio, sconfitto, vi perse la vita. Il crollo finale del regime di Massenzio possiede una eccezionale testimonianza archeologica: la scoperta nel 2005 delle sue insegne imperiali sul colle Palatino, dove furono sepolte dagli sconfitti per impedire che finissero nelle mani dell’odiato nemico. Sono conservate presso il Museo Nazionale di Palazzo Massimo, a Roma. Io ho avuto la possibilità di vederle dal vicino in occasione della mostra “Costantino 313” tenutasi al Palazzo Reale di Milano nel 2013 per commemorare il cosiddetto “Editto di Milano”. Sono splendide, in particolare lo scettro con il suo bel globo verde. Dopo Ponte Milvio, Costantino (in parallelo con le azioni volte consolidare il suo dominio) si applicò coscientemente per soppiantare Massenzio nel cuore dei Romani con una oculata campagna propagandistica. Non deve quindi stupire che Costantino sia ricorso al più potente strumento allora disponibile: le monete. Il RIC VI riconosce tre monete, tutte coniate a Roma nel 313: la 303, la 304 e la 312. Vediamole nel dettaglio. Cominciamo dalla 303 e 304: Si tratta di due monete aventi al rovescio la legenda LIBERATORI VRBIS SVAE: Ecco la 303: Della 304 non ho trovato una immagine (magari qualcuno di voi mi può aiutare). Essa si distingue dalla 303 in quanto il busto di Costantino e’ laureato, drappeggiato e corazzato (E) anziché solo laureato e corazzato (D); inoltre la 304 e’ stata coniata dalla 3^ officina (T), mentre la 303 dalla seconda (S). Tuttavia, sono noti esemplari “non in RIC”: Questa e’ la RIC VI 303 ma della terza officina (T): Ed ecco la RIC VI 304, ma seconda officina (S): Ed ora passiamo alla RIC VI Roma 312: Qui il rovescio e’ dunque RESTITVTOR VRBIS SVAE Queste monete LIBERATORI VRBIS SVAE e RESTITVTOR VRBIS SVAE sono strettamente collegate alla serie CONSERV URB SVAE di Massenzio. Tuttavia, mentre il dritto e’ logicamente cambiato (ora vi ci appare l’effigie di Costantino), il rovescio e’ lo stesso (sempre la dea Roma seduta dentro un tempio), ma con una legenda del tutto diversa: LIBERATORI VRBIS SVAE alternato a RESTITVTOR VRBIS SVAE, che identificano senza ombra di dubbio Costantino come vincitore del tiranno (“liberator”) e come restauratore (“restitutor”) della pace e della giustizia nella città di Roma, ora identificata come “sua”, nello stesso modo che aveva usato Massenzio nella sua serie (in cui si era identificato come “conservatore”, “protettore”). Particolare il fatto che entrambi i tipi siano stati coniati a Roma nel 313; probabilmente furono emessi per il consumo immediato del popolo di Roma: il messaggio doveva essere forte e chiaro. Con Costantino le parole non sono mai banali. Le parole “liberatori” (addirittura al dativo, una vera e propria dedica) e “restitutor” rappresentano appieno lo sforzo del vincitore di rappresentare il suo rivale Massenzio non come un mero usurpatore, ma come un tiranno dal quale il Senato ed il popolo romano erano stati liberati. E’ una differenza sottile, ma non da poco. Allarghiamo ora per un attimo un po’ il discorso. E’ da notare come, di pari passo alla produzione delle serie succitate da parte della zecca di Roma, anche altre zecche abbiano prodotto monete volte ad enfatizzare lo stesso tema. Ecco allora i tipi : ROMAE AETER AVGG di Londinium (es. RIC VI 269): ROMAE RESTITVTAE: sempre Londinium (es. RIC VI 272): RECVPERATORI VRB SVAE di Arelate (es. RIC VII Arelate 33): Anche queste produzioni terminano presto. Si chiude, infatti, nel 315 con il tipo RESTITVTORI LIBERTATIS da dalle zecche di Ticinum e Treviri: RIC VII Treveri 23: e’ in bianco e nero, ma e’ un solido RIC VII Ticinum 31: solido anche qui Come detto sopra, in Costantino nulla e’ casuale, anche la scelta di queste ultime zecche. La scelta di Londinium potrebbe essere legata (questo e’ un mio pensiero) al forte legame con la Britannia. Basti pensare che, alla morte del padre Costanzo Cloro, furono proprio le truppe di stanza ad Eburacum a nominarlo addirittura augusto nel 306. Quanto a Ticinum , in realtà significa Mediolanum dove Costantino si recò dopo aver lasciato Roma. Proprio a Mediolanum, nel febbraio del 313, si celebrò il matrimonio tra la sorellastra Costanza e Licinio, che sancì l’alleanza tra i due augusti. Fu poi in quella sede ed in quella occasione che fu promulgato il cosiddetto Editto di Milano, che fu stabilito il nuovo assetto dell’impero e che fu programmata la guerra contro Massimino Daia. Non dimentichiamo poi il ruolo che la città aveva avuto come capitale occidentale durante la prima Tetrarchia ed anche la sua posizione strategica. Quanto a Treviri, sappiamo che fu a lungo capitale imperiale dove Costantino risiedette come Cesare e dove svolse una intensa attività edilizia, a dimostrazione del forte legame con questa città. Ricordiamo, a titolo di esempio, la Basilica Palatina: Ma a Treviri tornò anche dopo aver lasciato Milano per affrontare una campagna contro Franchi e Germani e vi celebrò anche i decennalia del regno, proprio nel luglio del 315. Quanto ad Arelate, ricordiamo che proprio Costantino vi aveva trasferito la zecca di Ostia (se ne e’ già parlato). Come detto, Costantino lasciò Roma nel gennaio del 313. Il brevissimo lasso di tempo trascorso in città fa emergere tutta la sua capacità di statista in grado di riconquistare la fiducia e il rispetto del Senato e del popolo romano con una vera transizione ideologico-religiosa (se così si può dire) , anche se certo la forza degli eserciti ebbe il suo peso (oltre che grande uomo di stato era anche un grande uomo di armi). Non dimentichiamo come Costantino fosse arrivato a Ponte Milvio, ovvero sotto l’egida dell’ ”In hoc signo vinces”, paladino di Cristo contro il pagano Massenzio. Se guardiamo alle monete su postate, però, non vi sono ancora simboli cristiani, ma addirittura c’e’ ancora un tempio pagano e una dea (anche se questa dea e’ Roma). Inutile dire quindi che, al momento della sua partenza, una tale radicale trasformazione non era stata ancora completata, anche se certamente era avviata nella giusta direzione. Ne e’ una ulteriore prova la costruzione dell’Arco ordinata dal Senato poco tempo dopo, nel 315: La cosa per noi interessante e’ nella iscrizione: Al centro dell'attico è presente la seguente iscrizione: «IMP(eratori) · CAES(ari) · FL(avio) · CONSTANTINO · MAXIMO · P(io) · F(elici) · AVGUSTO · S(enatus) · P(opulus) · Q(ue) · R(omanus) · QVOD · INSTINCTV · DIVINITATIS · MENTIS · MAGNITVDINE · CVM · EXERCITV · SVO · TAM · DE · TYRANNO · QVAM · DE · OMNI · EIVS · FACTIONE · VNO · TEMPORE · IVSTIS · REM-PUBLICAM · VLTVS · EST · ARMIS · ARCVM · TRIVMPHIS · INSIGNEM · DICAVIT ·» «All'imperatore Cesare Flavio Costantino Massimo Pio Felice Augusto, il Senato e il popolo romano, poiché per ispirazione divina e per la grandezza del suo spirito in una sola volta con il suo esercito ha vendicato lo Stato, per mezzo di una giusta guerra, sia dal tiranno che da ogni sua fazione, dedicarono questo arco insigne per trionfi.» Le parole chiave sono sicuramente INSTINCTV DIVINITATIS: Costantino ha vinto per “ispirazione divina”. Ma di quale dio? Non vi e’ ancora un accenno diretto al Dio dei Cristiani, anche se dietro lo si intuisce chiaramante. E’ ancora un po’ presto per una affermazione esplicita, ma e’ questione di poco. E poi colpisce anche la parola “DE TYRANNO”: come detto su, nella sua politica propagandistica, Costantino ha liberato Roma non da un semplice usurpatore, ma da un vero e proprio tiranno. Insomma, le parole sono pietre, nel vero senso della parola. Quanto alla attività edilizia iniziale, in riferimento all’area del foro, a Costantino (che trovò molti monumenti – o almeno i due principali, ovvero il tempio di Venere e Roma e la cosiddetta Basilica) non solo già progettati e strutturati, ma anche quasi del tutto conclusi o prossimi alla conclusione, non restò che eseguire sia l’eventuale e non precisabile completamento strutturale e decorativo sia, più probabilmente, la dedicazione o ridedicazione con il suo nome. Proprio nel periodo che seguì la vittoria su Massenzio, iniziò inoltre la costruzione della sua prima basilica, quella del Laterano. Si è molto discusso su questa collocazione ‘periferica’ della cattedrale. L’interpretazione più in voga è quella che mostra un Costantino assai prudente che non vuole urtare l’aristocrazia e la popolazione stessa, ancora in forte maggioranza pagana, e preferisce quindi inserire la cattedrale il più lontano possibile dal centro della vita pubblica, ove si trovavano anche molti luoghi sacri della religione pagana. O forse, più prosaicamente, la basilica era così grande che difficilmente poteva essere collocata nell’affollato centro cittadino? Della vecchia basilica, oggi resta il nucleo principale del cosiddetto Battistero Lateranense: In vicinanza, Costantino iniziò anche la costruzione del nuovo palazzo imperiale, chiamato Sessorium (sui resti del vecchio palazzo di Elagabalo agli Horti Spei Veteris) dove risiedette la madre Elena. Di esso rimangono i resti delle Teme Eleniane e il cosiddetto tempio di Minerva Medica, in realtà una splendida aula decagona con cupola. Vi era anche una chiesa (oggi chiesa di Santa Croce in Gerusalemme) che doveva contenere le reliquie di Cristo trovate dalla madre Elena in Terrasanta. Successivamente al periodo che ci interessa, Costantino effettuerà poi una intensa attività edilizia in senso “cristiano” che esula dalla attuale discussione. Per chi vuole approfondire alleghero’ una lettura. Fonti: - RIC volume VI - Constantine the Great-- History and Coins (constantinethegreatcoins.com) - Iconografia_di_Costantino.pdf - Roma_costantiniana.pdf Le_iconografie_monetali (1).pdf Ciao da Stilicho5 punti
-
Tornese 1833 Contrassegno stella a 6 punte Gigante n. 280 - Rarità R3 Magliocca n. 766 - Rarità R5 Postate le vostre monete da 1 tornese del 1833 e cerchiamo di capire insieme l'effettiva rarità di questa moneta. Non era presente nelle colleziezioni "Utriusque Siciliae" e "Civitas Neapolis".4 punti
-
4 punti
-
Egitto, scoperto più antico birrificio del mondo: ha oltre 5mila anni Un team di archeologi statunitensi ed egiziani ha scoperto il più antico birrificio del mondo, risalente a oltre 5mila anni fa, in una necropoli nel sud dell'Egitto. L'antichissima fabbrica di birra è stata scoperta ad Abydos, dove si trova un vasto sito funerario nel deserto a ovest del Nilo, a oltre 450km a sud del Cairo. Gli scavi hanno permesso di identificare finora una fabbrica della birra di vaste proporzioni, suddivisa in otto aree, ciascuna delle quali comprendeva circa 40 vasi di ceramica dove veniva contenuta la bevanda, utilizzata anche per riti funebri e sacrificali. L'annuncio dell'eccezionale scoperta è stato dato con un comunicato dal segretario generale del Consiglio supremo delle antichità dell'Egitto, Mostafa Waziri, precisando che gli archeologi hanno dichiarato che si tratta della "più antica birreria del mondo finora conosciuta". Il birrificio risale ai tempi del re Narmer, vissuto intorno al 3.125 a.C., noto anche come il faraone Menes, semi-leggendario primo unificatore dell'Alto e del Basso Egitto. La missione archeologica è diretta da Matthew Adams, egittologo della New York University, e da Deborah Vischak, docente di storia dell'arte antica egiziana alla Princeton University. L'archeologo Adams ha spiegato che le ricerche hanno dimostrato che la birra veniva prodotta su larga scala, con circa 22.400 litri prodotti alla volta. Con tutta probabilità, ha aggiunto, il birrificio venne costruito nella zona di Abydos per fornire la birra utilizzata nei riti sacrificali dell'epoca del faraone della prima dinastia. "Le prove dell'uso della birra nei rituali sacrificali sono state trovate durante gli scavi nelle sepolture di Abydos", afferma il comunicato del Consiglio supremo delle antichità dell'Egitto. https://www.adnkronos.com/egitto-scoperto-piu-antico-birrificio-del-mondo-ha-oltre-5mila-anni_6fVb5TvG15ziiAULSLylz4/amp.html3 punti
-
Nel riclassificare i sampietrini in mio possesso in particolare per il primo anno di quelli Roma, percio' 1795 busto a 3/4 mi e' saltata all'occhio questa differenza sia nella grandezza e nella forma del busto per quanto riguarda la variante PRNCEPS APOST. Facendo riferimento al Serafini che identifica(come dalle foto nelle tavole) il secondo pezzo nel 436(busto grande) e il terzo nel 433(busto medio) rimane inedita (per classificazione) la prima delle 3 che per praticita' indico come busto piccolo Attendo riscontri e impressioni a riguardo e per chi ne possedesse un'esemplare un censimento sull'incidenza di una o delle altre varianti Grazie2 punti
-
Buonasera a tutta la sezione, vi mostro l ultima entrata in collezione... Ferdinando l, 120 grana 1818 Reimpressa con 8 su 7 e giglio nel taglio...! Come tutti gli esemplari che ho potuto osservare e avere in collezione, presenta la classica debolezza su basetta e parte dei capelli... Reputo personalmente questo esemplare con questa variante 8 su 7, davvero in buona conservazione per la tipologia... Saluti, francesco...2 punti
-
Chiedo scusa se ritorno un attimo sui Mezzi Tornesi, ma la moneta è una new entry e mi è arrivata da pochi giorni. Si tratta del millesimo 1836 che presenta 2 anomalie: la prima è la data, mi sembra un "6" ribattuto sul "5". La seconda è la stella sotto il busto che risulta sfrangiata tanto da non capire se è una stella a 5 o 6 punte. Cosa ne pensate? Saluti a Tutti, Beppe2 punti
-
Era di sicuro questo esemplare. Mi mancava e lo cercavo da anni.2 punti
-
Buonasera @uragano, complimenti per questi 3 sampietrini 1795, non facile vederne più pezzi in un'unica raccolta ! Venendo ai busti, il secondo ed il terzo mi erano già noti, e più o meno anche dalle foto che ho in archivio si presentano con la stessa frequenza (il terzo l'ho denominato per comodità "collo lungo", tipo i marenghi di V.E. II :-) ). Il primo invece non l'avevo mai visto prima, quindi è ragionevole ritenerlo più raro degli altri. A vederlo, per fattura e proporzioni, è simile al busto del tipo "APOSTOLORVM PRINCEPS" (Muntoni 96), che è l'unico tipo di sampietrino senza chiavi; per logica deduzione può ritenersi il "prototipo" della tipologia... quindi magari questo tuo ne è una prima evoluzione. Ciao, RCAMIL.2 punti
-
2 punti
-
2 punti
-
1975 Germania federale - 5 marchi J 50° anniversario della morte di Friedrich Ebert, fu il primo Presidente della Repubblica di Weimar (1919-1925).2 punti
-
Enrico Catemario Duca di Quadri venne chiamato dal Re numismatico per revisionare i tre volumi del CNI dedicati alle zecche meridionali. Nel Corpus figurano 604 monete della sua collezione così suddivise (Fonte: Luca Lombardi, Numismatici e numismatiche: Memmo Cagiati): Catalogo di vendita della collezione del Catemario: Enrico Catemario Duca di Quadri (Fonte: BCNN, gennaio 1987-dicembre 1990, p. 10):2 punti
-
Grazie per i vari interventi.... Però riflettendoci, è davvero "ingiustificabile" la presa di posizione di un autore come la Westermark che ha curato la redazione del Corpus su Akragas. Mi rifiuto di pensare che non si sia accorta di questi due esemplari in un'asta importante qual è quella della serie delle Jacob Hirsch di Monaco. Faccio un parallelo su un'altra zecca siceliota, allegando l'immagine di un falso CON SIMBOLO RICREATO PER MESSANA. Nel suo magistrale Corpus la prof. Caltabiano è risoluta e maniacale nel curare la sezione dei falsi. SE PENSIAMO CHE SENZA MEZZE MISURE INSERISCE GIUSTAMENTE TRA I FALSI IL PEZZO DEL GULBENKIAN CON IL DIO PAN SULLA ROCCIA..... (per la serie che nessuna importante collezione è esente da falsi!) Se i due pezzi Hirsch con "Testa arcaica senza collo" e "lepre" devono considerarsi falsi, è probabile siano mano dello stesso "falsario" del messana con il polipo..... Odisseo2 punti
-
Personalmente non so come giustificare la mancanza di citazione dei due esemplari ex Hirsch 26/1910, ma la mia prima impressione è nettamente sfavorevole. Nono solo, come evidenziato da Vitellio, ci sono incongruenze sui rilievi, ma gli stessi simboli presentano stili semplicemente ridicoli. La testina del secondo esemplare sembra una invenzione e non ha nessuna attinenza con le varie testine già note per Akragas. Poi la lepre.... le sue zampe sono semplicemente ridicole. Quelle posteriori sembrano di Paperino e quelle anteriori sono dei moncherini... Resta il fatto che la Westermark non li abbia degnato di menzione, nemmeno tra i falsi. Non li ha presi in considerazione forse perché non li ha potuti vedere in mano....2 punti
-
Ciao @odisseo, Pensare che il grande Jacob Hirsch descrive questi due tetradrammi "inediti", mi fa pensare che lui, come tanti del suo tempo, non erano grandi competenti. E inimmaginabile associare una lepre corrente, quando la lepre sulle monete di Akragas è sempre una preda. La conchiglia (Pecten) non ha nessuna rassomiglianza su tutte le Pecten che sono rappresentate su tutte le monete coniate a Akragantion. Sull'altro tetradramma, la testa del giovinetto, sembra più un indigeno, che le testine rappresentate sui Didrammi. I globetti, non hanno nessun precedente su tetradrammi Siciliani. Evidentemente, in quei periodi di fine 800 e i primi del novecento, c'era la caccia alle monete "inedite". La fantasia di qualche falsario dell'epoca, avrà pensato a far contento qualche collezionista, che con il tempo, riconoscendole, non li hanno mai tirate fuori. Aggiungere dei simboli su un conio ottenuto da monete genuine ( come ha postato il bravo @Archestrato) e abbastanza facile per un modesto falsario, il difficile è stare dentro ai canoni, che sono determinanti a riconoscerli, come l'esempio sotto.2 punti
-
1 punto
-
Magnifica @Francesco1984, Sai su che moneta è stata reimpressa?1 punto
-
1 punto
-
DE GREGE EPICURI Io non ho nuove idee. Proviamo a spostarla in "provinciali", forse salta fuori qualcosa di più...1 punto
-
Complimenti per l’acquisto! Anche io avevo notato quel commerciante di Pesaro ed avevo provato a offrire per una decina di pezzi ma evidentemente sono stato eccessivamente micragnoso e mi sono ritrovato con un pugno di mosche ?♂️ Ce n’era una in particolare con un doppio timbro che mi aveva fatto innamorare ma è volata troppo in alto... complimenti ancora e grazie anche per le note storiche ??1 punto
-
Ciao @Rocco68 sono contento che sia finito in buone mani ? la rarità secondo te è giusta R5 ?1 punto
-
medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale, istituita con regio decreto 27 aprile 1936, n. 1150, fu una medaglia concessa dal Regno d'Italia a tutti coloro che avessero preso parte alle operazioni militari in Africa orientale compiute dall'esercito italiano tra il 1935 e il 1936. La medaglia è costituita da una disco di bronzo il ritratto di Vittorio Emanuele 3 rivolto verso sinistra col capo scoperto, il tutto attorniato dalla legenda: "VITT · EM · III · RE · D'ITALIA · IMP · DI · ETIOPIA · " (Vittorio Emanuele III Re d'Italia Imperatore di Etiopia). Sul retro si trova raffigurato uno scenario africano con monti e deserto affiancato sulla sinistra da un fascio littorio. In alto si trova la scritta: "AFRICA ORIENTALE", mentre sotto lo scenario si trova il motto: "MOLTI NEMICI, MOLTO ONORE", e la firma di Benito Mussolini. Il nastro è a strisce nere e blu e poteva essere sormontato da una spilla a forma di gladio fiammeggiante per quanti avessero ricoperto il ruolo di combattenti attivi durante la campagna di operazioni militari in Africa orientale. L'uso del "gladio romano" per i ruoli non combattenti fu abolito con il regio decreto-legge 23 luglio 1936, n. 1584[3], e poi nuovamente introdotto, ed esteso ad alcune categorie del personale civile, con il regio decreto 10 maggio 1937, n. 2463. Il valore ( anche se credo che Lei lo terrà ) solo la medaglia col nastro siamo sui 50 euro , con l'attestato annesso qualcosa in più. Saluti Marco1 punto
-
d'I battito? sì, nodale! DIBATTITO SINODALE Ciao da Stilicho1 punto
-
Buon pomeriggio a tutti, stavo sfogliando alcuni cataloghi nella mia biblioteca per alcune ricerche, tra i quali la vendita Jacob Hirsch XXVI del 1910. E' un'asta particolare perchè è l'unica (della serie delle Hirsch) che presenta due collezioni diverse in serie a seguire di greche (la prima di doppioni del Museo di Berlino ex coll. Lobbecke) e la seconda di amatore ignoto. Premetto che le "classiche" Jacob Hirsch, Naville Ars Classica, Egger etc....sono aste che avrò visto, rivisto e strarivisto decine e decine di volta la singola asta..... Nella seconda collezione mi accorgo di due tetradrammi di Akragas, sui quali confesso, forse per distrazione o sbadataggine, non avevo mai buttato seriamente l'occhio prima di oggi..... Presentano due simboli MAI VISTI.....uno con CONCHIGLIA TRA LE CHELE DEL GRANCHIO E LEPRE SOTTO, l'altro con TRE GLOBETTI A INTERVALLO TRA IL GRANCHIO E TESTA ARCAICA SENZA COLLO SOTTO.. Il GRANDE JACOB HIRSCH LI DESCRIVE ENTRAMBI COME INEDITI....e ci credo bene!!!!!!! Ho verificato sul Corpus di Akragas e la prof. Ulla Westermark non ne fa mai menzione, neppure tra i falsi/falsificazioni..... La difficoltà di trarre un giudizio sulla loro bontà sta nel fatto che sono foto tratte da calchi in gesso però, se osserviamo attentamente i particolari, bannarli come falsi non me la sento....anzi! Le rotture di conio sull'aquila del 369, la bellezza dei simboli, la naturalezza del modellato, i contorni dei moduli mi porterebbero a ritenerle buone...... Possiedo le principali pubblicazioni sui falsi (anche datati): Svoronos sul falsario Christodoulos, Becker, Caprara etc.....e non risultano censiti questi falsi per Akragas...... Sono curioso di vedere le opinioni dei Forumisti. Io sono appassionato da oltre 20 anni di monete greche e non mai visto esemplari analoghi ma mi chiedo al tempo stesso: possibile che ad oggi, 13 febbraio 2021, in una monetazione poderosa e voluminosa come Akragas abbiamo ancora degli unicum risalenti al 1910 e mai più apparsi? Come mai la Prof. Westermark (scuola Jenkins e quindi con una certa tradizione di impostazione delle opere) non li ha presi in considerazione neanche per citarli tra i dubbiosi o i falsi? Mi è sfuggito qualcosa? Saluti Odisseo1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Sulle rigature nei campi ti rimando alle foto che allego. Premesso che tramite una visione solo fotografica, per prassi "do sempre il beneficio del dubbio" nei miei commenti, ma il fatto che anche per un altro utente (tra l'altro molto preparato ) l'impressione sia stata la medesima, conferma la mia impressione iniziale. Se approfondirai questa materia, capirai come la tonalità del metallo è un indice molto importante per valutarne la conservazione ed eventuali impropri maneggiamenti, come appunto la pulizia. Questa infatti lascia al metallo una innaturale brillantezza, decisamente molto diversa da quella naturale, e questo a ogni livello conservativo.1 punto
-
Non so perchè, ma mi è venuta in mente la discussione sui periti e sulla diversa interpretazione da parte loro della conservazione... Arka Diligite iustitiam1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
La verità è che io cerco sempre il modo per far prevalere la fonte numismatica su altre fonti... Arka Diligite iustitiam1 punto
-
Hai ragione è un polipo stilizzato, la testa e diversa dalle seppie. Che strana invenzione........1 punto
-
Buona la seppia ! Ma.... hanno dieci tentacoli : due lunghi e 8 corti e che non si arricciano molto , la "testa" piuttosto attaccata ai tentacoli..... propendo per un polipo... rappresentato un po' così..... Mi è venuta fame......... ? =1 punto
-
1 punto
-
Ciao Giovanni @margheludo, che piacere risentirti! Innanzitutto grazie per gli esagerati complimenti ?. Sono solo un modesto collezionista e uno studioso alle prime armi e ho solo da imparare da tanti di voi. Andiamo con ordine. Non dar retta a quel burlone di @Asclepia, non sono un accumulatore seriale ?. La mia raccolta dei quattrini è praticamente completa, varianti comprese, e ormai cerco solo di alzare il grado di conservazione, nel qual caso mi ritrovo con qualche sporadico doppione. Se proprio ti interessa, mi mancherebbe solo il 2 con la variante SICIL·: invece che SICIL·· (un solo pezzo da me visto, ex Inasta 50 del 2013, sul quale però nutro qualche dubbio, almeno dall’unica foto disponibile. Bisognerebbe vedere bene la moneta in mano e, soprattutto, trovarne un'altra per un confronto, ma di questo parleremo una prossima volta). In compenso, il mio archivio fotografico consta di ben 600 immagini che sto studiando per poter ricavare le sequenze dei coni. E’ uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve pur fare! ? La dentellatura. Innanzitutto non è un difetto riscontrato solo sui pezzi da 1 quattrino del 1791. Come hai visto nell’esemplare postato da Asclepia all’inizio di questa discussione, anche quelli da 1 del 1798 non sono esenti da questi decentramenti di conio. Per approfondire, ti suggerisco il dettagliato articolo “Le monete cordonate nel taglio nell’epoca del bilanciere” del maestro @Rex Neap Magliocca (cui mi rivolgo per un autorevole conforto), pubblicato su Appunti di Numismatica Italiana nel 2019. Con l’introduzione del bilanciere a Napoli, nel 1680 sotto Carlo II, si ebbe un notevole salto di qualità nella realizzazione delle monete, coniate con maggior precisione senza però risolvere definitivamente il problema del decentramento. Infatti, in numerose monete di Carlo II si riscontra il problema del “giro”, del contorno (non del taglio), composto da trattini, puntini o perline, realizzato spesso in maniera non uniforme, difetto che agevolava il diffuso malcostume della tosatura. Solo l’adozione sistematica e metodica della cordonatura (a partire da Carlo VI su piastre e mezze piastre e da Carlo di Borbone su tutti i nominali), realizzata sul taglio in incuso o in rilevo, unitamente alla perfetta centratura, consentì di debellare il fenomeno tanto deleterio. Tornando ai nostri quattrini, effettivamente il decentramento è insolito nella elegante e accurata monetazione borbonica. Inoltre, come hai giustamente evidenziato, nei quattrini si nota più nei coni di diritto che di rovescio (con qualche eccezione, vedi il suddetto quattrino 1798 dove compare su entrambi), soggetti, questi ultimi, a rottura più frequente. Esempio ne sono gli stessi vari e differenti rovesci del 1791 e del 1798 in tutti i nominali. In conclusione, a mio modesto parere, per gli esemplari in questione si tratta di un semplice, anche se inconsueto, disallineamento di conio. Per quale motivo in zecca non si reputò importante ritirarli e ribatterli? Ipotizzo per lo sfavorevole rapporto costi/benefici, per l’infimo valore del nominale, per il metallo vile, per la loro destinazione: erano pur sempre poveri spiccioli di rame coniati in “liberate” di quantitativi modesti, per una circolazione limitata ai lontani presidi del Regno. E comunque, queste monete, qualora ci si fosse accorto del difetto (e presumiamo che in zecca ne fossero consapevoli), risultavano comunque leggibili, integre e comprensibili, ancorché non perfettamente centrate. PS: sto terminando un articolo sulle medaglie francesi per la conquista nel 1646 di Piombino e Portolongone! Ti terrò aggiornato, se ti può interessare. Un caro saluto1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Pur definendola una sorta di gettone lo stesso numista aggiunge un commento, lo trovi in basso alla scheda: https://en.numista.com/catalogue/pieces30255.html "secondo quanto riferito circolavano insieme alla valuta normale, quindi la elenchiamo insieme alle monete"1 punto
-
Ciao @rada, anche io colleziono monete di grosso modulo in argento e questa moneta l'avevo presa in considerazione ma poi scartata. Come mio personale metodo si valutazione consulto il sito numista, che definisce token (o jeton se guardi in lingua francese) e quindi mi ha fatto propendere per non considerarla una "standard circulation coin"1 punto
-
E dato che ti piacciono.... Posto pure la mia 1839 D'Incerti 179/a Pagani 199 Peso grammi 27,43 Taglio inciso al rovescio Giudicata da Morello SPl +1 punto
-
1 punto
-
Ciao, per me è una classica produzione commemorativa ufficiale della zecca, utilizzando quei dati ponderali gli è stata data la possibilità di essere usata come 5 franchi, una cifretta del tutto rispetto all'epoca, e dato i tempi tanti non hanno avuto nessuna remora a spenderla. Se poi la si vuole definire medaglia, gettone, buono ecc. ecc. utilizzabile per un valore di 5 franchi poco importa, significa che ha egualmente circolato, ma aspetta qualche altro parere in merito.1 punto
-
1 punto
-
Ciao, ci tengo a precisare che la mia non è una critica ma è solo un parere personale... Come dicevo ieri la moneta è irrimediabilmente compromessa, la corrosione ha portato via del metallo lasciando dei crateri ben evidenti, non credo possa peggiorare, perché penso che la moneta sia già stata trattata per tirare via il cancro del bronzo che, come vedi, ha lasciato i crateri di cui sopra... Come hai già anticipato la moneta è comunque leggibile, soprattutto nella data e nella sigla del maestro di zecca, il che permette di classificarla correttamente... Comunque ciò che conta è che tu sia soddisfatto, e se questa moneta ti stuzzichera', come ha fatto con me ed altri amici del forum, non tarderai a volerne affiancare altre...1 punto
-
Qualche informazione : Il Tesoro di Sutton Hoo è la scoperta Archeologica più importante dell’Alto Medioevo Inglese Sutton Hoo è un sito archeologico risalente all’alto medioevo che si trova in Inghilterra, nella zona anticamente chiamata Anglia Orientale. Il sito nascondeva una nave sepolcrale con i resti di Redwald, un sovrano britannico del quale si sarebbero quasi perse le tracce se non fosse, appunto, per la sua tomba. Il Re inglese regnò nel VII secolo e fu figlio di Tytila, nipote di Wuffa e membro della dinastia Wuffinga. L’Anglia era, in quel particolare periodo storico, un centro assai importante per la nascente identità britannica, seguente al dominio romano di pochissimi secoli prima, e base per la nuova cultura anglo-sassone. Circa 10 anni prima della sua morte, avvenuta nel 624, Redwald era il sovrano più potente a sud del fiume Humber, e venne chiamato addirittura “Bretwalda”, “righello della Bretagna”, a simboleggiare l’importanza e la forza del suo dominio. Sutton Hoo fu il sito scelto per la sua tomba di altissimo pregio, un monumento funerario giunto sino ai giorni nostri e che rappresenta una delle scoperte di archeologia medioevale più importante per la Gran Bretagna. Il sepolcro del sovrano è costituito da una nave lunga circa 27 metri, che fu ricoperta di terra sino al XX secolo, quando venne scoperta in modo decisamente rocambolesco e poco scientifico. Nel 1926 la signora Edith Pretty divenne la proprietaria dell’appezzamento di terra che si rivelerà essere ospite (inatteso) del cimitero di Sutton Hoo. Il terreno, ancora lontano dall’esser definito “sepolcrale”, veniva utilizzato come appezzamento agricolo da tempo immemore, un particolare che si rivelerà essere non di poco conto nel prosieguo degli scavi. I suggerimenti arrivarono in seguito alle voci che volevano presenze “paranormali” infestare l’area, con i tumuli che venivano indicati come luoghi in cui osservare i fantasmi dei guerrieri sepolti. La signora fece iniziare gli scavi a Basil Brown, un appassionato di archeologia locale che, dopo aver esplorato 3 tre diversi tumuli, che però erano già stati violati, dopo circa un anno dall’inizio degli scavi giunse al tumulo che conteneva la nave di 27 metri di Re Redwald. Nel giro di pochissimo tempo fu evidente che la scoperta era di grande importanza, e giunsero altri esperti di Archeologia da Cambridge che però si trovarono al centro di un alterco con il museo locale. Dopo differenti vicissitudini, il confronto con dei Medium e altri episodi “curiosi”, nel Giugno del ’39 moltissimi dei manufatti di Sutton Hoo furono inviati a Londra, i quali però vennero subito rispediti al mittente per il caos generatosi in corrispondenza con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale. La signora Pretty fu riconosciuta proprietaria degli oggetti e, con una generosità da nobile inglese, la decise di donare tutto il sito e quanto vi fosse contenuto alla nazione. I tesori di Sutton Hoo All’interno di numerosi tumuli si nascondevano tesori che, per la storia inglese e per gli esperti di archeologia rappresentarono una scoperta cardine per scoprire usi, costumi e vicende di quel periodo dell’Inghilterra post-romana. L’Alto Medioevo fu infatti un’epoca assai poco documentata della storia britannica e il ritrovamento di tombe intatte, colme di manufatti e oggetti che descrivono e mostrano la vita dei personaggi di quel periodo, rappresentò un avvenimento epocale. Oltre ai resti della nave, vennero trovate un’armatura di metallo ricoperta d’oro e gemme preziose, un casco cerimoniale, uno scudo con la spada, una lira, 37 monete d’oro e molti altri oggetti, anche piccoli, che ci consentono di comprendere come, circa 1.500 anni fa, l’Inghilterra fosse già una nazione protagonista della storia e della politica europea. Sotto: il sepolcro di Redwald ricostruito. Fotografia di Arne Koehler via Wikipedia: La Lira. Fotografia di Steven Plunkett condivisa con licenza Creative Commons via Wikipedia: Un coprispalla. Fotografia di Rob roy via Flickr: Lo scudo restaurato. Fotografia di Colin Payne via Wikipedia: Inserto. Fotografia di Rob Roy via Wikipedia: La Fibbia d’Oro. Fotografia di Rob Roy via Wikipedia: La nave. Fotografia di Searoom SF via Flickr: Un elemento di uno scudo. Fotografia di Wordridden via Flickr: Inserto. Fotografia di Paul Hudson via Flickr: Elementi diversi. Fotografia di Rob Roy via Flickr: L’elmo di Redwald ricostruito. Fotografia di Bill Tyne via Flickr: L’elmo restaurato allo stato originale: Oggi Sutton Hoo è stata ulteriormente scavata e studiata, scoprendo anche un secondo cimitero poco lontano dal primo, i cui tumuli erano stati distrutti durante le normali lavorazioni della terra agricola dei secoli precedenti. Il cimitero fu in uso sino a circa il IX secolo e ospitò, in netto contrasto con le sepolture nobiliari dei tumuli, diverse decine di condannati a morte per impiccagione e decapitazione. Chi era Redwald? Adesso in tantissime trasmissioni inizierebbero a parlarvi della sua storia in modo certo, come se noi sapessimo davvero di chi stiamo parlando. La realtà è che, in effetti, noi non conosciamo quasi nulla di chi fu e di cosa fece. Per essere ancora più precisi, non siamo certi se il sepolcro di Sutton Hoo sia davvero quello del Re. La sua storia si intreccia con la diffusione del cristianesimo in Inghilterra, e quindi la possiamo evincere da diverse cronache di religiosi dell’epoca. Intrecciando tutti i “pochi” dati che abbiamo a disposizione, fra cui è importante citare la Historia ecclesiastica gentis Anglorum, di Beda il Venerabile, la prima fonte che parla di Redwald, viene fuori una vicenda umana che, come è facile intuire, è tutto fuorché precisa, ma affrontiamola lo stesso. Redwald nasce nel VI secolo dopo cristo, più o meno fra il 560 e il 580 (ma non conosciamo neanche il decennio) in un contesto di instabilità politica dell’Inghilterra post-romana. Forse è discendente della casata dei Wuffinga, e sposò una donna che gli diede almeno due figli, Raegenhere ed Eorpwald. (scusate la pronuncia, vi scrivo i nomi sotto). Forse ebbe un altro figlio, Sigeberth, e forse lo esiliò in Gallia, ma come è facile intuire qui la storia si intreccia con la leggenda. In quel periodo arrivò in Inghilterra Agostino di Canterbury, mandato da Papa Gregorio I a evangelizzare la remota “Albione”, e furono in molti a convertirsi al cristianesimo, fra cui forse i figli di Redwald. Anche Redwald si convertì, ma la sua casata non seguì il suo esempio, e nella sua casa non c’era solo un altare dedicato a Cristo ma anche un altro che Beda descrive come “per le vittime di demoni”. Bisogna specificare che in quel periodo la commistione di religioni era molto più normale di quanto non possa apparirci con gli occhi di oggi. Le vicende militari che rendono Redwald un personaggio significativo anche dal punto di vista politico sono legate alla campagna che questi condusse contro Aethelfrith, il sovrano della Northumbria. Aethelfrith aveva scacciato tale Edwin, il quale si era rifugiato da Redwald. Nel 616 o nel 617 le truppe di Redwald diedero battaglia a quelle di Aethelfrith sulle rive del fiume Idle, e quest’ultimo fu ucciso. Il figlio di Aethelfrith venne esiliato, la Northumbria fu data in premio a Edwin, e Redwald aumentò a dismisura il proprio potere. Rimasto come unico sovrano già cristiano d’Inghilterra, egli viene definito da Beda “Rex Anglorum”, un titolo che di cui fu accreditato anche grazie al debito di riconoscenza che Edwin aveva nei suoi confronti. Redwald probabilmente morì nel 624, anno più, anno meno. Per capire quanto le vicende di questi personaggi siano a noi sconosciute basta pensare che la sua morte viene registrata due volte da Ruggero di Wendover, nel 599 e nel 624, anche se probabilmente il 599 è riferito alla morte di Tytila, il padre di Redwald. https://www.vanillamagazine.it/il-tesoro-di-sutton-hoo-e-la-scoperta-archeologica-piu-importante-dell-alto-medioevo-inglese-1/amp/1 punto
-
L’uso del gettone è indicato dalla contromarca W C presente sull’altra faccia di questo esemplare: è per l’accesso a un bagno di piano alberghiero.1 punto
-
1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?







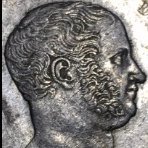
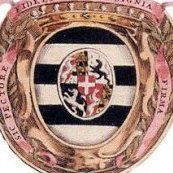

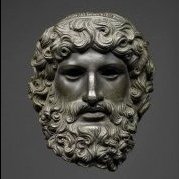
.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)