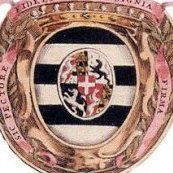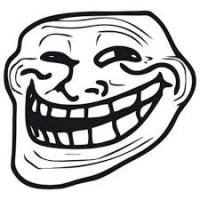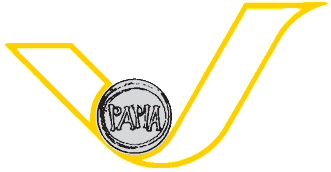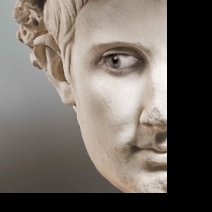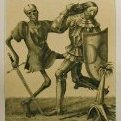Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 09/20/21 in Risposte
-
Purtroppo nella mia piccola collezione non vi sono monete con esempi di castelli o fortificazioni ma ho una medaglia (spero si possa fare una deroga al post ). Vi è rappresentata una veduta della città di Sora con il fiume Liri che l'abbraccia e con alle spalle il colle su cui si trova una chiesa e più in alto il castello. Opera dello scultore Egidio Ambrosetti.6 punti
-
Saranno almeno 100 le monete di Genova con il castello che è l'immagine della città medievale. La moneta al centro è un' intrusa in quanto quartaro con grifone.5 punti
-
Due belle fortezze normanne e sveve Guglielmo II e Tancredi, da Artemide Aste - Auction LI4 punti
-
Buono e bello. E, se ben ricordo, è l'ultima apparizione dei Dioscuri sulla monetazione romana, Dioscuri che apparivano sui primi denari della Roma repubblicana. Arka Diligite iustitiam4 punti
-
Ecco mura e torri da una non frequentissima moneta della repubblica di Ragusa, un artilucco (da 3 grossi) del 1627. L'emissione proseguì fino al 1706 e imitava il celebre pezzo coniato in Polonia. Il nome artilucco (o altilucco), viene dal turco per indicare un pezzo da 6 para: tanto era il valore della moneta nel'impero ottomano4 punti
-
3 punti
-
2 punti
-
DE GREGE EPICURI Consiglierei anche il bell'articolo di Mario Ladich: "Massenzio, l'ultimo imperatore che amò l'Urbe", comparso sull'ultimo numero di Monete Antiche (N.116, luglio-agosto 2021).2 punti
-
Napoletana del giorno, una variante che ancora mi mancava: Tornesi 8 del 1796 con le lettere R C (Regia Corte) più piccole rispetto agli altri millesimi.2 punti
-
Segnalo questo abstract in lingua inglese che fa riferimento ad un articolo sul tema "Massenzio e i Dioscuri": https://www.cambridge.org/core/journals/antichthon/article/abs/maxentius-the-dioscuri-and-the-legitimisation-of-imperial-power/C901A40DE327852360C026076E808D6D# Saluti Illyricum ?2 punti
-
Ciao a tutti, Si la capigliatura sembra diversa anche a me.... anche se penso che in quegli anni (40) un po di confusione con il punzone delle effige sia stata fatta...basta pensare alla 40 collo lungo e la 41 testa grande.... Un mio amico ha una 43 in collezione cn la medesima effige. Un saluto a tutti. Raffaele.2 punti
-
Concordo con @dux-sab Penso si tratti di due conii diversi con ritratto variato. Di questo tipo ne ho trovate 2: la prima la tua @favaldar che dovrebbe essere ex Asta Bertolami 2019 ( non la posto per motivi di privacy ). La seconda è quella aggiudicata da Nomisma: Saluti a Tutti, Beppe2 punti
-
Buongiorno amici Facciamo un piccolo censimento?? Vi va di postare il vostro SICILAR o almeno di dire io ce l'ho? Comincio io, arrivato qualche tempo fa, già postato, non bello come quello dell'asta ma pur sempre una rara rara rara moneta e a me piace molto. Vediamo se c'è adesione2 punti
-
Qui una torre circondata da mura su un bellissimo denaro di Volrico (1233-54) vescovo di Trieste. Arka Diligite iustitiam2 punti
-
Infine la torre di Ludovico della Torre (1359-65) con le lettere L - V ai lati della torre. Arka Diligite iustitiam2 punti
-
Buonasera, Anche se non posseggo tali monete, tra le emissioni greche, che ricordi, una delle prime raffigurazioni di torri o “castelli” proviene da una rarissima emissione della antica città di Ura (poi Kelenderis) in Cilicia, odierna Turchia, con legenda in aramaico. La datazione è da individuarsi intorno alla metà del V secolo a.C. (460-450 a.C.). Un esemplare, statere, ex Nomos 18/196: https://nomosag.com/default.aspx?page=ucAuctionDetails&auctionid=18&id=196&p=1&s=&ca=0&co=0&type=auction Ancora in Cilicia, ma a Tarsos stavolta, un altro statere databile tra la metà del V secolo a.C. e la fine dello stesso secolo. Un esemplare Ex Classical Numismatic Group 109/190: https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=365190 Da notare che secondo gli esperti di CNG la zecca era incerta dell’Asia minore, mentre secondo Roma Numismatics è certamente Tarsos, per le ragioni esposte nelle note del catalogo della loro vendita 17 per il lotto 528: https://www.numisbids.com/n.php?lot=528&p=lot&sid=3081 Aggiungo infine un esemplare sempre dalla Cilicia, ma di circa un secolo più recente (361-334 a.C.), coniato sotto il satrapo Mazaios sempre a Tarsos, citato anche nel link alla vendita Roma Numismatics di cui sopra. Qui le mura fortificate da torri sono più ampie ma hanno meno rilievo nelle raffigurazioni. Uno statere ex Künker 333/843: https://www.sixbid.com/en/fritz-rudolf-kuenker-gmbh-und-co-kg/7087/griechische-mnzen/5803748/cilicia-tarsos?term&orderCol=lot_number&orderDirection=asc&priceFrom&displayMode=large&auctionSessions=&sidebarIsSticky=false2 punti
-
Solo a me sembra alluminio? "La posata, infatti, aveva stampigliata sul manico l’aquila e la svastica nazista e la sigla “G & CL 39” che significa Gerhardi & Cie, Lüdenscheid, 1939, cioè il nome della ditta produttrice dell’oggetto che aveva sede a Lüdenscheid (Renania) e l’anno di fabbricazione." https://www.unalungasciadisangue.it/unalungasciadisangue.pdf Pagina 57 Servus Njk2 punti
-
2 punti
-
Buongiorno a tutti, è da tanto tempo che avevo in mente di aprire questa discussione, il titolo rende l'idea di cosa ci si aspetti. Ho usato volutamente un titolo semplice e abbastanza generico, per dare a tutti la possibilità di partecipare. Sono ben accette monete di tutte le epoche e metallo. Il soggetto è il Castello e le Torri in tutte le sue forme. Magari per ognuna chi vuole può accompagnarla con qualche nota. Credo che la maggior parte di noi ne ha visto o visitato qualcuno, e ne è rimasto affascinato. Essi sono la rappresentazione e manifestazione di quello che doveva essere il potere all'epoca alla quale risalgono. Sono stati per lunghi anni il punto fermo, il luogo sicuro dove rifugiarsi per il popolo che viveva sul territorio. Ne approfitto per riportare una nota da fonte web in merito alla funzione delle torre che andava via via evolvendo, '' la casatorre :' (o casa torre) è una costruzione fortificata, una rocca con funzioni sia militari che abitative in auge nel medioevo a partire dal X secolo. Ora non vorrei avviarmi e perdermi nei meandri dei Castelli e dell'incastellamento, di cui lessi tempo fa una bellissima discussione di Mario, @dabbene. Magari sarebbe interessante mettere qui il link. ? Vuole essere la mia, la proposta, di una discussione leggera piacevole, alla portata di tutti. Potremmo approfittare per aggiungere qualcosa alle nostre conoscenze. Sicuramente io sono di parte perché Amo molto questo soggetto nelle monete ma anche in altre '' opere''? La moneta che voglio proporvi è : 9 Cavalli Ferdinando IV millesimo 1790 Sul rovescio viene riportata una Bella Torre, in questo esemplare è a lati curvi, ma dello stesso nominale c' è quella a Lati Diritti(magari la postera' qualcuno di voi). Perchè mi direte (e mi sono chiesto anche io più volte nel passato) la scelta della Torre in una moneta da 9 Cavalli? Una risposta sicuramente ci viene in aiuto dall'araldica, il Castello rappresenta il regno di Castiglia che insieme a Leon erano le due regioni più importanti della Spagna, è lì che affonda le radici la casata dei Borbone. Aggiungerei che non era da tutti potersi far costruire un castello, solo le famiglie illustri potevano. Ovviamente invito i più esperti a correggermi laddove riporto delle inesattezze. E invito il cdc a chiudere la discussione nel caso il tema fosse già stato affrontato. Saluti Alberto1 punto
-
1 punto
-
Aggiornamento sulla mia spedizione dalla Gran Bretagna: oggi, incredibile a dirsi, dopo esattamente 4 mesi e 6 giorni, è arrivato il portalettere con la busta. Fatte le verifiche del caso in sua presenza e constatato che la spedizione era integra, ho pagato IVA e spese ed ho finalmente visto le mie monete, acquistate all'inizio di maggio. Non so se consolarmi con la felice risoluzione o incazzarmi ancora per la tempistica. Ignoro se sia un record, ma 4 mesi e 6 giorni non è male come attesa.1 punto
-
Io ricordo che qualche anno fa alcuni utenti suggerivano di togliere fino al 50 % del prezzo dei listino. Per me e' una cosa buona che invece gli autori del catalogo siano diventati piu' conservativi con le stime. E' come un perito con l'FDC facile rispetto a un altro che non lo concede quasi mai.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Ferdinando II, 5 Tornesi 1839 La moneta la ricordo sempre in questo stato, nonostante non uso maneggiarle con i guanti.1 punto
-
Questo è il mio esemplare: la legenda non è molto leggibile... voi vedete qualcosa?1 punto
-
I famosi 30 denari di Giuda sono appunto i sicli di tiro ... Anche se ci son pareri non sempre concordi alcuni dicono che tramite studi si risale a quei sicli altri dicono sia solo un'operazione commerciale ... Sicuramente non erano monete romane in quanto raffiguravano l'imperatore o gli Dei e in quanto monete pagane non potevano essere accettate per il tesoro del tempio ma doveva essere cambiate prima di versare la tassa al tempio1 punto
-
Buongiorno a tutti , amici di questo forum. Qualche anni di numismatica savoiarda mi hanno appreso di non essere troppo difficile con le monetine che io incontro qui o li. Dunque sono contento d'avere acquisto questo piccolo mezzo grosso di CE I , con data e segno del zecchiere leggibili. A presto, lo spero. Alain.1 punto
-
Mille grazie Silvio per la tua spiegazione, sempre molto interessante.1 punto
-
1 punto
-
ciao Tranchos, Per le lettere leggibili dell’esergo, ARAB ADQVIS, sarà un asse di Traiano con l’Arabia stante con il camello al revescio. https://www.acsearch.info/search.html?id=54870001 punto
-
Buonasera a tutti, Maravedis (8?)Filippo IV Moneta con i soli simboli di Castiglia e Leon. ? Saluti Alberto1 punto
-
L'esemplare del CNI IV, pag 487, n. 1 fa parte della collezione reale. Quindi, o attendi la pubblicazione del volume dedicato a Pavia, o chiedi al Museo Nazionale Romano se possono mandarti la foto. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
Buona sera al forum: Grazie per averci ricordato Roth, indimenticabile; un saluto da nonno Cesare1 punto
-
le mie richieste sono solo sull'autenticità eheheh . Premetto che per me tutte le monete sono belle, in quanto testimoni di un passato che noi possiamo ammirare e solo studiare Grazie infinite1 punto
-
Ed ecco un piccolo castello a far da cesura della legenda su un carrarino di Conte da Carrara (1414-20) della zecca di Ascoli. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
Ed ecco la torre su un denaro di Raimondo della Torre (1273-99) della zecca di Aquileia. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
E qui la torre del castello di Padova, detta Specola e individuata dal Prof. Gorini, in mano a San Daniele su un Carrarese da 4 soldi di Francesco I da Carrara (1355-88). Arka Diligite iustitiam1 punto
-
Ecco il castello a fianco della testa del leone sul Ducato nuovo o Ducatello di Venezia. Rappresenta il potere della Serenissima sulla terraferma. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
Siamo in due. L'idea delle monete con anello in polimero era curiosa, ma ormai la curiosità si è persa. Benissimo che le serie siano ora concluse. Idem con patate, non sopporto le monete colorate. Quindi se le tengano. Evviva l'anno prossimo si risparmia un pochetto!1 punto
-
Vista la mole di falsi che i Bulgari hanno disseminato, personalmente una ricerca sulla composizione qualitativa e quantitativa, la reputo inutili. Se usano dramme genuine di conservazione scarsa e di flan ridotti. i risultati saranno molto più vicino alle genuine. Riconiare su una genuina è risaputo. Se il conio moderno è creato da una genuina, i parametri per individuare la coniazione moderna saranno meno. E qui entrano le esperienze acquisite nel tempo, ad individuare gli errori di trasferimento, di fusione del nuovo conio, ed altri fattori che non sto qui ad elencare. Sulle ultime foto che ho postato, sono evidenziati quei dettagli, che su una copia moderna, un falsario, non li può creare, le rotture di conio con l'usura di esse. Ma per toglierti uno sfizio e non è costosa, questa composizione qualitativa e quantitativa falla e ci fai sapere. Cordialmente Giovanni.1 punto
-
Forse non ci siamo capiti, ho capito che il valore a catalogo è 10 €, ma poi bisogna trovare chi li sborsa i 10 euro per questa comunissima monetina... Quello che cercavo di farti capire è che il catalogo non è la Legge... Queste monetine (salvo il '56) hanno uno scarsissimo interesse commerciale, quindi è molto difficile riuscire a venderle.1 punto
-
E fai bene. Sará uno dei prossimi obiettivi? Sono un patito di aquile,non solo per l' estetica ma anche per il significato di esse. Ci hanno visto lungo a modificarla?,non perchè non era bella quella di prima,ma cosí non vi è paragone a mio modo di veder. Questa oncia la reputo una classica,un modello per le altre. Sembra che gli Usa siano i leaders delle once. Altra tipologia molto forte per me sono quelle cinesi col panda. Ma il " messaggio " passa meno forte della prima? Mie sensazioni personali ci mancherebbe? Salutoni1 punto
-
Ciao @ambidestro ..molto bello ed è la prima volta che lo vedo, è il medesimo castello che troviamo sui tolleri..giusto?1 punto
-
Il due grani è senza dubbio un bel pezzo, ha circolato ma ha i rilievi più definiti perché è stato coniato quando i conii erano ancora freschi, è stato usato un tondello ricavato dai 6 kreutzer rimpicciolito , cosa abbastanza comune. Per quanto riguarda il grano, ha fatto una cifra esagerata anche secondo me. Saluti1 punto
-
Io ci sono (SIVIS alias Stefano Palma, alias A.N.64 Studio di Numismatica)! Dal Veneto con furore ?1 punto
-
Su alcuni dettagli, che allego con queste foto, sono evidenti le lievi rotture di conio, espansioni del metallo, l'usura, ecc.1 punto
-
Buongiorno Rocco e buongiorno amici Quella volta sono stato pronto e fortunato a portare a casa quel 6 cavalli, è uno dei pezzi d cui vado più fiero. Però la mia napoletana di oggi non è un 6 cavalli, non è un 3 grana per Murat ma un 2 grana...provenienza Francia, variante con due stelle a chiudere la legenda al rovescio. D/ GIOACCHINO NAPOLENE RE DELLE DUE SICI. R/ PRIN * E GRAND AMMI'DI FRAN** Un punto al dritto e 4 stelle al rovescio. Data stretta. Come vi pare? Un caro saluto1 punto
-
Buongiorno a tutta la sezione, Condivido con tutti voi la mia 1816, ex collezione Mirabella.... Un saluto a tutti. Raffaele.1 punto
-
Una sezione della mia biblioteca numismatica che negli ultimi tempi ho curato molto è quella inerente le opere sulla storia monetaria e bancaria di Napoli e Sicilia, le monete infatti non vivono da sole ma fanno parte di un sistema assai complesso fatto di norme, istituzioni, strumenti finanziari, economie e mercati che hanno tutti la loro evoluzione nel tempo, per capire davvero le monete ed il loro funzionamento nei vari sistemi politici, sociali ed economici è necessario dotarsi anche di queste opere di taglio più prettamente storico economico... a tal proposito un'acquisizione libraria molto attesa e recente è quella della Storia del Banco di Napoli in 5 volumi che tratta non solo la storia di tutti i banchi pubblici creati nel corso dei secoli a Napoli e poi confluiti nell'unico banco noto come Banco di Napoli, ma è anche un affresco molto corposo di tutta la storia monetaria del regno napoletano in epoca moderna, dagli spagnoli ai Borbone, fino ad interessare anche l'epoca dell'Italia unita con le sue vicende monetarie ed in particolare le emissioni di cartamoneta del Banco di Napoli, un'opera davvero preziosa per immergersi a fondo in quei secoli e capire la moneta nelle sue vive e concrete funzioni...1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?




copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)