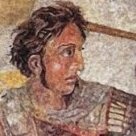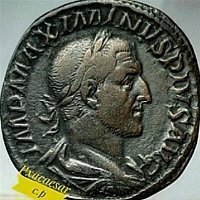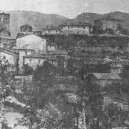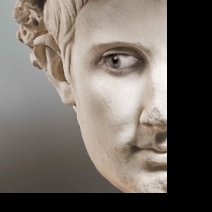Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 11/06/21 in Risposte
-
Scusa il ritardo.... Scheda distinta nelle due sottosezioni: https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-G256/43 punti
-
Splendida serie, dal design caratteristico che mi è sempre piaciuta. Ha decisamente diritto di figurare in collezione! Io ne ho recentemente acquistato una della serie precedente (che avevo già postato altrove), di cui sono felice e quindi la riposto...3 punti
-
Buongiorno a tutti, non riesco a capire l'anno di coniazione di questo 3 cavalli di Filippo II,voi che dite?...2 punti
-
Amici del Forum, anche se non sono presente come un tempo, sono sempre molto appassionato di Numismatica e leggo sempre questo amato spazio virtuale... non vedo tra l'altro l'ora di vederci ad un Convegno dal vivo, come è successo qualche giorno fa con qualcuno di voi a Bologna Desidero parlarvi di un'altra mia passione, che mi incuriosisce fin dalla prima adolescenza: la storia delle registrazioni sonore, in particolare degli albori di questa fantastica tecnologia, ancora importantissima, seppur con rivoluzionarie modifiche intervenute nel corso dei decenni. Quando vidi l'immagine dettagliata di un grammofono a tromba, frequentavo la terza media e fu su un libro di testo di educazione artistica. Il paragrafo parlava dello stile di tale prodotto, ponendo l'accento sulla tendenza dell'epoca di celare i meccanismi interni a favore di una notevole eleganza. Quell'immagine mi colpì ed iniziai a cercare informazioni su libri cartacei (Internet era poco diffuso) su come funzionasse questo grammofono, sulla storia dei dispositivi inventati prima e dopo ecc., chiedendo ai nonni cosa ricordassero di questi strumenti di un passato a loro vicino. Quando si parla di storia della registrazione sonora, cosa che affascinò l'uomo fin dai tempi antichi, con leggende di oggetti che potevano contenere voci e parole, molto spesso si parte da Thomas Alva Edison ed il suo fonografo. Credo però che valga la pena citare anche le invenzioni precedenti, che permettevano di registrare il suono solamente su vetro o carta, non potendo però permetterne la riproduzione. Esistevano infatti, già nella prima metà del 1800, dispositivi in grado di tracciare, tramite contatto diretto, le vibrazioni di oggetti come diapason e altri semplici generatori di suoni su un foglio di carta annerito con il fumo, uno tra questi fu ideato dal fisico francese Constant Duhamel, chiamato da alcuni testi "vibrografo". Il vibrografo registrava due fonti contemporaneamente e una di esse era sempre un diapason dalla frequenza di vibrazione nota, allo scopo di riferimento per ricavare la frequenza dell'altro oggetto posto in vibrazione. Una piccola "rivoluzione" tecnologica successiva fu ideata da Scott de Martinville, libraio ed editore francese (questa Nazione all'epoca fu al centro di queste importanti ricerche) che, osservando per lavoro l'immagine di una sezione anatomica di un orecchio umano ed interessandosi di stenografia, volle riprodurre la scrittura sonora imitando la natura; una sorta di orecchio meccanico per comprendere la struttura del suono, delle parole pronunciate. Ideò così il fonautografo, che inizialmente era composto da una sorta di grande imbuto che raccoglieva le vibrazioni sonore di qualsiasi fonte (compresa la voce umana), che terminava con una membrana molto flessibile collegata ad una setola rigida e da un meccanismo ricavato da un orologio che spostava orizzontalmente un supporto (di vetro o carta annerito con il fumo). Le vibrazioni, convogliate dall'imbuto, sollecitavano la membrana e di conseguenza la setola, che tracciava sul supporto una linea "ondulata" riproducente la vibrazione. Il suono poteva così scriversi "da sé", come riferirono con enfasi le pubblicazioni. Si conoscono fonautografi funzionanti realizzati all'epoca addirittura con le parti interne di un vero orecchio umano; ai nostri tempi questo può apparire piuttosto inquietante, ma si deve pensare alla mentalità di quel passato e che si trattava di ricerche puramente scientifiche e di strumentazioni atte a dimostrare processi del corpo umano, riservate ai laboratori. Infatti, molti testi di anatomia del 1800 citarono il fonautografo come esempio ottimale del funzionamento dell'orecchio. Inizialmente, il fonautografo era piuttosto rudimentale e necessitava di miglioramenti, al fine di trascrivere in modo più fedele le vibrazioni. Scott de Martinville collaborò così con Rudolph Koenig, uno tra i migliori studiosi e costruttori europei di strumentazioni per lo studio dell'acustica, che lo aggiunse nel suo catalogo commerciale, indirizzato prevalentemente a laboratori scientifici. Il migliorato fonautografo raccoglieva il suono mediante un dispositivo a forma di barile aperto o, in altri esemplari, di tromba, realizzato in gesso o in materiale metallico, con al suo fondo una sottilissima membrana di minugia o materiale gommoso. Alla membrana era fissato un leggerissimo ago, che trascriveva le vibrazioni su un foglio di carta annerito con il fumo, posto su un cilindro che si poteva ruotare a mano, come nel vibrografo. Completava il tutto un eventuale diapason, anch'esso collegato al cilindro, che poteva essere utilizzato, sempre come nel vibrafono, come riferimento per determinare le frequenze. Il dispositivo di Duhamel (a sinistra) e il fonautografo (a destra) in un Trattato di fisica di A. Ganot del 1875 Come già scritto, il fonautografo era riservato ai laboratori per gli studi sull'acustica; non aveva altre applicazioni pratiche, in quanto il suono non poteva essere riascoltato. Rudolph Koenig, nel suo Quelques expériences d'acoustique lo descrisse e lo studiò con l'ausilio di vari fonautogrammi, vale a dire le iscrizioni su carta delle vibrazioni, che aveva esposto nel 1862 alla Grande esposizione di Londra, fissate con un procedimento chimico. Nel 1877, Edison brevettò il fonografo, che permetteva, all'inizio in modo molto grezzo, di poter riascoltare i suoni registrati. Il principio era molto simile a quello del fonautografo; fonti dell'epoca raccontano che Scott de Martinville, che ancora svolgeva la professione di libraio ed editore, rimase molto amareggiato dalla similitudine con la sua invenzione e pubblicò un opuscolo dove descriveva il suo punto di vista; non ebbe però purtroppo molta considerazione. Non mancarono commenti negativi al fonografo di Edison, nonostante l'enfasi con cui si descriveva la sua invenzione: alcuni lo ritennero lesivo della riservatezza personale, in quanto poteva registrare, si diceva diventando sempre più piccolo ed occultabile in futuro, le conversazioni private delle persone. Una problematica molto attuale! Il resto è storia ancora più nota: dopo il fonografo (che registrava su cilindro) arrivò il grammofono, con il disco, maggiormente adatto alla copia in moltissimi esemplari. Nel 2008, alcuni ricercatori riuscirono a ricavare, grazie ad un sofisticato programma informatico, documenti sonori dalle registrazioni su carta effettuate nel 1800 con il fonautografo, probabilmente da parte del suo inventore. Attualmente, è quindi possibile ascoltare, seppure con una qualità bassissima, suoni precedenti all'invenzione del fonografo. Concludo quindi questo mio post, che spero sia apprezzato. Il Trattato di fisica nell'immagine mi è stato regalato dalla mia ragazza incuriosita anche lei dalla mia passione. Anche questa che ho raccontato è Storia, una delle nostre materie amate2 punti
-
Per Hong Kong con Elisabetta II da giovane (quella piccolissima da 1 cent per intenderci) me la sono tolta molto tempo fa, le mie sono tutte molto più vecchie, come questa del 18672 punti
-
Ok grazie, per iniziare proverò con 2.000 euro e se non và scenderò di volta in volta fino a 3 euro?2 punti
-
Ciao, avevo preso in considerazione anch'io la possibilità che l'ultima cifra potesse essere una Z ascrivibile alla cifra 2,ma facendo qualche ricerca ho notato che spesso il 7 è leggermente inclinato verso destra come nel mio esemplare, Inoltre il taglio del collo del sovrano è più simile ai 3 cavalli con sigle IAF/C piuttosto che ai tipi con sigle GR/VP,ed è per questi due motivi che reputo il mio esemplare un 1597,e quindi appartente ai tipi con IAF/CI coniati dal 1594 al 1598... Ad ogni modo anche se fosse un 1582,un 1587 o un 1592 si tratterebbe comunque di un pezzo inedito... Peccato che le sigle non siano più visibili...2 punti
-
A tutti quelli che comprano questa tipologia di banconote a lotti dico: Continuate così !!! e questa schifezzuole lasciatele a me!2 punti
-
2 punti
-
Per la medaglistica papale antica occorre studio e attenzione per imparare a distinguere le medaglie originali dai riconi del 1600/1770 opera degli Hamerani e da quelli molto più comuni del Mazio nel corso del 1800. Per le medaglie del 1800 e moderne i riconi costituiscono invece - per quanto ho potuto osservare in tanti anni - un fenomeno marginalissimo e del tutto occasionale; per fortuna non c'è la convenienza economica, perchè il nostro collezionismo è limitato e quindi sarebbe impossibile una produzione in quantità economicamente vantaggiose. In alcune occasioni certamenti i coni ex Mazio (ora conservati dalla Zecca) sono stati prestati per particolari emissioni; ma gli esemplari riconiati portano elementi identificativi della riconiazione. Come in tutti i settori del collezionismo ci sono le eccezioni. L'esempio sono le medaglie di massimo modulo delle basiliche (molto spesso uniface del rovescio), che sono medaglie affascinanti anche per chi non sia collezionista del settore. Per quanto ho potuto constatare, a mio giudizio, questi esemplari postumi non sono riconi, ma copie fuse e nelle fusioni basta la disponibilità di un esemplare originale per cimentarsi. Le medaglie dell'astuccio di giangi sono in metallo bianco bronzato e quindi in un metallo non rituale, che per le fusioni ha il pregio di essere duttile e di non determinare il restringimento del diametro. Recentemente ho visto le stesse medaglie in bronzo su ebay. ma con diametro mm. 80 anzichè mm. 82 e con le porosità caratteristiche delle fusioni in bronzo anche ben fatte. Come vecchio collezionista vorrei sostanzialmente tranquillizzare sulla bontà delle collezioni formate con attenzione e passione. Vorrei fare complimenti a robertoromano per i suoi esemplari in argento ; i massimi moduli in argento sono certamente molto rari. Le medaglie in asta Negrini sono a mio parere originali. Vorrei dire a chiconumi che i massimi moduli di Leone XIII sono certamente più rari rispetto a quelli di Pio IX, ma a mio giudizio la doratura non accresce rarità (non è difficile dorare medaglie) ed ha un limitato apprezzamento collezionistico solo perchè impreziosisce l'esemplare, venendo applicato sul medesimo un metallo nobile. L'apprezzamento delle dorature è comunque più significativo per quelle a mercurio, che di norma testimoniano una antichità dell'esemplare.2 punti
-
Ciao a tutti. Dal momento che mi trovo a Napoli per motivi di studio ho cominciato a mettere in collezione anche un pezzo della banca di Napoli. Tutto sommato stiamo parlando di cartamoneta circolante in tutto il territorio italiano e quindi meritevole di fare parte della collezione. ?2 punti
-
Buongiorno, visto così "al volo" direi 1597 e quindi "Inedito", almeno credo..2 punti
-
Non ti preoccupare, anzi per me sono dei complimenti, io nella mia enorme collezione che comprende monete romane,bizantine e greche ho solo quei due aurei. Ma di monete antiche d'oro ho due solidi uno zecchino e quattro tremissi ma anche varie monete antiche in argento e bronzo per un totale di circa 158 monete antiche in collezione. Grazie mille zanzaretta007 LAURA2 punti
-
Ancora a proposito di mappa...un bel horror made in Taiwan: Sul fronte lo statista Sun Yat-sen considerato Padre della Patria, ad Hong Kong come a Taiwan, sostenitore dei tre principi del popolo: nazionalismo, democrazia e benessere del popolo. Sul retro la Banca di Taiwan e sotto una mappa della città.2 punti
-
DE GREGE EPICURI Perchè e da chi sia stata venduta non sono fatti nostri, però dopo 31 post avrei voluto conoscere almeno il peso della moneta.2 punti
-
È da tanto che, colpevolmente, non aprivo una discussione sul forum ma il mio tempo libero purtroppo/per fortuna è sempre meno e cerco di dividerlo adeguatamente fra le mie passioni ed interessi. Di recente c’è stata un’interessante asta che ha messo all’incanto un’intera collezione che ha creato bagarre fra numerosi collezionisti. Quello che mi ha piacevolmente colpito è stato l’interesse suscitato, oltre quello ovvio alla moneta, verso i cartellini della vecchia collezione. Solitamente quando si compra una moneta il tondello resta “anonimo”, riparte da zero nelle mani del suo nuovo possessore destinando all’oblio chi prima di lui ha curato e coccolato quella moneta, un triste destino per noi collezionisti. Un semplice pezzettino di carta che accompagna la moneta invece ha permesso di non far cadere nel dimenticatoio il precedente possessore, un dovuto rispetto a chi prima di noi ha permesso che la moneta sia finita in mano nostra. Insomma una sorta di immortalità oltre che per il tondello, anche per chi prima di noi lo ha avuto. Una visione forse un po’ troppo romantica e poco legata all’attuale momento storico del collezionismo in cui il pensiero predominante è dettato da due sole parole: “Quanto vale?”, ma permettetemi questa visione forse più adatta ai tempi che furono e nel vedere l’interesse per i cartellini, che spero non sia motivato dal pensiero di un surplus sul valore economico, mi ha fatto comprendere che qualche “vecchio romantico” numismatico ancora c’è e questo è un bene per la Numismatica. Fatta questa doverosa e piacevole premessa passerei a parlare di una moneta ora in mio possesso ma sui cui sono riuscito a ricrearne parte dei suoi passaggi di mano nel tempo. Chi mi conosce sa della mia passione mai sopita per i cavalli. La moneta del popolo per eccellenza ricca di tipologie e di innumerevoli varianti e questo la rende, a mio avviso, il motivo sul perché sia tanto apprezzata dai collezionisti. Ognuno di noi credo possa vantare di avere in collezione un esemplare particolare, raro, o magari non ancora censito. Avendo per scelta ridotto la mia raccolta a pochi esemplari e cercando di studiare a fondo queste poche monete, periodo storico compreso, mi capita sovente di vedere gli stessi esemplari transitare di asta in asta nel tempo a conferma che le monete restano… i collezionisti passano. La ricerca continua di esemplari da censire mi ha portato a scoprire diversi passaggi d’asta di una moneta ora presente nella mia collezione. Una semplice curiosità ma che fa apprezzare ancor di più questo piccolo tondello di rame passato di mano in mano per tanti anni alimentando anche, senza negarlo, un po’ di ego del sottoscritto inorgoglito sapendolo passato in alcune collezioni importanti del passato. La prima notizia su questo cavallo lo troviamo nel “ragionamento” di Giovan Vincenzo Fusco Intorno alle zecche ed alle monete battute nel Reame di Napoli da re Carlo VIII di Francia edito nel 1846 dalle stamperie del Fibreno a Napoli (il Fibreno è un breve corso d’acqua che scorre a pochi metri dalla mia casa natale… segno del destino? ?). Il “ragionamento” del Fusco, illuminante per l’epoca, non è però esente da qualche imprecisione in quanto questo cavallo viene riportato come battuto nella zecca di Capua. Ve lo presento: Da Fusco 1846, Tav. IV, nr. 3 Passano gli anni e si arriva al 1882 dove, per la legge di cui sopra che non ammette deroghe al fatto che le monete restano mentre i collezionisti passano, questo cavallo, assieme alle altre monete della collezione Fusco, viene messo all’incanto. Pur se nel catalogo della collezione la moneta non è riportata tra le poche e sicuramente più meritevoli di figurare nelle tavole, la sappiamo presente perché al lotto 2149 leggiamo la descrizione di 6 cavalli con relativi riferimenti ed uno di essi è riferito proprio al lavoro del Fusco, tav. IV numero 3. Non so chi abbia preso la moneta ma di certo dopo è finita nella collezione Cora perché nel successivo passaggio, cioè la vendita della collezione San Romé del 1924, la ritroviamo al lotto nr. 2343 proprio con l’indicazione del passaggio precedente (collezione Cora nr. 167). Con relativa immagine nelle tavole. Passano gli anni ed ecco che, all’inizio del nuovo millennio, la moneta viene riproposta in un listino di vendita della ditta Baranowsky di Roma. Un sorriso, una stretta di mano e da allora questo cavallo riposa con me. Per concludere questa è una mia storia ma sono certo che molti di voi ne hanno altre da raccontare. Vi invito a farlo in modo da non tagliare quel legame che unisce noi collezionisti di oggi con quelli del passato onorando la loro memoria. D.F.1 punto
-
DE GREGE EPICURI Oggi vi mostro un altro bronzo dell'Orda d'Oro; pesa 1,59 g. e misura 18,5 mm. Anche questa,come numerale, si chiama "pul". Dovrebbe essere stata coniata da Sarai al Jadidah durante il suo regno (741-758 dell'Egira). Ho trovato anche il termine Jujid, che non so se sia la zecca. Sul primo lato un disegno ornamentale circolare, sul secondo una scritta araba.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
DE GREGE EPICURI Chiamarla padovanino le fa troppo onore. E' un falso moderno, anzi modernissimo. In ogni caso, un sesterzio autentico di Vitellio non sarebbe stato messo in un lotto...1 punto
-
Non sono un collezionista o un esperto di monete greche. Acquistata solo per il suo fascino.1 punto
-
1 punto
-
RIC T 514 di Giulia con Cerere al rovescio è attribuito alla famosa zecca della Tracia. Per quanto mi riguarda è abbastanza semplice distinguere le differenze di stile nel ritratto dei sesterzi di Tito e Domiziano, e quelle di fabbricazione (tondello èiatto anziché concavo come d'uso a Roma. Mi riesce più difficile apprezzare - da foto - le differenze tra 392b (Roma) e 514 (Tracia).1 punto
-
1 punto
-
In realtà sia i denari che i dupondi sono datati 80-81, quindi più che ad un fattore temporale penso che la differenza sia dovuta al diverso stile dei rispettivi incisori.1 punto
-
Grazie!!! Lo sarei stato in ogni caso, ma ora un pochino di più1 punto
-
Dall'antica Iberia, un attraente asse in bronzo di Carmona con al diritto una bella testa con elmo a calotta e piumato : 200-150 a.C. / 21,40 g / 33 mm . Passerà domani in asta LECERNAE TERTIA III al lotto 131 punto
-
1701 Regno di Sicilia - Filippo V° 1 grano (Palermo)1 punto
-
Non credo ci possa essere una relazione, ma potrebbe anche esserci. …Il Mastro di Zecca Giovanni Andrea Cavo entra in carica dal 6-Ottobre del 36 fino al 56. …Il Maestro di prova Geronimo de Novellis da Maggio del 36 al 37 …I Maestri di conio Franco Festinese Ottobre 35/ Marzo 37 e Giovanni Majorino dal Marzo 37 al 1678. ( dati tratti dal Magliocca ) Detto questo, volendo azzardare una ipotesi, punterei più sul cambio tra i due incisori ( Maestri di conio ) Festinese e Majorino. In ogni caso il problema è sempre lo stesso ovvero; in mancanza di documentazioni si possono fare tutte le ipotesi, anche le più fantasiose e visionarie, ma il dubbio é destinato a persistere.1 punto
-
1 punto
-
Io ho trovato solo i 2 euro 2021 da 2 mesi1 punto
-
1 punto
-
Concordo con @Orodicarta il Crapanzano vol.II è ottimo e ben documentato...comprato a 15 euro. Se vuoi in MP ti posso dire dove acquistarlo ...adesso è venduto anche molto meno. Complimenti per la bellissima serie del Banco di Napoli ? Ho letto che ti trovi a Napoli per studio, sarebbe magnifico se riesci anche a fare un salto al Memorial Correale che si tiene il 13-14 Novembre a Castellamare di Stabia (Na).1 punto
-
Si, proprio per questo motivo, e perchè purtroppo al retro è stato messo del nastro adesivo del tipo eliografico moderno, che ahimè debbo lasciare. Figurati che per quel biglietto del Cagayan del 1941 che ho postato nella discussione sulle guerre ho sentito questo commento "sarà una specie di miniassegno estero" e sono passati ad altro, buon per me!1 punto
-
Leggi anche questi approfondimenti sul fatti: Seconda guerra mondiale Occupazione giapponese dell'arcipelago delle Filippine Nel dicembre del 1941, a pochi giorni dall'attacco a Pearl Harbour, le truppe imperiali giapponesi si lanciarono all'attacco dell'arcipelago delle Filippine, importantissimo crocevia per la guerra nel Pacifico. Le forze statunitensi liberarono le Filippine dall'occupazione giapponese solo nel luglio del 1945. Isola di Luzon - Provincia di Cagayan - cartamoneta locale Certificato d'emergenza del Tesoro - 2 pesos 1941/42 ps: per visualizzare meglio i particolari cliccare sopra le immagini per ingrandirle.1 punto
-
Mi auguro che il tuo post non sia fatto per irridere..... Si vede benissimo dalla foto postata dove si individua sia il diametro che il peso, visto lo spessore della moneta.1 punto
-
Si discute. Saranno fatti suoi ma qui stan tutti a chiedersi perchè è stata pagata così poco. A me piacerebbe conoscerne la provenienza ( se ce la vuole dire e se non vuole, beh me ne farò una ragione.) Urca...! pesatura a occhio.1 punto
-
2012 Canada - 2 dollari 200° Anniversario della guerra angloamericana (1812-1815) Raffigurato il vascello da guerra HMS Shannon che lascia il porto di Halifax per partecipare al conflitto.1 punto
-
Gli esuli di Focea, inizialmente si stabilirono in Corsica nella base di Alalia dalla quale praticavano la pirateria nel mare Tirreno . Cartaginesi ed Etruschi li attaccarono in battaglia navale che i Focesi vinsero ma con la perdita di metà delle loro 60 navi pentecontere : allora i Focesi abbandonarono Alalia e dopo essere transitati a Reggio, da questa si diressero a Nord fondando Velia .1 punto
-
1 punto
-
5000 lire Antonello da Messina l Se è FDS... È un buon ritrovamento! La serie AA A, per qualche collezionista, da un plus valore. Chiaro non hai trovato un tesoretto... ma in rete l'ho vista proposta oltre a 100 euro.1 punto
-
Medaglia istituita a ricordo della guerra MCMXV-MCMXVIII con il decreto che autorizza a fregiarsi della stessa.1 punto
-
Attualmente, in vari siti di vendita on-line si trovano in vendita gli "Assignado Imperial" a cifre che vanno dai 200 ai 350 euro. Nella descrizione del lotto, normalmente si legge: " Asignado Imperial’ - Joseph Bonaparte - Barcellona -100 pesetas, 1813 and 1814". Fino a qui niente di male. Ma c'è un problema, gli "Assignado Imperial" non sono mai esistiti in quell'epoca, sono una fantasia moderna, stampati nella fine degli anni 60 inizio anni 70. Ho rintracciato la storia di questi pseudo assegnati in un forum di numismatica spagnolo dove il dubbio sulla loro autenticità serpeggiava già da tempo. Solo recentemente, in un articolo pubblicato su rivista specializzata di quel Paese a firma di M. Crusafont i Sabater e riportato sul forum, è stata raccontata la loro vera provenienza. Aggiungo che anche sul catalogo Edifil 2021 sono indicati come produzione di fantasia eseguita nel 1971 ma comunque valutati 50 euro... Nell'articolo non si cita il nome dell'artista, se così lo vogliamo chiamare, si racconta che questi si spacciava per un ingegnere - ma non lo era - nonchè studioso di numismatica per aver pubblicato un paio di articoli. Curiosamente l'artista, aveva inventato una storia per giustificare l'esistenza di questi biglietti: " i francesi, con l'obbiettivo di drenare moneta dalla catalugna, avevano introdotto nel paese un'importantev carico di questi assegnati, trasportati su un carro con l'intento di farlo arrivare a Barcellona. Durante il trasporto, il carico fu intercettatto da alcuni cittadini catalani, i quali, una volta scoperto il contenuto lo incendiarono. Solo alcuni bifglietti si salvarono, così da giustificarne la rarità e di conseguenza un maggior valore di mercato" La novella, fu creduta da un storico amico del nostro artista, il quale contribui alla sua divulgazione. Anche Antonio Badia storico/numismatico spagnolo, credendoli autentici pubblico un articolo sul bollettino della seconda esposizione di numiosmatica catalana. Per renderli più credibili, i biglietti furono stamapati su carta invecchiata, però, l'artista, commise un errore nel numerarli a mano con inchiostro. Gli esperti francesi della materia, ci misero poco ad individuare la falsificazione e fu lo stesso Antonio Badia a comunicare in che modo era stata scoperta la frode. Saluti. Foto presa dal web.1 punto
-
Buon pomeriggio, penso che non possa mancare per gli studiosi della materia, ma anche per gli appassionati, il seguente volume legato alla monetazione di Venezia: Problemi monetari veneziani (fino a tutto il secolo XIV). A cura di Roberto Cessi. Cedam 1937. Riporto l'indice completo. Qualora qualcuno fosse interessato, disponibile anche a pubblicare il documento d'interesse. Saluti, Domenico1 punto
-
Scusate ma non so fare foto migliori per evitare i riflessi del vetro.1 punto
-
Aggiungiamo ora un altro elemento al quadro indiziario, del quale era stato dato uno spunto in coda al primo post. L'immagine si riferisce infatti al così detto frontone A del “Grande Tempio” della colonia di Luna (l'odierna Luni), fondata nel 177 a.C. in territorio ligure ed il cui porto, secondo la testimonianza di Livio (XXXIV 8, 4-5), era già sotto controllo romano nell'anno 195 a.C. (dal portus Lunae si imbarcò Catone alla volta dell'Hispania). La decorazione fittile, ribattezzata “il concilio degli dei”, è costituita da cinque figure, purtroppo mutile, la cui la triade centrale è stata identificata con Apollo, Diana/Luna e Dioniso/Liber. Le due figure ai lati vengono invece interpretate come muse di un corteo apollineo o, in alternativa, potrebbero essere viste come divinità matronali. Una completa ed esaustiva disamina sul tema è stata recentemente proposta da Alessandro Coscia (Azioni rituali, prodigia e divinità tutelari romane in Gallia Cisalpina – Qualche riflessione sul caso di Luna), di cui riporto un significativo passo: “Le terracotte architettoniche riferite (e riferibili) ad edifici templari delle colonie in Gallia Cisalpina sono un vero e proprio “fossile guida” della romanizzazione. Pur nella loro frammentarietà, si è ritenuto di potere scorgere una costante tematica nell'elaborazione di tali schemi iconografichi, nelle colonie della Gallia Cisalpina: quella del metus gallicus” Sembrerebbe dunque essere di fronte ad un consesso tutelare caratterizzato da un'accezione salutare in funzione antigallica. L'Apollo di Luni è sia citaredo (vedasi la cetra ai suoi piedi) che arciere, per via dei segni del balteo sul petto, dalla spalla destra al fianco sinistro (non evidenti in foto, ma vedasi A.M. Durante, “Frontoni in terracotta del Grande Tempio di Luni”, p. 513). In ambito prettamente romano, l'Apollo arciere ha una funzionalità non certo nuova in ottica di difesa urbana (basti pensare alla seconda guerra punica ove è ad Apollo che si chiede di arrestare l'esercito cartaginese ormai prossimo a Roma), ma la figura per noi più interessante è senza dubbio quella centrale, una Diana/Luna caratterizzata da un seno scoperto, tipica di divinità legate alla sfera matronale, sensuale o della fertilità. Siamo di fronte alla dea eponima della colonia, in trono, con seno scoperto, ma analizzando con più attenzione la figura è possibile notare altri due particolari: sul braccio sinistro è ben evidente un'armilla, mentre il corpo suggerisce un movimento spiraliforme verso destra che, unitamente alla conformazione della parte bassa del torace e dell'interruzione delle pieghe del chitone, parrebbe indicare la presenza di un attributo tenuto fra le mani. In tale specifico ambito, è sempre il Coscia a sottolineare che, in una favissa del Grande Tempio, furono rinvenuti i resti di due grandi fiaccole, con molta probabilità parte del corredo della statua di culto. L'insieme iconografico parrebbe dunque delineare una divinità con valenza sia guerriera che, al tempo stesso, legata alla fecondità. Nella variante delle torques, le armille erano parte della tradizione celtica, così come devono essere viste quali oggetti ornamentali che la tradizione repubblicana lega ai trionfi militari (prima di Augusto erano solitamente donate alle truppe quale ricompensa per la vittoria). La dea Luna con accezione guerriera presenta poi numerose analogie con altre divinità affini, quali l'Artemide Soteira di Megara o l'Artemide di Salamina, che suggeriscono e consentono un specificazione funzionale ulteriore: non siamo di fronte ad una dea della guerra, ma ad una dea armata che protegge il territorio a lei consacrato. C'è poi la fiaccola, che offre una chiara sovrapponibilità a Diana Lucina, divinità tutelare dei parti: questo aspetto è particolarmente significativo. Luna è una colonia e, quantomeno nei primi decenni, per i romani che vi si stabilirono morte e calo demografico rappresentavano una concreta minaccia, in grado di compromettere l'esistenza dell'intero corpo civico. La funzione salvifica di Luna in ambito coloniale parrebbe dunque essere primaria, pertinente ed evidente.1 punto
-
Questa è mia, portata da mio padre, al tempo carabiniere a Roma, al ritorno dalla prigionia in varie parti della Germania. La conservo gelosamente.1 punto
-
1 punto
-
Ottime domande! Si, Gorny nel 2019. Forse l’avete già visto, ma chiedetevi sempre cosa può nascondere una patina artificiale: https://www.acsearch.info/search.html?id=4386312 Stessa moneta, un’anno prima: La didascalia di Bertolami: « somewhat smoothed », un pò lisciato. Il prezzo è stato moltiplicato per 8. Altra domanda accessoria, secondo voi, con che sostanza o che metallo sono riempiti i buchi e come invecchieranno queste monete?1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?







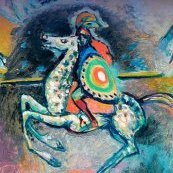


copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)