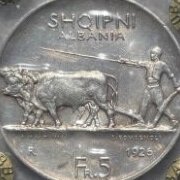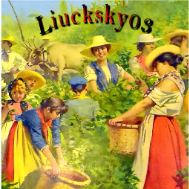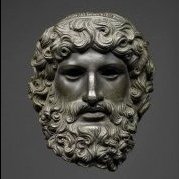Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 02/25/23 in Risposte
-
Salve. Posto i miei Gigliati. Di Gigliati ne so veramente poco ed allora li pubblico sperando che qualche collezionista appassionato ed esperto sappia individuarne qualcuno importante o qualcuno...falso. Sarei veramente felice di avere dei pareri su queste mie monete, pronto ad inviare tutti i dati che eventualmente mi verranno richiesti. Ringrazio fin da ora chi vorrà venirmi incontro. Grazie. Un caro saluto.5 punti
-
I soldati romani persero 200 tonnellate d’argento. La prova archeologica emerge dagli scavi presso il fiume Nella loro ricerca del minerale d’argento, i romani stabilirono due accampamenti militari nell’area di Bad Ems vicino a Coblenza, nell’attuale Germania, nel I secolo d.C. Cercavano la vena giusta per estrarre dalla collina enormi quantità d’argento. Le prove di presenza del minerale non solo erano rilevate soltanto nei depositi luccicanti del fiume, ma da alcuni saggi minerari condotti dai genieri. I romani, pregustando un successo strepitoso, impostarono un grande accampamento – e diciamo impostarono perché non lo conclusero – che avrebbe dovuto ospitare 300 soldati, protetti da alti recinti e da 40 torri. I 300 soldati arrivarono, ma dormirono nelle tende in un forte che doveva essere concluso, ma che non fu mai portato a termine. A un paio di chilometri di distanza, protetta da palificazioni acuminate, agiva l’unità di scavo. (nella foto) La ricerca dovette durare un tempo limitato. I Romani, per pochi metri, sbagliarono il filone giusto, dal quale, nei secoli successivi, furono recuperate 200 tonnellate d’argento. Con questo “buco nel vuoto” gli italici decisero di dar fuoco agli accampamenti – per evitare che finissero nelle mani del nemico – e si ritirarono . Questo è il risultato di una ricerca condotta nell’ambito di uno scavo didattico durato diversi anni – le conclusioni sono dei giorni scorsi – svolto dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle province romane della Goethe University in collaborazione con lo stato federale della Renania-Palatinato. Durante le indagini archeologiche sono state fatte diverse scoperte sorprendenti. La ricerca ha fatto guadagnare al giovane archeologo Frederic Auth il primo posto al Wiesbaden Science Slam. Quando il prof. Markus Scholz, che insegna archeologia e storia delle province romane alla Goethe University, è tornato a Bad Ems verso la fine dei lavori di scavo, è rimasto sbalordito: dopo tutto, tutte le foto inviate dal suo collega Frederic Auth mostravano solo un pochi pezzi di legno. Non sorprende che Scholz non si aspettasse ciò che ha visto dopo: una costruzione difensiva in legno composta da pali affilati, progettata per impedire l’avvicinamento del nemico. La struttura dall’aspetto militare aveva lo scopo di dissuadere chiunque dall’attaccare il campo. Tali installazioni – paragonabili, se vogliamo, al moderno filo spinato – sono citate nella letteratura dell’epoca. Cesare, per esempio, li menzionò. Ma fino ad oggi, nessuno di questi sistemi era stato trovato. Il terreno umido della zona di Blöskopf fornisce ovviamente le condizioni ideali per la conservazione: le punte di legno, che probabilmente si estendevano per l’intero fossato rastremato verso il basso intorno al campo, sono in buone condizioni. La grande sorpresa per gli archeologi è avvenuta durante gli ultimi giorni della campagna di scavo: nel terreno umido della collina “Blöskopf” era stata conservata una costruzione di punte di legno, destinata a scoraggiare potenziali aggressori. Due accampamenti militari romani precedentemente sconosciuti La ricostruzione del ritrovamento è compiuta dalla Gohete University: “Il lavoro degli archeologi di Francoforte e del dott. Peter Henrich della Direzione generale per i beni culturali dello stato federale tedesco della Renania-Palatinato, ha portato alla luce due accampamenti militari precedentemente sconosciuti nelle vicinanze di Bad Ems, situati su entrambi i lati della valle di Emsbach. Gli scavi sono stati innescati dalle osservazioni fatte da un cacciatore nel 2016, che, da un punto rialzato, ha individuato differenze di colore nel campo di grano, indicando l’esistenza di strutture sotterranee. Una foto scattata da un drone ha confermato la tesi: il campo era attraversato da una pista che sembrava originata da un enorme trattore. (eccola, qui sotto, ndr) In realtà, però, si trattava di un doppio fossato che inquadrava un accampamento romano. La prospezione geomagnetica ha successivamente rivelato un campo militare di otto ettari con circa 40 torri di legno. Gli scavi archeologici, condotti in due campagne sotto la direzione locale del Dr. Daniel Burger-Völlmecke, hanno rivelato ulteriori dettagli: il campo non fu mai completato. Vi si trovava un solo fabbricato stabile, costituito da magazzino e ripostiglio. I 3.000 soldati che si stima siano stati di stanza qui probabilmente hanno dovuto dormire in tenda. I segni di bruciatura mostrano che il campo è stato distrutto dal fuoco dopo pochi anni. Ma perché?” È stata la squadra studentesca, guidata da Frederic Auth, a individuare il secondo campo, molto più piccolo, situato a circa due chilometri di distanza in linea d’aria, dall’altra parte della valle di Emsbach. Un secondo campo, fondamentale per comprendere le anomalie – e la funzione – del primo. Il “Blöskopf” non è una tabula rasa quando si tratta di archeologia: gli scavi esplorativi effettuati nel 1897 hanno portato alla luce minerale d’argento lavorato, sollevando l’ipotesi che un tempo vi si trovasse una fonderia romana. La tesi è stata ulteriormente avvalorata dal ritrovamento di fondazioni murarie, resti di fuoco e scorie metalliche. Per molto tempo si è ipotizzato che le fonderie fossero collegate al Limes, costruito circa 800 metri a est intorno al 110 d.C. Queste ipotesi, ritenute valide per decenni, sono state ora smentite: la presunta fornace si è infatti rivelata essere una torre di avvistamento di un piccolo accampamento militare che ospitava circa 40 uomini. Probabilmente è stato deliberatamente dato alle fiamme prima che la guarnigione lasciasse il campo. La spettacolare struttura difensiva in legno è stata scoperta letteralmente il penultimo giorno degli scavi, insieme a una moneta coniata nel 43 d.C., prova che la struttura non poteva essere stata costruita in connessione con il Limes. Cunicoli romani situati sopra il deposito d’argento Ma perché i romani non riuscirono a completare il grande accampamento, scegliendo invece di abbandonare entrambe le zone dopo pochi anni? A cosa servivano le strutture? “Gli archeologi – risponde la Goethe University – hanno trovato un possibile indizio negli scritti dello storico Tacito: descrive come, sotto il governatore romano Curtius Rufus, i tentativi di estrarre minerale d’argento nell’area fallirono nel 47 d.C. Il rendimento era stato semplicemente troppo basso. Il team di archeologi di Francoforte è stato infatti in grado di identificare un sistema di pozzi-tunnel che suggerisce origini romane. Il tunnel si trova a pochi metri sopra il passaggio di Bad Ems, che avrebbe consentito ai romani di estrarre quantità enormi di argento, proseguendo sino a 200 anni fa, se la storia gliel’avesse concesso”. “L’argento fu estratto solo nei secoli successivi. La speranza dei romani per una redditizia operazione di estrazione di metalli preziosi spiega anche la presenza del campo militare: volevano essere in grado di difendersi da incursioni improvvise, uno scenario non improbabile dato il valore della materia prima. “Per verificare questa ipotesi, tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche”, afferma il prof. Scholz. Sarebbe interessante sapere, ad esempio, se anche il grande accampamento fosse circondato da ostacoli destinati a ostacolare l’avvicinamento del nemico. Finora non sono state trovate punte di legno lì, ma le tracce potrebbero forse finire per essere scoperte nel terreno molto più arido!. Miniere d’argento riservate ai secoli successivi Se avessero saputo che secoli dopo, in tempi moderni, 200 tonnellate di argento sarebbero state estratte dal terreno vicino a Bad Ems, forse non si sarebbero arresi così in fretta. I soldati a cui era stato ordinato di scavare le gallerie evidentemente non erano stati troppo entusiasti del duro lavoro: Tacito riferisce che essi scrissero all’imperatore Claudio a Roma, chiedendogli di consegnare in anticipo le insegne trionfali ai comandanti. Un’entusiasmante storia di ricerca, che anche Frederic Auth, che dal 2019 guida gli scavi a Bad Ems, sa raccontare in modo coinvolgente. Il suo racconto ha vinto il primo premio in un campo interdisciplinare di candidati al 21° Wiesbaden Science Slam all’inizio di febbraio. La ricerca a Bad Ems è stata condotta in collaborazione con la Direzione dell’archeologia statale presso la Direzione generale per i beni culturali della Renania-Palatinato, l’Istituto di preistoria e protostoria dell’Università di Erlangen-Norimberga e l’Università di scienze applicate di Berlino. Sono stati coinvolti anche il ricercatore e conservatore onorario dei monumenti Jürgen Eigenbrod e il suo collega Hans-Joachim du Roi, nonché diversi metal detector con i necessari permessi delle autorità dei monumenti storici. Il progetto è stato finanziato con il sostegno della Gerhard Jacobi Stiftung, della Società per l’archeologia del Medio Reno e della Mosella e della Fondazione tedesca per la ricerca (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). Le punte di legno sono state nel frattempo conservate al Römisch-Germanisches Zentralmuseum di Magonza. https://www.stilearte.it/i-soldati-romani-persero-200-tonnellate-dargento-la-prova-archeologica-emerge-dagli-scavi-presso-il-fiume/4 punti
-
Ciao @Catt. Qualcuno ti ha consigliato di lasciar perdere. Probabilmente a pelle non piace, anche se non si sono espressi sulla genuinità del denario L. Si tratta di una modesta fusione a cera persa. I piani non hanno niente di una moneta coniata, così come puoi vedere dalle foto in dettaglio, le sferette lucide tipiche da fusioni a cera persa. Nel merito dei tagli, solo una disattenzione del falsario, nel manipolare la copia in cera con pinzetta.4 punti
-
Come sospettavo grazie mille ! Rapidi e (quasi) indolori ! Torno nella povertá che mi appartiene !3 punti
-
2 punti
-
Buonasera a tutti, sono sempre piu affascinato da queste piccole monetine e dalla loro iconografia. Monetazione per niente monotona. Come riportato da @Illyricum65 nella sua pregevole discussione* ( che rappresenta per me un importante punto di riferimento) ci sono più varianti iconografiche. *La ripropongo qui per completezza. Ho ripreso con piacere a collezionarle e questa sera ve ne mostro qualcuna della serie . "Legionario che trafigge un cavaliere " @Stilicho so che è anche lui sensibile a questa tematica vediamo cosa ne pensa, sono ovviamente graditi commenti di chiunque voglia intervenire. Saluti Alberto2 punti
-
La fine del secondo conflitto mondiale portò l’Italia sul baratro del caos più totale. L’economia era disastrata, molti territori nazionali erano stati ceduti nei trattati di pace. L’inflazione aveva logorato enormemente il potere d’acquisto della lira. Il taglio più alto allora in circolazione, quello da mille lire, non aveva più un forte potere d’acquisto e quindi si rese immediatamente necessaria la creazione e l’introduzione nel tessuto economico di nuovi tagli di valore superiore. Nell’agosto del 1945 un Decreto Ministeriale autorizzò dunque la Banca d’Italia ad emettere titoli provvisori da 5 mila e da 10 mila lire. Essendo realizzati di fretta e trattandosi appunto di biglietti “provvisori” vennero usati come modello alcuni Vaglia Cambiari con minime modifiche come ad esempio l’aggiunta al centro del biglietto del contrassegno di Stato (Testina prima e Medusa poi). Questi titoli provvisori erano pienamente convertibili non solo con i biglietti classici di Banca ma anche con i biglietti d’occupazione come ad esempio le Am-lire. Queste ultime erano in circolazione regolarmente sul territorio Italiano a fine guerra e lo rimasero fino alla fine degli anni Quaranta. La semplicità grafica e la quasi totale assenza di elementi di sicurezza, tranne una piccola filigrana in uno spazio bianco a sinistra raffigurante una testa femminile posta di lato con sul collo alcune spighe, favorì enormemente i falsari. I titoli provvisori da 5 mila lire furono realizzati con diversi Decreti d’emissione fino alla fine del 1949 e mentre in un primo momento venne usato il contrassegno “Testina”, ben presto verrà sostituito con il contrassegno “Medusa”. Al Dritto dei biglietti vi sono presenti due teste muliebri rivolte verso il centro. La testa a sinistra rappresenta un profilo di Cerere mentre quella a destra il profilo dell’Italia. Il colore scelto per il taglio da 5 mila lire fu il blu celeste. Il Retro del biglietto è molto semplice e si caratterizza per la scritta che occupa tutto il biglietto “LIRE 5.000”. Questo sarà la prima tipologia con taglio da 5 mila lire, la primo di una lunga serie che avrà termine solo con il passaggio decenni dopo dalla lire all’euro. I Titoli provvisori sopravvissuti sono quasi tutti col contrassegno medusa, dunque i primi sono estremamente difficili da reperire sul mercato collezionistico. Il biglietto misura 254x75 mm e a causa della sua insolita lunghezza erano di solito piegati in più punti e durante la circolazione tendevano a logorarsi molto facilmente. Proprio per questo motivo è difficile reperire sul mercato collezionistico titoli provvisori in alta conservazione. Questo titolo facente parte della collezione Giaquinta fu emesso grazie al decreto amministrativo del 5 agosto 1945 e realizzato in 8 milioni di esemplari durante il regno d’Italia, successivamente verrano sanciti nuovi decreti d’emissione nelle prime fasi della Repubblica. Questi titoli provvisori furono messi in circolazione a partire dal luglio 1946 e finirono fuori corso il 30 giugno 1953. Fonti bibliografiche: -Monografia “Banca D’Italia,museo della banconota” Vol.1, 2000 -Catalogo cartamoneta Italiana “Gigante 2023” RIEPILOGO •Titolo provvisorio da 5 mila lire “Testina” •Decreto: 5 agosto 1945 •Tiratura : 4 Milioni Finalmente la medusa non è più sola all’interno della mia collezione 😀 E giusto per non farci mancare niente, ecco anche un falso d’epoca (veramente ben fatto) della stessa tipologia.2 punti
-
Ringrazio l'amico @numys per aver risollevato questa discussione creata sette anni fa integrandola con preziosi ed interessanti contributi. Giusto per curiosità, ed a integrazione del post #5, due pagine interne de La Domenica del Corriere del dicembre 1961 non presenti nella discussione.2 punti
-
Ciao, come già detto si tratta di un sesterzio dell'Augusta Faustina Minore con al rovescio una delle raffigurazioni della Consecratio ossia della consacrazione. Sono delle coniazioni postume, fatte dal marito ed imperatore Marco Aurelio, dopo la sua morte. Posto foto moneta stessa tipologia 🙂 ANTONIO2 punti
-
Scusate il ritardo purtroppo nel 2016 non ero ancora iscritto😉. Comunque volevo complimentarmi con @nikita_ per il post che risalta la figura di un grande pittore, disegnatore, illustratore che ha saputo raccontare la realtà italiana trasformandola in poesia ma sempre con grande rispetto (cit. Marcello Marchesi) ecco perchè molte delle copertine di Molino sono diventate oggetti da collezione. Di seguito una breve rassegna di alcune sue copertine: e alcune caricature: oppure con le illustrazioni di situazioni di pericolo più assurde ed incredibili: https://dangerousminds.net/comments/walter_molinos_lush_illustrations_of_people_in_peril Inoltre il post di @nikita_ha evidenziato come in quegli anni c'era l'esigenza di aver un taglio superiore al 10.000 lire per una maggiore stabilità e praticità e mi permetto di allegare l'articolo, a firma di Luciano Micconi, che analizza tali aspetti nonché dettaglia il potere d'acquisto della lira nel tempo: Spero che rispolverando questa discussione, che reputo molto importante da un punto di vista storico, artistico e sociale, possa non soltanto incuriosire ma anche essere oggetto di approfondimenti. Sempre un passo avanti @nikita_👍 Grazie e buona lettura numys2 punti
-
come correttamente anticipato da @bavastro si tratta di un doppio denaro coronato emesso per la contea di Provenza a nome di Charles II d'Anjou; vedi per confronto la pagina in collegamento... https://www.cgbfr.com/provence-comte-de-provence-charles-ii-danjou-double-denier-coronat-tb-ttb,v54_0267,a.html Mario2 punti
-
Ciao, ho seguito con molta attenzione questa discussione, anche se è una monetazione bellissima la napoletana che purtroppo non colleziono, ed essendo sempre interessato al discorso falsi esprimo quello che è un mio parere in base alle foto pubblicate dall'autore del post. Che sia un falso è indubbio e quasi sicuramente d'epoca. Sulla tecnica utilizzata per produrlo io propenderei, visto l'aspetto generale della moneta, per la fusione e non per la coniazione. Dalle foto del bordo postate, in due si può vedere che è molto regolare. In una invece (che posto) si vede come ci sia una piccola mancanza di metallo anomala ed una sorta di eccedenza di metallo simile ad una sbavatura che molto probabilmente è il punto di ingresso del metallo fuso quando è stata prodotta la moneta. Preciso che il mio è solo un parere basato su quello che le foto mi comunicano visivamente. Resto anche io in attesa di altri interventi 🙂 ANTONIO2 punti
-
Medaglia straordinaria del Pontificato di Pio XI senza data , realizzata nel 1938 a ricordo della beatificazione di Santa Maria Domenica Mazzarello (1837-1881), fondatrice della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice dette Salesiane di Don Bosco -F.M.A., la cui ricorrenza è oggi 14 maggio. Fu canonizzata da Pio XII nel 1951. Si ringrazia la Numismatica Varesi di Pavia per aver prestato la foto della medaglia, appartenente alla raccolta Liburnum - PB https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-AF15S/1571 punto
-
Buongiorno. Sperando di fare cosa gradita vi segnalo che nella prossima asta ROMA NUMISMATICS asta XXVII 22 e 23 marzo 2023, al nr di lotto 764 compare questa interessante moneta "imitativa" del tipo GLORA ROMANORUM. @grigioviola spero che possa interessarti. Description "Censeris" Æ 18mm. Uncertain (British?) mint, circa AD 354-358. [..]NSERI[..], diademed, draped and cuirassed bust to right / COHTATI[...]S, emperor standing to left on galley, holding phoenix and standard with Chi-Rho on banner, Victory seated behind, steering ship. Cf. C.H.V. Sutherland, "Carausius II", "Censeris", and the Barbarous FEL. TEMP REPARATIO Overstrikes in NC Vol. 5 (1945), No. 3/4 , pp. 125-133, 6; cf. BM 1971,0318.1 = R.A.G. Carson and J.P.C. Kent, ‘A Hoard of Roman Fourth-Century Bronze Coins from Heslington, Yorkshire’ in NC Vol. 11 (1971), p. 225. 1.91g, 18mm, 12h. Good Very Fine. Very Rare. From a private UK collection. Fin qui i dati. Di seguito propongo la traduzione della descrizione Nel 1887 Sir Arthur Evans pubblicò una notevole copia di un FEL TEMP REPARATIO Æ romano trovato a Richborough recante la legenda DOMINO CARAVSIO CES (NC Vol. 7, pp. 191-219). Evans ha sostenuto che la moneta non era semplicemente una barbara imitazione, ma quella di un sovrano del quinto secolo altrimenti non registrato della Gran Bretagna meridionale di nome Carausius. La moneta pubblicata da Evans condivide lo stesso tipo di rovescio del presente esemplare e allo stesso modo reca una versione confusa del nome Costanzo (che fu interpretato erroneamente come Costantino da Evans) sul rovescio. Ciò portò Evans a concludere che questo nuovo Carausius fosse associato a Costantino III, sia come usurpatore indipendente che chiedeva il riconoscimento sia come effettivo candidato del legittimo imperatore. La questione venne riaperta nel 1945 da C.H.V. Sutherland che poté pubblicare ulteriori esemplari rinvenuti a Richborough oltre ad altri di provenienza incerta. I nuovi esemplari erano tutti del tipo "cavaliere che cade", tuttavia condividevano tutti una somiglianza di stile con l'esemplare di Evans, nonché caratteristiche chiave come il nome confuso di Costanzo sul retro. Sebbene le loro leggende fossero incomplete, c'erano prove sufficienti per Sutherland per concludere che Carausius fosse il probabile nome indicato su tre dei nuovi esemplari che pubblicò. Sutherland rifiutò l'attribuzione di Evan di questa monetazione al V secolo e stabilì che furono coniati durante gli anni 350, una visione successivamente supportata da Kent che sostenne che quasi certamente possono essere assegnati agli anni 354-8 (NC Vol. 17, pp. 78- 83). Gran parte degli studiosi successivi, tra cui Kent e più recentemente Casey, si sono concentrati sulla potenziale esistenza di un "Carausius II" e ha trascurato quasi del tutto una delle scoperte di Sutherland. Tra le monete incluse nel suo articolo del 1945 ce n'era una trovata a Richborough che portava il nome di un potenziale sovrano completamente diverso, il cui nome può essere letto come Censeris o forse Genseris (DOMINO CΛ[…] CENSERIS). Sebbene frustrantemente incompleto, è probabile che il presente esemplare porti anche il nome Censeris (..NSERI..) data anche la somiglianza nello stile e nella tipologia con gli esemplari pubblicati da Sutherland. Sutherland era convinto che entrambi rappresentassero emissioni di governanti minori che affermavano di essere colleghi di Costanzo II e potessero essere attribuiti al periodo (o alle conseguenze) dell'usurpazione di Magnenzio quando Costanzo non deteneva il controllo totale sulla Gran Bretagna. Non ci sono prove storiche, tuttavia, dell'esistenza di una persona o di un dominio semi-indipendente. Anche lo storico Ammiano Marcellino tace sulla questione nonostante abbia fornito quello che sembra essere un resoconto completo degli eventi in Gran Bretagna durante questo periodo. Inoltre, gli argomenti altamente tecnici e convincenti di Kent per isolare la datazione di questi problemi agli anni 354-358 li collocano durante un periodo in cui Costanzo deteneva il controllo indiscusso sull'impero e i suoi agenti erano particolarmente attivi nel punire i dissidenti in Gran Bretagna. Mentre gli scettici potrebbero ignorare questi problemi come semplici copie, Casey osserva che mostrano un grado di originalità che va ben oltre i loro prototipi (Carausius e Allectus: The British Usurpers, London, 1994, p. 167). Se queste monete sono semplicemente copie, allora perché tentare di incidere i nomi "Carausius" e "Censeris"? Perché incidere DOMINO invece della sigla che troviamo sugli originali e sostituire la legenda al rovescio con qualcosa di completamente diverso? Queste domande rimangono irrisolte e il caso di Carausio e Censeris rimane non provato.1 punto
-
Salve a tutti. Dopo le interessanti discussioni su splendidi argenti apro una parentesi su un piccolo bronzo. Dovrebbe essere il primo tipo coniato a Thurium . al D/ Athena con elmo attico verso destra, al R/ toro andante verso sinistra, con testa abbassata; sopra ΘOYPIΩN; lettera A tra le zampe del toro; in esergo ? . Diametro 15,5 mm peso 2,83 gr . Classificato come HN Italy 1904, SNG Cop 1494, Attianese Calabria Greca 1250, BMC 124 (con toro verso destra), in nessuno dei tipi richiamati è riportata però la A sotto il toro. Acquistata una quindicina di anni fa da Lanz non ho trovato in aste seguenti, in cataloghi o in sillogi questa variante con lettera A sulla quale chiedo, come ormai è mia abitudine, lumi agli amici del forum che ringrazio anticipatamente. PS) le foto lasciano un po' a desiderare perchè ', oltre alle mie non grandi capacità, la patina nera, molto solida, è lucida e crea qualche difficoltà1 punto
-
Walter Molino (1915 –1997) è stato un famoso illustratore italiano. Esordisce nel 1935 nel Il Monello, L'Intrepido ed in vari giornali satirici. La sua popolarità cresce nel 1941 allorquando sostituisce il pittore Achille Beltrame nella realizzazione delle copertine de La Domenica del Corriere (settimanale del Corriere della Sera), per trent'anni Molino vi raffigurò il fatto più interessante della settimana. Era una rivista molto apprezzata sin dal 1899 e nel corso del tempo superò più volte il milione di copie vendute. Dal 1946 Walter Molino curò inoltre le coperine del Grand Hotel e tantissimi altri romanzi figurati. Fu anche un grande caricaturista di personaggi italiani ed esteri. Su La Domenica del Corriere n. 19 del 1965 Molino abbozza il fronte di un biglietto da 50.000 lire. In un passo dell'articolo: Una nuova banconota di grosso taglio, auspicata a suo tempo anche da Luigi Einaudi, dovrebbe facilitare tutte le operazioni milionarie e snellire la circolazione. Walter Molino, ispirandosi alle banconote presenti e passate, ha progettato questo tipo di banconota che ci offriamo di suggerire al Governatore della Banca d'Italia Dott. Guido Carli. (immagine tratta dal settimanale La Domenica del Corriere orginale del 1965 di mia proprietà) Nel 1967 viene ufficialmente messa in circolazione la banconota da 50.000 lire con il ritratto di Leonardo da Vinci, è stato accolto, anche se in parte, il suggerimento? Il settimanale era molto popolare sino alla fine degli anni '60, successivamente ci fu un inarrestabile declino nonostante era stata modernizzata la veste grafica, doveva giocoforza andare a passo con i tempi, le illustrazioni sparirono e la copertina diventò fotografica, ma indubbiamente perse il suo fascino. La Domenica del Corriere non fu più prodotta dal 1989, dopo novant'anni dalla sua nascita. Le altre banconote raffigurate sulla rivista che presento oggi, come recita un breve articolo sul retro del settimanale: "sono state riprodotte grazie alla collaborazione della Banca d'Italia".1 punto
-
Dopo, ordineremo un articolo sul quotidiano Corriere della Sera. L'arma segreta di Putin. Coccodrillo della terra settentrionale. Organizziamo una conferenza in Svizzera. Inviteremo testimoni oculari dall'Ucraina. E fidati di me. Tra un anno, tutti crederanno.1 punto
-
Ciao, grazie per aver ricordato. Abbiamo il divieto di discutere del ciarlatano N. Ma proviamo meglio e tu ed io diventiamo gli autori della bufala. C'è un documento originale. La cronaca di Pskov (1582), che descrive l'invasione dei coccodrilli: Dopo una tempesta, molti coccodrilli strisciarono fuori dal fiume, mangiarono mucche e molte persone. Su questa base scriveremo un libro: la Russia è il luogo di nascita dei coccodrilli.1 punto
-
DE GREGE EPICURI Questa medaglietta, comperata in Francia, pesa 2,29 g e misura 21 m; è un po' malconcia, e penso che avesse un appiccagnolo, che ha perduto. Come dimensioni e tipologia, ricorda un po' le numerosissime medagliette prodotte dopo la campagna del 1859, con le effigi di Vittorio Emanuele II e Napoleone III. Questa però è tutta francese: GARIBALDI VOLONTAIRE, recita la scritta al diritto; e al rovescio, intorno alle due bandiere francese e italiana, REPUBLIQUE FRANCAISE. Garibaldi in effetti arrivò a Marsiglia dopo la sconfitta ed esilio di Napoleone III, intenzionato ad aiutare la neonata repubblica. Era accompagnato dai due figli e le sue forze inizialmente furono molto raccogliticce, composite e non numerose, al massimo 4000 uomini, fra cui molti volontari italiani e stranieri. Poi (ma solo a periodi) le truppe aumentarono; il coordinamento con l'esercito francese fu sempre difficile. Ebbe però alcuni successi, in particolare a Digione, oltre a varie sconfitte; l'attività bellica fu sempre "di disturbo" e difensiva, evitando battaglie in campo aperto con le forze prussiane, molto più numerose ed equipaggiate. In alcuni casi fece numerosi prigionieri e si impossessò delle insegne del nemico. La Francia ufficiale non gli mostrò molta gratitudine.Fu eletto all'Assemblea Nazionale, ma la sua nomina non fu convalidata, e non gli fu permesso di parlare in quella sede, dove era avversato da molti deputati. L'unico a riconoscere la sua generosità, il suo valore ed i suoi successi fu il poeta (e deputato) Victor Hugo, in un celebre discorso.1 punto
-
1 punto
-
Questa è l' unica Pataca reale😅 Dai è per sollevarti un pò😄1 punto
-
ll problema è che qualsiasi tipo di misura da errori, incluso quando qualcuno misura la propria altezza. Quindi dire che una misura da errori e che per questo non è affidabile significa dire tutto e niente e buttarla in caciara. Se io voglio sapere quando fu creato un artefatto romano databile al C14 immagino di poter ottenere una datazione con un errore di una decina di anni. Se il ricercatore si accontenta di questo errore bene. Ma se poi voglio sapere l'esatto giorno mese e anno in cui il manufatto venne creato (magari perchè l'esatta datazione è storicamente rilevante), allora è normale che il C14 non sia lo strumento di datazione giusto. Ci sono altri strumenti (inclusa la stratigrafia, la numismatica, la storiografia) che permettono di fornire informazioni che il C14 non può dare. Dire però che i manufatti Romani vennero creati nel medioevo poichè il C14 commette un errore di una decina di anni significa semplicemente perculare chi ascolta1 punto
-
1 punto
-
Ahmad I° ( 1603/1617 – 1012/1026 AH) Sultani (Dinar) d'oro , Costantinopoli. Anno 1012 Egira , primo del sultanato che rimaneva invariato fino alla fine1 punto
-
Il vero problema non sono le vandale in senso stretto, che hanno vari problemi ... Ma come tutte le monetazioni. Il vero magma è dato dalle cosiddette protovandale e dal mondo delle imitazioni....1 punto
-
La moneta non è in mio possesso quando arriverà, riprenderò il post con foto fatte bene. Grazie per la valutazione io con le conservazioni sono molto stretto per prudenza a prestissimo e grazie ancora.1 punto
-
Salve. La medaglia commemora la morte della principessa Astrid di Svezia, moglie di Leopoldo III del Belgio, avvenuta il 29 agosto in un incidente stradale nei pressi di Küssnacht am Rigi, sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni. D/ Ritratto a mezzo busto della principessa con diadema, collana di perle e scialle ripiegato a sinistra. Firma G. DEVREESE lungo il bordo in basso a destra. R/ Ramo con gigli. Iscrizione ai lati SA MAJESTE / ASTRID / REINE DE GRACE / ET DE BONTE / 1934-1935 Bronzo: 141 g; diametro 74 mm; sul contorno in incuso J. FONSON 497. Provenienza asta Elsen 153. La medaglia è stata realizzata anche in argento. apollonia1 punto
-
Il caso di questa monetina in asta è interessante in quanto c'è già un poco conosciuto "caso CENSERIS" di cui ho giusto recentemente letto un articoletto del marzo 2022 comparso sul sito di The Classical Association in Northern Ireland. in cui si parla del presunto personaggio "Censeris" in relazione ad un'altra tipologia di monete. Due tipi di monete con riportato in legenda "Censeris". Cattiva (o difficoltosa) lettura o personaggio da studiare? La ricostruzione è davvero molto ipotetica ma estremamente interessante e esemplificativa del lavoro incrociato di sudio di fonto storiche testuali ed archeologiche nello specifico epigrafiche e numismatiche. Buona lettura1 punto
-
Ciao @Litra68. La serie FEL TEMP REPARATIO costituisce uno dei filoni principali della mia collezione (senza grosse pretese, eh? 😉) . Hai detto bene, questa serie non e' per niente monotona come potrebbe sembrare a prima vista, offrendo, infatti, una grande varietà di esemplari anche nell'ambito della stessa tipologia (qui falling horseman). A proposito delle falling horseman, io rimango sempre colpito dalla loro dinamicità: pare proprio di vedere le figure in movimento. E mettendo insieme più falling horseman si potrebbe quasi ricostruire una breve scena, come se fossero un insieme di fotogrammi. Senza contare la varietà delle effigi, con i dettagli di abbigliamento, copricapo, acconciatura, armamento e postura (del cavaliere, soprattutto). Ed infine, il prezzo che e' in generale abbastanza contenuto (ovviamente con tutti i distinguo del caso). La tue monete mi piacciono; sono monete che hanno adempiuto al lavoro per cui sono state prodotte, con un grande carico di storia sulle spalle. Se ti e' possibile, per mia curiosità, potresti fare una foto più dettagliata della moneta in alto a destra e fornire il diametro ed il peso? Grazie e buona giornata da Stilicho1 punto
-
Non è una banconota ma dovevo metterlo…. Ma che indica con le freccine?? Forse sono io con L occhio inesperto😏😏🤣🤣1 punto
-
Rocco, riporto la foto del retro della prima moneta postata in questa discussione. spero sia più chiara. Grazie. Un caro saluto.1 punto
-
Ciao @Giov60 Concordo in larga parte con il tuo pensiero. Sebbene le monete per collezionisti abbiano corso legale e potere liberatorio come tutte le monete in circolazione, hanno una caratteristica particolare che le differenzia dal normale circolante. L'autorità emittente (lo stato italiano) non cede queste monete al loro valore nominale, ma ad un valore arbitrario diverso da quello nominale. La perdita di significato del valore nominale fin dall'origine è a mio avviso dirimente per distinguere una moneta/medaglia pensata per i collezionisti da una moneta vera e propria pensata per la circolazione che poi può essere anche collezionata. L'abitudine di creare monete a corso legale con valore nominale fittizio è vecchia di almeno un secolo, vedi le 20 lire fascetto del 1923, che venivano vedute dall'autorità emittente a 80 lire o le 100 lire vetta e fascione dello stesso periodo, cedute a 400 lire (anche se in quel caso le caratteristiche dei 20 lire e 100 lire erano formalmente quelle della convezione monetaria latina, de facto non più operativa dal 1914). Sebbene non siano monete destinate alla circolazione, come tutte le cose hanno un interesse collezionistico (ognuno colleziona quel che gli pare). La numismatica tuttavia dovrebbe studiare la storia e le caratteristiche della monetazione destinata alla circolazione monetaria. Il collezionismo di monete il cui stesso valore sovraimpresso non è accettato dall'autorità che di diritto le emette, fatica ad essere inserito nella numismatica e rientra concettualmente nella medaglistica, che è una forma di collezionismo affascinante tanto quanto la numismatica, ma non è numismatica in maniera stringente. Volendo sintetizzare, a mio avviso le monete per collezionisti emesse dal IPZS hanno interesse scientifico/collezionistico e artistico, ma non rientrano pienamente all'interno del collezionismo numismatico, quanto in quello medaglistico, o comunque in una sovrapposizione fra le due forme di collezionismo. Sul valore che queste emissioni avranno ora e in futuro possiamo solo dire che ci vuole la sfera di cristallo. A mio avviso fin tanto che ci sarà l'Unione Europea, il mercato sarà vivo e pimpante (anche se è cercare di far spendere più di 5000 Euro ad un collezionista per le emissioni del solo 2023 mi pare folle da parte dell'autorità emittente). Il mercato delle emissioni in lire è crollato principalmente perchè non esiste la lira come moneta corrente, e quindi i nuovi collezionisti non trovano interessante andarsi ad impelagare in emissioni che non conoscono e che non gli appartengono.1 punto
-
Purtroppo Caro Archestrato è proprio cosi.... cerchiamo di dare sempre un nostro contributo, quando è possibile..1 punto
-
Se bloccassero l'acquisto agli account che già le hanno acquistate a febbraio (a maggior ragione quelli dei furboni che ne hanno prese in quantità), farebbero cosa gradita, evitando così ulteriori speculazioni.1 punto
-
Fondamentale, ho velocemente visionato la sezione di cui mi parli. Mi scuso per la disattenzione. Domani provvederò a pubblicare la foto della mia moneta nella discussione giusta, in modo che Rocco possa inserirla nel suo censimento. Ancora grazie per la tua segnalazione. Buonanotte.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
e questo? sarà la madre degli altri?? Emporium Hamburg 85, n. 20 ITALIEN, LUKANIEN / Stadt Paestum, AE Sextans (268-89 v.Chr.). Kopf der Demeter r., dah. 2 Punkte. Rs.Eber r. über Mondsichel. 3,72g. SNG Cop.1341;1 punto
-
si, ho provato; il suono è un po' più sordo, non quello tipico dell'argento.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Qui vedete un tagliando che notifica una spedizione di metallo prezioso (oro e argento) a testimonianza di come venissero movimentati gruppi di preziosi. Se ne legge il valore dichiarato in lire. Siamo nel 1850, nel Lombardo Veneto (da Morbegno a Milano), dovremmo dedurre che di lira austriaca si tratti. La ricevuta non ci dice molto altro se non che la spedizione è indirizzata presumibilmente a un privato. Si sarà trattato di metallo già monetato o di metallo grezzo? Non lo sappiamo. Magari si trattava di candelieri a 800/1000, chissà... Mi piacerebbe imbattermi un giorno in una ricevuta di una spedizione indirizzata alla zecca.1 punto
-
Io penso, però, che si tratti di Costanzo II Cesare, zecca di Nicomedia. Buona serata da Stilicho1 punto
-
Di seguito anche il 4 Tornesi, Proveniente dalla Numismatica De Falco.1 punto
-
Quel giorno ero contento di poter incontrare il "papà" di uno dei miei eroi della mia infanzia ed era stata organizzata una giornata celebrativa in tuo onore e per quello che sei stato capace di creare. Ma all'improvviso non potesti venire, poiché ti sei ritrovato ad affrontare una grande battaglia e che hai combattuto con lo stesso spirito che è presente nei racconti che ci hai lasciato... "Ci rivedremo in quel luogo dove le ruote del tempo si incrociano". Buon viaggio Maestro Matsumoto. Akira "Leiji" Matsumoto ( 25/01/1938 - 13/02/2023 )1 punto
-
Bella moneta. Molto bella. Presenta anche una curiosità, mi pare. Le due E di VENETVS. Il trattino orizzontale superiore dell'ultima sembra interrotto, spezzato, mentre nella prima quel trattino non c'è. Il punzone della E si è spezzato durante la preparazione del conio? Se è così avremmo l'indicazione della direzione in cui venivano incise le lettere del conio, ciò, in questo caso, in senso orario; per altro cosa intuibile per un destrorso.1 punto
-
Ciao Domenico. In questo momento scrivo con il telefono e quindi errori sono suscettibili. Ti informo che l'utilizzo della croce Pisana risale al Barbarigo ed a mio parere (discusso con la dott.ssa Baldassarri) è un affronto fatto a Firenze ed a Milano (allora alleate) in quanto Venezia sosteneva Pisa. Si parla se non ricordo male del 1494. Il riutilizzo della croce Pisana va di pari passo al fatto che i sesisi veneziani erano la risposta ai sesini bianchizadi di Milano che avevano la croce con i ricci. Potrei darti più informazioni, ma sto scrivendo un articolo che andrà in futura pubblicazione, pertanto ti devi accontentare.😉😊1 punto
-
Il suo valore è dato dal peso dell'argento in esso contenuto. Troppo rovinata per avere un valore collezionistico.1 punto
-
Un esemplare, frazionato al bordo, di denaro al nome di Carlo magno ( monogramma al diritto ) , attribuito a Milano e descritto in didascalia RRR . Sarà il 30 Gennaio in vendita NomismaAste 2 al n. 642 .1 punto
-
Ringrazio #Gigetto 13 per la considerazione, ma ha fatto tutto Grierson ...ubi maior..... Io mi sono limitato ad attribuire gli stessi criteri a monete più tarde rispetto a quelle illustrate nel MEC1 (come tra l'altro aveva già suggerito Murari) e poi a documentare con i ritrovamenti veneti quanto l'ipotesi di Grierson fosse corretta. Piuttosto su quella moneta di Berengario io ho effettivamente detto una cosa nuova, cioè che si tratta di Berengario II (950-961) e non di Berengario I, come è a mio avviso è dimostrato da un importante ripostiglio da Feltre. Se vi interessa trovate la mia ipotesi sintetizzata in una nota dell articolo sul denaro veneziano di Ottone da Cividale, disponibile in rete. Notte, Andrea1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?