Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 04/25/23 in Risposte
-
Volevo dirvi che... quando mi sono iscritto a questo gruppo l'ho fatto perché, dopo anni di archeologia sul campo e dopo averla abbandonata con delusione del sistema Italia ed universitario per dedicarmi ad altro, un mio amico - il fratello minore che non ho mai avuto - nipote di un importante collezionista e studioso di Bologna, mi ha fatto riappassionare alle monete antiche. e qui trovavo spunti di divertimento e di leggero approfondimento. si... leggero... Il problema è che sono stato investito da così tanta roba meravigliosa che ora sono impazzito per le monetazioni altomedievali, da lì la monetazione bizantina... ma non vuoi anche interessarti al periodo tardoromano? E poi c'è sempre la monetazione repubblicana romana che era stata la mia prima passione da studente di numismatica. Però anche le celtiche sono interessanti... E vuoi mettere le monete medievali? Ci sono aree del forum che non voglio neppure aprire per paura 🙂 Mannaggia a voi!!!! Il leggero problema è che ad ora ho in elenco qualcosa come 68 tra articoli scientifici e libri da leggere, sto collezionando centinaia di immagini tratte dal web della qualunque e tra un po' mia moglie cambierà la serratura della porta di casa... Mannaggia voi... grazie! PS... ho inserito queste due righe qui proprio perché è una questione visceralmente numismatica anche se non si tratta di un oggetto in particolare.8 punti
-
Nota in oro e argento, ci svela una pagina di storia della Somalia Italiana e del faro edificato a Capo Guardafui, sentinella del mare e simbolo di un’epoca di Roberto Ganganelli | Capo Guardafui, un luogo ignoto a quanti non conoscono in modo approfondito la storia, in particolare quella coloniale italiana: punta estrema del Corno d’Africa, nell’attuale Somalia, ha a nord il Golfo di Aden e a sud l’Oceano Indiano. Capo Guardiafui e il suo faro, un po’ di storia Conosciuto nell’antichità come Aromatum Promontorium – ossia, “Promontorio delle spezie” – deve il suo nome ai pericoli che i naviganti incontravano in quel tratto di mare. Naviganti e mercanti soprattutto italiani, tanto che il nome attuale deriverebbe da “guarda e fuggi” anche se alcuni studiosi pensano sia derivato dal portoghese. Poco distante da Capo Guardafui si trova il cosiddetto “Falso Capo Guardafui” che, a causa delle nebbie, veniva talvolta confuso col precedente causando incidenti marittimi e rovinosi naufragi. Per questo, nei primi anni Venti, durante il dominio italiano sulla Somalia, venne decisa l’edificazione di un faro che venne inaugurato nel 1924 e intitolato a Francesco Crispi (1818-1901) il quale, da presidente del Consiglio, aveva avviato la colonizzazione. Capo Guardafui nel Corno d’Africa: in posizione strategica, divide il Golfo di Aden dall’Oceano Indiano. La carta della Somalia Italiana è qui raffigurata sul rovescio di una medaglia della Squadriglia autoblindo della Somalia risalente agli anni Trenta Si trattava di un classico faro a traliccioche, tuttavia, pur strategico per la navigazione poneva non pochi problemi logistici, sia per la sua posizione difficile da raggiungere per i convogli dei rifornimenti sia per la presenza, in zona, di agguerriti ribelli migiurtini che attaccarono a più riprese l’installazione. Una guarnigione militare presidiava il Faro Francesco Crispi e, nel vicino villaggio di Tohen, dove era stata installata una fondamentale stazione radiotelegraficadotata di due grandi antenne, strategica per le comunicazioni nella regione. Dal traliccio al “fascione”: l’idea del governatore Corni Progettato dagli ingegneri della Regia Marina, il faro dovette essere modificato nel 1930 a causa della corrosione atmosferica e venne realizzato, sotto il governatorato di Guido Corni, quell’edificio così particolare che esiste ancora oggi. Il Faro Francesco Crispi nell’originaria forma con struttura a traliccio e in quella inaugurata nel 1930, voluta dal governatore della Somalia Italiana in pietra locale e con un fascio in cemento armato Eccolo in una descrizione dallo stesso Corni: “Nel 1929, presentando il traliccio in ferro del Faro Crispi segni di avanzata corrosione dovuta all’azione dell’aria marina, feci montare la lanterna su di una torre in pietra rossa e dura del luogo, cerchiata di anelli in cemento armato e recante una scure, simbolo del littorio”. Francobolli per un faro simbolo del regime in Africa Diciannove metri di altezza, come un edificio di sei piani, e soprattutto quella forma così “propagandistica” e particolare che lo rendono un simbolo della presenza italiana nella regione. Il faro di Capo Guardafui, a partire dal 1932, divenne il soggetto di una serie di francobolli“pittorici” della Somalia Italiana nei quali è raffigurato mentre, con i suoi potenti riflettori, dall’altura di 244 metri su cui è edificato, squarcia il cielo notturno (le lampade avevano una portata di circa 40 miglia). I quattro francobolli emessi dal 1932 dalle Poste Italiane con l’immagine del faro di Capo Guardafui La serie venne stampata dal Poligrafico dello Stato e approvata con Regio Decreto del 7 gennaio 1932 apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio. Gli otto soggetti scelti furono: il Faro Francesco Crispi (per i valori da 5, 7 ½, 10 e 15 centesimi), la Torre Mnara di Mogadiscio, il Palazzo del Governatore a Mogadiscio, un termitaio, uno struzzo, un ippopotamo, un’antilope Kudù e il tipico leone somalo con una piccola crineria. La medaglia della Regia Marina per il “Faro Mussolini” Ribattezzato anche “Faro Mussolini”, l’edificio appare inoltre su una medaglia, rarissima in oro e rara in argento, coniata nel diametro di 23,5 millimetri circa (in oro 18kt, pesa 8,5 grammi) e sul cui dritto le iscrizioni SOMALIA ITALIANA e REGIA MARINA circondano la figura turrita dell’Italia che riceve da un soldato ferito il tricolore; sullo sfondo, i tetti e le cupole di un villaggio somalo. La raffigurazione si riferisce all’eroismo dei militari italiani e somali che difesero il faro dagli attacchi dei ribelli tra il 1925 e il 1926. La rarissima medaglia con il “Faro Mussolini” e le vicine antenne radiotelegrafiche rende omaggio, al dritto, all’eroismo dei soldati italiani e somali che difesero la struttura fra il 1925 e il 1926 Solenne anche il rovescio sul quale il “Faro Mussolini” è raffigurato assieme alle antenne della vicina stazione radiotelegrafica e ad una figura femminile in volo col motto PER SILENTIA ET SIDERA(“Attraverso silenzi e stelle”) a ricordare sia quella luce guida – così importante per la navigazione – che quei segnali radio che, dalle antenne di Capo Guardafui, si diffondevano nell’etere. La medaglia risale a dopo il 1930, dal momento che raffigura già la versione “littoria” del Faro Francesco Crispi che, anche questo pochi lo sanno, pur non più operativo esiste ancora. Potrebbe addirittura essere stata realizzata in occasione dell’inaugurazione del faro. Il faro di Capo Guadafui dopo la caduta della Somalia Italiana Nel corso della Seconda guerra mondiale gli inglesi, dopo aver sconfitto gli italiani e aver conquistato la Somalia, non abbatterono il Faro Francesco Crispiche, anzi, restò acceso anche negli anni Cinquanta, durante l’Amministrazione fiduciaria italiana sulla ex colonia. Francesco Crispi (1818-1901), iniziatore della politica di espansione coloniale del Regno d’Italia nel Corno d’Africa, e un’immagine del faro di Capo Gaurdafui come appare oggi L’ultimo suo guardiano si chiamava Antonio Selvaggi ed era soprannominato “il principe di Guardafui” e quel faro, diventato protagonista nel 2015 di un libro di Alberto Alpozzi (clicca qui per saperne di più), per la Somalia del XXI secolo è candidato a diventare un monumento storico. Uno spunto di riflessione per quanti sbandierano la cancel culture come la crociata del secolo. Aspettiamo voci più autorevoli,può trattarsi di una spilla commemorativa al Faro di Crispi ma posso sbagliarmi ...,3 punti
-
2 punti
-
Sempre nella Certosa di San Martino sono custoditi due stemmi: uno con il leone rivolto a destra, l'altro a sinistra. Un'ulteriore conferma di come l'araldica - non solo quella monetaria - fosse lasciata all'estro dell'artista.2 punti
-
Errori del genere esistono, sono documentati e, naturalmente, assai rari. Per quanto riguarda i Washington quarters, sono noti 3 (TRE) esemplari di monete two-tailed, doppia coda, ovvero con l'aquila incisa su entrambe le facce https://coinweek-com.translate.goog/pcgs-certifies-two-rare-unusual-washington-quarter-errors/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp Non ho trovato riscontri su monete, autentiche, con due teste, mentre anche nel link citato si fa riferimento ai numerosi falsi, ottenuti attaccando insieme due mezze monete autentiche. Se ne parla più diffusamente qui: https://www-thesprucecrafts-com.translate.goog/two-headed-coin-value-768399?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp Attendiamo le foto del contorno della moneta, indispensabili per capire se si tratti di un artefatto o se possa essere, invece, un autentico errore di conio. petronius2 punti
-
Quello che ha scritto è bellissimo, io proprio come lei da quando ho scoperto questo forum mi sono appassionato alla numismatica e ora non saprei proprio come farne a meno. Mi sono appassionato alla numismatica quando avevo più o meno 10 anni, ora ne ho 18 e penso che mi abbia aperto un mondo di conoscenze che nemmeno sapevo esistessero. Dai Celti ai Normanni passando per i Longobardi e i Bizantini tutte popolazioni che a me prima erano totalmente sconosciute e che ora in piccolissima parte conosco. Grazie mille a tutte le persone che contribuiscono ogni giorno alla crescita di questo forum2 punti
-
Mi scuso per non essere riuscito a collegarmi prima (grazie Luciano per avermi citato) e provo ora a rispondere. Il sesino postato da @titire è una variante di Alvise Mocenigo (1570-1577) ed è una delle 99 varianti emesse durante il dogado. Molto interessante è l'avere il cerchio sia al dritto che al rovescio che rende questa moneta leggermente più rara delle sue sorelle. Il Papadopoli nel suo libro per il doge Mocenigo oltre alle 99 varianti inserice anche 14 disegni: e questo è il sesino della nostra discussione. Interessante anche il peso di g. 1,51 che è una via di mezzo tra il peso teorico della prima emissione di Francesco Donà con g. 1,764 e l'emissione di Pietro Loredan dove il peso era stato portato a g. 1,324 (dovevano essere tagliati 180 pezzi per marca). L'ipotesi che il tuo sesino sia la prima emissione sucessiva al Pietro Loredan è intrigante sia per il disegno sia per il peso. Per quanto riguarda l'iconografia ti ricordo che la croce psana era già stata utilizzato dal Barbarigo in 2 monete per i possedimenti di terraferma. Altro particolare divertente è il nome: perchè sesino se valeva 8 piccioli o bagattini ed aveva il valore di 2 quattrini? La risposta è nella prima emissione in quanto il sesino doveva sostituire nelle nuove province di terraferma “certi sesini forestieri bianchizadi”. In questo caso si effettua una rivalutazione in quanto 1 soldo vale 1 sesino e mezzo al posto del valore di 2 sesini stranieri occorrenti in modo da renderlo più accettabile alla popolazione. Spero di essere stato di aiuto e buon 25 Aprile. Fabry2 punti
-
Stessa domanda per la piastra del 1785 che ha il leone a destra e 10 torrette disposte 3/2/2/2/1(come il ducato del 1784)mentre il ducato dello stesso anno ha il leone a sinistra ma le torrette del Portogallo adesso sono 9 disposte 3/2/2/1/1... ...2 punti
-
In alternativa ad ‘armonica’ a me verrebbe ‘armatura’. Un saluto, Valerio2 punti
-
Per non parlare del pungente e pacificatore Petronio, interpretato da Leo Genn, che per chi non se ne fosse accorto è l'immagine che rappresenta l'amico @petronius arbiter2 punti
-
NAPOLI Repubblica napoletana (1648) Da 15 Grana 1648 var. sigla X AG (g 4,31) questo esemplare -a mio giudizio- si caratterizza per la lettura completa dell’anno 1648. Avrei però un quesito da sottoporre con riferimento al lavoro di Pietro Magliocca, La moneta napoletana dei re di Spagna nel periodo 1503 - 1680 (Nomisma, 1a Edizione 2020), pagg. 254-255. Vengono catalogati al riguardo due tipi: a) tipo GAC/S b) tipo GAC/M Ricordo che al D/ viene rappresentato il busto di San Gennaro mitrato, con la mano destra benedicente e con quella sinistra che tiene un pastorale ed un libro sul quale sono poggiate due ampolle; a destra, le sigle mentre a sinistra è presente il contrassegno. Mentre al R/ abbiamo lo stemma coronato con all’interno la scritta SPQN (Senatus PopulusQue Neapolitanus). Il tipo GAC/S (Magliocca 1 pag. 254) non riporta tra le varietà il contrassegno della “X”, presente invece tra le varietà di cui al tipo GAC/M (Magliocca 2 pag. 255). Le iscrizioni circolari sia per il D/ sia per il R/ sono uguali per entrambi i tipi. D/: ^S^I^REGE^ET^PROTE^NOS (data) R/: ^HENR^DE^LOREN^DVX^REI^NEAP Il dubbio nasce sull’esatta interpretazione/lettura della sigla sull’esemplare postato. In sintesi, secondo voi, si tratta di GAC/S ovvero di GAC/M ? Grazie per qualsiasi contributo. Domenico1 punto
-
Buonasera a tutti, sono sempre piu affascinato da queste piccole monetine e dalla loro iconografia. Monetazione per niente monotona. Come riportato da @Illyricum65 nella sua pregevole discussione* ( che rappresenta per me un importante punto di riferimento) ci sono più varianti iconografiche. *La ripropongo qui per completezza. Ho ripreso con piacere a collezionarle e questa sera ve ne mostro qualcuna della serie . "Legionario che trafigge un cavaliere " @Stilicho so che è anche lui sensibile a questa tematica vediamo cosa ne pensa, sono ovviamente graditi commenti di chiunque voglia intervenire. Saluti Alberto1 punto
-
Importante ritrovamento archeologico in Spagna getta luce sulla misteriosa cultura tartessiana Due volti femminili rinvenuti negli scavi archeologici. Foto:CSIC. Ricercatori del CSIC spagnolo portano alla luce cinque busti in pietra del V secolo a.C. nel sito di Casas de Turuñuelo a Guareña (Badajoz), gettando nuova luce sulla misteriosa cultura tartessiana. Nei campi di Las Vegas del Guadiana, sono stati presentati questo martedì mattina i primi volti di sculture della cultura tartessiana, relativa cioè alla città di Tartesso. Si tratta di una antica civiltà che prese il nome dal fiume Guadalquivir, chiamato anticamente Tartessos, e che si sviluppò nella Penisola Iberica sud-occidentale, considerata una delle più importanti culture autoctone dela penisola iberica, che commerciava con fenici e greci, e che durò almeno fino al V secolo a.C. La misteriosa civiltà di Tartessos, sul fiume Guadalquivir I nuovi ritrovamenti stanno rendendo sempre più difficile sostenere l’antica teoria che la civiltà di Tartesso non avesse entità propria. Nella quinta campagna di scavi archeologici condotta da un team del CSIC presso il deposito di Casas de Turuñuelo a Badajoz sono stati rinvenuti cinque insoliti busti antropomorfi risalenti al V secolo a.C. che cambiano l’interpretazione della storia. I volti hanno una qualità che si riteneva impensata in quel periodo. Nell’area è in corso di escavazione un grande edificio a due piani con oltre 2.500 anni di antichità che sta letteralmente gettando luce sul passato del Mediterraneo. Un ritrovamento archeologico molto importante Questo straordinario ritrovamento, informa il CSIC, rappresenta un profondo cambio di paradigma nell’interpretazione di Tartesso, tradizionalmente considerata una cultura aniconica per la rappresentazione della divinità attraverso motivi animali o vegetali, o attraverso betilos (pietre sacre). Infine, il ritrovamento non fa che sottolineare ulteriormente sia l’importanza del sito sia l’importanza della cultura tartessiana nella valle del Guadiana durante i suoi ultimi momenti. https://www.itagnol.com/2023/04/importante-ritrovamento-archeologico-spagna-getta-luce-misteriosa-cultura-tartessiana/ Hallazgo histórico: descubiertos los primeros rostros humanos en la antigua Tartessos Se trata de un descubrimiento inédito al representar rostros humanos, algo desconocido en esta civilización Las excavaciones en el yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, en las proximidades de Guareña (Badajoz), han sacado a la luz los restos de cinco relieves antropomorfos del siglo V a.C., los primeros pertenecientes a la cultura tartésica, la mítica civilización prerromana que ocupó el suroeste de la Península Ibérica entre los siglos VIII y IV a.C. El descubrimiento se ha realizado durante la excavación del sector este del yacimiento, el área por el que se accede al patio del edificio donde se documentó un masivo sacrificio de animales, principalmente caballos. Lo insólito del nuevo hallazgo es que las representaciones corresponden a rostros humanos, lo que supone un cambio de paradigma en la interpretación de la cultura tartésica, considerada anicónica por representar la divinidad a través de piedras sagradas y de motivos animales o vegetales. https://www.lasprovincias.es/sociedad/hallazgo-historico-descubiertos-primeros-rostros-humanos-antigua-20230418200634-ga_amp.html1 punto
-
Disclaimer: io ve la giro come l'ho trovata. C'è una tradizione secolare e corpi che non sono stati analizzati quindi siamo nel mondo delle belle teorie. Inoltre, basta fare una ricerca, questa teoria non è assolutamente nuova. Dal gruppo facebook Renovario imperii -> https://www.facebook.com/renovatioimperiiofficial Già da diversi anni circola un'ipotesi che mi ha sempre emozionato: il corpo di Alessandro il grande, colui che dominò il mondo conosciuto poco meno che trentenne, si trova nella Basilica di San Marco. In concomitanza con la festa del santo, direi che è l'ora di vederci chiaro. Per farlo dobbiamo tornare indietro nel tempo e nello spazio, a Babilonia, nel 323 a.C. Alessandro muore al centro del suo impero e quasi subito i suoi vecchi amici e generali se ne contendono le spoglie: chi avrà il corpo di Alessandro avrà un potente mezzo di potere. Dopo alterne vicende la salma viene portata in Egitto, dove il macedone riposerà per diversi secoli, nella città che porta il suo nome. Ad Alessandria la sua tomba, che nel frattempo è diventato un imponente complesso architettonico, è visitata da Cesare, Ottaviano, Settimio Severo e Caracalla. Dopo l'ultimo imperatore citato, non abbiamo più notizie, fino all'omelia di San Crisostomo (400 d.C.): "Dov'è, dimmi, la tomba (sema) di Alessandro? Mostramela, e dimmi in che giorno morì!" Come è possibile che la memoria del più grande uomo dell'antichità fosse stata cancellata? C'è da dire che nei decenni precedenti i cristiani avevano dato luogo a diversi episodi di distruzione dei templi antichi. La tomba di Alessandro avrebbe potuto benissimo essere tra i monumenti distrutti. Ma...la teoria sviluppata dallo storico inglese Andrew Chugg va in un'altra direzione. La salma di Alessandro sarebbe stata custodita grazie ad una "sovrapposizione religiosa": i cristiani avevano l'abitudine di sovrapporre i propri santi con gli idoli antichi. E Alessandro potrebbe essere stato "salvato" da San Marco, santo caro ad Alessandria. Bisogna notare una cosa molto interessante: San Marco morì sotto Nerone; il suo corpo, scomparso per secoli, ricomparì proprio quando le notizie della tomba di Alessandro vennero meno. Arriviamo al IX secolo d.C. Due mercanti veneziani sbarcano ad Alessandria alla ricerca del corpo del santo. Riescono nel loro intento, riportando un corpo in Italia che, dopo qualche secolo, prende il suo posto nell'odierna basilica. Non abbiamo descrizioni accurate della salma del santo, ma qualcuno pensa che potrebbe essere mummificato, proprio come Alessandro. Non è finita: nella cripta della tomba di San Marco è stato scoperto un blocco calcareo con motivi macedoni e legati strettamente ad Alessandro Magno. Il blocco è risalente all'età ellenistica. Nonostante questa teoria abbia diversi "luoghi d'ombra" (non si sa se la chiesa di San Marco e la tomba di Alessandro coincidessero ad Alessandria), basterebbe una cosa per fare chiarezza: un esame del corpo. Un qualcosa che la Chiesa dovrebbe assolutamente fare, per amore della verità, per l'umanità intera e della storia che essa porta in grembo da secoli. Il blocco in S. Marco con la stella argeade, simbolo della famiglia reale macedone. disegno di CHUGG Sotto il post un'utente commenta in quanto ha trattato di questo argomento per la sua tesi: "Ho dedicato una certa parte della mia tesi a questo argomento! È molto interessante ad esempio scoprire che il sarcofago del santo è stato aperto solo una volta e che pare contenga i resti di due cadaveri. Di certo non c'è San Marco, Alessandro... chissà!" "le reliquie di San Marco sono scomparse (probabilmente smarrite o dimenticate) per poi ricomparire miracolosamente nell'XI secolo durante una funzione, pare apparendo come un miracolo fuoriuscendo da una colonna . Molti studiosi pensano che servissero delle reliquie che sostituissero quelle "perse". Ad ogni modo, la ricognizione sui reperti ossei c'è stata, si tratta di varie parti di scheletro appartenenti a due individui. I poveri sventurati sepolti lì chissà chi sono! Quanto ad Alessandro, il suo corpo sarà stato perso e/o distrutto durante la follia iconoclasta dell'Alessandria tardoantica... i cristiani hanno colpe indicibili!" "è impossibile anche che ci sia [IL CORPO DI S. MARCO nota mia] visto che è dato storicamente accertato che le reliquie portate da Alessandria scomparvero! Lo dicono proprio i documenti amministrativi della basilica!" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Secondo un intrigante teoria esaltata dalla storica Marian Vermeulen, la tomba di Alessandro Magno potrebbe essere nascosta a Venezia. -> https://ilserenissimoveneto.it/la-tomba-di-alessandro-magno-alla-basilica-di-san-marco-a-venezia/ Nel giugno del 323 a.C. Alessandro III di Macedonia, meglio conosciuto come Alessandro Magno, si ammalò gravemente. Aveva conquistato gran parte dell’antico mondo mediterraneo, dalla Persia all’Asia, e non aveva intenzione di fermarsi. In quella lontana primavera aveva attraversato le paludi di Babilonia e poco dopo stava combattendo una forte febbre. Nonostante la malattia, ha continuato a pianificare la sua prossima campagna che avrebbe dovuto portarlo alla conquista della penisola arabica. Tuttavia, le sue condizioni erano peggiorate. Alessandro Magno stava progressivamente perdendo conoscenza e la capacità di parlare. Dopo dodici giorni di malattia perse la sua ultima battaglia, era l’11 giugno del 323 a.C., e non si svegliò mai più. Aveva solo trentadue anni. Il mistero sulla non-morte I migliori generali di Alessandro il Grande erano stati i suoi amici più cari sin dall’infanzia trascorsa insieme alla corte macedone. Dieci anni di costante campagna militare avevano rafforzato il loro cameratismo e, dopo la sua morte, erano disperati per la perdita del loro re. Alessandro però sarebbe potuto essere stato ancora vivo, in coma, quando i suoi compagni più fedeli lo reputarono morto. Gli storici antichi, infatti, riportano che il suo corpo rimase perfetto e incontaminato per oltre una settimana nel caldo giugno babilonese. La spiegazione più probabile è che soffrisse di una forma di malaria che spesso finisce in coma. Indipendentemente da ciò, il destino di Alexander era segnato e la morte arrivò presto a coglierlo. I suoi fedeli amici commissionarono un sarcofago d’oro per contenerne il corpo, oltre ad un enorme carro funerario decorato per riportare infine la bara in Macedonia. Il corteo, però, non completò mai il suo viaggio. Lungo il trasporto, uno dei successori di Alessandro, Tolomeo, sequestrò il corpo e lo seppellì a Menfi, in Egitto . Più tardi, suo figlio trasferì Alessandro Magno in una sontuosa tomba nella città di Alessandria. La tomba di Alessandria Il corpo di Alessandro Magno rimase per secoli nella sua magnifica tomba, fatto ben documentato da fonti antiche. Cleopatra fece arrabbiare gli abitanti di Alessandria prendendo l’oro dalla tomba del re macedone per finanziare le sue guerre contro Ottaviano Augusto. Registrate nel dettaglio sono anche le molteplici visite alla tomba di Alessandro da parte di diversi imperatori romani. Giulio Cesare , Augusto, Caligola , Settimio Severo e Caracalla . Eppure nel 400 d.C. Giovanni Crisostomo visitò Alessandria per vedere la famosa tomba, ma non la trovò. L’ultimo riferimento alla tomba di Alessandro Magno risaliva a dieci anni prima da Libanius, intorno al 390 d.C.. Il breve lasso di tempo in cui la tomba del condottiero scomparve dai documenti scritti fu un periodo di grandi rivoluzioni nel mondo antico. Tra il 389 e il 391 d.C., l’imperatore Teodosio emanò i “Decreti Teodosiani”. Questi documenti stabilirono il cristianesimo come l’unica religione proibendo i culti pagani. Ne seguì la distruzione di numerosi templi e luoghi sacri politeisti. Alessandro, adorato come un dio sin dalla sua morte, sarebbe stato un obiettivo primario di questa distruzione iconoclasta. Può darsi dunque che la tomba del re di Macedonia sia stata vittima di queste purghe. Tuttavia, l’apparizione improvvisa e alquanto inspiegabile di un altro famoso cadavere nella città di Alessandria suggerisce un’alternativa allettante… La tomba di San Marco Alla fine del IV secolo d.C., le fonti antiche iniziarono a fare riferimento ad una tomba di San Marco ad Alessandria. La prima menzione viene da San Girolamo nel 392 d.C., appena due anni dopo l’ultima notizia della tomba di Alessandro Magno. Secondo la tradizione cristiana, l’apostolo Marco fu martirizzato dai pagani nel 68 d.C. proprio nella città di Alessandria. Doroteo, Eutichio e il Chronicon Paschale affermano che gli assassini di Marco ne bruciarono poi il corpo in sfregio ai cristiani. Nessuna menzione di un corpo sacro del santo esisteva quindi negli oltre trecento anni precedenti. Un testo chiamato “gli Atti di San Marco” spiega però che una tempesta miracolosa spense le fiamme sul cadavere dell’apostolo e i cristiani riuscirono a strapparlo dalla pira. Tuttavia, la prima datazione di questo documento, lo colloca alla fine del IV secolo d.C., dunque centinaia di anni dopo la morte di Marco e nel mezzo del periodo nel quale scomparve Alessandro Magno. L’autore Andrew Chugg, a questo punto, ipotizza che il presunto corpo di San Marco sia in realtà quello dell’antico re macedone, ribattezzato Marco per salvare il conquistatore dalla distruzione dei cristiani. L’avvento dell’Islam Alla fine del VII secolo d.C. le forze arabe avevano conquistato gran parte del Nord Africa, inclusa Alessandria. Crescevano le tensioni tra musulmani e cristiani in tutta la regione. Nell’828 d.C., due capitani di mercantili veneziani fecero allora un patto con le autorità cristiane di Alessandria per portare in salvo il presunto corpo di San Marco. Rimossero il cadavere dalla sua tomba, lo deposero in un carro coperto di carne di maiale, così da prevenire qualsiasi ispezione ravvicinata del contenuto, e lo portarono di nascosto a bordo della loro nave, diretta a Venezia. Inizialmente i resti vennero ospitati in una piccola chiesetta ma, nel 1063, i funzionari veneziani commissionarono la magnifica Basilica di San Marco. L’8 ottobre 1094 la salma fu deposta nella cripta sotto la famosa chiesa nell’omonima piazza. Lì rimase per quasi ottocento anni, fino a quando le frequenti inondazioni iniziarono a minacciare l’incolumità del cadavere. Nel 1811 la Chiesa rimosse quindi le spoglie trasferendole nuovamente nell’altare maggiore al piano nobile. La mummia di Alessandro Diverse informazioni suggeriscono che il corpo di San Marco potrebbe essere stato mummificato, ma non ci sono documentazioni in cui gli antichi cristiani avrebbero eseguito pratiche di mummificazione pagane. Pertanto, la mummificazione potrebbe indicare un diverso occupante della tomba dell’apostolo. A tal proposito, ne La Cronique des Veniciens del 1275, Martino da Canale raccontava che: “se tutte le spezie del mondo fossero state raccolte ad Alessandria, non avrebbero potuto profumare così la città”. Proprio come l’aroma delle spezie proveniente dalla tomba contesa. Profumi e metodi coerenti con la mummificazione. Inoltre, i documenti indicano che a quel tempo involucri di lino sigillavano il cadavere. I mosaici della Basilica veneziana raffigurano il corpo del santo come un cadavere intatto piuttosto che uno scheletro. Questa potrebbe essere semplicemente una licenza artistica, certo, ma forse riflette che un corpo mummificato inizialmente arrivò a Venezia. Ulteriori indizi provengono dal trasferimento delle spoglie nell’attuale collocazione presso l’altare maggiore. Leonardo Conte Manin ha documentato l’evento e le sue osservazioni non contengono prove che alludono ad uno scheletro incendiato, come dovrebbe essere quello di Marco. La sua affermazione che lo scheletro appiccicato al tessuto in alcune aree è coerente con lo stato previsto di una precedente mummia, ora decomposta. La scultura macedone A fornirci le domande più intriganti e senza risposta sull’origine del corpo nella tomba di San Marco, è anche un grosso pezzo di calcare scolpito. Una porzione spezzata di un originale più grande, è stato trovato a pochi metri dal sito della tomba originale di Marco nella cripta della Basilica. Il blocco calcareo, ora esposto al Chiostro di Sant’Apollonia a Venezia, raffigura un rilievo di scudo, schinieri, spada e lancia. Questi armamenti sono perfettamente coerenti con gli stili macedoni, un fatto affermato anche in uno studio di Eugenio Polito nel 1998, diversi anni prima che Andrew Chugg iniziasse la sua famosa ricerca. Polito descrive “Un frammento non attribuito relativo ad un monumento funerario con motivi analoghi è oggi conservato a Venezia, ma sicuramente deriva dal mondo ellenistico. Esso presenta uno scudo macedone con al centro un motivo a stella, una coppia di schinieri e una lunga lancia e sul lato più piccolo i resti di una spada. Il ceppo doveva appartenere ad un grande monumento che si può collocare genericamente tra il III e l’inizio del II secolo a.C.”. Il “motivo a stella” ha una sorprendente somiglianza con la stella di Macedonia. Era un simbolo strettamente associato alla famiglia di Alessandro Magno e visibile su molte tombe correlate. La spada scolpita nel blocco è indiscussa come una kopsis di stile greco. Se si analizza l’estensione della lancia dall’angolo della sua discesa fino alla sua conclusione logica alla base del blocco di pietra, le sue dimensioni corrispondono alla caratteristica sarissa macedone. Furono appunto queste le armi, sviluppate da suo padre, che aiutarono Alessandro Magno a conquistare il mondo. Tuttavia, le tattiche militari romane le resero obsolete, rendendo improbabili le successive incisioni romane di una tale lancia. Perché questa scultura, con chiari collegamenti macedoni, è dunque situata nella cripta della Basilica di San Marco vicino al luogo di sepoltura originale del corpo? Un indagine ancora aperta Inoltre, Andrew Chugg ha effettuato misurazioni basate su un’estrapolazione delle dimensioni della pietra originale. Lo storico ha affermato che la lastra è perfetta per essere una copertura esterna del sarcofago di Nectanebo II, ora in mostra al British Museum. Questo sarcofago è stato a lungo associato ad Alessandro Magno. Chugg afferma che è il probabile primo luogo di riposo del corpo del condottiero a Menfi. Quasi completato il sarcofago, colui che doveva esserne l’occupante designato era fuggito dall’Egitto. La magnifica tomba non era dunque occupata quando Tolomeo arrivò con il corpo di Alessandro e, avendo bisogno di un luogo di riposo temporaneo, la riadattò al re macedone. Sia le fonti antiche che le più moderne tecniche scientifiche offrono molteplici percorsi per indagare e identificare il corpo che si presume sia quello di San Marco. Potrebbero essere impiegate più tecniche di datazione al carbonio, test del DNA e analisi dello smalto dei denti. Comprensibilmente questi potrebbero essere meno attraenti in quanto richiederebbero la rimozione invasiva del campione dal corpo. Tuttavia, molto potrebbe essere appreso semplicemente dall’esame fisico dei resti. Sempre che il Vaticano dia la possibilità di indagare su questa affascinante storia custodita a Venezia. Andrea Bonazza1 punto
-
Cari Lamonetiani, oggi faccio un'incursione in una sezione che frequento raramente (colleziono Regno e Repubblica Italiana) con due monetine reperite in un mercato ad Ismir (Smirne), durante un viaggio in Turchia. Spero di far cosa gradita con questa condivisione: Il potin, conosciuto anche come bronzo bianco, è una lega di rame con alta concentrazione di stagno o di piombo, in cui sono presenti a volte tracce di altri metalli. (da Wikipedia)1 punto
-
Avevo letto qualcosa in merito qualche anno fa, ma @Vel Satieshai fatto bella ed esaustiva raccolta di informazioni, bravo.1 punto
-
Dimenticavo... Il Maestro di Zecca Francesco Maria Berio fece eseguire i diversi conii per le Piastre e le mezze Piastre (1734-1736) agli incisori Giovanni De Gennaro e Giacomo Antonio Hoger. Premesso che la firma di un solo incisore non significa necessariamente che lo stesso abbia eseguito sia il dritto che il rovescio della stessa moneta, con molta probabilità, vennero accoppiati dei conii che vedevano un incisore per la figura e l'altro per lo stemma e viceversa. I due conii conosciuti con la variante "gigli invertiti" - per una serie di elementi - si possono attribuire allo stesso incisore. Per fare un esempio, la medaglia per il matrimonio di Carlo di Borbone con Maria Amalia, fu eseguita da entrambi gli incisori, con al dritto gli stemmi realizzati da Hoger ed al rovescio la scritta con i caratteri di De Gennaro. Allego uno screenshot di pagina 190 del libro "La Massoneria nelle due Sicilie e i fratelli meridionali del '700" vol.1 di Ruggiero Di Castiglione · 20141 punto
-
Per me sia la moneta che la patina sono buone; e poi, scusate, a che scopo falsificare una patina di questa intensità e spessore su un bel denario? Capirei ripatinare un bronzo, ma non l'argento, che casomai se pulito eccessivamente, andrebbe leggermente patinato, ma non con questa intensità.1 punto
-
1 punto
-
Buon giorno ilLurkatore. Guardi che Pierg50 ha detto nel corso della discussione ben due volte come verifica il fuori asse. Cordialità Gabriella1 punto
-
1 punto
-
Mi fa piacere che ci siano giovani come @SAURON05... sono sempre pronto a condividere quello che ho imparato negli anni. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
Un giovane, educato e pure interessato alla numismatica: cosa vogliamo di più ? @Vel Satiesquando ho scritto che ci sono moltissimi giovani educati questa è la conferma.1 punto
-
Ti ringrazio io per il chiarimento. Riassumendo, non conosco la medaglia mostrata da MrPalanca, né sono riuscito a rintracciarla sui testi di cui dispongo. Mi sembra che concordiamo che non è la tipica medaglia del Regime, potrebbe essere anche precedente, come del resto lo era il faro quando venne costruito : che ne pensi ?1 punto
-
Conosco molto bene questa voglia bulimica di sapienza monetaria 😅... E' un malanno da cui sono affetto fin da bambino, quando passavo ore a sognare sui misteri e le avventure celate dietro i colori e le immagini delle banconote dei vari paesi del mondo come di quelle italiane, poi negli anni sono passato a collezionare monete di tutti i tipi e di tutte le epoche, finchè un potente impulso ordinatore unita alla sofferenza tascale mi fecero coordinare e polarizzare tutte le energie nella raccolta e acquisto di libri a tema numismatico e storico monetario-economico... Il risultato è che sono sommerso dai libri e mi lambicco il cranio ogni giorno per reperire lo spazio necessario ai sempre nuovi acquisti, ho una lista infinita di libri sia vecchi che appena pubblicati da acquisire e sono sempre indeciso per giorni sulle priorità da dare a ciascun acquisto, tra costo conveniente di un volume, rarità di un altro e voglia inesorabile e ineludibile di approfondire un certo argomento trattato da altri ancora, un casino insomma 😅1 punto
-
@OppianoComplimenti vivissimi e contento che questo pezzo sia rimasto ad un collezionista italiano!1 punto
-
Ma scusate,vi siete mai chiesti il perché nessuno risponde?... Forse semplicemente perché la risposta non c'è, ognuna trae le sue conclusioni e colleziona ciò che gli pare,poi è risaputo che le cose rare, indipendentemente dalla motivazione,suscitano più interesse... Lo stemma borbonico è pieno di varianti diverse...1 punto
-
Ciao Sandokan forse non mi sono spiegato bene. Io ho inquadrato questa A come epoca fascista per poter capire di che epoca poteva trattarsi la spilla . Concordo in pieno con te che all ‘epoca fascista non facevano proprio niente di occulto anzi tutto era buono per far pubblicità. Per il momento Io non sono riuscito a trovare una spilla uguale a questa . Ciao spero che ci siamo capiti , seguo molto i tuoi interventi e grazie a te e a molti altri si cresce. Questo forum è una miniera d’oro. Colgo l’occasIone per ringraziare tutti1 punto
-
Buongiorno Jagher apprezzabile e documentatissimo il tuo intervento sul Faro, con il notevole materiale che hai mostrato. Il Regime firmava vistosamente tutto ciò che produceva, dalla Architettura alla Grafica, ed anche il faro sarebbe rientrato in questa consuetudine. Proprio per questo dissento sull'interpretazione di una M assai criptica, che sarebbe contenuta alla base della lettera A di FARI, una prudenza in netto contrasto con l'iconografia del Regime. Posso sbagliare, ovviamente : ma se il faro si presentava con la scure, non vi era alcun motivo da parte del Regime per nasconderla, se ho capito bene l'interpretazione. Un saluto cordiale. @Jagher1 punto
-
Proprio simpatici questi volantini. Non avresti una foto più dettagliata per leggere meglio tutto? Il primo è una banconota da 500 “fragole” della “banca delle mercanzie di fisica divertente”. Poi aggiunge tipo che te le danno con la bottiglia di liquore… ma oltre non leggo più 🤷♂️ L’altro sostiene che diecimila franchi in banconote saranno [boh] a chi potrà […] questo articolo allo stesso prezzo. Come diceva Nikita si ispirano a banconote francesi reali, come queste. Complimenti se sono tue 🏆1 punto
-
Anch’io avevo pensato inizialmente a un particolare strumento musicale, ma il commento di mia moglie ha tolto ogni dubbio: “Io vedo una donna matura e bugiarda”. La malizia (o anche un pizzico d'invidia) femminile ha fatto centro. Buon 25 Aprile apollonia1 punto
-
1 punto
-
Oltre alla posizione dei gigli, da notare la differenza di spaziatura nei numeri della data1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Capovolgi la prima foto. Le ali ci sono, ma non sono quelle di un'aquila.1 punto
-
Banconota pubblicitaria ricchi e poveri Banconote propagandistiche politiche1 punto
-
Una moneta simile l'ho postata al post n°55 di questa discussione da asta Gadoury online n°40, del 24 aprile 2023. lotto n°83 che ha realizzato € 15000 + diritti da una base di € 1500. Giulio II (1503-1513) Giulio, Zecca di Roma, AG.gr. 3.69 Riferimenti MIR 558 (R3), Munt 24, Berman 570 odjob1 punto
-
Ciao Giova... a mio avviso tantissime propposte in web specie in e bay non sono assolutamente da considerare...per le monete o francobolli e Marche ecc che ho... dare retta a certi siti sarei miliardario che la metà basta... ciao1 punto
-
Concordo con l'identificazione del tipo ufficiale di riferimento (la spes di Tetrico II). Quanto al periodo, con buona probabilità, va collocata oltre la fine dell'impero gallico in quanto il modulo ridotto fa ipotizzare quasi di sicuro una emissione non coeva. Prendetela con le pinze, ma come periodi di produzione (anche se non può essere intesa in maniera assoluta) è abbasta valida questa tabella di Doyen:1 punto
-
Di nulla Bene, nonostante l'usura è quindi visibile, è l'unico pezzo che possiedi o ne hai altri che potrebbero appartenere alle tre emissioni successive?1 punto
-
Tipologia prodotta in quattro diverse emissioni a partire dal 1935, riconoscibili, oltre che alle diverse date presenti al fronte in basso al centro, anche dai numeri di serie e le firme, Essendo la data posizionata in corrispondenza con un'eventuale piega centrale, capita spesso nei biglietti molto usurati di non essere ben visibile, in questo caso basta ricorrere ad un catalogo (meglio se cartaceo), il tuo biglietto serie 0193 appartiene alla prima emissione. 10 Lire Impero (lamoneta.it)1 punto
-
I biglietti di Stato del Regno d'Italia non sono proprio il mio forte, so che questa tipologia è comunissima e ne sono arrivati sino ai nostri tempi anche a mazzette intere. Il biglietto che presenti appartiene alla prima emissione del 1940 (Grassi/Porena/Cossu), quando non è eccessivamente usata è ben visibile la data sul fronte in basso al centro. Eventualmente se ne trovi un'altra uguale ma con la data del 1944, non considerarla doppia, si classifica come prodotta durante la Repubblica sociale italiana.1 punto
-
ROMA Gregorio XIII (1572 - 1585). Testone 1575. Condivido volentieri (ex Rimoldi Numismatica). D/ GREGORIVS XIII PON M - Busto a destra, piviale con San Pietro. Sotto, tre globetti. R/ IVSTI INTRABVNT PER EAM - La Porta Santa. Nel vano, in quattro righe, AN D 1575. Ai lati, RO-MA. In esergo, armetta della Zecca. 9,44 g. Muntoni 33.1 punto
-
Comunque io sono sempre del parere, che la rarità di una moneta si giudica da quante ce ne sono in giro in senso assoluto e non da quante ce ne sono belle.1 punto
-
Ok.Mi scuso non conosco questo sito.Sono iscritto da poco.Saluti e grazie.1 punto
-
A me stupisce ma fino ad un certo punto. Se non hai strumenti culturali per discernere le notizie vere da quelle false, oramai i siti, le pagine che raccontano 'ste baggianate sono aumentate a dismisura e se uno - ripeto, senza strumenti culturali - fa una ricerca attraverso Santo Google troverà principamente queste informazioni. Che diventeranno |falsamente| autorevoli per il fatto stesso di essere numerose ed onnipresenti1 punto
-
Quando si dice "due piccioni con una fava" Dall'asta e-live 2 (2019) di numismatica ferrarese - Piastra 1825 - D/ variante "collo lungo" o "collo diverso" - R/ variante "tre pallini nello stemma del Portogallo".1 punto
-
Ciao, lo screenshot che hai postato proviene da un documento PDF dell'Archivio di Stato di Napoli. La storia che ho accennato e le cifre che ho riportato, si trovano sui libri di Lodovico Bianchini (sarebbe da leggere anche la sua biografia). Queste pagine in allegato provengono dal volume del 1859 "Della storia delle finanze del regno di Napoli". https://www.google.it/books/edition/Della_storia_delle_finanze_del_regno_di/ie-fE6rPYKwC?hl=it&gbpv=1 Buona lettura1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?







.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)














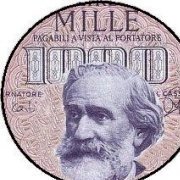

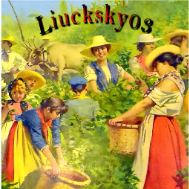

.thumb.jpg.49bf7893ab8deb0b9efbfc02c41b7421.jpg)



