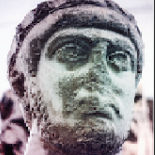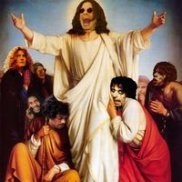Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 04/30/23 in Risposte
-
Buongiorno Qua di seguito una delle ultime entrate in collezione...una moneta tutto sommato comune ma che col passare del tempo non riuscivo a trovare come piaceva a me. Finalmente si è presentata l'occasione di trovarla coi rilievi leggibili e con una patina niente male e non me la son fatta sfuggire. Al dritto il profilo di Rinaldo d'Este con la sua lunga chioma di capelli ricci ed al rovescio il patrono di modena inginocchiato con uno scorcio della città sullo sfondo. Come vi sembra? Vi piace? Grazie e un saluto a tutti Marco4 punti
-
Buongiorno e buona Domenica a tutti. Partecipo alla discussione con mio ultimo arrivo Borbonico. Ferdinando II 10 Tornesi 1840 Magliocca 675 Conservazione B abbondante spero. Cosa ne pensate? Saluti Alberto4 punti
-
Trovate oggi in ciotola al mercatino domenicale due monete mancanti ed una mini banconota (cm. 4 x cm. 7) per per un totale di 4 euro, in aggiunta una moneta a titolo gratuito per il museo degli orrori Un valore che non avevo della Repubblica Domenicana, il mezzo pesos (12 1/2 gramos) in rame/nickel con un bel modulo da 31 mm di diametro. Il 5 centavos messicano del 1937, un nominale di quel periodo che non avevo: Ed infine un cent del Governatorato inglese di Hong Kong - prima emissione senza lettera nella serie numerica del 1941 E per non farci mancare nulla una moneta del Regno di Napoli non conteggiata già inserita nel Museo degli orrori3 punti
-
Buongiorno a tutti, esattamente un anno fa (era l'ultima domenica di aprile) mi ritrovai a sbirciare sulle bancarelle di Cordusio e feci il mio primo acquisto: un denario di Augusto con Lucio e Caio sul rovescio. Una moneta di scarsa conservazione, pagata poche decine di euro, ma capace di spingermi a cominciare una collezione di monete romane imperiali. Voglio condividere con voi il risultato di questo primo anno, fatto di acquisti in asta con certificati di lecita provenienza, e di studio sui libri suggeriti da molti di voi, oltre che di una metodica lettura delle discussioni del forum. Il bisogno di condividere ciò che ho messo insieme non è per mera esibizione, ma per raccogliere suggerimenti utili a migliorare; mi è molto chiaro che il collezionismo numismatico è una lunga maratona e non una gara di velocità, e posso, con molte probabilità, aver sbagliato qualcosa al momento della partenza. Adesso però devo iniziare a gestire la corsa con più consapevolezza, e mi serve anche il vostro aiuto. Come potete vedere, la mia collezione inizia con un paio di repubblicane, un piccolo sesterzio in argento che spero di poter presto confrontare con un sesterzio imperiale, e un denario, e termina con "un'invasione" a Costantinopoli con due solidi bizantini. In mezzo diverse imperiali, mi affascinano molto i denari ma non disdegno qualche bronzetto. La regola è una: la moneta mi deve piacere per il ritratto e/o per il rovescio. Sono riuscito a raggiungere uno degli obiettivi importanti che mi ero posto: un denario con elefante di Giulio Cesare. Ultimamente ho scoperto la bellezza dei follis del terzo secolo, e credo che i miei prossimi acquisti saranno principalmente in quell'area. Naturalmente, conto di raccoglierne il più possibile del mio omonimo Gratianus. Obiettivi medio/importanti da raggiungere senza fretta: il "tribute penny" di Tiberio, un Caligola (anche un bronzetto andrebbe bene), un sesterzio (mi piacerebbe molto di Nerone, come potete vedere è un imperatore che mi piace molto, ma credo che dovrò accontentarmi di qualcosa di più economico), un solido del terzo secolo. Adesso, qualche domanda in ordine sparso: - al momento ho acquistato solamente da Inasta e da Artemide, mi dite quella che secondo voi è un'altra casa d'aste da cui dovrei assolutamente comprare per la qualità dei pezzi offerti? - ha senso aggiungere in collezione monete di scarsa conservazione se appartengono ad un imperatore di cui non se ne trovano facilmente, ad esempio Pertinace, o i quattro imperatori del 69 d.c.? - conviene comprare dai negozi di numismatica che si trovano online, o è meglio aspettare l'occasione in un'asta? Attendo di leggere i vostri consigli - mi interessano meno i giudizi - saranno molto preziosi per me. p.s.: vi terrò aggiornati sugli sviluppi della mia collezione aggiungendo nei commenti le foto dei nuovi arrivi.2 punti
-
Nella prossima asta 128 Numismatik Naumann verrà battuto con nr 813 un bellissimo esemplare di sesterzio di Geta. Base d'asta 2000€: stima 2500€ -> https://www.numismatik-naumann.at/auktion/#!/auction/lot?a=3445&l=813&p=2&c=72838 GETA (209-211). Sestertius. Rome. Obv: P SEPTIMIVS GETA PIVS AVG BRIT. Laureate and bearded head right. Rev: FORT RED TR P III COS II P P. Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia; wheel below seat. RIC 168a. Condition: Good very fine. Weight: 25.50 g. Diameter: 33 mm.2 punti
-
Condivido volentieri: Alessandro VIII (1689-1691) Doppia 1690 - Munt. 9 AU (g 6,69). La leggenda VECTIGALIBVS REMISSIS allude alla diminuzione delle imposte sul macinato e sulla carne voluta dal pontefice per venire incontro ai disagi della popolazione più povera di Roma.2 punti
-
Finalmente entrati in collezione i due volumi del North … dall ultima asta Ranieri, con bel Ex Libris. Se qualcuno lo riconosce mi farebbe un gran favore2 punti
-
Questa sfortunata moneta da 6 tornesi mi è stata regalata questa mattina, è una rarissima variante monofacciale, ma giusto perchè in una faccia non si scorge nulla di definito! Ho messo il rovescio con gli assi alla tedesca ↑↓ , se intravedete qualcosa divertitevi a ruotarla per eventualmente posizionarla nel modo giusto2 punti
-
Si tratta del tempio arcaicizzante a mègaron (senza colonnato ed con pareti in muratura piena) di fine VII- inizio VI a. C. che si trova all'interno del tèmenos, cioé dell'area sacra, del santuario della Malophòros (Demetra portatrice di frutti) a Selinunte. Una roba che pochi vanno a vedere ma è una figata pazzesca. Visto che il Mègaron era in uso in epoca micenea già in epoca classica doveva essere come per noi vedere una chiesa romanica o paleocristiana. dalla Treccani: Così viene chiamata nei poemi omerici la parte più intima e solenne del palazzo reale, sala del trono e dei banchetti, luogo di ritrovo della famiglia, ornata con l'arte più squisita e ricercata. Telemaco nel palazzo di Menelao, Ulisse nel palazzo di Alcinoo, ne ammirano le decorazioni lucenti d'oro, di metalli preziosi, di avorî, sulle porte e sulle pareti, le incrostazioni di "ceruleo smalto". In base a tali descrizioni, l'ambiente in parola è stato riconosciuto negli scavi di varie località micenee, come nella stessa Micene, a Glãs sul lago Copaide, e, conservato più compiutamente e con maggiore quantità di particolari, a Tirinto (vedi cretese-micenea, civiltà, XI, p. 877, fig. 36; Grecia, XVII, p. 803). Si riconoscono nel megaron di Tirinto le tre parti principali menzionate da Omero, cioè un vestibolo (ἄιϑουσα), sulla cui fronte sono due colonne di legno su basi di pietra, un'antisala (πρόδρομος), accessibile dal vestibolo per tre porte a duplici battenti racchiuse fra due ante sporgenti dai muri laterali, e in fondo la grande sala, il vero e proprio μέγαρον, al quale si accede invece attraverso l'antisala da una porta unica: nel centro della sala era l'ampio focolare rotondo, ἐσχάρη, centro spirituale e materiale della casa, attorno al quale stavano quattro colonne disposte a rettangolo e sostenenti il tetto. È ancora discusso se la parte mediana del tetto sopra ai sostegni fosse aperta in una specie di lucernario rialzato, per la luce e lo sfogo del fumo: problema che si riconnette con la forma del tetto medesimo, se cioè esso fosse piatto, oppure a spioventi; la seconda ipotesi è più probabile, data l'origine nordica dell'edificio a megaron. Non abbiamo a ogni modo testimonianza di finestre sulle pareti laterali della sala. Di fianco al focolare a Tirinto era il trono del principe, e il pavimento della sala attorno alle colonne era leggiadramente dipinto; nell'antisala si sono trovati residui d'un bellissimo fregio parietale in lastre d'alabastro e incrostazione di pasta vitrea, con serie di rosette ed elementi semiellittici a palmette e spirali, che ricorda come ripartizione il più tardo fregio dei templi dorici a triglifi e metope. Davanti al megaron di Tirinto stava l'ampia corte a colonne, con un altare; tutto attorno altri edifici, ciascuno consistente in elementi più o meno affini e ciascuno col proprio cortile d'ingresso, ma senza un vero e proprio aggruppamento comune, ciò che distingue radicalmente il palazzo miceneo del continente dal palazzo cretese. Infatti gli scavi vanno sempre più mettendo in evidenza la derivazione del megaron da un tipo di casa, importato in varie parti della Grecia preistorica dal nord, da regioni di clima freddo, e del tutto contrapposto alla casa cretese, di tipo mediterraneo, creata per un clima caldo, con i numerosi ambienti disposti attorno al cortile centrale. Possiamo ormai seguire anche l'evoluzione del megaron da forme assai primitive fino alla perfetta creazione di Tirinto, attraverso le testimonianze di Sesklo, di Dimēni e di Lianokládi in Tessaglia, di Troia, di Egina, dì Eleusi, di Tera, di Argo e via dicendo. Negli esemplari tessalici soprattutto vediamo come dapprima il focolare stesse in mezzo alla stanza ampia che era sul davanti; poi, per la poca comodità della sua posizione fra le due porte, lo vediamo spostato in parte o portato dietro alla parete anteriore della sala, mentre gradualmente si trova la soluzione più pratica di spostare la sala ampia di dietro; in tali esemplari tessalici dei semplici sostegni lignei preludono alle colonne di Tirinto. Nei tipi più primitivi vediamo inoltre il contorno del megaron ancora irregolare: a Eleusi notiamo nella stanzetta posteriore un andamento trapezoidale, che forse denota un passaggio dalla stanza absidata delle case precedenti alla forma del megaron, ma soprattutto a Troia si passa con tutta chiarezza da una forma più antica, del II strato, allungata e stretta, fornita di un profondissimo atrio e con un terzo stretto ambiente in fondo, accessibile dalla sala grande, alla forma del VI strato, più simile a quella micenea, dalle dimensioni più larghe e corte. A Troia il singolo megaron è già comune negli strati più antichi accanto alla casa pluricellulare, e domina quasi assoluto nel VI strato; a Fylakōpē di Melo penetra un megaron di tipo primitivo nella seconda città, premicenea, e uno evoluto nella terza città, quella micenea; a Creta il megaron è introdotto solo nell'ultima fase del tardo-minoico, a Hagía Triáda, Gourniá e Cnosso. Dal megaron miceneo, è ormai generalmente accettato, deriva la forma del tempio ellenico, che mantiene anch'esso le due varietà, cioè la sola cella, o la cella fornita di ádyton, e, per la prima volta nell'Ereo di Olimpia, anche con opistodomo aperto sul tergo. L'ádyton stesso del tempio greco è talora chiamato megaron dagli scrittori, come tale rimane anche la denominazione per alcuni speciali santuarî (p. es., il tempio di Demetra al Tenaro, quello di Despoina in Arcadia, ecc.), e per certe fosse sacrificali a divinità ctonie, come quella nel bosco di Demetra e Core a Potniaí. Bibl.: v. cretese-micenea, civiltà, XI, p. 891; Fiechter, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., VII, col. 2533 segg.; Ebert, ibid., XV, col. 220 seg.; per il megaron tessalico v. anche H. D. Hansen, Early Civil. in Thessaly, Baltimora 1933, p. 65 segg.2 punti
-
Ciao @gennydbmoney, posto foto fatte tenendola in mano con altra angolazione, più tardi la osservo meglio dal vivo. Vi risparmio i dettagli delle mie dita. Da queste foto si distingue bene anche il simbolo sotto al busto se può servire per censimento. Al rovescio si dovrebbe vedere meglio, il sottocorona da queste foto sembra avere un accenno di rigatura , anche questo verificherò meglio dal vivo. Saluti Alberto Perdonatemi, avevo omesso di inserire le foto...2 punti
-
Mi scuso per non essere riuscito a collegarmi prima (grazie Luciano per avermi citato) e provo ora a rispondere. Il sesino postato da @titire è una variante di Alvise Mocenigo (1570-1577) ed è una delle 99 varianti emesse durante il dogado. Molto interessante è l'avere il cerchio sia al dritto che al rovescio che rende questa moneta leggermente più rara delle sue sorelle. Il Papadopoli nel suo libro per il doge Mocenigo oltre alle 99 varianti inserice anche 14 disegni: e questo è il sesino della nostra discussione. Interessante anche il peso di g. 1,51 che è una via di mezzo tra il peso teorico della prima emissione di Francesco Donà con g. 1,764 e l'emissione di Pietro Loredan dove il peso era stato portato a g. 1,324 (dovevano essere tagliati 180 pezzi per marca). L'ipotesi che il tuo sesino sia la prima emissione sucessiva al Pietro Loredan è intrigante sia per il disegno sia per il peso. Per quanto riguarda l'iconografia ti ricordo che la croce psana era già stata utilizzato dal Barbarigo in 2 monete per i possedimenti di terraferma. Altro particolare divertente è il nome: perchè sesino se valeva 8 piccioli o bagattini ed aveva il valore di 2 quattrini? La risposta è nella prima emissione in quanto il sesino doveva sostituire nelle nuove province di terraferma “certi sesini forestieri bianchizadi”. In questo caso si effettua una rivalutazione in quanto 1 soldo vale 1 sesino e mezzo al posto del valore di 2 sesini stranieri occorrenti in modo da renderlo più accettabile alla popolazione. Spero di essere stato di aiuto e buon 25 Aprile. Fabry2 punti
-
Cari tutti, Vico D’Incerti nel 1956 sulla RIN pubblicò uno studio sulle “monete discutibili” di Vittorio Emanuele III. Ecco il link per chi volesse leggere l’articolo: http://www.socnumit.org/doc/VDI/VDI1956RIN_MonDiscVEIII.pdf Oggi, leggendolo, l’attenzione è stata attirata dall’esemplare in oggetto, e mi sono domandato se esso è conosciuto e se è apparso in qualche asta o collezione privata ovvero è presente in qualche museo. Grazie mille e buona lettura.1 punto
-
In verità, un treno di 3 vagoni, prodotto in Fiat nel 1929 in unico esemplare, con tecnologie di alto livello e finiture artistico-artigianali di pregio : destinatario l' allora re di Italia . le immagini sono tratte dalla ristampa di un opuscolo illustrativo dell' epoca . Il convoglio, dopo il 1947, implementato di ulteriori vagoni e restaurato ed aggiornato, è parte dell' attuale treno presidenziale .1 punto
-
1 punto
-
DE GREGE EPICURI L'oggetto ideale di ogni collezionista. Anzi, l'impossibile oggetto del desiderio.1 punto
-
Qui trovi un bell'articolo di un nostro forumista: OSELLE (roth37.it)1 punto
-
SOLVM PROVOCATA FERIT FERISCE SOLO SE PROVOCATA Si allude alla determinazione di Venezia nel controllare il suo territorio da qualsiasi attacco straniero, pronta a reagire anche con la forza ove necessario. La rosa in fiore fa parte dello stemma del Doge veneziano Alvise II Mocenigo II. 1700-1709. E’ una Osella e non un Ducato. Attenzione che vi sono dei falsi, tipo: https://www.deamoneta.com/auctions/view/818/442 Attendiamo più specifici riscontri.1 punto
-
Si deve tenere conto anche della funzione della terza lettera della combinazione alfanumerica: Si arriva sino a GA ------ I ed è proprio la terza lettera che determina il cambio di contingente di stampa. Iniziano da AA ------ A sino a ZA ------ A (*) per poi passare a AA ------- B sino a ZA ------ B per poi passare a AA ------ C sino a ZA ------- C e così via sino alla fine > AA ------ I sino a GA ------ I (*) quel 20.000 lire del primo post LA 122811 A si trova nel primo contingente di stampa. ps: non si troverà mai una banconota da 20.000 lire con una B come seconda lettera. La seconda lettera della combinazione alfanumerica determina un'intera emissione e non un semplice contingente di stampa, si sarebbe dovuto arrivare sino a ZA------Z per poi ricominciare con una nuova diversa emissione iniziando da AB ------- A1 punto
-
Ciao @Vel Saties, Penso che la discussione cui si riferisca @Andrea Costa sia la seguente:1 punto
-
Salve, segnalo : Il tesoretto di Populonia Fiorenzo Catalli e Luciano Giannoni (curatori) Martina Fusi, Stefano Legnaioli, Carolina Megale, Vincenzo Palleschi (contributi) Il tesoretto di Populonia venne rinvenuto nel 1939 durante campagne di scavo archeologiche ed il ritrovamento fu diviso fra la famiglia Gasparri (proprietaria del fondo) e lo Stato Italiano, che le custodisce ancora oggi presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze. L’opera pubblica, per la prima volta, tutti gli esemplari. Nel libro, oltre a ripercorrere le fasi storiche e documentali della scoperta, vengono compiute anche analisi statistiche e XRF, queste ultime finalizzate a comprendere la composizione delle leghe utilizzate per realizzare le monete. https://www.edizionidandrea.com/1 punto
-
B urla, duo mogio C oso' BURLA D'UOMO GIOCOSO Buona serata da Stilicho1 punto
-
@Vel Satiesio parlo sempre per esperienza personale.... Una volta mi è capitato pure di intrufolarmi in una comitiva di statunitensi a Firenze, a causa di una bella biondina... invece di stare con il mio gruppo! Ma la mia "trasgressione accademica" è stata comunque ripagata...1 punto
-
1 punto
-
Questa tipologia di busto ha più rilievo rispetto al tipo normale, quindi maggiore è l'usura sui capelli rispetto a legenda e contorno.1 punto
-
La notizia è dell'anno scorso ma vi dico che il lacerto individuato sotto la strada che ho visto personalmente era veramente meraviglioso. Pensavo ne avessimo pgià parlato ma forse l'avevo fatto in un gruppo per archeologi. Un pavimento con tessere musive è stato rinvenuto in una delle più importanti isole della Dalmazia. Un’ampia villa romana del II sec. d.C. si nasconde sotto le strade Il mosaico romano riportato alla luce e gli archeologi al lavoro, nelle fotografie scattate dall’archeologa Vilma Matulic È stato scoperto sull’isola di Hvar in Croazia, lo scorso 15 febbraio 2022, un enorme pavimento musivo a decorazioni geometriche. È venuto alla luce in seguito ai lavori di realizzazione della rete idrica e fognaria della città. Hvar si trova nei pressi della costa orientale del mare Adriatico e appartiene al gruppo delle isole della Dalmazia centrale. Proprio in questi giorni stanno affiorando nuovi resti che confermano l’ipotesi iniziale: si tratta di un ampio complesso che costituiva gli ambienti di una villa romana del II sec. d. C. Ad accompagnare lo stupore di questo ritrovamento c’è anche molta preoccupazione. Le infilstrazioni d’umidità e l’innalzamento del mare stanno allarmando gli archeologi: sono una grave minaccia per la sopravvivenza dei resti dell’antica Pharia romana. Gli abitanti vorrebbero che il mosaico rimanesse in loco, protetto da uno strato di plexiglass, per consentire di osservarlo nel contesto originario e di apprezzarne la bellezza, aggirandosi tra le strade dell’isoletta. Il mosaico romano riportato alla luce, nelle fotografie scattate dall’archeologa Vilma Matulic LA SCOPERTA DI ALTRE STANZE DELLA VILLA ROMANA DI HVAR IN CROAZIA Intanto si continua con gli scavi. Sono 14 le aree – attigue al luogo del ritrovamento della superficie musiva – che interessano la ricerca: altri reperti potrebbero aiutare a definire le caratteristiche dell’edificio. Sono state scoperte altre stanze della villa romana durante gli scavi nel fondo del vicolo. Lo comunica il Muzej Staroga Grada, impegnato nelle operazioni di scavo e di studio: “I mosaici sono decorati con motivi geometrici e floreali multicolori e sono di lavorazione qualitativamente superiore. Per analogia con mosaici simili e stili di officina conosciuti, le opere qui ritrovate possono essere datate al II secolo d.C. Avremo una migliore comprensione dello scopo di questo lussuoso edificio della Faria romana dopo l’analisi e l’interpretazione dei reperti archeologici e dopo aver unito tutte le planimetrie delle stanze con pavimenti a mosaico presenti sotto le case circostanti, che sono state scavate nei decenni precedenti”. Negli ultimi cento anni, quest’area è stata scavata da numerosi archeologi. GLI SCAVI E LA STORIA DI HVAR Gli scavi odierni sono condotti da Marina Ugarković dell’Istituto di Archeologia. Sara Popović dell’ArheoProjekt supporta l’operazione con una squadra di giovani archeologi, provenienti da tutto il Paese. Una volta che gli scavi termineranno, si deciderà quali siano le prossime mosse da intraprendere. Il proposito attuale del Museo del Centro Storico è di staccare il mosaico per trasportarlo al sicuro in un ambiente protetto, sostituendo l’originale con una copia calpestabile. La proposta dovrà essere accolta dagli addetti al patrimonio di Spalato. Ma come mai sono presenti questi eccezionali reperti proprio in questo sito? Hvar crebbe nell’ambito della cultura greca. La caduta e il declino di Siracusa, sua protettrice, pose fine al dominio greco. L’isola cadde così sotto il dominio dell’antica Roma nel 219 a.C. e fu Demetrio di Faroe a governarla sotto le direttive dei romani. – Giorgia Basili1 punto
-
Concordo alla grande,non è male come crederebbe Alberto @Litra68, ma si mantiene mb al rovescio e quasi mb al dritto,perchè paga dazio un pochino il capello oramai quasi tutto liscio☺️ Albè tranquillo,non arriva ancora a scarrafone😁 .....e anche se fosse😍1 punto
-
Perdonatemi se riprendo questo antico post. Ma io ho visto il museo e, seppur sia realizzato attorno ad un unico oggetto, è veramente evocativo e la statua risalta enormemente. Salendo la scala ci sono spiragli che ti permettono di vederla da diversi lati come un'apparizione. Un po' come deve essere stato per lo scopritore belga. Io l'ho trovato molto interessante e la statua molto bella1 punto
-
1 punto
-
Per me è una R10 , talmente rara che così trasparente non ne ho mai viste1 punto
-
PRIN cipe Soltanto a Massa. A Messerano in quella data, ma lo abbiamo già escluso. Altrove soltanto Conti,Marchesi, Signori .... Ho trovato , oltre a un paio di città tedesche e alla transilvania, anche imitazioni, non so se e quanto attendibili, di Pisa, mirandola e Tassarolo. Nulla che faccia pensare alla moneta della discussione.1 punto
-
1 punto
-
Ad attribuirlo a Massa è stato Andrea Paulucci, esperto commerciante e numismatico. Le legende sono le stesse della moneta venduta da LANZ. E' stato Lanz ad attribuirla oppure l'ha avuta da un collezionista già attribuita ? Lanz si è perso nella nebbia e non avremo risposta. Ho guardato sul "Fascio Numismatico" (pubblicato nel 1927) e con la legenda . CONFIDENS Etc. ...elenca Frinco,Messerano,Rovegno e Maccagno.(Piemonte e Lombardia). Non Correggio e Massa ma è libro quasi centenario. Mi fermo qui. Poi farò altre ricerche. Buona domenica.1 punto
-
1 punto
-
Ciao,100 post attivi @Daniele Elias ciao daniele,stai facendo probabilmente una scelta che ti fará far il salto di qualitá.Forse sará anche il passaggio tra raccoglitore come me a vero collezionista,chissá😁. I canali di vendita sono quelli,come ben detto su dall' amico @Kriper0204, quelli nominati da lui sono molto immediati. Lascia perdere i compro oro, lí si fa l' interesse sul fino, la numismatica la guardano poco. Ps: questa discussione andrebbe credo in PIAZZETTA, qui si discute di come si usa il forum quando si hanno intoppi😁 @CdC (grazie) non mi odiare pure di domenica mattina,quando puoi,anche martedí🤣....è per una causa nobile😁1 punto
-
Abbastanza raro, posto un esemplare battuto dalla NAC 90, lotto 866 in conservazione SPL1 punto
-
1 punto
-
Credo @Vietmimin ad oggi pressochè invariato ed in nostra isola . Una buona serata1 punto
-
Buonasera, si tratta di un imperiale, coniato nel Trecento. E' esattamente il tipo presentato da @Oppiano, con la legenda del rovescio che inizia un po' a sinistra, e non al centro come sugli altri tipi, e con le foglie del trifoglio cuspidate. Io lo collocherei nel periodo compreso tra il 1311/2 e il 1323, nello stesso periodo in cui si coniavano imperiali dello stesso valore a nome di Enrico VII a Milano, a Cremona, a Piacenza, a Brescia e a Parma.1 punto
-
Buonasera @titire premetto che Siena la conosco veramente poco, ti allego una scansione del MIR n. 507 e del Toderi n. 20, che confermano le conclusioni a cui eravate arrivati aggiornando però la catalogazione del CNI. Un saluto1 punto
-
1 punto
-
Grazie a tutti! Posto foto con altra luce e zoom, mi dite per favore se son migliori? Ho corretto titolo.. pardon.. @gennydbmoneymetto anche ingrandimento data1 punto
-
Potremmo dire dalla Treccani: tìtolo s. m. [dal lat. titŭlus]. – 1. Con riferimento all’antichità romana (per la quale è di uso frequente, anche oggi, la forma lat. titulus), iscrizione apposta alle immagini degli antenati; più genericam., iscrizione sopra statue, archi trionfali, ecc. Più visivamente: https://www.moruzzi.it/la_titolatura_imperiale.html La titolatura delle monete romane imperiali IMPERATOR Imperator con il significato di comandante, fiu usato in epoca repubblicana, come cognomen, per indicare il generale vittorioso che era stato acclamato dalle sue truppe sul campo. Da Tiberio in poi viene aggiunto, un numero per mostrare in quante occasioni l’imperatore era risultato vincitore. AVGVSTVS Fu ottenuto per la prima volta da Ottaviano nel 27 a.C. da allora in poi fu il titolo più distintivo dell’imperatore e divenne inseparabile dalla restante titolatura imperiale. La scelta del termine non avvenne casualmente; infatti, data per certa la derivazione dalla radice della parola augur, il termine Augustus stava ad indicare che colui che lo portava non era affatto un uomo ordinario. PONTIFEX MAXIMVS La suprema carica della gerarchia religiosa, quella di Pontifex maximus, fu accettata da Augusto alla morte di Lepido, nel 12 a.C. Il titolo, che conferiva grande dignità a chi lo rivestiva, fu regolarmente esteso a tutti i successori di Augusto. TRIBUNICIA POTESTAS Il potere tribunizio fu usato come cognomen “imperator”, con o senza indicazione del numero delle volte in cui tale carica fu rivestita. La numerazione della tribunicia potestas indicava l’anno del regno. PATER PATRIAE Il più alto onore che lo stato romano concesse agli imperatori, quello di essere considerato pater patriae, padre della patria, fu attribuito per la prima volta ad Augusto nel 2 a.C. Il titolo non aggiungeva nulla ai poteri dell’imperatore, ma era una espressione di gratitudine da parte del senato nei confronti del princeps. OPTIMVS Questo titolo che appartiene a Traiano, gli fu offerto all’inizio del regno e fu comunemente applicato in tutti i documenti ufficiali. Il nome OPTIMVS fu accettato da Traiano nel 114-115 d.C. e fu adottato su tutte le monete emesse negli anni successivi. OPTIMVS PRINCEPS è normale sulle monete da circa il 105 d.C. Il titolo, come i titoli militari di Traiano, fu abbandonato da Adriano, dopo un breve uso nel 117 d.C. TITOLI VARI Spesso titoli come DIVI F(ilius), figlio del divino, DIVI AVGVSTI F(ilius), figlio del divino Augusto, furono usati per mostrare una relazione esistente tra l’imperatore regnante ed il suo antenato. TITOLI MILITARI1 punto
-
Volevo dirvi che... quando mi sono iscritto a questo gruppo l'ho fatto perché, dopo anni di archeologia sul campo e dopo averla abbandonata con delusione del sistema Italia ed universitario per dedicarmi ad altro, un mio amico - il fratello minore che non ho mai avuto - nipote di un importante collezionista e studioso di Bologna, mi ha fatto riappassionare alle monete antiche. e qui trovavo spunti di divertimento e di leggero approfondimento. si... leggero... Il problema è che sono stato investito da così tanta roba meravigliosa che ora sono impazzito per le monetazioni altomedievali, da lì la monetazione bizantina... ma non vuoi anche interessarti al periodo tardoromano? E poi c'è sempre la monetazione repubblicana romana che era stata la mia prima passione da studente di numismatica. Però anche le celtiche sono interessanti... E vuoi mettere le monete medievali? Ci sono aree del forum che non voglio neppure aprire per paura 🙂 Mannaggia a voi!!!! Il leggero problema è che ad ora ho in elenco qualcosa come 68 tra articoli scientifici e libri da leggere, sto collezionando centinaia di immagini tratte dal web della qualunque e tra un po' mia moglie cambierà la serratura della porta di casa... Mannaggia voi... grazie! PS... ho inserito queste due righe qui proprio perché è una questione visceralmente numismatica anche se non si tratta di un oggetto in particolare.1 punto
-
buonasera, vorrei resuscitare questa discussione poichè ho delle 1988 in fdc da rotolino con 88 grandi e data sdoppiata in un caso, dato che sto disquisendo con una persona che mi dice non valere nemmeno 50€, quando ho visto ad una sua asta passare una 1964 ,che è una C,da sola anche se "periziata" con dicitura che da Gigante viene bei soldini in fdc, chiedo gentilmente quanto possa realisticamente valere in condizioni fdc questa 1988, che è una ,NC, anche se presenta un'usura periferica del conio che le dona una buccia d'arancio misto"effetto"patina a bersaglio, spero di essere stato chiaro. grazie se risponderete.1 punto
-
Ciao @paultss, certamente lo avrai già letto, ma te lo segnalo lo stesso qualora fosse di tuo interesse. https://it.wikisource.org/wiki/Un_tallero_di_Maccagno Saluti. Ti segnalo anche questo: 2002. 'The Circulation of Dutch Leeuwendaalders in 17th Century Ottoman Palestine: New Evidence from Two Unpublished Hoards' Jaarboek voor Munt en Penningkunde 89: 47 -68. https://www.academia.edu/4424141/The_Circulation_of_Dutch_Leeuwendaalders_in_17th_Century_Ottoman_Palestine_New_Evidence_from_Two_Unpublished_Hoards_Jaarboek_voor_Munt_en_Penningkunde_89_2002_47_-681 punto
-
Buonasera , Voglia di Vicereale... Filippo II Carlino Sigle GR/VP Riporto una nota presa dal web. Curiosità Filippo II di Spagna si sposò quattro volte e per quattro volte divenne vedovo, ebbe numerosi figli ma pochi di loro giunsero all’età adulta. Il Re di Spagna la prima volta si sposò con sua cugina la Principessa Maria Emanuela d'Aviz; la seconda volta fu con un’altra cugina, la Regina Maria I d'Inghilterra; la terza si sposò con la Principessa Elisabetta di Valois; infine con la nipote Arciduchessa Anna d'Austria. Quest’ultimo matrimonio segnò l’inizio delle unioni endogamiche che determinarono la fine della Casa d’Asburgo con Carlo II per l'eccessiva consanguineità. Saluti Alberto1 punto
-
Portando ad esempio la monetazione veneziana, solo le monete che portano il nome del doge vengono a lui attribuite. In assenza del nome si parla di monetazione anonima, pur sapendo esattamenre la data di emissione grazie alle iniziali del massaro. Quindi, visto che furono coniate prima del referendum, verrebbero chiamate monete anonime del Regno d'Italia. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
E' difficile dirlo. Comunque 5 lire d'argento erano una discreta somma. Qui puoi vedere un estratto dalla "Guida pratica popolare di Firenze" del 1865, ad uso dei Piemontesi che dovevano trasferirsi nella nuova capitale. Ci sono i prezzi di alcuni piatti serviti nelle trattorie fiorentine. Ci si può fare un'idea su cosa si poteva mangiare con 5 lire all'epoca.1 punto
-
È solo il taglio della foto che ha incluso parte dello sfondo più scuro. Mi scuso per l'imprecisione grafica, ma ero abbagliato dalla conservazione di questa moneta che dev'essere finita subito in tasca ad un collezionista 150 anni fa (e lì rimasta). Di solito questi Scudi, solo per la loro dimensione nella circolazione, sono ricoperti di graffi e graffietti per non parlare dei bordi tormentati da colpi spesso provocati da lanci su pietra per verificarne il suono dell'argento, mentre in questa moneta i bordi del contorno sono ancora taglienti: Mi sono accorto che se dico "in buona conservazione", i pignoli del forum tacciono. Quando scrivevo "FDC" o "in alta conservazione", apriti cielo, c'era la corsa a trovare veri o presunti difetti. Stavolta, è vero, mi sono nuovamente sbilanciato e vedo che i "motori" si si stanno scaldando...1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?