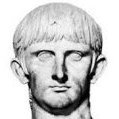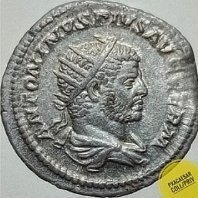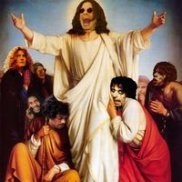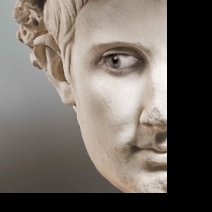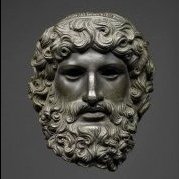Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 02/09/24 in Risposte
-
Salve. Posto la foto della mia piastra 120 grana 1828 di Francesco I. La bustina della perizia, come al solito, mi ha creato dei problemi... Saluti.5 punti
-
Consultando il catalogo dell'asta delle collezioni Sambon-Giliberti (dispersa a Napoli dal 10 dicembre 1921) custodito presso la biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, mi sono imbattuto in due curiosità che, a mio avviso, raccontano un pezzo di storia del collezionismo napoletano della prima metà del Novecento. In origine il catalogo era composto da due libretti: il primo contenente un elenco delle monete in vendita e un secondo composto di sole tavole. Il catalogo che ho consultato è stato successivamente rilegato (testo+tavole) con una copertina rigida e in ogni pagina, accanto a ogni lotto, sono riportati a matita il prezzo di vendita e il nome dell'acquirente. Per alcuni lotti non compaiono i nominativi, bensì dei numeri, probabilmente perché gli acquisti venivano effettuati per acquirenti che volevano rimanere anonimi. La seconda curiosità è in un foglietto volante nel quale sono trascritti tutti i partecipanti dell'asta e le loro presenze durante le quattro giornate (domenica compresa). Come potete leggere vi parteciparono grandi collezionisti.4 punti
-
3 punti
-
Calma e gesso. 1) Moneta autentica. 2) Non esistono dupondi né assi per Postumo, ma solamente sesterzi (corona laureata) e sesterzi ritariffati (corona radiata) di ipotetico doppio valore (o comunque superiore della versione laureata). 3) Questo è un sesterzio (devo controllare sul Bastien) che dovrebbe essere uscito dall' atelier II (Chateaubleau) e quindi non è una produzione ufficiale di zecca. Il pezzo ha tutta l'aria di essere un prodotto realizzato per fusione. Anche qui dovrei controllare nel libro di Pollon per una possibile definizione da quale delle tre officine dell'atelier potrebbe essere uscita. ma al momento son fuori casa e non ho né Bastien né testo di Pilon sull'atelier II3 punti
-
Mi sa, caro @Scudo1901, che stavolta non mi devo vergognare nel confronto fra monete mie e tue. Ti posto (in realtà l'ho già presentato una o due volte in altre discussioni) il mio 20 Lire del 1928 di buona qualità:3 punti
-
Buonasera, è da un po' che non posto una moneta, stasera vi mostro un 50 lire in Acmonital, come sempre chiedo i vostri pareri di conservazione. Saluti Marfir2 punti
-
Condivido una delle mie due 1831. Entrambe con 4 quadratini nello stemma del Portogallo (a mio parere la più comune delle 5) 37,5 mm - 27,27 g taglio inciso al rovescio e giglio ad ore 8.2 punti
-
1. Statere in oro di Carataco, unico esemplare conosciuto, coniato nel 40-41 d.C. circa a Calleva (Silchester, Hants). Trovato vicino a Newbury, Berks., il 10 novembre 2019. In vendita il 15 novembre 2020, stima £ 30.000. Da quando è stata annunciata la scoperta dell’unico statere d’oro conosciuto di Carataco («Coin News», giugno-luglio 2020) sono state sollevate molte discussioni in ambito accademico. Che questa moneta susciti così tanto interesse non sorprende. Carataco è sempre stato un personaggio noto. In vita era celebre come combattente per la libertà. Per otto anni resistette all’invasione romana della Gran Bretagna a partire dal 43 d.C. Per otto anni fu l’uomo più ricercato dell’Impero romano, braccato senza sosta, di combattimento in combattimento, di fortezza in fortezza, sulle montagne del Galles, finché non fu tradito e consegnato ai Romani nel 51 d.C. da Cartimandua, regina dei Briganti dello Yorkshire, a cui era ricorso per chiedere aiuto. Quando fu portato a Roma in ceppi per essere esibito e ucciso, la sua fama era già notevole: si era diffusa in tutta la Gallia ed era arrivata a Roma ancor prima di lui. L’imperatore Claudio volse questa situazione a proprio vantaggio. Fece esporre in pubblico Carataco ammanettato insieme alla sua famiglia ma invece di giustiziarlo, come di norma, lo perdonò e liberò, il che rese Claudio ancora più celebre. Carataco rimase a Roma, in tranquillo ritiro e, per quanto sappiamo, morì alcuni anni dopo a Roma. Ma la sua fama gli sopravvisse e, all’inizio del II secolo d.C., accrebbe ulteriormente grazie allo storico romano Tacito che diede un resoconto emozionante del discorso di Carataco mentre si trovava in catene davanti a Claudio e ai cittadini di Roma. Anche se Tacito lo riportò molti anni dopo, forse tutto o solo in parte, questo discorso ha risuonato nel corso dei secoli e fece di Carataco un personaggio leggendario fino ad oggi. Ricordato nella tradizione gallese medievale e nelle leggende gallesi, a Carataco venne attribuita l’introduzione del cristianesimo in Gran Bretagna e venne persino indicato come padre di papa Lino. È apparso nella commedia di John Fletcher Bonduca (1613), nell’opera Carattaco di J.C. Bach (1767), nella cantata Caractacus di Elgar (1898) e, più recentemente, in vari romanzi e nel dramma televisivo Claudius the God. 2. Per otto anni Carataco fu l’uomo più ricercato nell’Impero romano, alla guida delle tribù gallesi in una guerriglia contro le forze di Claudio. Dati i suoi due millenni di fama internazionale – come primo noto combattente per la libertà della Gran Bretagna e membro più conosciuto della più antica famosa famiglia reale britannica (suo padre era Cunobelino di Colchester, “Old King Cole”, immortalato come Cymbeline da Shakespeare) – non sorprende che la prima moneta d’oro di Carataco portata alla luce abbia colpito i numismatici. David R. Sear, autore di Roman Coins and their Values (Spink 2000-2014) e tra le autorità più note nel mondo sulla numismatica antica, afferma: «Questo deve sicuramente essere classificato tra le scoperte numismatiche più emozionanti del XXI secolo, se non di tutti i tempi». Dopo quarant’anni di ricerca, perché è stata trovata una sola moneta d’oro di Carataco? Il dottor Philip de Jersey, autore di Celtic Coinage in Britain (Shire 1996) e Coin Hoards in Iron Age Britain (Spink 2014), afferma: «Il semplice fatto che sia unica, dopo tutti quegli anni di ricerche e migliaia di reperti ritrovati, deve indicare che si trattava di una moneta rara e insolita fin dal momento in cui è stata coniata». 3. Carataco potrebbe essere discendente di Cassivellauno, comandante della coalizione britannica contro Cesare nel 54 a.C., rappresentato qui con l’elmo alato (ABC 2472). Il dottor John Sills, autore di Divided Kingdoms: the Iron Age gold coinage of Southern England (Chris Rudd 2017), è d’accordo. Dice: «L’unicità dello statere di Carataco deve significare che pochissimi esemplari furono coniati all’origine». Egli suggerisce che sia stata «battuta all’inizio del suo regno per cementare la sua autorità come nuovo sovrano di una dinastia straniera». Gli stateri di Carataco potrebbero essere stati donati all’aristocrazia locale perché servissero a identificare e consolidare lo status del nuovo sovrano ma sembra che non siano entrati in circolazione. Due grandi tesoretti, ritrovati a Bentworth e Chawton («Coin News», dicembre 2013 e aprile 2016), arrivano fino alle coniazioni in oro di Epaticco e potrebbero essere collegati all’invasione Claudiana; se stateri di Carataco fossero entrati in circolazione dovrebbero essere presenti in questi repertori, ma non lo sono». Ci può essere un’altra ragione per la grande rarità degli stateri d’oro di Carataco: dei pochi che furono coniati, la maggior parte furono probabilmente riconvertiti in lingotti subito dopo l’invasione di Claudio. Perché? Perché chi si fosse trovato in possesso di una di quelle monete sarebbe stato subito identificato come anti-romano e, peggio ancora, come simpatizzante dei ribelli. John Sills dice: «Probabilmente non era saggio per nessuno possedere una moneta d’oro del leader della resistenza dopo l’invasione romana. Sarebbe stato pericoloso essere scoperti dai romani con una coniazione di Carataco». Non è ironico che una moneta d’oro celtica che nessuno voleva possedere duemila anni fa sia ora la moneta d’oro che i collezionisti celtici più desiderano nella loro collezione? 4. Il fratello di Carataco, Togodumno, morì combattendo contro i Romani nel 43 d.C. Quarto di statere in oro (ABC 3008), trovato a Bourne End, Beds., nel 2013. Venduto da Chris Rudd nel 2014 per £ 10.200 (ingrandimenti). 5. Carataco e Claudio potrebbero essersi incontrati a Roma molto prima che Claudio invadesse la Gran Bretagna nel 43 d.C. Moneta d’argento (ABC 1376) e tetradramma d’argento (BMC 228). 6. Claudio ha trascorso solo 16 giorni in Gran Bretagna. Ma era così orgoglioso della “sua” conquista che ribattezzò suo figlio Britannico, rappresentato qui con Marte. Sesterzio, 51 d.C. circa, BMC 226. Aggiudicato da Numismatica Ars Classica NAC AG, asta 59 del 6 ottobre 2011, lotto 658, per CHF 125.000 (£ 104.000). Le notizie e le ipotesi attuali su Carataco, molte innescate dalla scoperta, lo scorso novembre, dell’unico statere battuto a suo nome, sono sorprendenti. Ad esempio, l’archeologo professor Michael Fulford ha recentemente scoperto un enorme fossato, lungo 1,5 miglia e profondo fino a 4,8 metri, che Carataco potrebbe aver scavato intorno alla sua capitale a Calleva (l’attuale Silchester, Hampshire) per difenderla dagli invasori romani («Current Archaeology» 356, novembre 2019). «Il ritrovamento di uno statere d’oro di Carataco è estremamente importante», afferma il professor Fulford, «in quanto aggiunge non solo un nuovo esemplare alla serie delle sue coniazioni, che altrimenti erano solo in argento, ma fornisce anche informazioni sulle risorse di colui che comandava all’epoca l’invasione romana della Gran Bretagna». 7. Quando Claudio invase la Gran Bretagna, Carataco scavò o ri-scavò un fossato difensivo intorno alla sua capitale, Calleva, che misurava 1,5 miglia di lunghezza e fino a 4,8 metri di profondità. Sala regale a Calleva, 10-45 d.C. Altre due affermazioni arrivano dalla Dottoressa Daphne Nash Briggs, esperta numismatica e autrice di Coinage in the Celtic World (Seaby 1987), e dall’archeologo Reverendo Professor Martin Henig, autore di The Heirs of King Verica: Culture & Politics in Roman Britain (Amberley 2002). Nel loro articolo di prossima pubblicazione, Caratacus, suggeriscono che il combattente britannico per la libertà potesse essere cresciuto a Roma, dove incontrò Claudio. Dicono: «Non è affatto inverosimile immaginare che Carataco abbia effettivamente parlato con Claudio, sia nel latino che aveva imparato un tempo a Roma, sia nella lingua celtica che Claudio aveva assorbito da bambino a Lione. Forse Claudio lo aveva conosciuto personalmente proprio come aveva conosciuto i figli di altri capi, tra cui Prasutago, che divenne sovrano delle tribù confederate degli Iceni e degli Atrebati, il gallo-britannico Cogidubno, e manteneva ancora un sentimento amichevole nei suoi confronti». La seconda ipotesi riguarda l’amica del poeta Marziale, Claudia Rufina, detta “testa rossa” (Epigrammi XI, 53), descritta dal poeta come «caeruleis… Britannis edita», ossia “nata dai britannici blu” e che era, come scrive Anthony Birley, «senza dubbio la figlia o la nipote di un beneficiario dello Stato romano nel periodo immediatamente successivo alla conquista» (The People of Roman Britain, Batsford 1970, pp. 15-16). Secondo gli autori, Rufina «avrebbe potuto essere la figlia di Carataco» (D. Nash Briggs e M. Henig, Caratacus, in «Association for Roman Archaeology News», autunno 2020). Quando ho detto al professor Henig che è stato trovato uno statere d’oro di Carataco, ha esclamato: «Sono elettrizzato. Questa è una delle monete celtiche più importanti trovate in questo secolo». 8. Cranio di un uomo di 25-35 anni rinvenuto nel fossato intorno a Calleva. È morto difendendo Calleva con Carataco quando le forze di Claudio attaccarono nel 43-44 d.C.? 9. Carataco raffigurato come barbaro seminudo. In realtà egli era probabilmente ricco, ben vestito, ben istruito (a Roma?), scriveva in latino, aveva schiavi, beveva del buon vino italiano in un calice d’argento e indossava le più moderne armature romane. Allo stesso modo commenti entusiastici sono stati fatti da altri studiosi solitamente riservati. Il professor Chris Gosden dell’Istituto di Archeologia di Oxford, sede del Celtic Coin Index, descrive lo statere di Carataco come «una moneta straordinaria». Il dottor Philip de Jersey, ex amministratore del Celtic Coin Index, dice: «Che moneta straordinaria! A differenza del primo statere d’oro di Volisios dei Catuvellauni, della cui esistenza era certo Derek Allen già nel 1944, non credo che nessuno di noi abbia mai pensato che potesse essere ritrovato questo statere di Carataco. Sembra piuttosto straordinaria, dopo così tanti decenni di rilevamento di reperti antichi in metallo – di quella che dopo tutto è una risorsa in diminuzione – l’apparizione di qualcosa di così inaspettato e, inoltre, appartenente a un sovrano che ha avuto un ruolo così importante nella storia britannica». Rainer Kretz, un esperto di monete dinastiche del Tamigi settentrionale e la prima persona a rendersi conto che l’abbreviazione Dubn (ABC 3008) può riferirsi al fratello di Carataco, Togodumno, afferma: «Essendo stato battuta da un sovrano che fino ad ora era conosciuto solo da tre monete in argento e tre minimi, questo rappresenta una scoperta davvero sensazionale. Chi, sinceramente, avrebbe mai puntato sul ritrovamento di uno statere di Carataco eppure, contro tutte le probabilità, eccolo!» E il dottor John Sills, un coautore di Ancient British Coins (Chris Rudd 2010), sostiene che è «la più importante moneta dell’età del ferro mai trovata in questo paese» («Coin News», luglio 2020, p.39). Dato il grande interesse che ha suscitato la scoperta dell’unico statere d’oro di Carataco e la notevole fama del principe che lo ha coniato, ci si attende che questa moneta possa raggiungere un prezzo record quando sarà battuta in asta il 15 novembre prossimo. Il professor Colin Haselgrove, che ha recentemente pubblicato un rapporto sugli scavi a Stanwick, nello Yorkshire, ex capitale della regina Cartimandua, che consegnò Carataco ai romani nel 51 d.C., afferma: «Questa potrebbe diventare la moneta più preziosa dell’età del ferro trovata fino ad oggi. A tutti piace un eroe britannico». Lo statere d’oro di Carataco, unico esemplare conosciuto, sarà venduto in asta a Norwich il 15 novembre 2020. Crediti fotografici: 1, 3a, 4, 5a © Chris Rudd. 2 Caractacus by William Blake © The British Museum, 3b Jane Bottomley © Chris Rudd. 5b, 6 © Numismatica Ars Classica NAC AG. 7 Reconstruction by Margaret Matthews, in Late Iron Age Calleva, Britannia Monograph Series No.32, Soc. PRS, 2018. 8 Photo Diana Pearl McNutt © University of Reading. 9 Caractacus marble statue, John Henry Foley, 1859, © City of London, Guildhall Art Gallery. https://www.panorama-numismatico.com/lo-statere-di-carataco/2 punti
-
2 punti
-
No. Se vuoi puoi farti anche tu i rivetti personalizzati. Quello che davvero conta sono eventuali indicazioni riportate sul cartellino relative a eventuali iscrizioni, come tribunale, Camera di Commercio o altro ente, che se mendaci possono costituire un falso e quindi anche un reato. Come ho scritto sopra, no. Una persona (non faccio nome, ma è accaduto veramente) si era fatto fare i rivetti personalizzati e si presentava nel cartellino come “competente” in una determinata area monetale. Come ha già ben spiegato @Arka, il cartellino non è una perizia, ma esprime solo un parere di conservazione, peraltro (a mio parere) spesso molto limitato visto lo spazio esiguo per poter esplicare degnamente eventuali note (aspetto questo molto sottovalutato. Leggendo l’articolo sui NIP, presentato da cronaca numismatica e citato in questo topic, vedo piacevoli intenti di cambiamento a questo riguardo). 1) Commetterebbe “una furberia” se sul cartellino scrivesse che è un perito CCIAA o NIP quando non lo è. Come scritto sopra, chiunque può sigillare con rivetti personalizzati, e un commerciante può benissimo farlo a mò di garanzia sulle sue monete. 2) come già ampiamente spiegato sopra, vale come PARERE. Le perizie sono ben altre cose (e costano ben più di 10 o 15€) 3) Come già scritto, si, ma non deve riportare false credenziali. Certamente, ma poi sorgerebbe il problema della sicurezza, in quanto la moneta potrebbe benissimo essere sostituita con un’altra. Ci sono periti che hanno ovviato a questo inconveniente inserendo un qr-code che riporta a un certificato elettronico online, così da rendere la perizia più sicura indipendentemente dai rivetti Si possono anche omettere… ma per ovvie ragioni è meglio riportarli al fine di dimostrare le proprie credenziali professionali. Teoricamente si (prendi ad esempio i cartellini di Emilio Tevere… una certa “differenza” la fanno ancora). Ma come scrivo sempre, il mio consiglio è quello di imparare da sé a giudicare il grading. Le perizie hanno da sempre costituito un argomento molto vivace nel forum. Se fai delle ricerche ti si aprirà un vero mondo. Spero di aver risposto esaurientemente alle tue domande. Se vuoi contattami anche in privato, io rientro tra coloro che sono iscritti alla CCIAA come periti numismatici anche se non esercito questa attività in maniera professionale, per cui sentiti libero di contattarmi qualora volessi farmi altre domande. Un saluto Fabrizio2 punti
-
Sì, è vero ci sono queste differenze negli anni indicati dal buon Andrea, ma si tratta di minuzie. La prima "A" chiusa o aperta nella firma di GIAMPAOLI) che oltretutto, a mio avviso, è poco visibile se non con lente a forte ingrandimento.. Nel 1954 invece, ci troviamo con due conii con differenze sparse qua e là, il II tipo (il più comune, chiedo scusa, nella risposta a @Marfir avevo detto il contrario) presenta: - bordo più sottile; - la "INC" di incisori, più a destra rispetto a Romagnoli; - le cifre del millesimo più sottili; la "R" di Roma (segno di zecca) più piccola; - la chioma di vulcano più ampia; - il manico del martello più corto. -2 punti
-
Ripropongo l’esemplare Prova di Stampa in questo thread, che ormai si è sfocato rispetto alla moneta che lo ha aperto (nessun problema), in modo così da vedere se qualcuno ha voglia di aggiungere i suoi esemplari, così per confronto. Mi piacerebbe vedere anche la PROVA standard del 20 lire Elmetto, più rara di questa, variante che appare più frequentemente in asta, e che si situa tra R3 e R4 pur non trovandosi in tutti i mercatini domenicali 😸. Sarebbe anche interessante che qualche esperto di prove ci potesse spiegare gentilmente come mai la prova semplice è più rara di quella “di stampa”2 punti
-
2 punti
-
Alla prossima asta Nomisma 69 del 23-24/3/2024 sarà battuto il Lotto 1258 così ottimamente descritto in Catalogo e relative foto. NAPOLI Filippo IV (1621-1665) 2 Cavalli 1632 - Magliocca 140 (questo esemplare illustrato, indicato R/5 senza alcuna valutazione) CU (g 1,49) RRRRR Questo esemplare, estremamente raro, è raffigurato nel Magliocca a pag. 247, n. 140. Il due Cavalli di Filippo IV, con al rovescio ritratte due cornucopie e con la legenda PVBICA COMMODITAS, venne, nel passato, denominata moneta dal valore di un Cavallo. Gli studiosi della monetazione di Napoli, Michele Pannuti e Vincenzo Riccio nel loro lavoro sulle monete di Napoli (dalla caduta dell’Impero Romano alla chiusura della zecca), pag. 182 nota 22, corressero questo errore riportando la moneta (in considerazione del suo peso) al valore di due Cavalli. Sia il Cagiati che il Dell’Erba restituirono due esemplari di questo tipo, rispettivamente, uno con la data 1622 (rif. Corpus 272, pag. 290 - Cagiati n. 1 pag. 285, coll. Gnecchi) e l’altro con la data 1636 (citato dal Dell’Erba), ma gli stessi Autori (cioè il Pannuti ed il Riccio) hanno tralasciato, giustamente, la trascrizione delle suddette monete perché ritenute inesistenti con incise queste date; l’evidenza venne avvalorata esaminando l’esemplare del Corpus al n. 667, pag. 339 e del quale né proposero la foto nel loro lavoro, ma non si accorsero che al rovescio la parola PVBLICA era mancante della lettera L. Il Cagiati disegnò solo l’esemplare con la data 1622. La moneta è con la lettera S dietro la testa, a sinistra di Filippo IV e questa è accertata identificativa del mastro della zecca dell’epoca, Lorenzo Salomone il quale svolse la sua funzione nella zecca di Napoli negli anni dal 1630 fino al 1634. Nel 1622 la zecca era retta da Michele Cavo, che siglava le monete con le sue iniziali M e C, appare quindi manifesta l’errata catalogazione e trascrizione da parte sia del Cagiati sia dal Dell’Erba degli esemplari con la data 1622 e 1636; quanto accaduto ha portato, probabilmente, ad un errore di lettura della data da parte degli autori tenuto conto delle piccolissime dimensioni della moneta oppure, molto probabilmente, da un disegno originato con errore. Al contrario, trascritti correttamente con la data 1632, ma con la denominazione di Cavalli (perché antecedenti al lavoro del Pannuti), sono i due esemplari presenti nel Corpus ai nrr. 667 e 668 pag. 339, rispettivamente il primo della collezione Reale (SM) ed il secondo riportato dallo stesso Cagiati al n. 2 (sempre della coll. Gnecchi). L’esemplare della collezione Reale (SM) è raffigurato alla Tav. XII con il n. 19 e contiene, come detto, l’errore al rovescio della parola PVBICA anziché PVBLICA e avanti busto, a destra, il contrassegno del coniatore, cioè la raffigurazione di un piccolo giglio. Un ulteriore esemplare è della coll. Bovi, trascritto al n. 69 pag. 55 del suo lavoro sulle monete di Napoli di Filippo IV e di Enrico di Lorena (Bollettino del Circolo Numismatico Napoletano, Anno L-LI, gennaio 1965 - dicembre 1966); Il Bovi la descrive come moneta da Due Cavalli e aggiunge la nota (61) che sul Corpus venne denominata Cavallo, evidenziando (perché visibile) il giglio avanti busto (contrassegno come la moneta di SM) ma non nota l’errore PVBICA. Nel catalogo della collezione di monete di Bovi/Mastroianni (Museo Principe Gaetano Filangieri), stampato nell’anno 1984, l’esemplare (del Bovi) è raffigurato a pag. 239 Tav. 30 con la numerazione 38/1006, con la data 1622 e con le sigle M/C, ovviamente anche in questo caso è compiuto lo stesso errore di trascrizione del passato. Infatti, esaminando attentamente la foto si evince che è con la data 1632, ha il giglio avanti busto ed è con l’errore PVBICA. La moneta proposta ha la sua prima apparizione sul mercato numismatico (stessa moneta raffigurata dal Magliocca), ha la data 1632, contiene l’errore PVBICA e ha il contrassegno del coniatore “giglio”. Non si conoscono altresì passaggi tra privati e il nominale manca in tutte le collezioni conosciute, a parte SM e il Bovi. Ultima e doverosa osservazione è determinata dalla condizione, ad oggi, a meno di una prova contraria, che questi limitati esemplari conosciuti avendo sempre il giglio (come contrassegno) e contenenti lo stesso errore di conio “PVBICA”, provengono da un'unica battuta e operata sempre dallo stesso coniatore di turno nei locali della zecca di Napoli. Grading/Stato: MB Complimenti!1 punto
-
Recentemente visionando delle immagini sul web mi sono imbattuto nei seguenti esemplari. Cosa ne pensate, visti i dettagli e particolari dei 2 esemplari? g.3.99 g.5.01 grazie per le considerazioni di chi vorrà partecipare, Skuby1 punto
-
Buona sera sono novizia sul serio nell'ambito numismatico mi potreste aiutare a dare una collocazione storica a questa moneta? Grazie.1 punto
-
Buongiorno a tutti, sono interessato a queste due monete che mi sono state proposte e mi faceva piacere condividere con voi le foto per sapere il vostro giudizioso in relazione allo stato di conservazione che voi attribuireste. Le monete sono in bustina sigillata con la perizia del perito numismatico quindi mi rendo conto che le foto sono quelle che sono, considerando inoltre anche la difficolta di riuscire a fotografare l' oro.. Grazie comunque a chi ha piacere di intervenire dando il suo parere. Marco1 punto
-
Cari Lamonetiani, il Gazzettino #11 sta già viaggiando a gonfie vele (siamo già a 50 pagine di monete e notizie). Avete voglia di aggiungere un articolo da voi scritto? Mandatelo a [email protected], ma mi raccomando entro il prossimo giugno.1 punto
-
1 punto
-
Premetto che condivido in toto quanto scritto da @Tinia Numismatica. Purtroppo, a mio parere, questo non è un attestato di provenienza. Ció che il venditore si è limitato ad attestare è l’autenticità della moneta. E certamente non basta richiamare l’art. 64 per fare assumere a questo documento la valenza di attestato di provenienza. La cosa peggiore è che il venditore non si è neanche sforzato di scrivere “attesto ai sensi dell’art. 64 CdB la lecita provenienza della moneta”, come pure molti fanno (secondo me sbagliando) ma almeno sarebbe stato qualcosa…1 punto
-
Appena ho modo provvedo! Ho scritto che è un sesterzio ma intendevo "sesterzio ritariffato" quindi doppio perché con corona radiato.1 punto
-
Un particolare guerriero a cavallo, forse con stendardo o lancia, dal rovescio di una accattivante dracma, dal 'medioevo' afgano e dalla città di Kabul . E' in queste ore in vendita Savoca 195 al n. 534 .1 punto
-
1 punto
-
Già dare un giudizio da foto è difficile, ancor più con la plastica.Da quello che vedo, hanno ambedue una bava di conio che presumo possano essere FDC, però vedo anche dei segni abbastanza pesanti sul 50 Lire Aratrice, un pò meno sul 20 Lire. A mio parere il perito può averle chiuse FDC con segni o SPL +.1 punto
-
Quell'escrescenza sembra però qualcosa di aggiunto a posteriori... tipo una colatura di metallo per saldarci un anello o una spilla e farne un bottone o un "gioiello"...1 punto
-
Il secondo è stato "battuto" dal fratello di Rambo (cit.) . La prima , magari, potrebbe essere coniata su un qualcosa di precedente ?1 punto
-
Vedo ora il tuo contributo,ora non ho tempo ma stasera mi voglio sfondare di Arslan e celtismo padano .👏👏1 punto
-
Ciao, può anche darsi che ci sia solo un esemplare (il primo) che sia stato clonato dal secondo ma questo non si può dire con certezza. Come anche che sia opera di un falsario alle prime armi che si è messo un giorno a casa ed abbia deciso di clonare una moneta. Come falsario alle prime armi non è stato poi tanto incapace. Moneta che da quanto sostieni non esiste come tipologia ( hai detto che è di fantasia) percui cosa aggiungere. Mi auguro che sia come tu sostieni e che non vi siano ulteriori esemplari che giacciono beati in tante collezioni 🙂 ANTONIO1 punto
-
Quasi sicuramente ma ti prego prendi quanto dico con le pinze. La tua striscia appartiene secondo me all' emissione del 1968 con vignetta 16x20mm dentellatura 14 x14 1/4 su carta fluorescente. Inoltre la dentellatura al mio occhio risulta essere a blocco e non a pettine come per gli esemplari per macchinette, ma anche questo controllo essendo una striscia verticale non mi e' semplice. Controllare la fluorescenza e' una cosa che potresti fare con una lampada UV e ci toglieremo ogni dubbio. Mi auguro comunque di essermi sbagliato alla grande ..e mi auguro che tutta questa ricerca incuriosisca sino al punto di iniziare a studiare personalmente, garantisco per un sicuro divertimento. Se ne hai altri postali pure.1 punto
-
1 punto
-
sapevo di questa differenza e non solo per il 1954, fino ad un certo anno, ma non ricordo quale, hanno usato due conii per le 50 lire, vado a cercare il link che ho letto sperando di non aver travisato il ricordo eccolo qua, spero di fare cosa gradita https://www.erroridiconiazione.com/50-lire/1 punto
-
Moneta molto rara ed affascinante, ti invidio! Comunque anch io propendo per catalogarla come sesterzio, uno degli ultimi, quindi con un peso lontano anni luce da quello che avevano i primi sesterzi della dinastia giulio-claudia1 punto
-
Ciao, Il bronzo Bertolami già menzionato, assente dal Göbl (27 mm, 5,96 g) è stato poi venduto dalla CNG nel 2019 con una didascalia più esatta (non c’entra niente con il RIC 32): « Questo sembra essere il primo esemplare registrato del rovescio IOVI CRESCENTI su una moneta di bronzo. Nonostante il modulo piccolo ed il peso contenuto, è probabilmente un sesterzio e non un asse. Il disegno del rovescio differisce da quello sugli antoniniani di questo tipo, in quanto il bambino è seduto in modo regolare, anziché all’amazone, sul dorso della capra. È stato discusso insieme ad altri aspetti di questa monetazione da Holmes 2017b. Poco dopo, sorprendentemente, sul mercato è comparso un secondo esemplare in uno stato ancora più corroso (Leu Web Auction 5, 23 settembre 2018, lotto 837). » https://www.acsearch.info/search.html?id=5840860 L’altro è il lotto 837 della vendita Leu menzionato dalla CNG: https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=2726&lot=837 « Asse », 23 mm, 5,45 g Secondo Leu, fa parte dell’ultima emissione di Viminacium prima del trasferimento della zecca a Colonia, nel 256/257 d.C. Il tuo bronzo sarebbe il terzo esemplare, e propenderei per la zecca di Roma. Non so se esistono bronzi per Valeriano II a Viminacium, e lo stile del ritratto mi pare sia simile ad alcuni bronzi di consecratio di Roma per il Cesare. Prova a vedere se non vedi traccia del S C all’esergo. Qual’è il diametro? @Stilicho Solo il nuovo RIC V.4 che riguarda l’impero gallico è uscito (Jérôme Mairat).1 punto
-
Ma ragione su cosa? Che un giorno queste monete varranno meno di oggi? Pazienza, dove c’è gusto non c’è perdenza.1 punto
-
annuncio online, partiva da 250€ ci siamo incontrati e abbiamo chiuso a 190. Ricordo di aver visto venduti sulla baia intorno ai 2201 punto
-
Ciao @didrachm, come ho già scritto e come ha già provato a spiegarti Raffaele, l'argomento sulle piastre del 1831 è stato concepito come un vero e proprio archivio fotografico, fatto di dati e foto... proprio per questo - se hai notato - tutti coloro che hanno partecipato pubblicando le proprie piastre, hanno rispettato questa semplicissima regola... così, noi tutti, proveremo a mantenerlo libero da commenti e domande varie... quindi, ti rinnovo l'invito: per qualsiasi domanda, dubbio, perplessità in merito ad eventuali varianti, non esitare a spostarti su questa discussione... In merito alla tua domanda riguardo la variante "collo lineare"... Se tu avessi aperto questo link che - non a caso - ho riportato alla fine del mio intervento... avresti letto anche il primo commento di @giuseppe ballauri (#276 pag.12) il quale, con una breve descrizione ed una foto che vede più piastre sovrapposte, riporta un esempio abbastanza esplicativo della variante in oggetto... poi, continuando a leggere, post dopo post, pagina dopo pagina, potrai trovare anche altri interessantissimi esempi. Spero che, anche questa semplicissima immagine che ti allego, possa aiutarti a comprendere la differenza tra il taglio normale alla base dell'effige e quello che definiamo "collo lineare" (per le Piastre del 1° tipo e del 2° tipo). Spero di esserti stato utile. Lorenzo1 punto
-
Piastra 1831 (37 mm / 27,35 g) Contorno al D/ e giglio ore 9. Variante al D/ "collo lineare". Ad oggi - unico esemplare conosciuto. Provenienza: CAMBI NOTA: L'identificazione di questa variante su una Piastra 1831, risale al mese di Maggio 2022 e cioè, quando vidi proprio quest'esemplare proposto in un lotto multiplo di un'asta Cambi (CAMBI & CRIPPA NUMISMATICA, Asta 714, Lotto 173). Ad Ottobre 2022, la pubblicai per la prima volta in una discussione qui sul forum - unitamente ad un'altra mia fortuita scoperta, una Piastra 1836 con la stessa variante "collo lineare" e cioè, con questo particolare taglio lineare alla base dell'effige. Fino a quel momento, questa caratteristica, era stata osservata solo su alcune Piastre del millesimo 1834 (scoperta fatta tempo prima da @Raff82).1 punto
-
Penso che il principio "tanto cosa vuoi che succeda"a questo punto sia da tenere in considerazione. O no...1 punto
-
La presentazione delle monete più che tale sembrava una televendita, come siamo caduti in basso...e poi a dire la verità, tranne quella di Mennea non ho trovato nessuna interessante davvero, opinione personale 🙂1 punto
-
1 punto
-
Ciao,infatti anche se le foto non erano ottimali è proprio la differenza che si notava tra le due monete prima e dopo la pulizia che mi hanno fatto escludere si trattasse di un suberato e che molto probabilmente ( visto il salto di patina e perdita di metallo che indico nelle foto prima e dopo la pulizia) si trattava di moneta cristallizzata. Nell'ultima foto postata si vede ancora meglio il nocciolo interno della moneta dove è saltato il metallo che è di color argento. Fosse stata suberata il metallo (rame o bronzo) doveva essere scuro. 🙂 ANTONIO1 punto
-
Mi è’ arrivato il libro di Vincenzo Castelli e ho incominciato a sfogliarlo. Inizia con una parte generale sulle origini e la storia delle monete senesi, indispensabile per poter seguire il successivo catalogo. Si passa poi al Catalogo con 210 tipologie di monete descritte e con le immagini relative, il tutto seguito da una parte molto interessante sulle falsificazioni. Segue oltre alla bibliografia molto completa, una parte sulle valutazioni di mercato, quindi un libro decisamente completo sia per chi vuole capire e conoscere la monetazione senese che per il collezionista per orientarsi nel mercato. Mi ripropongo di ritornarci dopo una lettura del testo, sicuramente è’ un testo importante e che sarà un riferimento per questa monetazione.1 punto
-
Julio Romero de Torres ( 1915 ) Il Poema di Cordoba Cordoba - Museo Julio Romero de Torres1 punto
-
1 punto
-
Per chi ama la numismatica, che in un'asta molto seria un nummo sia denominato "uncertain" è una sfida evidente che ho accolto. I quattro nummi sono questi: Provo a identificarli. Il lotto 733 mi pare che corrisponda a Valentiniano III, RIC 21081 punto
-
Cari tutti, questa sera mi piacerebbe condividere con voi una monetina recentemente acquistata. L’oggetto in questione era parte di un lotto di 7 monete proposte in asta come tutte della zecca genovese ( vi allego la foto proposta nei cataloghi) Ad un analisi delle monete proposte, saltava all’occhio una monetina somigliante alla prima tipologia di esemplari da 8 denari, ma che presentava in esergo al posto della data una serie di tre stelle a sei punte. Questa caratteristica è nota per alcune contraffazioni operate da zecche lombarde, quelle di Bozzolo in particolare sono quelle che presentano identica rappresentazione. Spinto dalla curiosità di capire se le mie idee erano corrette (e dal modico prezzo di partenza) ho deciso così di provarci, aggiudicandomi il lotto alla base. Di seguito le caratteristiche della moneta: Bozzolo Scipione Gonzaga (1613-1670) CNI 215, MIR 96/1, Bellesia 79 moneta piuttosto rara, a livello di passaggi in asta per ora ho trovato solo quello dell asta Christie’s del giugno 2003 (lotto 533) - ex collezione Pesce. Se qualcuno avesse altri riferimenti di questa interessante tipologia sarei grato se me li girasse . Grazie a tutti e buona serata Le foto della moneta1 punto
-
1 punto
-
1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?







.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)