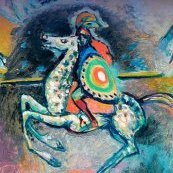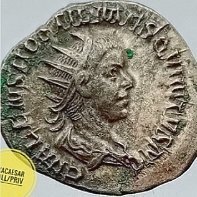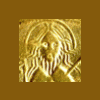Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 09/08/24 in Risposte
-
Buongiorno. Mi permetto di fare due considerazioni, una di carattere generale e una di carattere specifico. In termini generali, credo sia opportuno ricordare che i Ministri sono temporanei per la natura stessa dell'incarico: cambia il Governo, cambia il Ministro. I Funzionari, chi più chi meno, sono presenze costanti negli anni e, pertanto, credo siano loro a determinare la gran parte delle attività e i relativi tempi di esecuzione. Per quanto attiene alla specifica vicenda di Sangiuliano, invece, concordo con l'invito a non fare chiacchiere da bar. Nel post di apertura ho letto che le dimissioni erano un fatto "determinante per noi numismatici" ma, salvo mio errore, non ho poi letto le motivazioni di tale affermazione. Un saluto cordiale e a presto.5 punti
-
Beh, il cappellone non vale certo il lire 5 del 1901. In ogni caso al museo della zecca lo hanno sostituito..idem per il 5 lire del 1914. Se poi andiamo a vedere che al Museo Nazionale Romano hanno fatto di tutto (in tema di sostituzioni) il piatto è servito. Sanzioni dici? Il direttore della zecca dell'epoca finì malamente la sua carriere, parcheggiato in un ufficio dimenticato....4 punti
-
La nota di Nomos è stupida e piuttosto sorprendente… L'etnico è ovviamente HIMERA come troviamo ΣVRA a Siracusa. L'etnico completo nel genitivo è HIMERAION. In seguito la H scompare. La lettera H con la barra orizzontale inclinata è attestata nelle iscrizioni (cfr. Laurent Dubois “Inscriptions grecques dialectales de Sicile" p.296)4 punti
-
Dubito che l’evoluzione della numismatica possa dipendere dalla persona che è ministro della cultura3 punti
-
Vorrei segnalare l'uscita de: La monetazione della Langobardia Major2 punti
-
Sul manganaro in Mikra kermata…, tav.4 n. 51 un esemplare di diverso conio e con diversa disposizione lettere ma a parer mio similare per stile.2 punti
-
2 punti
-
Asta Ghiglione: Numismatica 39 10 Maggio 2007 Numismatica 40 15 Novembre 2007 Numismatica 41 8 Maggio 2008 https://www.ghiglione.it/Download.html#M26 Asta NAC 108/2018 (già citata), ma inserisco il link: https://www.arsclassicacoins.com/catalogues/auction-108/ Asta NAC 43/2007 (già citata), ma inserisco il link: https://www.arsclassicacoins.com/catalogues/auction-43/2 punti
-
Mi viene in mente la Nac 108. Poi Varesi 59. Nac 43???2 punti
-
Passeggiando per le vie del Rastro di Madrid, pensai a questa discussione2 punti
-
E' in nichel, non si patina Secondo me falsa, e poi pulita aggressivamente per distogliere l'attenzione sui dettagli approssimativi2 punti
-
Buongiorno e Buona Domenica a tutti. Dalla mia Collezione . Piastra 120 Grana Ferdinando II millesimo 1858. Riporto un interessante evento Storico e motivo d'orgoglio per noi del Regno Delle Due Sicilie. 1858 primo tunnel ferroviario italiano a Nocera. La galleria dell'Orco è un traforo ferroviario della ferrovia Cancello-Avellino situato nei pressi di Codola, tra i comuni di Nocera Inferiore e Castel San Giorgio. Inaugurato nel 1858, rappresenta il primo tunnel ferroviario realizzato nel Regno delle due Sicilie. Nell'accezione popolare il termine "orco" si riferirebbe ad Annibale, che sarebbe passato di lì per assediare e conquistare Nuceria nel corso della II guerra punica. La galleria fu realizzata quando l'area era ancora sotto la giurisdizione del Regno delle due Sicilie, durante la reggenza di Ferdinando II. Prende il nome dal cosiddetto Passo dell'Orco, situato lungo la "montagna spaccata". Il passo ha origini romane ed è funzionale al raggiungimento della città di Nuceria Alfaterna, attraverso una diramazione della via Popilia. La denominazione del passo è attribuita alla presenza del campanile dell'orco, un mausoleo di epoca romana (I secolo)presente lungo il tratto viario. Il tunnel fu inaugurato il 31 maggio 1858, dopo circa venti mesi di lavori, alla presenza del vescovo di Nocera Angelo Giuseppe D'Auria, del ministro delle Finanze del Regno e di diverse autorità militari presenti a Nocera. Per l'occasione, la galleria fu rischiarata da cinquemila lumini e alcuni carri furono tirati a mano. L'evento fu in seguito immortalato in una serigrafia del Giornale del Regno delle due Sicilie. Il traforo entrò in funzione il 17 febbraio 1861, dopo la caduta del Regno delle due Sicilie. Servì a collegare la strada ferrata che correva tra Capua e Mercato San Severino. Saluti Alberto2 punti
-
Per un euro ho preso questa moneta della Polinesia francese del 1999, insieme ad altri nominali sapevo di averla in collezione, ma c'era qualcosa che non mi convinceva... Fortunatamente non è una doppia, a casa avevo la stessa del 1967 ma senza IEOM sotto il collo della Liberty questa: ps: Istituto Emittente d'OltreMare (acronimo: IEOM)2 punti
-
Chiedi per te o per un tuo amico? Le mie le tengo come animali di supporto emotivo in giardino, sono Pino, Nino, Gina, Rina: e qualcuna sembra stia evolvendosi a tortora leggendaria, qui una foto di Epic-Pino all'alba: In effetti fanno un po' di casino, ma anche gli altri "chirp-chirp" non scherzano. Non saprei, ma prova a dargli così tanto mangime che non possono più volare, poi le prendi con un retino e me le spedisci. nk2 punti
-
Posso dirti che il valore commerciale non è una discriminante. Le monete di alto valore hanno, per il falsario, il problema di essere ben controllate (uno non spende cifre alte senza un minimo di accortezza anche se a volte non basta), mentre per quelle di basso valore sono facilmente smerciabili, ma devono essere facilmente richieste anche se rendono poco (sempre per il falsario). Comunque, il 20 Centesimi 1936, rientra tra le monete di discreto valore perché R2 e, soprattutto , fra le ricercate: quindi, di interesse per i falsari.2 punti
-
Condivido l'appello. Non facciamo come Galileo e Colombo quando litigarono in Time Square, tanto sappiamo già come funzionano le cose.2 punti
-
Il Bland-Allison Act Gli emendamenti del Senato, tuttavia, annacquarono non poco le intenzioni iniziali di Richard Bland, soprattutto ad opera di Wiliam B. Allison, dell'Iowa, tanto che alla fine la legge fu approvata col nome di Bland-Allison Act. E questo nonostante il veto del presidente Rutheford B. Hayes, che continuava a essere contrario. L'Atto stabiliva che il Tesoro avrebbe acquistato una quantità mensile di 2 milioni di dollari (e non 4 milioni, come avrebbe voluto inizialmente Bland) di verghe d'argento, da trasformare in monete da un dollaro secondo il rapporto legale. Tale misura non riuscì però a migliorare sensibilmente la circolazione monetaria, nè impedì il declino dei prezzi dell'argento e dei prodotti agricoli. Ma un effetto positivo, almeno per noi numismatici lo ebbe, eccome, poiché portò alla coniazione di quella che, dopo un'accoglienza iniziale a dir poco tiepida, sarebbe diventata col tempo la moneta americana più richiesta e apprezzata dai collezionisti di tutto il mondo. Il dollaro Morgan, naturalmente Non mi dilungherò certo su di esso, poiché la sua storia è stata ampiamente raccontata nella discussione dedicata, alla quale rimando tutti quelli che non l'avessero ancora letta o volessero rinfrescarne la memoria Storia di Morgan Ma almeno uno vale la pena mostrarlo, soprattutto in favore di coloro che forse già temono che in questa discussione si parlerà solo di economia, politica, e... favole. State tranquilli, parleremo anche di monete... dal prossimo post petronius2 punti
-
Materiale: Bronzo Peso: quasi 1 gr Lato: 12 mm Spessore: 1 mm La moneta è quadrata, ma era cosi anche in origine? Si leggono i numeri 1631 punto
-
Vitellio e' nel RIC I. Tuttavia, nella revisione di Sutherland del 1984, questa moneta non e' stata inserita (Curtis Clay scrive "erroneusly omitted").1 punto
-
1 punto
-
l'unico che può inserire nel primo post sei tu1 punto
-
Oggi un'identificazione proposta da un ospite speciale, Numérobis ve la presenta!1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Non conoscevo questa moneta e quindi sono andato un po' a leggere. In effetti, su questa tipologia TVTELA AVGVSTI per Vitello, le opinioni sono cambiate nel tempo. Inizialmente erano considerate o come falsi o come reincisioni di un rovescio VICTORIA AVGVSTI sempre di Vitellio. Questo potrebbe forse spiegare l'assenza della moneta nel RIC I? La ricerca più recente, alla luce anche della comparsa di nuovi esemplari (tipo quello del post #4) ha rivisto il suo pensiero e ora ammette la presenza di questo rovescio per Vitellio. L'effigie rappresenterebbe Vitellio seduto in atteggiamento protettivo verso due figure che, secondo il pensiero prevalente dovrebbero rappresentare i cittadini dell'impero. Forse proprio in attesa dell'arrivo di Vespasiano che poi, guarda caso, erediterà lo stesso rovescio. Fonti per letture ed approfondimenti: - articolo: THE TUTELA TYPE OF VITELLIUS E. Krupp, F. Krupp The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society, Seventh Series, Vol. 1 (1961), pp. 129-130 (3 pages) Disponibile per la lettura libera on line previa registrazione: https://www.jstor.org/stable/42662311 - pagina del FAC con intervento di Curtis Clay (che ha messo in vendita la moneta di sopra e che considera il pezzo un asse per i suoi riflessi rossastri) e che parla anche diffusamente di questo rovescio in Vespasiano: TVTELA AVGVSTI: a new sestertius type for Vespasian in 71 (forumancientcoins.com) - esempla del Mnzabinett di Berlino (che lo identifica come dupondio): MK-B | Vitellius 69 n. Chr. (smb.museum) Spero di non aver detto inesattezze; il mio "inglisc is very pur"😁 PS: @modulo_largo, da dove viene la tua immagine? Ciao. Stilicho1 punto
-
Salve,potrebbe essere questo bronzo di Caligola? https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/1/22801 punto
-
In merito è forse di qualche interesse la nota al lotto Nomos 33/1022: There is, of course, no H in the Greek spelling of Himera; the N we see here is the end of the genitive plural meaning "of the people of Himera". However, the use of the Doric form (with Α rather than Ο or Ω) confirms the statement by the Greek historian Thucydides that the language spoken in Himera was a mixture of Chalkidian and Doric (6.5.1). https://nomosag.com/nomos-33/10221 punto
-
https://cultura.gov.it/organizzazione Dovrebbero creare una “casella” tutta dedicata al mondo della numismatica e monetazione/medagliatica in generale con poteri di indirizzo e controllo.1 punto
-
No no la lega Calcidica l’ho postata solk per l’attinenza della cetra mi riferivo invece proprio a dei bronzi, coniazioni ibride con tipi di citta’ lucane o magno-greche differenti. Diversi ibridi vennero fuori anni fa e - non vorrei sbagliare - ma Mi sembrava che ne avesse parlato anche Attianese1 punto
-
Bravo euskadi,complimenti per l’ottimo occhio e competenza su questa particolare monetazione,persone come te arricchiscono il forum.1 punto
-
Vero. Ecco l'immagine dal bollettino falsi moneta n. 5243 Questa moneta è stata condannata dall'IBSCC Photo/ con il permesso dell'International Bureau for the Suppression of Counterfeit Coins. Fare riferimento al Bulletin on Counterfeits di cui sopra. Lega d'argento scadente. Da una serie di tipi simili.1 punto
-
1 punto
-
Salve,dovrebbe essere questo grossetto di Vittorio Amedeo I di Savoia, datato sembra 1631 https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-VA1/21 punto
-
Materiale: presumibilmente Bronzo Peso: meno di 1 gr Diametro: 18 mm Spessore: 0,5 mm La moneta è molto sottile, cosi ad occhio azzarderei che l'epoca è compresa tra il 1600 ed il 1800 ma aspetto la vostra sapienza...1 punto
-
Materiale: Bronzo Peso: quasi 4 gr Diametro: 20 mm Spessore: 1 mm sapete aiutarmi a identificarla con precisione? a ore 3 del volto si legge una S1 punto
-
Sì, e' una GLORIA EXERCITVS (con la X e non con la S😉) con uno stendardo. Il simbolo che si vede nello stendardo potrebbe essere un Chi/Rho. Ciao. Stilicho1 punto
-
Petronius, sei un narratore eccezionale, aspetto la prossima puntata con trepidazione. Che patina fantastica quel dollaretto lì!1 punto
-
DE GREGE EPICURI Credo sia un: VICTORIAE DD NN AVG ET CAES. Nello scudo retto dalle Vittorie c'è un VOTA (es. VOT V MULT X). L'imperatore? Mah, forse Magnenzio.1 punto
-
Ciao, se il peso ed il diametro sono corretti tenderei ad escludere si tratti di un asse. Più probabile sia un sesterzio un pò sottopeso coniato gia su tondello piccolo e con usura da circolazione con la personificazione dell'Annona sul rovescio. Posto foto di un esemplare della stessa tipologia 🙂. ANTONIO1 punto
-
Esatto. Che sia sigillata Bazzoni tanto di cappello vista la grandissima esperienza del compianto coomerciante/studioso in materia di monete del Regno, testimoniata anche da eminenti studiosi/e. Però...c'è un però...che certi personaggi che ruotavano intorno alla zecca nel secolo scorso hanno avuto la bella pensata di riconiare queste famose monete....ecco perchè è di fondamentale importanza esaminare alcuni dettagli (principalmente nel bordo) e anche avere una documentazione che certifichi la "nascita" di questa moneta nel 1901...e infine..dimenticatevi che i pezzi siano 114..sono di più.1 punto
-
Buongiorno a tutti, Riprendo questa bella discussione dell'Amico Alberto @Litra68 per condividere l'ultimo Tarì aggiunto in Collezione: ET . HIE .. REX Un vero doppio punto!!1 punto
-
Il discorso si è concentrato sulle coniazioni coeve e sui riconi, sembra che dal bordo si possa riconoscere il tipo di moneta, che in entrambi i casi sono originali perché creati con coni originali. Saluti Marfir1 punto
-
Si hai ragione. Sul catalogo c'è un evidente errore sui dati ponderali del denaro (che pesa sui 0.7-0.8 e con legenda intera ha un diametro intorno ai 17 mm. Cmq la moneta postata in questa discussione è un denaro senza alcun dubbio.1 punto
-
Confermo la tua identificazione. Aggiungo catalogazione e zecca. Coniato nel 1245 zecca di Brindisi Spahr n 135 D'Andrea n. 171. Moneta comune. Difficile trovarla con leggenda totalmente leggibile.1 punto
-
Buon Giorno, dal Suo intervento traspaiono interesse e passione, il progetto che vorrebbe “mettere in cantiere” è decisamente molto ambizioso, se mi permette di darLe un suggerimento La inviterei, prima di immergersi nel lavoro di studio e catalogazione delle monete rischiando di perdere di vista il quadro generale, di dedicare qualche tempo, se ancora non l’ha fatto, alla pianificazione di quello che vorrebbe realizzare e a inquadrare complessivamente l’argomento. Le opere da Lei citate alle quali fare riferimento sono fondamentali. Tutte hanno delle criticità che sarebbe necessario superare. Quello che rende estremamente complesso il Suo progetto potremmo ridurlo alla necessità di mettere in discussione alcune delle conclusioni degli autori delle opere di riferimento introducendo nuovi argomenti per superarne i limiti. Diversamente si tratterebbe di riscrivere con parole diverse gli stessi concetti. Solo un altro appunto in merito al Fiorino dell’asta NAC 89 di cui ha pubblicato l’immagine, non si tratta di un MIR 5-7 ma probabilmente di un Fiorino della serie IX (tra gli ultimi a partire da 9-38) o di uno dei primi della serie X (ci sono diversi semestri dei quali è sconosciuto il segno nel periodo). Parere personale. Se cerca tra le discussioni si era parlato di questo segno trattando il segno “trottola”, ma da una analisi stilistica l’accostamento non torna. Cordialità PS con allarmante frequenza le classificazioni proposte dalle case d’asta sono imprecise, in particolar modo quelle delle case d’asta straniere. Se non si definiscono in modo “indiscutibile” almeno le classificazioni, non si fanno passi avanti. La inviterei a considerare il Fiorino nella prossima asta Kunker 412, lotto 1176, indicato come MIR 12-18 in effetti si tratta di un Fiorino della XXIII serie MIR 23-02 Mi scuso per l’intervento, il tono del quale potrebbe suonare “saccente”, cerco di approfondire l’argomento da parecchi anni, studio un periodo limitato con sporadiche puntate negli anni successivi, ci sono periodi e classificazioni che ancora non posso dire di aver compreso in modo adeguato, il tutto per inquadrare la vastità e la complessità degli argomenti. Buon lavoro1 punto
-
Opportuno segnalare anche il Gigante: https://catalogogigante.it/monete-italiane/regno-ditalia/vittorio-emanuele-ii-di-savoia-1861-1878/10-centesimi-valore-entro-semicorona-di-alloro-1-tipo-30-mm-9.75-10.00-g-ae/moneta?mpe=2&aal=2-801-38-0&tip=38-133-1-1509-15&cnu=1209 “La natura di questi 10 Centesimi "Esperimento" di bronzo, la relativa zecca di produzione e il numero di pezzi prodotti, sono oggetto di opinioni contrastanti; in mancanza della necessaria documentazione, atta a dirimere la questione, ci siamo limitati ad approfondire ed elaborare quanto contenuto nella letteratura di riferimento. Il primo riferimento che abbiamo di questa emissione è Marchisio [1904b, p. 214], il quale la cataloga come "Prova" coniata a Napoli. Il CNI [I, p. 477, n. 31] conferma la classificazione del Marchisio. Cagiati [1918, p. 56], che non cita le zecche ma cataloga le monete per tipologia, la considera un esperimento di una nuova valuta per le popolazioni meridionali, aggiungendo che "[...] parecchi esemplari da me visti dimostrano tutti di essere stati molto in circolazione […]" Pagani [1957, p. 20, p. 110] si allinea alle catalogazioni del Marchisio e del CNI. Guerrini [1957, p. 73], sposa la tesi dell'esperimento di nuova valuta che ha circolato, avanzata dal Cagiati, aprendo tuttavia all'ipotesi che la zecca di produzione possa essere diversa da quella napoletana. Simonetti [1968, pp. 4-11], in un primo momento, ipotizza la coniazione di quest'emissione nella zecca di Torino; tuttavia, in seguito [Simonetti III, p. 24, n. 23/1, pp. 35-36], l'attribuisce, con riserva, alla zecca di Napoli, aggiungendo che la considera un esperimento di circolazione in quanto "[...] soddisfa uno dei requisiti che deve avere una moneta per essere considerata tale [l'avvenuta circolazione], ma manca il requisito principale, il regolare decreto di emissione". Pannutti e Riccio [1984, p. 322] la catalogano tra le monete napoletane, specificando che "Inseriamo nell'opera questa moneta in quanto secondo autorevoli studiosi, si tratterebbe di una vera moneta (e non di un saggio), destinata alla circolazione sperimentale nelle nuove province meridionali dell'Italia unita. Resta incerta l'effettiva coniazione nella zecca di Napoli." Infine, Castellana [2000-2004, pp. 9-10], accennando ad una prova da 10 centesimi, riferisce che "[...] forse successiva ad un'emissione con la scritta esperimento (in 20.000 esemplari) sotto l'effigie del Re rivolta verso destra e con il collo lungo […], forse coniata dalla Soc. Estivant e C. di Parigi, su commessa della Zecca di Napoli. Scopo dell'emissione dovette essere il sondaggio dell'opinione pubblica, restia a sostituire il sistema valutario borbonico con quello italiano. L'emissione rimase allo stato sperimentale dopo la normalizzazione della circolazione nazionale in quelle regioni del sud [...]" Tuttavia, per la precisione, dobbiamo ricordare che la società Estivant ottenne, a seguito del RD 288/1861, l'appalto diretto della zecca di Napoli, che mantenne fino a quando, dopo il 10 gennaio 1863, la medesima società consegnò l'ultimo quantitativo di monete che si era impegnata a produrre [Mastroianni Bovi 1989, p. 433]; dopodiché, anche per la zecca di Napoli valse la Convenzione del 21 dicembre 1861, tramite la quale la Banca Nazionale assunse l'esercizio temporaneo di tutte le zecche, che tenne fino al 31 dicembre 1873 [Carboneri 1915b, pp. 287-288]. La letteratura di riferimento ci offre due diverse opzioni per quanto concerne la natura di questa moneta: "Prova di zecca" o "Esperimento di circolazione". Inoltre, ci indica la zecca di Napoli quale luogo di produzione, anche se con qualche riserva da parte di alcuni; infine, ci viene segnalato un quantitativo di 20.000 pezzi. Tutto, purtroppo, senza la citazione di alcuna fonte. Pertanto, nella catalogazione di questi 10 centesimi "Esperimento", possiamo solo avanzare delle ipotesi, tenendo conto sia della letteratura consultata sia delle particolari vicende che in quell'epoca interessarono la circolazione monetaria nelle province meridionali del regno. Il 10 centesimi di bronzo di cui discutiamo, è stato, senza dubbio, coniato in una delle zecche del regno d'Italia e, come tutti possiamo notare, presenta, nell'esergo del dritto lungo il bordo, la scritta esperimento. Sia il tipo del dritto (effigie sovrana con il collo lungo) sia quello del rovescio (due rami di alloro), sono tipici delle monete immediatamente precedenti quelle del regno d'Italia. Si tratta, comunque, di un'emissione che presenta, oltre all'indicazione del neonato regno e della data di coniazione, le caratteristiche, sia metrologiche sia di valore nominale, delle monete da 10 centesimi vere e proprie, in quel momento non ancora istituite. Incominciamo la nostra analisi dalla scritta esperimento, presente nel dritto di questi 10 centesimi, che, anche – e soprattutto – in mancanza di un apposito decreto di emissione, esclude la natura di monete vere e proprie di quest'emissione. Nella monetazione italiana la scritta esperimento appare solo in prove realizzate, nel 1860, dalle zecche di Bologna (quattro tipi di prove per la sperimentazione di nuovi materiali) [Pagani 1957, p. 10, nn. 42-52] e Milano (due tipi di prove per la sperimentazione di nuove leghe metalliche) [ibid., pp. 11-12, nn. 57-58, 61-62]. Successivamente, nel 1926, la zecca di Roma utilizzò la scritta esper. tecnico per ristampare su monete d'argento da 2 lire e 1 lira, ritirate dalla circolazione, i tipi delle monete di nichelio da 1 lira [ibid., p. 46, n. 268] e 50 centesimi [ibid., p. 48, n. 282]. Risulta evidente di come la scritta esperimento sia sempre stata utilizzata, anche se in pochi casi, solo per sperimentazioni di natura tecnica e che, tale scritta, non rientra nella consuetudine storica delle zecche di Bologna e di Milano. A tale proposito, dobbiamo considerare che le caratteristiche tecniche della monetazione di bronzo del regno d'Italia sono esattamente quelle ereditate dal precedente regno di Sardegna e, più in generale, dal sistema decimale. Pertanto, per l'emissione da 10 centesimi di cui discutiamo, dobbiamo giocoforza escludere l'ipotesi della sperimentazione di natura tecnica; anche perché nel 1861 circolavano già, in tutto il regno d'Italia, le nuove monete di bronzo da 5 centesimi, 2 centesimi e 1 centesimo. Infine, è utile fare presente che per lo studio delle monete del regno, sono sempre state utilizzate le scritte saggio e prova. Pertanto, in base a quanto esposto, non riusciamo a trovare alcun elemento per escludere, nella produzione dei 10 centesimi 1862 "Esperimento", la zecca di Napoli a beneficio di altra zecca. Tuttavia, non limitiamoci alle sole considerazioni di natura tecnica, ma indaghiamo anche su quelle più strettamente legate all'effettiva necessità di utilizzo di questi 10 centesimi sperimentali. In merito, Cagiati [1918, p. 56] ci informa che "[...] parecchi esemplari da me visti dimostrano tutti di essere stati molto in circolazione, cosa che non accade di solito ai saggi [...]" e Guerrini [1957, p. 71] scrive che "Non v'è dubbio che la moneta abbia circolato a Napoli [...]" Quante prove di monete sono state osservate in parecchi esemplari che sono stati a lungo in circolazione? Forse, potrebbe essere questo il solo caso. Allora, cosa sottintende la scritta esperimento presente in quest'emissione? Lasciamo, momentaneamente, in sospeso la questione legata alla natura di questi 10 centesimi e prendiamo in considerazione le indicazioni che ci portano alla sua presunta utilità. Guerrini [1957, p. 68] ci segnala che, sia presso l'Archivio di Stato di Napoli sia nel catalogo Fiorelli [1866], che elenca i conî che, alla chiusura della zecca di Napoli, furono trasferiti al Museo Nazionale, non ha trovato alcuna notizia in merito a quest'emissione ed ai suoi eventuali conî. Dopodiché, lo stesso Guerrini [1957, p. 72], facendo notare che il conio del dritto di questo 10 centesimi "[...] è quello che appare nelle monete della zecca di Bologna, coniate per il Governo Provvisorio per le Regie Provincie dell'Emilia […]", ne ipotizza la coniazione nella zecca di Bologna. Tuttavia, in nessun altro Archivio di Stato italiano è stata rinvenuta alcuna notizia in merito ai 10 centesimi in oggetto, così come non appaiono i relativi conî, e/o punzoni, in alcun elenco del materiale creatore utilizzato nelle varie zecche del regno. Inoltre, il conio dell'effigie reale di questi 10 centesimi non lo troviamo in tutte le monete coniate a Bologna, ma solo in quelle da 2 lire, così come lo ritroviamo anche nelle monete da 2 lire coniate a Firenze per il Governo della Toscana e in quelle coniate, sia a Genova sia a Torino, per il regno di Sardegna. Infatti, la moneta da 2 lire, con i suoi 27 millimetri di diametro, è quella che più si avvicina al 10 centesimi, che ha un diametro di 30 millimetri. Quanto abbiamo rilevato non ci aiuta, purtroppo, a risalire alla zecca di produzione di questi 10 centesimi sperimentali di bronzo e non è neppure emerso il motivo della loro coniazione. Nel 1861 già circolavano in tutto il regno le monete di bronzo da 5 centesimi, 2 centesimi e 1 centesimo; tutte coniate anche nella zecca di Napoli. Tuttavia, la moneta da 10 centesimi non era ancora stata istituita e neppure era in previsione di esserlo. Infatti, Lanfranco [1929a, pp. 286-287] ci informa che "Nel novembre del 1959, la Commissione Monetaria era incerta sull'eventualità di prendere in considerazione l'utilizzo di monete da 10 centesimi di bronzo, perché troppo pesanti, ingombranti e di scarsa utilità negli scambi." Anche Guerrini [1957, p. 71] scrive, a proposito dell'istituzione delle monete da 10 centesimi, che "[...] era ostile il Parlamento." Da uno studio di Bovi [Mastroianni Bovi 1989, pp. 428-429] risulta che "Il 27 febbraio 1861 a Napoli fu fatto un contratto in 39 articoli fra il marchese D. Michele Avitabile capo dell'Amministrazione delle monete e il signor G. B. Colombier rappresentante della ditta Estivant. Col detto contratto questa ditta si impegnava di coniare a Napoli monete di bronzo da 1, 2 e 5 centesimi coi pesi e i diametri stabiliti dalla legge del 20 novembre 1859. Il governo si riserva di coniare una moneta da quattro centesimi, del peso di grammi quattro e del diametro di millimetri 23, che doveva servire al cambio col grano; una da dieci centesimi o altre di altri valori. […] Intanto si rendeva sempre più necessaria una moneta di bronzo di valore maggiore di quella di 5 centesimi come dimostra una lettera, indirizzata dal Segretario generale al luogotenente del re nelle provincie meridionali (7 giugno 1861), la quale dice che la ditta Estivant fornirà 12 milioni di lire in monete da 5, 2 e 1 centesimo; ricorda che le piccole monete borboniche inferiori ad un grano restavano inutili nelle casse del Banco, perché non adatte ai comuni pagamenti e conclude che le dette monete di bronzo non sono adatte al cambio della moneta. Infatti la maggior parte delle monete borboniche è fatta dai 10 tornesi che sono di valore molto differenziato dalla moneta da 5 centesimi; sarebbe utile la produzione di monete da 10 centesimi. Interpellato in proposito il ministro dell'Agricoltura Industria e Commercio, risponde il ministro dicendo che, oltre che per altre ragioni esposte altrove, la coniazione dei centesimi 10 non è possibile in quanto la legge del 20 novembre 1859 e il decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 non prevedono la battitura di questa moneta." Da quanto riportato, risulta evidente che nelle province meridionali, in merito alla circolazione monetaria, vi era una precisa e diversa esigenza rispetto agli altri territori del regno. Ciò nonostante, il governo, benché precedentemente si fosse riservato di farlo, negò la possibilità di coniare le monete da 10 centesimi e tale diniego valeva comunque per tutte le zecche del regno; tuttavia, tale disposizione valeva certamente per le monete ordinarie e non per le ventuali coniazioni sperimentali. In ogni caso il grave problema della circolazione monetaria spicciola nelle provincie meridionali rimase irrisolto e questi 10 centesimi "Esperimento" furono comunque coniati e fatti circolare. Nel meridione il problema monetario era tanto grave che Guerrini [1957, p. 69] ebbe a scrivere che "La nuova moneta di bronzo introdotta dal nuovo governo era costantemente rifiutata dai venditori al minuto, sicché tutti quelli che erano pagati con quella (come operai e soldati) non potevano spenderla e quindi erano costretti a barattarla con quella [borbonica] in rame, che sola circolava senza difficoltà, con una perdita di circa il quattro per cento." Inoltre, sempre Guerrini [ibid., p. 71], riporta che il quotidiano Nazionale del 10 gennaio 1862 scrisse che "Sappiamo che nelle amministrazioni secondarie della posta il garbuglio [determinato dalla minuta circolazione di moneta] è stato tanto che s'è dovuto tornare al computo in moneta napolitana [...]". Il fatto che tale questione economica fosse circoscritta ai soli territori dell'ex regno borbonico, rende improbabile la coniazione di questo esperimento in zecche diverse da quella di Napoli. Infatti, la non più rinviabile necessità di una moneta da 10 centesimi era un'esigenza prettamente meridionale e la Estivant, essendo una società privata, aveva la possibilità di muoversi con maggiore autonomia rispetto alle zecche controllate direttamente dall'amministrazione pubblica, come nel caso - ad esempio - della zecca di Bologna, e il motivo per cui il materiale creatore di questi 10 centesimi non compare nel catalogo Fiorelli, così come nell'Archivio di Stato di Napoli non è stata trovata alcuna documentazione in merito, potrebbe essere legato al fatto che il materiale in oggetto fu realizzato in autonomia dalla zecca di Napoli, rimanendo poi nelle disponibilità della società che la gestiva, che, per questo motivo, non impiegò nella coniazione di questi 10 centesimi il contrassegno di zecca. Risulta quindi verosimile che la società Estivant, a seguito dei gravi problemi descritti, abbia proceduto alla realizzazione di un esperimento di circolazione, dalle appropriate caratteristiche tecniche ma con i tipi diversi da quelli decretati per le monete dei tagli inferiori, che fosse facilmente distinguibile rispetto all'eventuale nuova moneta da 10 centesimi non ancora istituita. Così si giustifica, nella realizzazione di questo esperimento, l'utilizzo dei tipi, collo lungo nel dritto e due rami di alloro nel rovescio, propri delle precedenti monete sabaude dichiarate fuori corso. In tal modo il prodotto finale risultò pienamente funzionale allo scopo, senza peraltro essere assimilabile ad un falso. Infine, la scritta esperimento, collocata nel dritto di questi 10 centesimi, era esplicativa della loro funzione sperimentale. Ricordiamo che di questi 10 centesimi abbiamo notizia, in merito alla loro certa circolazione, per mezzo dell'osservazione di "parecchi esemplari" che "dimostrano tutti di essere stati molto in circolazione" [Cagiati 1918, p. 56], tanto che "non v'è dubbio che la moneta abbia circolato a Napoli" [Guerrini 1957, p. 71], solo da studiosi napoletani, il che rafforza gli indizi che indicano Napoli quale unico palcoscenico di questa sperimentazione. Poco importa se qualche mese dopo l'emissione di questi 10 centesimi "Esperimento", in forza della L 737/1862, furono istituite le monete da 10 centesimi; infatti, come abbiamo visto, la loro istituzione, benché assolutamente necessaria nelle province meridionali, non era affatto né prevista né certa, in quanto sia le autorità monetarie sia il Parlamento non erano favorevoli alla loro coniazione. Noi non conosciamo le motivazioni che spinsero prima il Marchisio [v. supra] e poi il CNI [v. supra] ad attribuire la coniazione di questi esperimenti alla zecca di Napoli; certamente, per farlo, avranno avuto le loro ragioni. Lo stesso discorso vale per l'indicazione del numero di 20.000 pezzi coniati fornitaci da Castellana [v. supra]; un'informazione tanto precisa sarà stata determinata da riscontri certi. Pertanto, riprendendo il discorso rimasto in sospeso in merito alla natura di quanto in oggetto, questa emissione in bronzo da 10 centesimi costituirebbe un esperimento per una nuova valuta, coniata, presumibilmente nella zecca di Napoli nel 1862, a seguito delle particolari esigenze economiche coeve, relative alla circolazione monetaria spicciola nelle province meridionali, causate dall'adozione del sistema decimale, privo, in quel momento, di monete di bronzo superiori ai 5 centesimi. Essa, sarebbe stata immessa in circolazione limitata - forse 20.000 pezzi, poi quasi tutti ritirati - per effettuare un sondaggio circa la sua effettiva utilità. Questa iniziativa, potrebbe avere contribuito a spianare la strada alla successiva istituzione della moneta di bronzo a corso legale da 10 centesimi, che, fino a quel momento, era stata osteggiata sia dalla Commissione Monetaria sia dal Parlamento. Non vi è alcun dubbio che, in ogni caso, questi 10 centesimi "Esperimento", costituiscono un documento storico-economico di indiscutibile importanza.”1 punto
-
Sono da sottolineare più aspetti positivi di questo Convegno, intanto che e’ una prima, che e’ in Abruzzo che e’ una regione dove mancavano da tempo questi eventi e poi bello che oltre gli ambiti commerciale ci sia una parte culturale con conferenze !1 punto
-
Buongiorno, 41 esemplari sono conservati presso il museo civico di Vieste (Fg) nella collezione Petrone. Dagli anni '80 di fatto gli archeologi concordano sull'ubicazione dell'Uria garganica presso Vieste, in quanto unico sito che ha restituito testimonianze archeologiche compatibili con una urbanizzazione sviluppata tra il IV e il III sec.a.C. oltre alla scoperta di iscrizioni con dediche a Venere Sosandra presso una grotta sull'isola di Sant'Eufemia, prospiciente la città e sede del Faro, riscontro del carme 36 di Catullo, ove il poeta testimonia il culto della dea presso Uria garganica.1 punto
-
Buongiorno a tutti, Non so a voi ma a me il fatto di averle riunite dopo più di 170 anni è una cosa che mi piace assai1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?