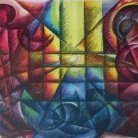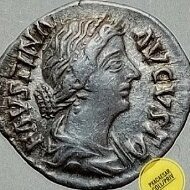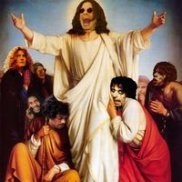Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 11/18/24 in Risposte
-
Nummi attribuiti erratamente ad Avito suddivisi per "tipologia"4 punti
-
Ciao, è una moneta comunissima. Se fosse stata la prova riporterebbe tale dicitura al rovescio lungo il bordo, come quella che ti allego3 punti
-
Mi scuso se mi allontano forse troppo dall’argomento, ma sollecitato dalle immagini di Cerere postate nei preziosi contributi alla discussione, sono andato a ricercare se mai la dea fosse, come dire?, sopravvissuta alla caduta dell’impero romano... Mi ha colpito in particolare una moderna epifania della dea, dove essa appare ancora del pieno delle sue funzioni. Essa protegge infatti la floridezza di un nuovo “impero” (quello statunitense), coronando l’edificio del Chicago Board of Trade Building , nel quale in origine si svolgevano gli scambi del grano. La statua, in stile Déco, è del 1928, opera dello scultore John H. Storrs. Un caro saluto e a presto, Lvcivs LX3 punti
-
Il riferimento al 1870 non è da riferirsi alla breccia di Porta Pia, quanto piuttosto al plebiscito che si svolse domenica 2 ottobre 1870 per sancire l'annessione al Regno d'Italia del territorio di Roma e del Lazio dopo la presa di Roma. L'annessione fu formalizzata con regio decreto 9 ottobre 1870, n. 5903, che all'art. 1 stabiliva «Roma e le provincie romane fanno parte del Regno d'Italia». Successivamente, l’art. 1 della Legge 3/2/1871, n. 33, recante “Pel trasferimento della Capitale del Regno da Firenze a Roma”, ed entrata in vigore il 19/2/1871, recitava “La città di Roma è la Capitale del Regno.”. Con questa Legge, quindi, fu deciso il trasferimento della sede del governo da Firenze - dal 1865 era la Capitale d'Italia, succeduta a Torino - alla Città Eterna. Il trasferimento ufficiale si realizzò il 1° luglio successivo. Il giorno dopo, 2 Luglio 1871, il re Vittorio Emanuele II fece ufficialmente il suo ingresso solenne nell'Urbe per insediarsi al Quirinale. Sempre il 3 febbraio 1871 fu approvato il relativo regolamento per il trasferimento del governo a Roma e nominata la commissione governativa con il compito di attuare, coordinare e sovrintendere a tutte le operazioni per l'insediamento degli organi di governo nella nuova Capitale. Da subito furono scelte le sedi delle massime istituzioni: il Palazzo del Quirinale, già residenza estiva del Papa, fu destinato a Palazzo reale; a Palazzo Madama, già sede del Ministero delle Finanze pontificio, fu insediato il Senato; a Palazzo Montecitorio, già sede dei tribunali, fu insediata la Camera dei Deputati, convertendo in aula il cortile centrale.3 punti
-
@AldoFerraro prima di tutto la moneta che stai cercando di vendere è comunissima e priva di valore. Secondo, se avessi letto il regolamento (come consigliato nella procedura di iscrizione) avresti appreso che non è consentita la vendita se non nelle apposite sezioni. Per questo motivo chiudiamo qui la discussione, e ti invitiamo a leggere e rispettare il regolamento se vuoi continuare ad essere parte di questa comunità. Grazie per la collaborazione3 punti
-
3 punti
-
Era da tempo che aspettavo l'occasione per prendere una frazione achemenide, ma ultimamente anche il prezzo di questa tipologia ha subito un rialzo. La moneta in questione mi è sembrata ancora pienamente godibile e il prezzo pagato è stato davvero irrisorio. Questa la descrizione del venditore. Non ho ancora avuto modo di controllare i riferimenti citati. ACHAEMENID EMPIRE. Time of Darios II to Artaxerxes III (circa 420-350 BC). Tetartemorion. Sardes. 6mm // 0,21g Obv: Persian king kneeling-running r., holding dagger and bow, quiver over shoulder. Rev: Incuse punch. SNG Kayhan 1041 (1/4 Siglos); Klein 764 (same); Rosen 679 (same).3 punti
-
Buonasera a tutti, è da tanto che non scrivo in piazzetta, lo spunto mi viene da un grazioso quadretto di monete napoletane in rame che ho composto così per gioco con le mie monete ed una placchetta di Ferdinando II di Borbone. È Straordinario scoprire quante cose vengono fuori solo partendo da una moneta o gruppo di monete e dalla loro osservazione e dai quesiti che uno può porsi. Ecco pensavo al Rame di Napoli e cosa trovo? Che c'è un dolce Siciliano che ha delle origini che si intreccerebbero con le monete. Riporto quanto trovato sul web. Fonte Wikipedia. Le Rame di Napoli sono dei dolci tipici di Catania consumati normalmente durante le festività dei defunti; in provincia di Caltanissetta sono chiamate marmurate. Si tratta di biscotti dal cuore morbido al gusto di cacao, ricoperti per intero da una glassa di cioccolato fondente. Non si conosce con esattezza l'origine del nome tuttavia esistono varie ipotesi: la prima cita un pasticciere di Napoli come inventore di questa ricetta; un'altra ipotesi parla di un atto di vassallaggio della Sicilia nei confronti di Napoli durante l'epoca del Regno delle due Sicilie. L'ultima ipotesi, risalente sempre al Regno delle due Sicilie, sembra anche la più verosimile. Si afferma, infatti, che durante il regno borbonico, successivamente all'unificazione del Regno di Napoli con il Regno di Sicilia, fu coniata una moneta contenente una lega di rame, in modo da sostituire la più ricca lega di oro e argento. Il popolo, con l'introduzione di tale moneta, pensò bene di creare un dolce che riproducesse tale moneta, inventando così la Rama di Napoli. La ricetta originale conteneva farina, zucchero, cacao amaro e marmellata di arance ma negli anni vennero apportate diverse modifiche, sia nella dimensione che negli ingredienti utilizzati, introducendo l'uso di Nutella, crema di pistacchio, marmellate e altre composte di frutta o vegetali (zucca o brassica). Ad Acireale, dove prendono il nome di "nucatuli", ne esiste una tipica versione alla zuccata, una confettura realizzata con la zucca e condita con scorze di agrumi. Tradizionalmente preparato durante le festività di Ognissanti viene regalato ai bimbi, come dono dai parenti defunti per essere stati buoni durante l'anno. Saluti Alberto2 punti
-
È autentica...direi di sì È a nome di Anastasio. Si È barbarica . Si Per qualcuno è dei Gepidi. Per altri Ostrogota coniata a Sirmium. Le trovi spesso citate come Sirmium Group. Demo ne parla da sempre... Ultimamente anche Asolati Saluti No... Questa è coniata in italia2 punti
-
Stamattina c'era un velo di sole e ho provato a scattare diverse fotografie del rovescio. Tra una decina di tentativi ho selezionato quello che ritengo essere il risultato più soddisfacente. Lascio a voi giudicare, in particolare @Stilicho ed @ilnumismatico che è esperto dell'arte fotografica.2 punti
-
Ciao @Atexano. Avendo un pò di tempo a disposizione e cercando nel mio archivio ho trovato un denario che ha gli stessi "conii" di dritto e rovescio del tuo ed è censito come falso ottenuto per fusione ( vedi foto). Cosa aggiungere a beneficio tuo e di quanti hanno seguito questa discussione. A mio parere i tanti dubbi sull'autenticità della tua moneta diventano certezza ed ovviamente di questo mi dispiace. Resta a tutti noi di positivo l'aver reso ancora più noto un falso che sicuramente si presenterà con altri esemplari sul mercato che dal mio punto di vista è cosa non da poco. Quindi sono io che ringrazio te per aver condiviso la moneta. Ritornando nel dettaglio si nota che i due esemplari hanno praticamente lo stesso grado di quella che può sembrare usura da circolazione, stessi difetti su lettere e perlinatura e quello che più risalta di anomalo praticamente la stessa forma del tondello che nella Numismatica classica , per monete coniate a martello, è sempre sinonimo di dubbia autenticità ( vedi foto comparate). Tre indizi sono più di una prova. Mi sento anche di escludere, per il suo aspetto generale, che il tuo denario possa aver fatto da matrice per gli altri falsi. ANTONIO2 punti
-
Questa cartolina del 1899 FANCIULLEZZA ABBANDONATA - Festa di Beneficenza per l'Ospedale dei Bambini - Milano , tiratura 100 esemplari numerati2 punti
-
Buongiorno, proseguo con il postare alcune cartoline di commissione privata, oggi è la volta della cartolina del 1899 Mostra di Bambole- Primo Congresso per L'Igiene dell'Allattamento, Milano Tiratura 250 esemplari nimerati , valore facciale 10 cent. la seconda è la versione piuttosto rara di Saggio senza effige del valore , questa tirata in 100 esemplari2 punti
-
Debellatio è un termine della lingua latinache designa la fine di una guerra causata dalla completa distruzione di uno stato ostile. l’uso del termine - applicato al caso in questione - non e’ quindi corretto in quanto non vi fu nessuna distruzione dello Stato pontificio ma l’occupazione di una parte del suo territorio. Le perdite furono contenutissime - non vi fu alcun eccidio, distruzione o annientamento. Il papa stesso ordino’ di cedere alle forze avverse per evitare inutili sacrifici di vite umane. Il capo dello Stato Pontificio non solo non fu perseguito bensi addirittura protetto e messo in sicurezza grazie alle Guarentigie. L’esercito ( delle guardie svizzere a protezione del Pontefice) pote’ essere mantenuto, le strutture amministrative anche e non vi fu alcuna transizione di potere. Vi fu invece in seguito un’evoluzione dei rapporti che regolarono i due stati formalizzati alfine con i Patti Lateranensi. La similitudine con la dissoluzione del Regno delle due Sicilie non e’ corretta in quanto nessuna forma di governo o di stato sopravvisse a questa mentre lo stato pontificio, territorio a parte, conservo’ intatto le sue prerogative di stato sovrano mutando solo in parte la forma. tale capacità di adattamento ha tra l’altro permesso al piccolo stato di avere una storia ben piu’ lunga di qualsiasi altro stato, Giappone forse a parte. Questa e’ la storia de facto ( et de iure) di quanto successo dopo il 1870. Puo’ piacere o meno ma e’ quanto successo. ringrazio DB;8 per il bel denario di Lepido😊2 punti
-
il Magliocca, nel suo manuale, nella pagina dove è descritta la moneta, a piè della stessa, in una nota specifica che ci sono esemplari con lo stemma di questa forma, curvilineo anzichè dritto.2 punti
-
Discussione "frizzantina", con tendenza alla rissa. Per riportare un po' di pace tornerei alla monete che ha ispirato la discussione, la famosa 1000 lire CONCORDIA del 1970. Forse proprio per esorcizzare i forti contrasti che ci furono tra lo Stato Italiano e la Chiesa dopo la presa di Porta Pia e la caduta del Papa Re, la moneta coniata nel 1970 riprende l'immagine della Concordia da un denario di L. Aemilius Lepidus Paullus (62 a.C.). Mostro le 2 monete qui sotto, augurando Pace e Concordia a tutti!2 punti
-
Buonasera a tutti. Come promesso ho fatto una verifica sul concetto della c.d. "debellatio" e trascrivo qui di seguito quanto riportato nella relativa voce sull'Enciclopedia Treccani: "Debellazione. In diritto internazionale (per lo più nella forma latina, debellatio), annientamento dell'organizzazione di uno stato, quale si produce per effetto dell'occupazione del suo territorio da parte di un altro stato in seguito a una guerra. La debellazione costituisce uno dei modi con i quali si estingue la personalità internazionale di uno stato. Ad esempio: il Regno delle Due Sicilie nel 1861; lo Stato Pontificio nel 1870, eccetera." (cfr. Lessico Universale Italiano, Treccani, volume VI, pag. 77) Come potrete leggere, lo Stato Pontificio è addirittura menzionato quale esempio dell'istituto in esame. Ne parlano anche diversi storici ma penso che la Treccani possa mettere tutti d'accordo. Un saluto cordiale e a presto.2 punti
-
Finito di leggere il Gazzettino 11, un punto importante della Milano Numismatica appena conclusa, e posso dire di essere rimasto veramente stupito dalla qualità degli articoli scritti e dalla mole di informazioni che ho potuto acquisire. Alcuni articoli potrebbero essere sviluppati e diventare vere e proprie monografie dedicate a specifiche zecche. Questo dimostra quanta passione ognuno di noi metta nelle monete del proprio territorio, facendo sviluppare degli articoli meritevoli tutti di estrema attenzione, che dovrebbero essere utilizzati come punto di riferimento anche dagli studiosi e dai compilatori di eventuali cataloghi specializzati, se non dalle stesse case d’asta. Complimenti a tutti per l’impegno.2 punti
-
https://www.ebay.it/itm/176369154695?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=-kZAknnlRKe&sssrc=4429486&ssuid=INDC0ziVQiq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Un po' cara. Qui la si può trovare a soli 25.000€2 punti
-
Nuovo arrivo nella collezione Savoia- Acaja : Amedeo D'Acaja Forte II Tipo (o Patacco) Zecca di Pinerolo - Mir Savoia 311 punto
-
Se lei ( mi rivolgo naturalmente a Vigano’) avesse avuto l’accortezza ( o la velocità) di leggere il testo da lei stesso citato, avrebbe trovato le stesse spiegazioni che mi sono affannato a dare sopra. non mi fa purtroppo copiare il testo ma le riassumo di seguito i punti che potra’ verificare nel testo originale riportato sopra dal sempre premuroso Oppiano. dice Filippazzi: che si distinguono tre fasi di ‘sovranità territoriale del Papa. Identificandole dalla fondazione della Guardia Palstina ad oggi - senza menzionare ALCUNA cesura nel processo. il potere temporale dei papi era finito gia’ tre colte prima del 1870 ( repubblica Romana ad esempio) senza pero’ alcuna conseguenza de facto per la sovranità papale che sarebbe continuata fino sl 1870 e successivamente - trasformandosi - evolvendo in quella che oggi e’ riconosciuta come Santa Sede, cui fa da contenitore il neonato Stato della Cotta’ del Vaticano (SCV come riportato anche sulle targhe delle poche automobili del colle Vaticano). il sommo pontefici continua a godere anche subito dopo il 1870 dei palazzo apostolici, e degli altri edifici ecclesiastici posti da subito ancora sotto la sua piena e totale giurisdizione. scrive ancora Filippazzi che negli anni in cui lo stato pontificio ( o meglio la Santa Sede) era stato privato della sovranità territoriale , continuo’ ad esercitare pienamente le prerogative proprie della sovranità: con lo ius legationis inviando i suoi rappresentanti in tutto il mondo ( rimando a qualche mio post piu’ su dove sostenevo la medesima cosa). con il Trattato Lateranense del 1929 arrivera’ infine anche la sovranità territoriale vera e propria riconosciuta in pieno dallo Stato Italiano. Il Vaticano - saggiamente rinunciava ad eccessive pretese territoriali- reiterando in questo modi il distacco dal potere temporale ma ribadendo il suo status di entità statale ( nel senso di Stato) pienamente indipendente e sovrano che non era mai venuto meno ne’ prima della breccia di Porta Pia con le cattività francesi, Gaeta etc , ne’ tantomeno dopo in una continuità sostanziale di presidio terreno della missione affidata da Cristo al successore di Pietro - conclude Filippazzi. le fonti sono utili da citare - ancora di piu’ se le leggiamo e le comprendiamo. 😉1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
dipende, ma se ti iscrivi alla newsletter di ipzs di solito lo scrivono, quelle del 20/11 alle ore 111 punto
-
In questo caso l'hai pagata il giusto, qFDC o FDC viaggia ad altri prezzi..1 punto
-
Per chi volesse: https://www.iusecclesiae.it/article/download/2073/565/497#:~:text=1 del Regio Decreto del,“debellatio” dello Stato Pontificio.1 punto
-
L' opuscolo di un piccolo, piuttosto interessante museo locale, forse un poco ai margini dei percorsi turistici1 punto
-
@lorluke La cattedrale e' un vero capolavoro del mastro incisore che ha reso proprio in modo incredibile il senso di tridimensionalità di un monumento già di per sé complesso, come ho potuto notare visitandolo. Poi.....il dritto! In generale, devo dire che anche sulle monete romane, pur colpito dalla varietà e dalla bellezza dei rovesci, ammiro sempre di più i dritti proprio per la potenza espressiva di alcune effigi. Beh, e' chiaro che qui siamo in medaglistica, e' un pò diverso. Quanto alla foto....bravo direi! Poi hai avuto il beneplacito del nostro @ilnumismatico! Io ho un Huawei P 30 lite con cui non riesco proprio a fare le foto in macro. Magari c'e' un modo, ma io non riesco. Scatto le mie foto "monetarie" con una vecchia digitale compatta Sony. Ciao e ancora complimenti. Stilicho1 punto
-
Salve Direi che potrebbe trattarsi di un 2 soldi di Genova https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-GE31/411 punto
-
Si tratta di una moneta che, oltre l'usura - peraltro non eccessiva - ha subito tante "picchiettature" e colpetti che ne hanno vieppiù abbassato la conservazione sotto l'MB. Per confronto posto un esemplare in buona conservazione:1 punto
-
Diciamo che fa il suo dovere, ma per una foto macro vedo che ha dei limiti che, con tutta la buona volontà che ci puoi mettere, faranno sempre un po di “collo di bottiglia”. Però ripeto, è un discorso prettamente tecnico - fotografico, numismaticamente parlando la tua foto è comunque chiara per il compito che deve svolgere1 punto
-
1 punto
-
Bella medaglia e buona foto. Non so il modello di smartphone che usi, ma nel caso volessi migliorare la qualità devi prestare più attenzione alle bruciature di luce, che compromettono in misura minore la nitidezza. Son comunque sottigliezze secondarie1 punto
-
Devo dire che anch'io inizialmente preferivo nettamente il dritto al rovescio. Però, più la guardo e più la rappresentazione della Stephansdom mi affascina per la minuziosa cura degli elementi architettonici, fin nei più minimi particolari. Ho trovato in vendita su eBay un'incisione della prima metà del XIX secolo e la somiglianza è davvero impressionante! Addirittura, mi sembra che in certi dettagli la medaglia superi l'incisione.1 punto
-
Buongiorno e complimenti ! Bello anche il rovescio, ma il diritto è un'emozione !1 punto
-
1 punto
-
bellissimo errore di conio ti consiglio di farla periziare, è una battitura con interposizione di altro tondello, Rara, siamo circa 120€ in FDc come la tua1 punto
-
Jamaica, 1 dollaro 1992, dedicato a Sir Alexander Bustamante, politico e leader laburista; nel 1962, all'indipendenza, divenne primo ministro .1 punto
-
la monetazione imitativa che ha avuto grande diffusione è sempre difficile da attribuire. in parte, nel IV secolo in africa, fu forse anche incoraggiata dalle autorità locali... si trattava prevalentemente di copie fuse. nel V secolo, in italia, diciamo tra 435 e 490, datazione corretta per questi esemplari, è impossibile dire da chi fossero prodotte.... gli scopi erano quasi certamente locali.1 punto
-
Da Cesarea nella Cappadocia,un attraente esemplare di didrammo al nome di Domiziano, con al diritto testa laureata dell' imperatore ed al rovescio figura della Vittoria andante con ramo di palma e corona . Sarà a giorni, il 30 Novembre, in vendita Cayon 422 al n. 5431 .1 punto
-
Ciao @Atexano ben tornato 🙂. Presumo che il denario sia già in tuo possesso percui esprimo il mio parere da appassionato ( che colleziono, studio e quindi acquisto monete percui l'autenticità delle stesse sta alla base di tutto) nella speranza che poi arrivino gli interventi degli esperti. Il denario, nel suo aspetto generale, mi fa una bruttissima impressione. Le buone foto che hai postato ( comprese quelle del bordo) mi fanno propendere per la non autenticità. Attendo come te ulteriori interventi, [EDITATO DA CDC] a beneficio di tutti noi che ribadisco siamo appassionati, desiderosi di apprendere e di crescere dal punto di vista della Numismatica. E come farlo se non intervenendo e confrontandosi? 🙂 ANTONIO1 punto
-
Cartolina illustrata dagli Stati Uniti affrancata con l' ordinario 1c verde serie americani famosi Thomas Jefferson, emesso nel 1968 + due 6c marrone nero dell' ordinaria serie americani famosi del 1966. Considerando che l' 1c verde è stato emesso nel 1968 direi che siamo intorno a quegli anni li. Interessante la label Air Mail Sheraton Hotels, e' possibile che la cartolina sia stata fornita dall'hotel stesso come free gift in stanza o acquistata in hotel e spedita dallo stesso, in quegli anni molti hotel di lusso avevano il servizio posta solitamente in portineria, molti avevano anche il loro annullo. Ooh yeah buddy..🌃 bella la New York di quegli anni.1 punto
-
Qui https://www.cronacanumismatica.com/veronafil-139-scalda-i-motori-in-vista-del-21-23-novembre/ si informa che tre le autorità emittenti presenti, ci saranno anche: Commercializzazione filatelica e numismatica del Vaticano; Sovrano militare Ordine di Malta con le sue monete e i suoi francobolli.1 punto
-
Beh, la Santa Sede non mi risulta essere uno stato temporale, bensì la sede episcopale di Roma (come leggo su Wikipedia), lo Stato del Vaticano nasce nel 1929 (come leggo su wikipedia), lo Stato Pontificio finisce nel 1870 (come leggo su wikipedia), non conosco monete tra il 1870 ed il 1929, medaglie quanto se ne vogliono, non rilevano, la legge sulle guarentigie non riguarda i rapporti tra Regno e Stato Pontificio; la stessa è una legge unilaterale, non un trattato internazionale tra 2 soggetti del diritto internazionale posti sullo stesso piano; i Papi stessi si autoproclamavano "prigionieri"1 punto
-
Buongiorno filatelici cari Allora, io qui, pur avendo il catalogo Filograno, mica sono riuscito a catalogarla? Non ho trovato nè questa, nè la prossima che posteró. C' è sempre uno o piú dettagli che non combaciano mai interamente ad una catalogazione ben precisa. A meno che non sbaglio a guardare o non so interpretar bene dei dettagli. Chi mi sa dire di piú? Grazie Cito anche @PostOffice1 punto
-
Buongiorno, posto cartolinaedita dalla Repubblica Sociale Italiana in ricordo dell' eroe Goffredo Mameli, che dire, racchiude tutto, splendida grafica storica e il ricordo di quello che fu... salutiF.P.1 punto
-
Ciao Mario grazie della gentile risposta la moneta è proprio quella, quindi si tratta di un falso, molto interessante l'articolo, comunque sia questo tondello si porta dietro un bel pezzo di storia senza niente invidiare alle monete originali Saluti Latino1 punto
-
Ancora una cartolina estera, questa volta siamo in Francia. Allego immagini fronte retro. Trovo molto bello il francobollo1 punto
-
Cito: (dal Portale di Archeologia Medioevale dell'Università degli Studi di Siena) Quindi, se per prima coppellazione si intende un processo che interessava solo il I stadio del processo sopra descritto, oppure la prima fase del II stadio ("Il metallo prodotto era un associazione di vari elementi") ci troveremmo con tondelli di argento a bassa purezza e con proprietà meccaniche scadenti (se ho interpretato bene). Proverò a chiedere chiarimenti direttamente alla professoressa Calabria ;)1 punto
-
Se non erro tutti i denari con sigla S.C. furono coniati proprio da Silla in poi. Con Silla i poteri si concentrarono su uno stesso individuo; questo fu senza dubbio un punto di non ritorno e, come dice il Catalli, la monetazione risentì subito di questa nuova situazione. Con Silla si assistette alla produzione di monete al di fuori di Roma sotto il controllo dei sui subordinati, dopo Silla vi furono abbondanti emissioni di denari firmati da magistrati diversi dai monetales. La straordinarietà di queste coniazioni è testimoniata appunto dalla sigla S.C.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?