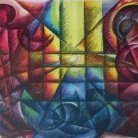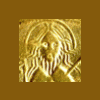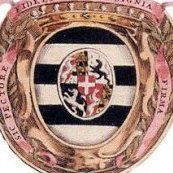Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 12/01/24 in Risposte
-
buona sera volevo condividere il mio ingresso nel club presentando questo esemplare che mi sono procurato di recente. è il tipo più comune, millesimo 1622, al dritto presenta una ribattitura, mentre il rovescio è regolare. non ne ho potuto misurare il diametro, che a detta del venditore è di 32,5 mm mentre il peso è di 14,21 grammi. tondello che mi ha sempre affascinato anche per la vaga aria da moneta romana, ha rappresentato per oltre un secolo e mezzo, fino alla produzione degli 8 tornesi del 1796, la moneta di rame con il più alto valore coniata a Napoli.4 punti
-
Buongiorno, @Litra68, @gennydbmoney, @Releonoto con piacere che le nostre piastre con il doppiopunto sono state aggiunte al nuovo catalogo Nomisma. Complimenti e grazie ancora a Pietro Magliocca per il lavoro svolto. Un saluto a tutti. Raffaele.4 punti
-
Buongiorno a tutti, Noto con piacere che questa variante è stata aggiunta sul nuovo Nomisma con grado di rarità R4. Con l'occasione ringrazio e mi complimento con Pietro Magliocca per il lavoro svolto. Un saluto Raffaele.4 punti
-
Buongiorno e buona domenica di inizio dicembre ! Da qualche tempo sto portando avanti uno studio relativo alle mezze piastre di papa Innocenzo XI, che analogamente ai testoni della serie "MELIVS...", affidò al nominale superiore il motto "AVARVS NON IMPLEBITVR", traducibile nell'ammonimento contro l'avarizia "L'avaro non sarà saziato (dal denaro)". Mentre per i testoni ci furono anche altre emissioni "fuori serie", le mezze piastre sono tutte di questa tipologia, con coniazioni riportanti l'anno VII di pontificato (1682-1683), a meno di un tipo senza data. Il Muntoni ne classifica dieci tipi dal n°44 al n°53, e negli anni ho elaborato una "tabella di rarità", come segue: Muntoni 44 R Muntoni 45 R Muntoni 46 R4 (???) Muntoni 47 R2 Muntoni 48 C Muntoni 49 R Muntoni 50 R Muntoni 51 R Muntoni 52 R2 Muntoni 53 R Per la Muntoni 46 ho inserito i "???" perchè non ne ho mai viste, e il fatto che sia l'unica mancante al Serafini mi lascia il dubbio che possa anche essere una "errata interpretazione" dei compilatori del CNI (sarebbe la CNI 50, ma anche le foto delle tavole non corrispondono alla descrizione), poi ripresa dal Muntoni. Dopotutto si tratterebbe dell'accoppiamento di due conii di altre tipologie (D. M.51 / R. M.47), come da questo "fotomontaggio": Se qualcuno ne ha notizia, eventuali segnalazioni sono graditissime ! 😉 A queste dieci, c'è da aggiungere una undicesima mezza piastra che Muntoni e CNI non considerano, ma che era presente sul Serafini al n°62 (rarità R3), che differisce dalla Muntoni 45 per il bordo perlinato della cartella del rovescio: L'immagine di destra è il rovescio dell'esemplare passato in asta Ranieri 19, lo scorso 13/11. Allego una tabella riassuntiva con classificazioni e immagini, ogni contributo o integrazione è ben gradito. Ciao, RCAMIL. Tabella mezze piastre Innocenzo XI.pdf3 punti
-
Ha sempre dato la stessa impressione anche a me, questo è il rovescio di un bronzo dell' imperatore Clodio Albino,la corona di alloro è praticamente uguale...3 punti
-
Allego stesso francobollo con annulo d'epoca, come ben visibile l'annullo ha impresso molto bene il fronte del francobollo, passando anche al retro dello stesso. poi se si ha la fortuna di trovarli su grande frammento, come quello che posto, la cosa è più facile, purtroppo per chi fa storia postale è come un omicidio..3 punti
-
buon giorno amici volevo condividere con voi le monete che ultimamente sono entrate nella mia collezione.3 punti
-
@fapetri2001 Premetto che quello che scrivo non è il Vangelo in merito, ma una fallibile opinione che mi sono fatto nel tempo. Questo un' altro esempio simile al tuo. Questi alti valori per l' epoca oltre che fiscalmente vennero sicuramente usati anche per posta ma in quantità molto limitate, vennero invece usati per l' uso dei telegrammi. Soprattutto quando gli annulli sono così ben centrati credo che quasi sempre non siano di uso postale. Qui un esempio di One shilling con il timbro postale di Glasgow datato 17 agosto 1871, uno scellino era una grossa somma di denaro nel 1871 e questi francobolli venivano usati per telegrammi fino a 20 parole. Quando i francobolli non erano usati postalmente veniva apposto sugli stessi l' annullo con datario a cerchio, quando invece venivano usati per posta l' annullo circolare non era quasi mai sul francobollo dove invece troviamo gli annulli numerali con forme diverse. Esempio: Altri esempi di uso postale. Come sai in filatelia ci sono sempre delle eccezioni, ma diciamo che seguendo una statistica ci permette di stabilire alcune conclusioni partendo dall' esame di alcuni esempi/campioni.3 punti
-
Buona Sera, Intervengo, per opportunità, dopo la chiusura dell’asta nella quale è stata offerta una delle monete oggetto di questo intervento. L’asta in questione è la Bolaffi numero 46 chiusa oggi, con riferimento a questo lotto e ad acuni Fiorini, unitamente a quello in questione ne presentava altri, oltre a due imitazioni anonime, quasi tutti in conservazione modesta. In aggiunta a quello esaminato, un altro dei Fiorini, per altro non classificato correttamente, meriterebbe un approfondimento. Da notare come il realizzo più alto tra i Fiorini della Repubblica d Firenze riguardi una imitazione, per altro sottopeso. C’è anche chi colleziona imitazioni. Evito di divagare. Per stabilire un punto di partenza, allego una coppia di immagini, nell’ordine i due esemplari, il primo dall’asta Ranieri 14 del 19-11-2019 lotto 326, l’altro dall’asta Bolaffi indicata lotto 585. Presentano il primo il segno “croce stilizzata” (Bernocchi 137/8) MIR 4-8, il secondo il segno “giglio piccolo” (?) (Bernocchi 254/6) MIR 4-52. Asta Ranieri Asta num. 14 Asta Bolaffi Asta num. 46 Non avendo ancora potuto analizzare un MIR 4-52 (al di sopra di ogni sospetto) e non conoscendo nel dettaglio l’aspetto del segno, non potendo ricavare ulteriori informazioni dalla sua classificazione (a un certo punto la classificazione della IV serie segue l’ordine alfabetico del nome del segno) che non risulta indicativa di un periodo specifico; non sono in grado di stabilire che aspetto dovrebbe/potrebbe avere questo specifico Fiorino. Tutti i riferimenti che ho potuto trovare sono per me irraggiungibili. Al contrario mi è invece noto come si dovrebbe presentare un MIR 4-8. Allego l’immagine di un Fiorino MIR 4-8 dall’ asta CNG Triton XX del 2017 lotto 1246 (a mio parere sicuramente buono) con tutte le caratteristiche stilistiche dei Fiorini più antichi della IV serie. Faccio notare in particolare le campiture delle ali del giglio. Asta CNG Triton XX Dimenticavo, le prime due monete sono al netto del segno di zecca figlie degli stessi coni di diritto e di rovescio. La cosa è quanto meno inusuale e certamente inattesa. Alcune considerazioni: premetto che il mio atteggiamento di fronte a situazioni simili è sempre particolarmente prudente (leggi negativo), ho criteri di valutazione e riferimenti precisi, scostamenti troppo marcati da quella che valuto personalmente come normalità impongono una precisa analisi; non ho visto le monete ma solo le immagini. Bisognerà capire e spiegare i motivi delle difformità rispetto al modello di MIR 5-8. Si potrebbero considerare come varianti o come artefatti a seconda delle prove a supporto. Nel caso fossi in errore verrebbe rivalutata la possibilità che alcuni coni possano essere stati “reimmatricolati”; oppure potrebbe trattarsi di un caso simile a quello del Fiorino MIR 3-7 esitato nell’asta NAC 44 del 2007 e successivamente nella recente Lugdunum 23 del 2023 dove un possibile danneggiamento (?) del conio aveva alterato il segno di zecca rendendolo di difficile lettura. Se ne era parlato qualche tempo fa in una discussione. In questo caso mi risulta difficile comprendere, anche chiamando in causa doppie battiture o altri possibili incidenti, come possa essersi alterato in questo modo il segno. Ma come insegna l’esperienza, le cose evolvono verso la complessità. Non sono gli unici Fiorini, tra quelli esitati nelle aste degli ultimi anni, appartenenti al primo periodo della IV serie, che “non mi piacciono”, presentano a volte particolari spiazzanti o conservazioni improbabili, è stato un periodo di evoluzione dello stile e di continui cambiamenti. Sono sempre pronto a ricredermi nel caso si riesca a comprendere l’arcano, non si finisce mai di scoprire cose nuove se si è curiosi, invito chi volesse a esprimere le sue considerazioni. Come puro esercizio della fantasia provo a prospettare alcuni possibili scenari, in ordine sparso, senza privilegiarne alcuno, anche se probabilmente alcune ipotesi sono più fragili di altre. Le monete sono entrambe buone, le discrepanze dipendono dalla evoluzione stilistica, il segno giglio piccolo è dovuto alla alterazione accidentale di un conio e in effetti non esiste (se questo fosse effettivamente il segno indicato dal Bernocchi come giglio piccolo, in considerazione della poca precisione nel delinearlo, potremmo avere la spiegazione). Ribadisco di non aver visto direttamente nessuno degli esemplari censiti segnalati in letteratura, l’ipotesi potrebbe essere fuori dalla realtà. È la tesi che preferisco, non che valga più delle altre, le monete con il segno “giglio piccolo” sarebbero da considerare un “artefatto”, contemporaneo al Fiorino originale prodotto in conseguenza a un danno del conio. Le monete continuano ad essere buone, persiste l’evoluzione stilistica, i due segni esistono e sono distinti, come conseguenza sono di periodi contigui (ci sarebbe una logica nella successione temporale), trova conferma l’ipotesi di Fiorini “reimmatricolati”. Questa ipotesi mi piace poco, la sua conferma cambierebbe alcune mie convinzioni, ma quello che conta è la realtà (il fatto che l’ipotesi mi piaccia poco e che ho convinzioni da adeguare è solo un mio problema). Le monete sono in qualche modo imitazioni, anche se sembrano fatte troppo bene, al netto di alcuni particolari e di alcune proporzioni. Le possibili varianti del caso, declinate per le imitazioni si possono ricavare dalle precedenti ipotesi. Le monete ci sono contemporanee, esistono CNC a cinque/sei assi che consentono di realizzare coni con risoluzione e finiture superficiali di pochi micron (realizzano ingranaggi per orologi e minuterie simili), copiando un modello, magari riadattato. Avrebbe poco senso cambiare solo il segno anche se l’incisione ex novo di tutto il conio richiederebbe parecchie ore di lavoro macchina. Coniare “male” le monete le rende più credibili. Forse il gioco, al di là di un esercizio di verifica delle potenzialità del sistema, non varrebbe la candela. Ricordiamo che l’oro con titolo molto elevato non pone problemi riguardo alle patine. Risparmio a tutti teorie aliene, cospirazioni e altre amenità, l’ultima di quelle proposte si colloca già ai limiti del ragionevole. Una ulteriore possibilità, potrebbe ridursi al fatto che la moneta di Bolaffi nulla avrebbe a che fare con il segno indicato, essendo il segno “giglio piccolo” altro e differente da quello in questione. Si sarebbe, fino a questo punto, ragionato attorno e di un abbaglio, mi consola sperare non sia, in ogni caso, solo tempo perso. Le possibili spiegazioni sarebbero più semplici, le ipotesi si ridurrebbero e si semplificherebbero, non riterrei comunque questo esercizio inutile se potesse servire a fare chiarezza. Spero di non aver tralasciato altre ipotesi plausibili e non avere eccessivamente tediato. Sono e restano pareri e valutazioni personali. Il fatto che un Fiorino, in immagine, non piaccia a me è irrilevante. Potrebbe dipendere solo da come è stato fotografato, non tutti i fotografi sono artisti. Cordialità2 punti
-
E' una riproduzione moderna. Veniva regalata dalla MisterDay Parmalat : https://www.forumancientcoins.com/monetaromana/falsi/ParmalatMisterDay/MisterDay.html E' la n. 11 della serie2 punti
-
2 punti
-
2 punti
-
Era la cassetta postale dell' albergo solitamente era in portineria, la posta poi veniva portata all' ufficio postale per l'invio e a volte gli alberghi avevano il proprio annullo. Esempi:2 punti
-
Anche questa discussione sarebbe utile averla in primo piano così che sia facilmente accessibile a tutti2 punti
-
Dovremmo averla in primo piano questa discussione per alimentarla con facilità.2 punti
-
Trovata all’interno di un albergo nel centro storico di vicenza2 punti
-
Senza polemica ma credo che prima di scrivere certe affermazioni occorra fermarsi un attimo, studiare (come Luca ben fa) e magari valutare anche CHI scrive e cosa (in questo caso un utente molto preparato sul periodo in questione). Scrivo questo perchè alcune osservazioni come quelle citate potrebbero suscitare in chi si prodiga nel condividere i suoi acquisti sentimenti di scoraggiamento, specie quando sono accompagnati da note informative che richiedono studio, impegno e tempo. Luca si distingue ripetutamente per approfondimento e studio, e per questo motivo dovrebbe godere della nostra fiducia. Ripeto: non significa essere dei creduloni, ma vista la sua preparazione, prima di mettere in dubbio un suo scritto, che almeno che ci si dedichi a capire meglio cosa è stato scritto in merito. E' quanto ho fatto io, ed ho potuto constatare che quanto da lui scritto viene confermato sia dagli scritti del Crippa (noto per i suoi approfonditi studi sulle monete di Milano) e nelle note dell'asta Nomisma 40 redatte da Nicolò Pirera, appassionato cultore e collezionista dell'epoca Napoleonica; infatti, al lotto 934 dove viene esitato un analogo esemplare (vedi foto in allegato) viene scritto quanto segue: "Moneta che appare sia nell'opera di A. Pagani sulle prove ed i progetti al n. 493 sia nell'altra sulla monetazione ordinaria dello stesso autore e censita al n. 75b. Crippa lo elenca al n. 50 tra i progetti (con rarità R4). Si differenzia dalla monetazione usuale del soldo per una definizione del conio molto più curata, il metallo solitamente lucido e di colore scuro, mentre l'impronta di Napoleone è maggiormente definita, oltre che per il bordo perfettamente circolare, liscio, e di maggior spessore. Siamo propensi a considerarla una moneta, giacchè se ne conoscono due esemplari che hanno circolato, anche se di tipo transitorio. Da li a poco infatti fu introdotto il nuovo tipo da un soldo (1811) con il bordo leggermente rialzato e liscio e la testa di Napoleone più piccola con la capigliatura a ciocche grandi. Di questo tipo, ad oggi, sono comparsi in asta pubblica, due soli esemplari negli ultimi 30 anni". Grazie Luca per aver condiviso un esemplare importante della monetazione Napoleonica2 punti
-
E ti pareva! mi è scappata l'intera immagine dell'astronave! Dopo l'invio del post sono andato su un'altra home e non ho controllato! ne dovevo mettere solo una porzione per l'identificazione! Era già pronta2 punti
-
Di Saint Vincent e Granadine, paese caraibico indipendente dal 1979 dove come valuta si usa il dollaro dei Caraibi orientali, fa parte anche l'arcipelago delle Grenadine. Negli anni '70 queste isole, pur essendo parte unitaria dello Stato e non dipendenze, hanno ricevuto autonomia postale e francobolli specifici (poco utilizzati ma validi) diversi da quelli ordinari di Saint Vincent, con indicazione di provenienza Grandine di Saint Vincent. I primi erano esemplari di Saint Vincent sovrastampati con l'aggiunta di "Grenadines of" sopra il nome dello Stato: Poi arrivarono le emissioni specifiche con la scritta per intero: Stessa idea ebbero i vicini di Grenada, indipendente dal 1974 e utilizzante il dollaro dei Caraibi orientali, che adottarono emissioni specifiche per le isole Grenadine nel loro territorio con la denominazione Grenadines of Grenada, o più spesso Grenada Grenadines. Inizialmente anche loro sovrastamparono francobolli ordinari di Grenada: E poi stamparono quelli specifici:2 punti
-
 Solo falsi moderni per ingannare i numismatici. Al 90% lo studio riguarda le monete con il castello.2 punti
Solo falsi moderni per ingannare i numismatici. Al 90% lo studio riguarda le monete con il castello.2 punti -
Aggiungo l'immagine presa dal catalogo dell'asta Varesi 79 del 10 maggio 2022.2 punti
-
Ringrazio per gli apprezzamenti Apro un piccolissimo off-topic, scusandomi con @Alan Sinclair. Concordo con @torpedo sul fatto che, per il mercato internazionale, lo slab sia una realtà assolutamente consolidata. Se sia o meno un obbligo non saprei dirlo, ma i realizzi importanti che fanno le monete chiuse in queste scatoline sono sotto gli occhi di tutti. Per una serie di motivi, personalmente ho scelto di non far chiudere le mie monete in slab quando, recentemente, le ho esitate . Visto che ogni tanto spunta fuori questo argomento, che ne direste se apro una discussione ad hoc in questa sezione e la metto in evidenza? Se siete d'accordo potete votare questo mio intervento con le faccine sorridenti o piangenti (in questo modo i punteggi non verranno sommati al profilo utente). Se ci saranno ALMENO 15 reazioni su questo post procederò ad aprire il thread. Grazie Chiudo l'off topic sullo slab (nel caso ne parliamo nell'apposito topic) EDIT: Qui c'è un'interessantissima discussione sugli slab relativa alle monete preunitarie. L'ho messa in evidenza visto che l'argomento è sempre attuale2 punti
-
Salve. Pubblico un quadro riassuntivo delle monete con la presenza in legenda del doppio punto in orizzontale o in verticale. Sono monete che "di regola" prevedono il punto singolo e che riportano il doppio punto solo in pochissimi esemplari ( o in un unico esemplare) fra tutti quelli a noi pervenuti. Questi esemplari vengono catalogati come rari o molto rari e di qualcuno non c'è ancora catalogazione. La maggior parte di essi fanno riferimento all'anno 1798 o all'arco di tempo che va dal 1790 al 1798. Ci sarebbe da chiedersi, a tal proposito, per quale motivo accada ciò. Naturalmente, ognuno trarrà le sue personali conclusioni dopo la valutazione del materiale pubblicato e delle didascalie che accompagnano ogni singola moneta, anche se, a questo punto, mi sembra quanto meno azzardato continuare a parlare di casualità, depositi di metallo o malfunzionamento del conio relativamente alla presenza del doppio punto in verticale o in orizzontale. Sono punti che sono stati apposti. Questo mi sembra certo. La finalità è tutta da scoprire... Mi scuso per il troppo spazio occupato e spero che il computer non mi scompagini le righe al momento dell'invio. Un caro saluto a tutti. -tarì 20 grana 1798 / foto 1: Dritto con doppio punto in verticale dopo "FERDINAN"; foto 1a: Rovescio. -tarì 20 grana 1798 / foto 2: Dritto con doppio punto in verticale dopo "FERDINAN"; foto 2a: Rovescio. N.B: i tarì al n.1 ed al n.2 hanno stesso conio. -tarì 20 grana 1796 / foto 3: Dritto con doppio punto in verticale dopo "HIE"; foto 3a: Rovescio. -tarì 20 grana 1798 / foto 4: Dritto con doppio punto in orizzontale dopo "HIE"; foto 4a: Rovescio. -tarì 20 grana 1790 / foto 5: Dritto con doppio punto in verticale dopo la "P" che è sotto il busto; foto 5a: Rovescio. -tarì 20 grana 1798 / foto 6: Dritto con doppio punto in verticale dopo "SICILIAR"; foto 6a: Rovescio. -piastra 120 grana 1795 / foto 7: Dritto con doppio punto in verticale dopo "SICILIAR"; foto 7a: Rovescio. -due piastre 120 grana 1798 a confronto / foto 8: al Dritto riportano "D.G:" con la "G" seguita da doppio punto in verticale. Una piastra è mia, l'altra è pubblicata su "Manuale delle monete napoletane 1674/1860", Magliocca, pag.202 n.363; foto 8a: Rovescio delle due piastre. N.B: le due piastre hanno diverso conio. -piastra 120 grana 1790 / foto 9: Dritto con doppio punto in verticale dopo "G" del valore ( da internet). -piastra 120 grana 1798 / foto 10: Dritto con doppio punto in verticale dopo "G" del valore. -mezza piastra 60 grana 1798 / foto 11: Dritto con doppio punto in verticale dopo "FERDINAN"; foto 11a: Rovescio. -grani(due) 1790 a confronto / foto 12: Rovescio con doppio punto in verticale dopo "12". Un grano è mio, l'altro l'ho ricavato da internet. N.B: le due monete hanno conio diverso. -grano 1791 / foto 13: Rovescio con doppio punto in verticale dopo "12". -piastra 1815+tarì 20 grana 1693(dritto e rovescio) / foto 14: la piastra con, al dritto, doppio rombo dopo "D" di "D.G."; tarì 1693 con, al rovescio, doppio punto in verticale dopo "HISP". -5 grana 1851 / foto 15: Dritto con doppio punto in verticale dopo "VTR" e dopo "SIC"+ doppio punto in orizzontale dopo "HIER"; foto 15a: Rovescio. -piastre 120 grana 1833 e 1856 (dritto e rovescio) / foto 16: la 1833 con, al rovescio, doppio punto in orizzontale dopo "G" del valore, la 1856 con al rovescio doppio punto in or. dopo VTR". - piastre 120 grana 1848 e 1856 (dr. e rovescio) / foto 17: la 1848 con, al rovescio, doppio punto in orizzontale dopo "HIER", la 1856 con, al rovescio, doppio punto dopo "HIER".1 punto
-
Carissimi amici, tra pochi giorni è il 2 dicembre, data molto significativa per i bonapartisti perché il 2 dicembre 1804 Napoleone si incoronò imperatore dei francesi a Notre-Dame de Paris ed il 2 dicembre 1805 vi fu la vittoriosa battaglia di Austerlitz. Per celebrare queste due ricorrenze, ho il piacere di mostrarvi una bella rarità napoleonica. Ad essere sincero, non posso affermare che si tratti di un acquisto recente. Difatti, l'acquistai da un privato poco più di un anno fa ma, per una serie di ragioni, non l'avevo ancora pubblicata qui sul forum. Anche se so che le prove non hanno molti estimatori, mi auguro, comunque, che sia di vostro gradimento. L'esemplare in questione proviene dalla prestigiosa collezione Este Milani, esitata nell'asta Varesi 54 del 2009. Tornò poi in asta sempre da Varesi nel maggio del 2022 ma andò invenduta. Come ho avuto modo di scrivere già in un'altra discussione, queste prove vennero realizzate a fine 1810 allo scopo di preparare il passaggio dalla coniazione fuori virola a quella entro virola per i nominali in rame (soldo, 3 centesimi e centesimo). Per questo si parla di "tipo intermedio", perché rappresenta in un certo senso l'anello di congiunzione tra I e II tipo. Il soldo viene classificato come R4 ed è il più comune tra i tre nominali. Segue per rarità il 3 centesimi, un R5 di cui sono noti pochissimi esemplari al mondo, ed infine il centesimo, di cui purtroppo non sono noti passaggi d'asta né esemplari conservati in collezioni private o raccolte museali e, per questa ragione, se ne dubita l'esistenza. Come potete notare, queste prove sono caratterizzate da un bordo alto e liscio, mentre l'effige di Napoleone è realizzata con particolare cura ed attenzione al dettaglio. Si guardi, ad esempio, ai capelli, elemento critico della monetazione napoleonica in Italia per la loro intrinseca delicatezza. Qui, invece, si può apprezzare una capigliatura ben delineata e definita.1 punto
-
Un’approfondita ricerca bibliografica e documentaria per comprendere la vera natura dei misteriosi “ingegni” operativi nella zecca partenopea di Carmelo R. Crupi | Pietro Magliocca, nei suoi interessanti lavori sulla monetazione napoletana pubblicati nel 2018 e 2020, afferma che icinque “ingegni” arrivati in quel di Napoli “da Alemania” nel 1619, atti a coniare moneta, invece che essere bilancieri, come tante volte fu scritto da altri autori del passato, in realtà erano macchine a coni rotanti, azionate mediante forza idraulica. In sostanza, secondo Magliocca tali cinque ingegni altro non erano che coni rotanti dello stesso tipo di quelli che, a quel tempo, erano già in azione da circa 50 anni nella zecca di Hall, in Tirolo, e da circa 40 anni nella zecca di Segovia, azionati, appunto, mediante forza idraulica. Non sono tuttavia persuaso di tale conclusione. I miei dubbi nascono dalla lettura comparata della bibliografiarecente e meno recente su questo argomento, da quella reperita in relazione alla descrizione di macchinari a coni rotanti effettivamente in funzione in altre zecche, nonché dall’analisi dell’aspetto esteriore delle monete napoletane che Pietro Magliocca ritiene siano state prodotte coi coni rotanti. Macchinario con coni rotanti ricostruito nella zecca di Hall, in Tirolo Analizziamo la bibliografia recente e meno recente intervenuta sui famosi “cinque ingegni”. Carlo Prota ne L’officina monetaria di Torre dell’Annunziata e la moneta di Napoli del 1622 da documenti del R. Archivio di Napoli, pubblicato nel 1914, afferma: “ […] E, dato l’urgenza con cui doveva uscire questa nuova moneta, fu stabilita che la zecca di Sant’Agostino fabbricasse le monete a mano, quella della Fonderia del R.o Arsenale le monete di rame con la tagliuola, e quelle fatte con l’ingegno venissero battute nell’officina di Torre dell’Annunziata. A tal uopo fu risoluto che Vincenzo Russo, Pietro Milla e Giovan Vincenzo Buonoacquisto si dovessero conferire nella suddetta Torre dell’Annunziata a gettare l’argento nella forma ivi preparata (Ved. Doc. n.3). Ma per poco tempo funzionò l’officina di Torre dell’Annunziata, poiché fu chiusa a metà del 1622 per evitare le frodi che ivi potevansi commettere dagli appaltatori Graffoglietti, Castelli, Fossa e compagni, e quella della Fonderia del R.o Arsenale venne chiusa nell’anno 1623. Esse furono riunite nella zecca principale di Sant’Agostino, dopo l’esposto fatto dagli ufficiali della R.a Zecca, specie del credenziero maggiore Gian Donato Turbolo, che in data 10 febbraio 1623 supplicava le S.rie Ill.me della Camera della Sommaria, affinchè per evitare le continue frodi e la poca correttezza come si facevano le monete in quelle zecche, le officine fossero tutte riunite in quella di Sant’Agostino, perché è diminuita la fabbrica della moneta d’argento e di rame ed essendosi presi locali di più si può fare la fabbrica della moneta con maggiore attenzione e diligenza (Vedi Doc. n.4)”. Una selezione di coni cilindrici usata nella zecca spagnola di Segovia Il documento n. 1 in calce a questo lavoro di Prota, rubricato Consulta della nuova moneta (22 gennaio 1622), ad un certo punto suona testualmente così: “[…] se chiamarono dentro il Tribunale della R.a Camera l’infrascripti officiali Michele Cavo maestro di Zecca, Giov. Donato Turbolo credenziero maggiore, Costantino de Costanzo maestro di pruova et Gio. Ant. Scarano R.o Credentiero della Sayola et se li ordinò che dassero il loro parere circa il remedio poteva stabilirse come pelle monete che si fabricavano a mano in la R. Zecca di Napoli come per le monete che si fabricaranno con nuovo ingegno nella Torre dell’Annunziata, li quali hanno dato il loro parere […]”. “Per quanto spetta al remedio da concedere alle monete per battere con l’ingegno suddetto dela Torre dell’Annunziata non havendone prattica di quelle zecche che hanno osservato cosa simile, ne anco avendo fatto esperienze della loro riuscita appigliandoci solamente col giuditio alla varietà che possono causare simili monete et confirmandoci ancora con l’observanza di molte monete di Fiorenza et Segovia da noi scandagliate, et trovatele con diversità stravagante siamo perciò di parere che al cianfrone che per adesso si intende battere in detta Torre se li possano concedere acini otto di remedio” (questa relazione degli ufficiali di zecca risulta compilata a Napoli, nella zecca, il 15 gennaio 1622). In altra parte del documento si legge: “[…] Fu dopo discussi, et risoluti li capi sop.tti proposto dall’Ill.mo Marchese de San Giuliano che avendo trattato con li officiali della Zecca delle monete si harebbe potuto tenere per accelerare la sudd.a fabbrica delle monete se disse che potrebbe costruirse moneta al doppio più di quello che hoggi si fa nella Zecca se si cognassero tari con li cicinelli tirati alle trafile [“girinelli”, nota in calce di Prota; tondelli per dirla con termine odierno] ma che v’era necessaria spesa di altre grana due et cavalli otto più per ogni libra non per li trafilatori; alli quali sarebbe stato necessario stabilire più salario di quello de li affilatori, che per gli ubrieri, li quali non potevano ubrare li cicinelli de la trafile con la facilità con la quale ubrarebbero le verghe a martello […] se risolse, che il molto utile che si causerà dalla presta costruttione delle monete, et necessità che si tiene di esse, li cicinelli dei tari se trafilassero, ancorchè per trafilarli et ubrarli poi vi corressero le grana due, et cavalli otto più di spesa per ogni libra. […] nelli cicinelli della trafila più proportionorse più il peso a quel che sta ordinato che è quanto ne occorre […]” (documento datato 22 gennaio 1622). Esemplare di moneta da 15 grana del 1619 battuta con coni di Nicola Galoti (Nicolò Globo) Analizziamo adesso il documento n. 3 in calce del lavoro di Prota, rubricato Dip. Sommaria Fascio 15 – Libro del Cred.ro mag.re pag. 221 datato 22 gennaio 1622. A un certo punto si legge: “Si è risoluto perché la fabrica di queste monete de tarì se facci al più presto possibile, che si pongano in ordine otto ingegni di trafile per li quali si assegnano quattro stanze le due dove stà il Rationale et le due altre stanze dove sta la funditura, ei che si faccia la spesa necessaria per gli ingegni predetti restando incaricato del tutto il Maestro di Zecca con far la spesa necessaria e farne il debito conto. Si è risoluto, che alli trafilanti sele diano per salario grana quattroper libbra et cicinelli. Si è risoluto che all’obrieri per obrare questi cicinelli de tari, se le diano grana quattro, cavalli otto per libra. Che il Maestro di zecca prevenga altri obrieri se non al numero di sessanta. Si è dipiù risoluto che si prevengano cognatori al numero de sessanta per potersi cognare argento e rame all’istesso tempo, e resta a carico del maestro di zecca provvederli di stanze, che dicano che esistano, e se ci bisogna accomodo si facci coll’intervento de Picchetto. Si è risoluto, che Vincenzo Russo Fiorentino, Pietro Milla e Gio. Vincenzo Buonacquisto napoletano funditori, si abbiano a conferire nella Torre della Annunziata a gettare le verghe nella forma appontata col salario di un tornese per libra e del mezzo sterlino solito […]”. Si noti che i trafilanti, ovviamente, erano gli addetti al funzionamento delle trafile; per gli obrieri riporto le parole di Vincenzo Ariani (Memorie della vita e degli scritti di Agostino Ariani, Napoli, 1778): “il metallo […] mediante la fusione riducevasi in lastre della qualità, o sia bontà intrinseca stabilita, le quali mercè il taglio di grosse forbici si dividevano in pezzi quadrangolari, e questi poi si ricuocevano fra carboni ardenti, per raddorcigli in modo da poter resistere a’ colpi dè martelli, per mezzo dè quali su di incudini levigate si spianavano da gli artefici, che erano appellati lubrieri. Dopo di che si consegnavano a gli affilatori, altri artefici, i quali con forbici proporzionate ritagliavano detti pezzi nè loro angoli, riducendogli ad una possibil forma più vicina alla rotonda; e mediante le bilance con i loro pesi accomodate al giusto stabilito peso della moneta terminavansi”. Uno degli studi di Carlo Prota sulle monete napoletane di Filippo IV e un grano del 1617 Dai documenti illustrati da Prota risulta evidente che degli ingegni facevano parte certamente le trafile, non già dotate di coni rotanti, ma, per quanto mi appresto a dire, atte a produrre lamine. I tondelli (“cicinelli” nei documenti) sarebbero stati tagliati dalle lastre metalliche dagli obrieri, dopo la laminazione-trafilatura. Per tali nuove operazioni, trafilatura dei tondelli e loro successivo taglio, infatti è previsto un aumento del salario per trafilatori (che nei documenti, si badi, sono distinti dai coniatori) ed obrieri, a causa dei maggiori impegno e difficoltà delle nuove operazioni di zecca. Importante notare che, nella fattispecie, non sono nominati gli affilatori, in quanto non era necessaria la loro prestazione, posto che i tondelli (“cicinelli”) erano tagliati, separati dalle lamine metalliche, dagli obrieri, ovviamente in tempi successivi alla laminazione. Una volta tagliati, i tondelli dovevano essere ricotti (al fine di ridare malleabilità al metallo incrudito dal forzato stiramento subito con la trafilatura), bianchiti e passati ai coniatori. Insisto sul fatto, importantissimo, che i documenti distinguono nettamente i trafilatori dai coniatori, per il qual motivo mi pare di tutta evidenza che la coniazione non avveniva con le trafile a coni rotanti, bensì in un momento successivo alla laminazione delle verghe. Si nota anche che il documento del 22 gennaio 1622 attesta che coi “cicinelli della trafila” si riusciva a proporzionare meglio il peso delle singole monete, fatto indicativo e di non poca importanza: è infatti noto che una delle criticità della tecnica di coniazione con coni rotanti consisteva proprio nella difficoltà di ottenere nummi di peso uniforme. Altro fatto notevole è che tutte le operazioni di zecca sopra descritte erano eseguite nella zecca di Napoli, mentre a Torre Annunziata era prevista esclusivamente la fusione e il getto delle verghe metalliche. Ciò in quanto, come attestato dai documenti di cui sopra, la sala della fusione, nella zecca di Napoli, era stata adibita ad ospitare parte degli otto ingegni di trafile, rendendo ivi impossibile la produzione delle verghe metalliche. Probabilmente fu questo il motivo per il quale si aprì un’officina ausiliaria in quel di Torre Annunziata: non per coniare moneta, almeno inizialmente, bensì per l’esecuzione di quella parte delle lavorazioni di zecca che non era più possibile eseguire a Napoli. Importante anche l’elevato numero di obrieri e coniatori previsto per la coniazione innovativa in argomento: se sessanta obrieri erano giustificati dalla notevole quantità di tondelli (“cicinelli”) da tagliare dalle lamine metalliche uscite dalle trafile, altrettanti coniatori non sarebbero giustificati nell’ipotesi che le monete venissero realizzate direttamente al momento della trafilatura, mediante i coni rotanti. Ciò rende più evidente che la coniazione delle monete avveniva in tempi successivi al distacco dei tondelli (“cicinelli”) dalle lamine. A tutto ciò qualcuno potrebbe contrapporre, in favore della teoria dei coni rotanti, il documento riportato nella nota 10 del saggio di Carlo Prota La moneta di Napoli di Filippo IV dal 1621 al 1623, apparso nel BCNN nel 1920, ovvero la fede di Ascanio Carafa in favore di Giovan Donato Turbolo in data 22 dicembre 1622, direttamente tratta dal Libro del Credenziero Maggiore allora conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli. L’Archivio di Stato di Napoli, autentica miniera di notizie numismatiche Questo documento recita testualmente: “Contraddisse sempre (riferito al Turbolo) alle nuove jnventioni proposte di battere le monete con li nuovi modelli nella Torre dell’Annunziata, et dopo, che furono svanite, restrinse a battere li tari per trafila del quale modo mai per prima posto in uso, si è arrivato a battere sino alla summa di ventimila ducati al dì che fu servitio di grandissima importanza”. Si potrebbe, dunque, affermare che “battere li tari per trafila”significhi che la coniazione avveniva mediante i coni rotanti, il cui funzionamento è del tutto simile a quello della trafila. Ma, a ben vedere, la stessa frase è per nulla in contrasto con quanto sopra espresso, potendo ben essere stata concepita in questo modo quale succinta descrizione di una operazione complessa, nel contesto di una annotazione che aveva ben altri scopi rispetto a quello di descrivere dettagliatamente l’innovativo processo di produzione monetale a quel tempo messo in esercizio nella zecca di Napoli. Ad ulteriore supporto della tesi della coniazione in tempi successivi alla trafilatura/laminazione delle verghe metalliche, si consideri che: mai nei documenti coevi si fa riferimento alla forza idraulica necessaria per azionare i coni rotanti. Sul punto si tenga conto del fatto che nelle maggiori zecche europee in cui fu in uso tale metodo di coniazione, delle quali Hall e Segovia rappresentano i casi più famosi ed eclatanti, i coni rotanti vennero sempre azionati da un importante ed ingombrante sistema di canali idraulici che faceva sì che un grosso flusso idrico colpisse le pale di grandi ruote idrauliche lignee, collegate meccanicamente ad ingranaggi solidarizzati coi coni rotanti; mai nei documenti coevi si fa riferimento alle dimensioni degli ingranaggi necessari per mettere in funzione i coni rotanti. Tali ingranaggi avevano dimensioni considerevoli, certamente sorprendenti per quei tempi e, soprattutto, per chi era abituato a considerare gli spazi necessari per la tradizionale coniazione a martello: a parte quelli installati ad Hall e Segovia, davvero di grandi dimensioni, tenuto conto anche del notevole spazio necessario per l’adduzione idrica verso le ruote a pale, esiste un’interessante descrizione degli ingranaggi connessi ai coni rotanti installati presso la zecca pontificia di Roma, redatta nel 1767 da Giovanni Pietro Chattard nel suo Nuova descrizione del Vaticano, tomo 3. L’autore, fortunatamente, rende note anche le dimensioni di quegli ingranaggi e della sala della zecca in cui erano installati: la sala che ospitava i coni rotanti misurava in pianta circa 14 per 9 metri (superficie di 126 mq) e l’ordegno “mosso da impetuoso e grosso canale d’acqua” aveva altezza di 3 metri, larghezza di 4 metri circa e profondità di circa 1,80 metri (il tutto per quasi 22 metri cubi); sulla scorta dei documenti coevi sopra menzionati è accertato che il nuovo metodo di coniazione, nel 1620, venne messo in funzione a Napoli in assenza di qualsivoglia opera idraulica al margine dell’edificio della zecca. E’ noto che la zecca a Napoli venne trasferita nel 1333, per volere di Roberto d’Angiò, nel palazzo di Nicola di Somma e che ivi rimase fino all’Unità d’Italia. Dall’analisi della tavola della città di Napoli, stampata nel 1566 ad opera di Antoine Lafrery, incisa su rame da Duperac, non risultano corsi d’acqua, naturali o artificiali, esistenti al margine o nelle vicinanze dell’edificio della zecca. Uno dei cosiddetti “grani bislunghi” di Filippo IV per Napoli coniato nel 1622 La zecca partenopea appare, infatti, inserita nel complesso tessuto urbano della città cinquecentesca, tessuto del tutto incompatibile, anche dal solo punto di vista degli spazi necessari, con canali idraulici di qualsiasi tipo. Stessa cosa dicasi per la pianta della città di Napoli realizzata da Baratta nel 1670. Un intervento edilizio di una certa importanza in zecca è attestato a partire dal 1675: sul prospetto opposto alla strada l’edificio è interessato da lavori di ampliamento, probabilmente in vista delle esigenze della nuova monetazione che, qualche anno più tardi, sarà coniata al bilanciere sotto il governo vicereale del marchese del Carpio. Ma a ben vedere, sono noti altri documenti che confermano questa tesi. Mi riferisco a due relazioni ufficiali, redatte nel 1821, da cui si traggono informazioni sulla consistenza e composizione di macchinari utilizzati a Napoli per la produzione di monete nel 1622. Rese note dall’avvocato Benvenuto Cosentini nel Bollettino del Circolo Numismatico Napoletano nel lontano 1916, dalla loro analisi l’autore fu indotto ad ipotizzare che nel 1622 a Napoli si coniassero monete di rame con l’ausilio di “macchine ben distinte dai bilancieri o ingegni del Galoti”. Tale dichiarazione di Cosentini può e deve essere intesa, oggi, alla luce delle considerazioni di cui sopra: oggi è chiaro che gli ingegni del Galoti nulla ebbero a che spartire col bilanciere. Giova rammentare che a Napoli l’utilizzo dei bilancieri venne introdotto per la prima volta nel 1680, inizialmente per la monetazione di rame. Ma analizziamo i documenti del 1821. Come detto, trattasi di due relazioni ufficiali. La prima venne compilata dall’Intendente della Provincia di Terra d’Otranto in tempi successivi al 22 settembre 1821, e riporta la notizia, non troppo dettagliata, dell’avvenuto ritrovamento in una buca, durante i lavori di demolizione del campanile della chiesa di Carmiano (comune oggi in provincia di Lecce) di tre torchi di ferro, sette pezzetti di rame perforati e cinque “impronti”, dei quali tre avevano l’effigie di Filippo IV di Spagna e due una croce con altre quattro croci più piccole, che recavano l’anno 1622. La seconda relazione è più dettagliata e utile, e fu redatta a Napoli l’8 novembre 1821 da Giovanni Pappalettere, segretario generale della Regia Zecca. Coerentemente con le specifiche competenze dell’estensore, essa descrive, in modo più pertinente, gli oggetti rinvenuti durante la demolizione del campanile della chiesa di Carmiano, correggendo il dato numerico dei coni fornito nella precedente relazione: tre presse di ferro; cinque coni, dei quali due con l’effigie di Filippo IV e tre con la croce e la leggenda NEAPOLIS REX 1622. Si specifica che i coni sono in acciaio e incisi in modo molto goffo. A questo punto il Pappalettere, persona competente sui fatti monetari, esprime il proprio parere: i coni dovevano essere montati agli estremi delle presse, entro i corrispondenti fori, e la coniazione doveva avvenire mediante colpo di percussione dato verticalmente. E’ del parere, altresì, che le presse dovessero essere vincolate a macchinari lignei o lapidei, visto che l’estremità di una di esse recava evidenti segni di vecchio impiombamento. Pappalettere continua col chiarire anche la funzione dei pezzetti di rame rinvenuti assieme agli altri oggetti: servivano per serrare e incastrare i coni entro i fori predisposti nelle presse. La relazione si conclude evidenziando il valore di testimonianza storica di quegli oggetti, in relazione a come si coniava la moneta nell’anno 1622. Faccio notare che nessuna delle due relazioni, ed in specie la seconda, vergata da un alto funzionario della zecca di Napoli, paventa l’ipotesi che i menzionati oggetti fossero stati realizzati da falsari, certificando nel contempo, per logica conseguenza, che essi fossero autentici dispositivi atti a coniare la moneta, utilizzati nella zecca di Napoli nel 1622. Tale considerazione, ad onor del vero, è stata espressa senza remore anche dall’vvocato Cosentini nel 1916. Resta il dubbio su quando, perché e da chi i menzionati attrezzi autentici della zecca di Napoli siano stati trasportati e nascosti in quel di Carmiano. Orbene, Magliocca afferma che gli oggetti descritti in queste due relazioni ufficiali corrisponderebbero ai coni rotanti che furono in funzione negli anni in questione nell’officina di Torre Annunziatae nella zecca di Napoli. A mio avviso, invece, la descrizione fatta dal funzionario della zecca Pappalettere è tale da escludere in modo categorico che detti materiali possano essere riconducibili a coni rotanti. Infatti, in entrambe le relazioni non sono menzionate parti di forma cilindrica, quando, invece, il Pappalettere parla chiaramente di coni da incastrare nei fori di presse metalliche, nelle parti estreme di esse, che, a loro volta, dovevano essere vincolate a macchinari di legno o di pietra, mediante impiombamento, asserendo, altresì, che la coniazione con siffatte presse dovesse avvenire mediante compressione secondo la direzione verticale, non facendo riferimento alcuno al movimento rotatorio proprio dei coni rotanti. Il tarì col sole raggiante coniato nel 1620 con gli “ingegni venuti da Alemanna” Un paio d’anni prima del Cosentini, Carlo Prota pubblicò nel primo numero del Bollettino del Circolo Numismatico Napoletano la ricerca, utile ancora oggi, sui Maestri ed incisori della Zecca Napolitana, in cui scrisse che nel 1619, al fine di dare attuazione ai proponimenti riformatori del maestro di zecca Giovanni Francesco Citarella, furono installati nella zecca di Napoli “cinque ingegni venuti da Alemanna” per produrre il tarì d’argento col sole raggiante nel rovescio, i cui coni, egli dice, furono incisi da Nicola Galoti, tedesco, e la moneta coniata ed emessa in pochissime liberate di prova. Al margine Prota riproduce nella nota 6 di pag. 18 un documento della Dipendenza Sommaria Zecca dell’Archivio di Stato di Napoli, redatto il 14 febbraio 1619, con cui si dispone un ulteriore pagamento di ducati quindici in favore di Nicolò Galoti, definito “alemanno intagliatore deli cugni”, riportando “in conto delle sue fatiche per causa deli cogni fatti per servitio de quella zecca et del novo modello de far le nove monete ad usanza d’Alemagna”. E’ il caso di notare che, dal tenore del documento, risulta che alla data del 14 febbraio 1619 ancora le monete non erano state coniate secondo “usanza d’Alemagna”. E’ riprodotto anche un ulteriore documento d’archivio, in cui si fa riferimento ad una relazione del maestro di zecca Michele Cavo al presidente della Regia Camera della Sommaria, datata 29 aprile 1619, da cui risulta che l’incisore tedesco Nicola Galoti ha lavorato ai coni della moneta da 15 grana per nove mesi e mezzo consecutivi, dal 14 luglio 1618 fino a tutto l’aprile 1619, dando ampia dimostrazione della propria bravura di incisore. Un rarissimo carlino del tipo “coi giri attorno” ideato da Fabrizio Biblia Più oltre, sempre nel suo lavoro del 1914, Prota riporta nella nota 5 di pag. 20 un documento inviato dal soprastante di fabbrica della Regia Zecca di Napoli all’attenzione del marchese di Santa Giuliana, vergato nel 1629 a Napoli, con cui si rammenta che negli anni precedenti, dietro ordine di quest’ultimo, vennero coniate le nuove monete “con giri attorno” mediante “l’ingegni di Nicola Galoti Tedesco”, ricevendo disposizione che si tenessero annotate tutte le spese sostenute per la rimessa in funzione di detti macchinari; si parla, quindi, di cantara quattro di ferro, provenienti dalla Regia Dogana, e di tre cantara di piombo del Castel dell’Ovo, consegnati in zecca, specificando che tutte le operazioni di ripristino di dette macchine coniatrici, in numero di cinque, con cui effettivamente furono battute le monete della riforma ideata dal catanzarese Fabrizio Biblia, e le relative spese erano avvenute sotto il diretto controllo del cavalier Giulio Cesare Fontana, definito “ingegnere maggiore” del Regno. Era accaduto, narra Prota, che dopo le prime coniazioni con detti ingegni, questi non vennero più utilizzati, tanto che lo stesso incisore Nicola Galoti ne pignorò tutte le parti metalliche. Dunque la Regia Camera della Sommaria non solo dovette accollarsi tutte le spese per eliminare i pignoramenti fatti dall’incisore tedesco, ma ebbe a sostenere anche tutte le spese per rimettere in funzione quei macchinari, che Prota definisce – errando – bilancieri. Dalle considerazioni precedenti ho maturato la convinzione che i cinque ingegni giunti a Napoli nel 1619 da Alemagna fossero macchinari non solo diversi dal torchio a vite o bilanciere (che entrerà in funzione a Napoli solo nel 1680), ma certamente diversi dai coni rotanti del tipo delle zecche di Hall e di Segovia. Questa mia opinione, a ben vedere, trova ulteriore conferma in due importanti documenti coevi. Il primo è il Documento V in appendice al pregevole lavoro di Giovanni Bovi sulle monete napoletane di Filippo III (BCNN, gennaio-dicembre 1967): nel contesto di una relazione del maestro di zecca Giovanni Francesco Citarella, compilata nella zecca di Napoli il 28 gennaio 1619, si parla del lavoro di incisore dei coni eseguito da Nicolò Globo, alemanno, con riferimento alle monete argentee da 15 grana col millesimo 1618, dal mese di luglio 1618 fino ad allora, per sette mesi consecutivi, nonostante che il “mastro dei cogni” fosse, a quel tempo, Giovanni Antonio Consolo, e ciò per espresso ordine del presidente della Regia Camera della Sommaria. Scudo napoletano in argento a nome di Filippo III del 1617 Nel documento si riferisce, ad un certo punto, di un pagamento di 55 ducati già effettuato in favore dell’incisore Globo, riportando testualmente, “per conto d’un modello da Lui proposto di far le monete ad usanza di Alemagna megliori e più belle di quelle di Fiorenza e di Segovia fatte con forza d’acqua”. E’ evidente, dunque, che la tecnica di coniazione proposta dal Globo (o Galoti, per dirla come Carlo Prota), a quel tempo tipica delle zecche di area germanica, era per Napoli innovativa ma anche e soprattutto differente da quella, basata su coni rotanti mossi da energia idraulica, adottata nelle zecche di Firenze e Segovia. Il secondo documento è quello riportato da Carlo Prota in calce alla nota 19 del suo lavoro La moneta di Napoli di Filippo IV nel 1621 e 1623(BCNN 1920), che testualmente recita, con riferimento al riattamento degli ingegni del Galoti/Globo del 1624 ai fini della produzione dei carlini e tarì ideati da Fabrizio Biblia: “In primo cinque ingegni armati di tutto punto con i suoi ferri, metalli e piombo, con suoi pile, et torrelli e zeppe, vite e catene, che non ci manca cosa alcuna”. Il mezzo scudo napoletano in argento a nome di Filippo III del 1617 Questa succinta descrizione degli ingegni non solo è coerente con le due relazioni ufficiali del 1821 viste sopra, ma è incongruente con un supposto macchinario dotato di coni rotanti, oltretutto azionati mediante energia idraulica. Non solo non vi è riferimento alcuno a cilindri rotanti, ma si parla chiaramente di pile e “torrelli” (torselli), con evidente rimando ai coni di incudine e martello, rispettivamente. Ma allora, come avveniva la coniazione col metodo proposto dall’incisore tedesco Galoti/Globo? Per farcene un’idea, a questo punto è indispensabile interrogare i documenti ufficiali più significativi in materia, le monete. Prima, però, mi sia consentita una brevissima digressione sulle monete napoletane prodotte a Napoli a nome di Filippo III in base alla riforma monetaria attuata dal maestro di zecca Giovanni Francesco Citarella. Da quanto si legge nei lavori di Magliocca, egli ritiene che le monete napoletane in argomento, che al dritto riportano il profilo del re di Spagna con voluminosa gorgiera, siano state coniate tutte con gli ingegni di Nicola Galoti/Globo. Ovviamente ciò non è e, per rendersene conto, basterebbe osservare le monete in argomento: sul presupposto che gli ingegni tedeschi dovessero venire azionati a mano, mediante leve, peraltro coerentemente con le relazioni del 1821 sopra analizzate, non sarebbe stato possibile coniare i grandi moduli dello scudo e mezzo scudo del 1617 in modo diverso che a martello. Con gli ingegni tedeschi, azionati a mano, si poterono coniare soltanto le monete di modulo sensibilmente più piccolo di quello degli scudi e dei mezzi scudi del 1617. Ciò, peraltro, è coerente con quanto attestato dal documento datato 14 febbraio 1619 prima analizzato, secondo cui, rammento, a quella data ancora non erano state coniate monete secondo “usanza d’Alemagna”. Un raro esemplare di terzo di scudo d’argento del 1617 per Napoli Stesso discorso per la moneta da un terzo di scudo coi millesimi 1617 e 1618: osservando la foto di una di queste monete pubblicata a pag. 162 di Magliocca 2020, è possibile notare al dritto un macroscopico salto di conio nell’effigie reale, fatto che poteva accadere solo con la tecnica di coniazione a martello. Per poter risalire al metodo effettivo di coniazione delle monete oggetto del presente saggio, si noti quanto segue: il tarì di Filippo III col sole raggiante, millesimo 1620, la cui foto è pubblicata in entrambi i lavori di Magliocca riportati in bibliografia, denuncia una nitidezza e precisione di rilievi impensabile per la coniazione a martello; trattasi di moneta certamente coniata con un macchinario, in serie. Ad ogni buon conto, si può affermare che non può essere stata coniata coi coni rotanti in quanto, se così fosse, la macroscopica deformazione perimetrale del metallo che la caratterizza non dovrebbe esserci. Infatti con la tecnica dei coni rotanti la moneta era staccata, tranciata, dalla lamina metallica in tempi successivi alla coniazione, ergo la forma della moneta coniata con i coni rotanti deve, per forza di cose, avere una forma rotonda e priva di deformazioni in pianta. Si badi, ho parlato di forma della moneta e non già di forma dei rilievi impressi sulla moneta che, come noto, con i coni rotanti assumevano molto spesso una forma ellittica. le precedenti considerazioni sono viepiù valide con riferimento ai c.d. “grani bislunghi” del 1622: come si concilia la loro forma macroscopicamente allungata, ellittica, col fatto che, se fossero stati battuti ai coni rotanti, sarebbero stati tagliati dalla lamina dopo la coniazione? Concludendo, tenuto conto di tutti i ragionamenti in precedenza illustrati e di quanto desumibile dall’analisi del documento moneta, si può ragionevolmente affermare che gli ingegni del Galoti/Globo consistevano non in un solo particolare macchinario, bensì in un insieme di macchinari funzionali alla coniazione, azionati a mano mediante apposite leve: trafilatrice a cilindri rotanti, tranciatrice dei tondelli (taglietto; qualche volta definita “tagliuola” nei documenti napoletani coevi), pressa a coni basculanti o oscillanti. I sistemi di coni rotanti e di coni oscillanti descritti da Angelo Finetti Infatti la pressa a coni oscillanti, che secondo letteratura era diffusa nei territori di lingua tedesca tra la fine del XVI e per tutto il XVII secolo, è perfettamente compatibile con la descrizione fatta dal Pappalettere nel 1821 in relazione al macchinario ed agli oggetti ritrovati in quel di Carmiano: in queste macchine i coni di incudine e di martello erano smontabili ed estraibili dai propri supporti, proprio come è per le presse a coni oscillanti; in esse l’asse principale di funzionamento è quello verticale; in letteratura è, altresì, noto che nel caso di monete di piccolo modulo, come per le monete napoletane in argomento, le presse a coni oscillanti erano azionate a mano. In questo contesto è il caso di rievocare le parole di Philip Grierson in merito alle presse a coni rotanti ed a coni basculanti: “[…] Altri sistemi per coniare le monete furono quelli del torchio a rulli e del torchio oscillante. I coni del torchio a rulli venivano incisi sulla superficie dei rulli e i nastri di metallo venivano fatti passare ta questi affinché, all’uscita, recassero l’impronta di più monete, le quali venivano poi tagliate mediante fustellatrice. Poiché la pressione dei rulli provocava un’espansione longitudinale delle lamine, affinché le monete assumessero forma circolare si dovevano incidere i coni con una figura ovale piuttosto larga. I risultati non erano molto soddisfacenti perchè riusciva difficile allineare esattamente i coni e, dal momento che le monete venivano tagliate dal nastro solo dopo essere state coniate, non era possibile garantirne l’uniformità di peso. Philip Grierson descrive in modo esemplare le tecniche di coniazione meccanizzata Questo metodo (Welzenpragung) presentava l’ulteriore svantaggio di costringere a raschiare tutti i coni incisi su uno stesso rullo se uno solo di essi subiva un danno. Inventate nel XVI secolo, furono impiegate largamente in Germania nei secoli XVII e XVIII tanto nella versione originale quanto in quella perfezionata, nella quale i coni potevano essere rimossi (Taschenwerkebetrieb). Il torchio oscillante fu una variante del torchio a rulli molto utilizzata nel XVII secolo. I coni erano incisi su superfici curve di ‘culle’ che erano imperniate assieme ed azionate da una barra oscillante collegata alla ‘culla’ superiore. Quando si piazzava un tondello fra le facce delle culle si abbassava la barra perché passasse tra le due superfici. Spesso le impressioni erano insoddisfacenti e le monete di foggia irregolare [si pensi ai grani bislunghi, NdA] perché la pressione non si distribuiva uniformemente sulla superficie della moneta; tuttavia le culle avevano il vantaggio, rispetto ai rulli, di consentire il controllo del peso dei tondelli prima che venissero coniati. Né il torchio a rulli né quello oscillante potevano produrre monete coniate sul taglio”. da: https://www.cronacanumismatica.com/gli-speciali-di-cn-sui-cinque-ingegni-per-coniar-moneta-giunti-a-napoli-dalla-germania-nel-1619/1 punto
-
Di nulla! Sempre un H36 direi. Tieni conto che queste monete hanno tantissime varianti di conio anche interne alle stesse categorie Hafner. Quindi un H39 ad esempio è a sua volta suddiviso in H36a-b-c a seconda di minimi dettagli come quelli delle perle. Sempre H36 resta però.1 punto
-
Vero ,ma bisogna considerare che la definizione" nettaorecchie" è una definizione di comodo usata dagli archeologi per definire appunto degli oggetti di cui non e perfettamente chiara la funzione, poi magari erano nettaunghie o per "scapperarsi" noi non possiamo saperlo con certezza. Bisogna anche sottolineare che anticamente la sicurezza e i tentativi di igiene non andavano di pari passo. La letteratura archeologica è zeppa di "funzioni" appioppate random a oggetti la cui funzione era di difficile interpretazione. Oltretutto se questa definizione viene applicata "in primis" essa si ripercuoterà ad "in saecula saeculorum" in tutte le pubblicazioni a seguire come "ipse dixit"1 punto
-
1 punto
-
Il 3 novembre 1896 si recò alle urne un numero eccezionale di elettori, ben due milioni in più rispetto a quattro anni prima, decretando la nettissima vittoria di McKinley, con il margine più ampio dal 1872. Celebrata il giorno dopo dal New Orleans Bee con questa divertente vignetta, nella quale il neo-presidente prende a pugni sul ring un dollaro d'argento, personificazione dei Free Silver, mentre il cane che scappa con la scritta Peffer raffigura il senatore populista William A. Peffer (vedi #post 68 pag. 3), che aveva fallito la rielezione. Le figure sulla destra col punto interrogativo al posto della testa sono i rappresentanti del partito democratico, che si chiedono come sia stata possibile una sconfitta del genere. Infatti i democratici, oltre che nel nordest industriale, dove era prevedibile (ma forse non in quella misura, non conquistarono nemmeno una contea), persero anche in roccaforti agrarie come il North Dakota, il Minnesota e l'Iowa, vincendo nel Sud e nel West (ma non in California). Come mostrato in questa cartina dove sono indicati in rosso gli stati vinti dai repubblicani e in azzurro dai democratici. Se la gran parte del merito di questa vittoria va, naturalmente, ai repubblicani, bisogna però dire che i democratici ci misero del loro. Il frenetico attivismo di Bryan, non solo non portò a un aumento significativo dei voti in suo favore, ma forse ottenne proprio l'effetto contrario. Perché se anche la gente accorreva in massa ad ascoltarlo, capitava poi di rado che si convertisse alla sua politica. Anzi, il suo rancore, e il tentativo di far leva sull'emotività del pubblico, produssero in molti la convinzione che egli fosse un pericoloso demagogo. Inoltre, gran parte del clero condannò come blasfemo il suo discorso della croce d'oro. E un ritratto spietato di Bryan arrivò da John Hay, futuro ministro degli esteri: "Uno sciocco ma loquace avvocatucolo da strapazzo, che promette il paradiso in terra a chiunque abbia un buco nei pantaloni, e la distruzione a chiunque vada in giro con la camicia pulita." Amen petronius1 punto
-
Bellissima moneta complimenti ! A diritto superbo profilo del Re, baffi e capelli superbi. Secondo me SPL++1 punto
-
Non sono d'accordo, credo che ormai un convegno serva molto di più proprio per aggregare, per confrontarsi, per conoscersi e molto meno per vendere, ormai il grosso delle vendite avviene attraverso aste online.1 punto
-
1 punto
-
Mi riferivo a oro, ag e bronzi. Le moderne non le colleziono. So che la plastica le danneggia. Avevo dimenticato in una bustina di plastica alcuni 2 lire, comuni, e dopo anni si sono trasformati in polvere.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
rimanendo in tema volevo segnalarvi la bella mostra di quadri presente al Museo Diocesano di Donnaregina dedicato al periodo caravaggesco napoletano, con la presenza di tele dipinte da artisti napoletani che erano legati alla lezione del pittore lombardo. tale insieme apparteneva a Giuseppe De Vito, collezionista napoletano, e studioso della pittura seicentesca. ve la raccomando perchè questi dipinti chi sa quando si avrà l'occasione di riammirarli dal momento che la sede della fondazione proprietaria è a Firenze.1 punto
-
Ciao Genny, speriamo resti figlio unico per tanto tempo ancora. Un saluto Raffaele.1 punto
-
1 punto
-
Provo a risponderti da appassionato quale sono Ci si basava molto sulla osservazione diretta. Oggi avviene il contrario: si vedono molte più fotografie e molto meno monete in mano. Questo, seppure vantaggioso perchè consente di "vedere" monete a distanza, può rappresentare una arma a doppio taglio quando si debba valutare, per esempio, l'autenticità di una moneta. L'osservazione diretta, credo, sia insostituibile (soprattutto per monete rare e di un certo valore). Ciao. Stilicho1 punto
-
Buongiorno, concordo al 100%. In un passato mio post ( 5 lire aquilotto del 1926 ) avevo manifestato esattamente questo concetto. Premessa/Riassunto : in merito al 20 lire elmetto, non ho acquistato quella periziata Tevere, soprattutto perché @ilnumismatico, che saluto e ringrazio ancora, mi aveva fatto notare la macchia verde sulla moneta ( 20 lire elmetto ) tipico delle monete lavate e messe in perizia. Ora, anche il sigillo/busta era piuttosto "molle" e temendo una manomissione ho optato per un "elmetto" periziato SPL da Raffaele Negrini nel 2019. Secondo me molte monete sono proposte con almeno mezzo grado di conservazione in più rispetto a quello che dovrebbero avere. Io prima di acquistare il 20 lire mi sono studiato tutti i "vecchi" posts sul Forum per imparare ed apprendere da Voi Esperti Numismatici, Periti ed Appassionati. Quindi credo che si dovrebbero considerare valutazioni e perizie facendoci un esame di coscienza : " il Perito e/o venditore la valuta tot, secondo me potrebbe essere conforme ? Se sì acquisto, altrimenti lascio perdere. Permettetemi "una nostalgia" : quando ho iniziato a collezionare, c'era in attività a Milano in Via Volta, un certo Perito numismatico del Tribunale di Milano - Ernesto Memoli e reputo le sue perizie tra le più veritiere che ho in collezione.1 punto
-
Anche qui prova a fare qualche altra foto ,magari con altra angolazione, perchè io il volatile non lo vedo 😀1 punto
-
L'autore dice di se stesso: "I suoi contributi su ComplianceJournal.it sono ampiamente apprezzati per la loro chiarezza e profondità analitica". Quantomeno conferma che i contributi non sono apprezzati per la veridicità o verosimiglianza. 🤐1 punto
-
1 punto
-
A convincere la Mauritania a ritirarsi, nel 1979, fu un'azione del Fronte Polisario, l'organizzazione politica e militare che con l'appoggio dell'Algeria sostiene l'indipendenza del Sahara Occidentale col nome di Repubblica Araba Sahrawi Democratica, che organizzò una spedizione armata e sparò dei razzi contro il palazzo presidenziale nella capitale della Mauritania. La Repubblica Araba Sahrawi Democratica è attualmente riconosciuta da 74 paesi del mondo (*) e controlla la parte del Sahara Occidentale a est del Berm, la lunga fortificazione creata dal Marocco lungo tutto il Sahara Occidentale. Teoricamente non dovrebbe essere parte di questa discussione in quanto emette monete e banconote (denominate in "pesetas sahrawi"), ma di questo contante è dubbia la circolazione. Così come l'utilizzo dei suoi francobolli, che io sappia mai documentato. (*) di cui nessuno dell'UE, e molti pur mantenendo il riconoscimento hanno sospeso le relazioni col governo ufficiale Sahrawi in esilio in Algeria.1 punto
-
Ok, ma tutte queste particolarità dovrebbero portare ad una conclusione o sono solamente delle testimonianze che, peraltro, si notano in altri simili esemplari? Forse il simbolo sotto il busto è l’elemento più importante, salvo errori.1 punto
-
Tra l'altro in molti documenti coevi si parla per l'appunto di rame puro...1 punto
-
1 punto
-
Sempre alla ricerca di nuovi testi e nuovi confronti ho acquisito questo catalogo , referente ad una mostra tedesca del 2009. L' intento era quello di seguire la migrazione dei "Vinnili" dalla partenza nel bacino dell' Elba fino all' arrivo in Italia. Naturalmente la sezione italiana fa la parte del leone ma dal mio punto di vista trovo interessantissimo il segmento con i reperti pre Pannonia ,così misconosciuti. Va da sé che i corredi tedeschi ,austriaci,cechi e ungheresi sono delle chicche anch'esse tutte da scoprire e gustare. Nel complesso un catalogo molto ben fatto e gradevole da consultare.1 punto
-
Gent.mo tartachiara, questo è veramente un argomento interessante. I falsi sono una costante in Numismatica ed in generale nel mondo dell'arte. Chiunque si intenda ad esempio di pittura sa che molti quadri sono dubbi, o addirittura esposti in Musei, considerati originali eppure...In piccolo anche la Numismatica sconta il fatto che esistano falsari così bravi da ingannare anche l'esperto.Per fortuna sono pochi, ma circolano molte monete false considerate "buone". Se la discussione si svilupperà posterò qualche moneta che forse metterà in crisi anche qualche esperto ( originali? falsi raffinati? ). Per quanto riguarda le tecniche di falsificazione, in biblioteca ho diversi testi. Uno in particolare mi è sempre piaciuto perchè "spiega molto", è molto datato (1908), non al passo con i tempi ( scanner e stampanti 3D ) ma molto interessante. Penso sia reperibile in Internet e ve lo consiglio: Il libro è stato ristampato nel 1983. Ciao Beppe PS: se qualcuno non riesce a scaricarlo, in qualche giorno potrei scansionarlo e metterlo in lista.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?