Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 06/17/25 in Risposte
-
AVVISO per i nuovi lettori: i contenuti di tutta la discussione, sino al post #51 compreso, sono raccolti e meglio organizzati nel pdf al post #52, di cui pertanto consiglio la lettura.5 punti
-
Arrivata fresca fresca ieri dall'ultima asta Bolaffi voglio condividere la nuova acquisizione. Si tratta di un testone di Carlo I del secondo tipo, per intenderci quello con la spada in verticale, con le sigle GG di Nicola Gatti per la zecca di Cornavin. Sul volume del Cudazzo classificato al 266b come inedita per la variante in legenda al rovescio che termina con IMP. In una nota il Cudazzo indica questa variante con un peso calante, 7,20 gr. parecchio inferiore allo standard di questa tipologia, anche questa da me acquistata ha un peso basso, 7,92 gr. ma potrebbe essere solo una causalità visto che non mi risultano ordinanze con variazioni di peso. È comunque, il testone di Carlo I, la prima moneta sabauda con il ritratto del duca, se non consideriamo il bianco dozzeno di Amedeo VI che voleva riprodurre il penny inglese e, a differenza delle altre monete con ritratto del periodo, riproduce il duca con un busto e non solo con la "testa" da cui il nome "testoni". Presa all'asta ad una cifra veramente bassa, non avevo mai visto un testone essere venduto a questo prezzo, quindi anche se non perfetto devo ammettere di essere stato veramente soddisfatto! Le mancanze al diritto, poi, sembrano date più da una debolezza di conio che da un'usura prolungata, colpevole forse il peso ridotto e quindi lo spessore del tondello. Tutti i commenti sono graditi...5 punti
-
@penna invisibile cosa non è chiaro? Una moneta da 2 centesimi vale 2 centesimi. Me lo chiedo pure io4 punti
-
No. Io, che su questo argomento sono già drastico, in questo caso lo sono un po' meno. La numismatica italiana non è morta con V.E. III, semmai ha iniziato a degenerare sotto di lui. Ma ancora oggi c'è numismatica con gli Euro (e molta di più ce ne è stata con la Repubblica): solo che bisogna fare un po' di fatica a distinguere le monete dalle "figurine" (o giocattoli), delle quali siamo travolti. Però tra tanti giocattoli qualche moneta (quelle che troviamo nei portafogli) ancora esiste. E quella è numismatica, degna di essere studiata e collezionata, testimone del nostro tempo4 punti
-
IL SIMBOLO DELLA POTENZA DI ROMA: L’AES GRAVE A Roma l'emissione di moneta arrivò seguendo due strade: la cosiddetta “monetazione romano-campana”, di cui si dirà oltre, e l’aes grave. Si definisce aes grave un sistema di monete di bronzo, fuse, a valore intrinseco (cioè, valevano tanto quanto il metallo che contenevano). In sostanza, la nascita della moneta a Roma è simile a quella avvenuta in Asia Minore, con la differenza che là i governanti decisero di garantire il peso dell'elettro, qui quello del bronzo; là fu adottata la punzonatura (che si può ritenere una forma arcaica di coniazione), qui la fusione. Le monete di aes grave sono quasi lingotti circolari: hanno infatti un peso ragguagliato all’unità di misura in uso a Roma, la libra, suddivisa in 12 once. Le monete principali, del peso e del valore di una libra, erano gli asses (“assi librali” in Italiano) nome probabilmente derivante da asser, “palo”, essendo il palo la rappresentazione visiva dell’unità (come per noi, oggi, l’indice alzato); il simbolo del valore impresso su di essi era infatti “I”. Furono inoltre emesse le frazioni dell’asse, ossia semisse (mezzo asse, simbolo “S”), triente (la terza parte dell’asse, ossia 4 once, simbolo “····”), quadrante (“···”), sestante ( “··”) e oncia (“·”). Più raramente fu emessa la semioncia (simbolo “S”) e, ancor più raramente, i multipli dell’asse, ossia dupondium (due assi, “II”), tressis (“III”) e quincussis (“V”); in un solo caso (la moneta RRC 41/1) fu emesso il decussis (“X”). Ma quanto pesava una libra (e, quindi, un asse)? Le monete, proprio per la loro fattura grezza, presentano una grande variabilità (ad esempio, gli esemplari dell’asse RRC 14/1 oggi noti vanno da 240 a 400 g). Tuttavia si ritiene che Roma abbia utilizzato, nel tempo, tre differenti valori di riferimento: la libra propriamente romana da 327 g, la libra italica da 341 g e quella osco-latina da 273 g[1]. Le monete di aes grave sono quindi massicci pezzi di metallo, di fattura grezza, con iconografie assolutamente essenziali: molta sostanza e poca forma. Il loro fascino è proprio quello di simboleggiare la più antica cultura romana, improntata a rusticità, praticità, sobrietà, ben lontana dalla raffinatezza e dal gusto del bello che connotavano, invece, la cultura magno-greca (e che traspaiono anche nell’iconografia della monetazione romano-campana). Scrisse Romolo Calciati nel 1978: “Raramente una moneta riesce a dare una tale impressione di potenza, di realismo, di aderenza storica del soggetto monetario alla realtà sociale e politica della nazione che intende rappresentare. Immaginiamo questo asse poderoso e ponderoso gettato sul piatto della bilancia dello scambio come una spada di Brenno: esso dava la sensazione precisa della potenza di Roma repubblicana. Diremmo, col linguaggio contemporaneo, che questo asse librale era un efficacissimo mezzo di comunicazione, il corrispettivo della stampa, della televisione, delle parate militari”. _____________________________ L’aes grave è sicuramente molto antico ma è difficile oggi, per noi, capire a quando risalga. Vista la fattura grezza e la natura di monete a valore intrinseco (quindi, concettualmente molto vicine al bronzo scambiato a peso), si potrebbe pensare che sia estremamente antico: in effetti, in passato gli studiosi ipotizzavano i Romani avessero iniziato a produrlo tra il VII e il V secolo a.C.[2]; del resto le leggi delle XII tavole, promulgate nel 451-450 a.C., parlano frequentemente di asses, per cui sembra logico che questa moneta dovesse esistere. Tuttavia i rinvenimenti archeologici fanno pensare che le monete di aes grave siano più recenti; fra i numismatici moderni solo Corradi[3] crede ancora in una datazione al V secolo a.C., mentre gli altri autori sono convinti che sia comparso nella seconda metà del III secolo a.C. (più precisamente tra il 338 e il 311 a.C.)[4] oppure addirittura agli inizî del III secolo a.C.[5]. La difficoltà di datare l’aes grave comporta tre problemi interpretativi. Primo problema: capire in che rapporti si pongano aes grave e monetazione romano-campana. Come si vedrà in seguito, le monete romano-campane sono diversissime e (almeno apparentemente) incompatibili l’aes grave: comprendono infatti, oltre al bronzo, anche argento e oro; sono coniate anziché fuse; presentano iconografie estremamente raffinate, anziché grezze; soprattutto, presentano anche quelle di bronzo pesi molto ridotti (fra 2 e 15 g, in un solo caso 19 g) e, quindi, non potevano avere un valore intrinseco. Eppure, sembra che i due sistemi monetarî siano stati in uso in contemporanea, tra la fine dei IV secolo e la metà del III. Per spiegare questa anomalia si è pensato che i Romani usassero l’aes grave per i commerci interni e per quelli con i popoli italici, le monete romano-campane invece per i commerci con i popoli magno-greci (culturalmente più evoluti e, quindi, abituati a monete meno grezze). Secondo problema: capire se l’aes grave sia un’invenzione romana, o meno. Infatti, monete di aes grave (oggi molto rare) furono emesse, oltre che dai Romani, anche da Etruschi e da numerosi altri popoli italici (Umbri, Osci, Apuli e popoli della costa adriatica), ma non si riesce a determinare quali di esse siano le più antiche. Inoltre, molte delle città che emisero aes grave furono assoggettate da Roma proprio tra la fine dei IV secolo e la metà del III, per cui non si riesce a capire se la loro monetazione sia iniziata prima della conquista romana o dopo. Per queste ragioni, alcuni storici pensano che l’aes grave sia stato inventato dai Romani ed essi abbiano esportato tale idea nelle altre città italiche; altri invece ritengono che sia nato in Etruria e poi copiato dai Romani; altri ancora che sia comparso in modo spontaneo e indipendente fra popolazioni differenti, a causa di circostanze economiche comuni. Terzo problema: capire quali siano le emissioni di aes grave più antiche, fra quelle stesse romane. Qui serve un’ulteriore precisazione: nei secoli, il peso medio delle monete romane (soprattutto quelle di bronzo, più limitatamente quelle d’argento) calò progressivamente. Questo successe perché lo Stato, quando non aveva abbastanza metallo prezioso da monetare ma doveva comunque pagare i debiti, cominciava a emettere monete un po’ meno pesanti. È evidente che queste iniziative spingevano i venditori ad alzare i prezzi delle loro merci (per ricevere una stessa quantità di metallo prezioso) e, per questo, tale meccanismo è oggi definito come “svalutazione” (di monete a valore intrinseco), un fenomeno ben conosciuto e che si è manifestato anche in altre culture antiche. Tanto premesso, si è visto che Roma emise assi librali di pesi medi differenti, 341 g, 327 g e 273 g; tuttavia, siccome Varrone afferma che “habet iugerum scripula CCLXXXVIII, quantum as antiquus noster ante bellum Punicum pendebat” (“lo iugero comprende 288 scrupoli[6], tanto quanto pesava il nostro asse prima della Guerra Punica”) molti studiosi[7] ritengono che l’emissione più antica non sia la più pesante, ma quella da 327 g. Le serie di aes grave più antica sarebbe allora la RRC 14 e sarebbe, secondo la testimonianza di Varrone, precedente alla prima della Prima Guerra Punica (“ante bellum Punicum”). Successivamente, l’Urbe sarebbe passata a emettere assi più pesanti, da 341 g, probabilmente perché, ampliando la sua sfera di influenza, avvertiva il bisogno di commerciare non solo con i Romani stessi, ma anche con altre popolazioni italiche (la libra da 341,1 g è infatti ritenuta lo standard italico). Appartengono a questa categoria di peso le serie RRC 18 e RRC 19. Dopo queste due serie, Roma sarebbe passata a emettere aes grave basato su un asse di 273 g. Al riguardo, ci sono due opinioni fra gli studiosi: o fu adottato (sempre per ragioni commerciali) lo standard della libra osco-latina, oppure si era tornati alla libra romana ma ne era stata effettuata la prima svalutazione (è significativo, infatti, che 273 sia i 10/12 di 327: lo Stato, forse, aveva cominciato a produrre assi contenenti solo 10 “once-peso” di metallo, sebbene continuassero essere suddivisi in 12 “once-moneta”). Fra le serie di questo periodo la più interessante è RRC 24, che presenta in tutti i nominali, al rovescio, una ruota a sei raggi: alcuni studiosi ritengono che, per tale ragione, anche queste monete fuse (come la didracma RRC 14/3, di cui si dirà in seguito) siano state emesse in occasione della costruzione della via Appia (312-308 a.C.; Crawford invece data questa serie al periodo tra il 265 e il 242 a.C.). ___________________________________________ Come detto, esistono monete di aes grave anche presso altre popolazioni italiche, oggi abbastanza rare (a testimonianza del fatto che ne furono emesse relativamente poche). Esiste però un gruppo di monete fuse che presenta interessanti peculiarità: la cosiddetta serie ovale, i cui nominali presentano tutti su una faccia una clava (attributo di Ercole), sull’altra il simbolo del valore (“I” per l’asse, “C” - ossia sigma uncinato - per il semisse e i pallini per gli altri nominali, sino all’oncia). Lo standard ponderale di riferimento dell’asse sembrerebbe di circa 151 g (ma non è certo). Le caratteristiche di questa serie sono: - la forma, che non è tonda (unico caso nella penisola) ma ovale e, peraltro, con una grande variabilità (ovali perfetti, rettangoli arrotondati, tronchi di cono, etc.); - la grande distribuzione del sestante, di cui sono stati rinvenuti molti esemplari da Trento a Termoli; - l’estrema variabilità del peso; in particolare, sebbene in teoria i sestanti dovessero pesare 25,17 g, in realtà gli esemplari rimasti vanno da 9 a 51 g. Gli studiosi ritengono, sulla base dei ritrovamenti, che queste monete possano essere state emesse da Tuder (odierna Todi, città umbra), Tarquinia o Velzna (città etrusche; la seconda, ridenominata “Volsinii” in epoca romana, oggi non esiste più). Per la data, tenuto conto del peso, si propone la fine del IV secolo (circa 320 a.C., epoca in cui gli etruschi usavano una libra di circa 150 g, detta appunto “etrusco leggera”) oppure la metà del III (epoca in cui i romani, a seguito di una forte svalutazione, cominciarono a emettere aes grave - cosiddetto “semilibrale” - con un asse di metà libra romana, quindi circa 163 g). Sussiste però, nella mia opinione, un’altra possibilità di interpretazione. Esiste infatti un rarissimo lingotto di aes signatum, coevo o poco più recente del “ramo secco”, che presenta il disegno della clava; è stato quindi ipotizzato un collegamento tra questo lingotto e l’aes grave ovale[8]. Allargando il discorso, potrebbe darsi che le monete ovali siano proprio un elemento di passaggio tra l’aes signatum più antico, con disegni di “ramo secco”, “lisca di pesce” e clava, e le monete tonde; in altri termini potrebbero essere una specie di “lingottini” e ciò spiegherebbe sia la forma (a metà tra il parallelogramma dei lingotti e il disco delle monete) sia la grande variabilità della forma stessa (derivante dal fatto che si trattava, appunto, di un primo tentativo di trasformare i lingotti in monete) e del peso (come appunto i lingotti con “ramo secco” e “lisca di pesce” che, appunto, avevano un peso abbastanza variabile). Infine, credo che dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità che queste monete siano riconducibili a Roma, quanto meno sotto forma di monete “coloniali”: infatti, questa è l’unica serie di aes grave (a parte, ovviamente, quelle romane) ad aver avuto una diffusione così ampia, che si spiegherebbe solo se fosse la moneta di una città capace di intrattenere commercî dal Trentino al Molise, come alla fine del IV secolo poteva essere Roma. Inoltre queste monete sono state rinvenute, nei ripostigli, insieme all’aes grave romano (ma questo accade anche per altri aera grava italici). Del resto, delle tre città proposte come sede della zecca, sappiamo che Velzna fu resa tributaria da Roma dal 294 a.C. e soggiogata nel 280, Tarquinia fu conquistata nel 295 e anche Tuder fu in qualche modo assorbita da Roma nel III secolo. Se la serie ovale fosse attribuita alla Roma arcaica, tuttavia, andrebbe chiarito il problema del peso, troppo leggero per gli standard romani arcaici[9]. NOTE [1] La più piccola unità di misura del peso usata a Roma era lo scrupolo, corrispondente (secondo l’opinione prevalente - non è sicuro) a 1,137 g. Sappiamo, da Varrone, che la libra romana pesava 288 scrupoli (cioè, 12 once da 24 scrupoli ciascuna), quindi appunto 327,45 g. La libra italica doveva pesare 300 scrupoli (341,10 g), quella osco-latina 240 (272,87 g). [2] Nel 630 a.C., secondo Marchi e Tessieri (1839); nel 539, secondo Eckhel (1792); nel 450, secondo Mommsen (1860). [3] Dissertazione sull'aes grave fuso e coniato di Roma e relative riduzioni, in “Nummus et Historia” VII, Formia 2003. [4] Secondo Hill, Cesano, Breglia, Alteri, Panvini Rosati, Babelon, Soutzo, Grueber, Haeberlin, Millingen, Sear. [5] Crawford, in particolare, propone il 280 a.C. [6] I Romani suddividevano in 288 scrupoli sia la libra (12 once da 24 scrupoli), sia il giorno e la notte (12 ore da 24 scrupoli), sia lo iugero; si chiamava quindi allo stesso modo (scrupulum, letteralmente “sassolino”) la più piccola unità di misura sia del peso, sia del tempo, sia della superficie. [7] Sono di questa opinione Thomsen, Crawford e Coarelli. [8] Ambrosini, Le monete della cosiddetta serie ‘ovale’ con il tipo della clava, in “Studi Etruschi”, 1987. [9] Roma, a seguito delle svalutazioni, arrivò a emettere aera grava con assi del peso di mezza libra (detti, perciò, “assi semilibrali”) ma solo alla fine del III secolo. Se le monete ovali fossero così recenti, non potrebbero rappresentare una forma di passaggio fra lingotti e monete tonde. In alternativa si potrebbe pensare che siano monete coloniali, commisurate alla libra etrusca leggera. ILLUSTRAZIONI Asse RRC 14/1 Asse RRC 24/3 Sestanti della serie ovale Pezzi di aes grave esposti nei musei italiani4 punti
-
Credo che le pubblicità siano uno dei modi in cui si finanzia il sito e di conseguenza la sua esistenza. Credo che sia meglio "sopportare" che non trovar più online "la casa dei numismatici"3 punti
-
Mi inserisco nella discussione dopo averla debitamente condivisa sui social vista l'importanza del tema trattato. Il venditore ha fatto un'altra vittima. Le monete proposte, e poi acquistate da un mio amico che non sapeva di questa faccenda, sono in parte della stessa tipologia di quelle già segnalate da Fabry, ma ne sono spuntate delle altre. Come vedete dalle foto allegate il bagattino con la madonna e il bambino deve essere il vero cavallo di battaglia di questo signore. Sono presenti però anche esemplari che almeno nell'iconografia provano a riprendere il "Redentore su trono" tipico dei grossi, oppure esperimenti di replica del mezzo soldo da sei bagattini a nome di Alvise Mocenigo. Il pezzo più strano è però sicuramente quello che presumibilmente dovrebbe replicare una bolla o sigillo datato dal cartellino XVIII o XVII secolo. Che dire, bisogna solo inchinarsi nei confronti di un vero fenomeno😆. Aggiungo inoltre che alla richiesta del mio amico di ricevere riferimenti circa la provenienza della moneta il signore ha segnalato un certo lotto di un'asta di inizi anni 2000: il dubbio che le monete non provenissero dal suo ingegno lì per un attimo mi ha sfiorato. Dopo aver con fatica recuperato il catalogo in questione, il lotto nomina tutte altre monete e di certo non questi abbozzi. Fine della storia. A parte gli scherzi, torniamo a collezionare monete vere, che trasudano storia e storie infinite e non pezzi di metallo battuti l'altro ieri. Buon collezionismo.3 punti
-
2 punti
-
La Numismatica, nel vero senso della parola, esisterà sino a quando esisterà la moneta, corrente o di epoca passata. Il collezionismo numismatico è un'altra cosa... In quel caso, da quando si cerca di lucrare sul collezionista, avete ragione la cosa è degenerata... Ma anche il collezionista che compra per lucrare (o almeno lo pensa) e non solo per collezionare e per piacere personale rischia di fregarsi da solo! Studiare le monete si può fare con monete di tutte le epoche, come si può collezionare monete di tutte le epoche... a volte collezionare monete di prezzo basso e di facile reperibilità è anche bello, senza pensare di mettere da parte un tesoro!2 punti
-
A mio parere il Crapanzano/Giulianini è perfetto, volendo potresti aggiungere pure il volume II° ed andare indietro nel tempo, va benissimo anche usato. In questa discussione una recensione.2 punti
-
2 punti
-
QUANDO A ROMA GOVERNAVANO I RE In origine, a Roma si diffuse l’idea che anziché barattare le merci fra loro, fosse più utile scambiarle con un bene prezioso e durevole; nacque così l’idea di barattare il bronzo con le merci. Questa cosa la sappiamo per quattro motivi: perché è stato così in tutte le civiltà di cui si hanno notizie (seppure usando beni-rifugio differenti: argento, conchiglie, etc.); perché ce lo riferisce Plinio (“rudi usos Romae”); perché ne resta memoria nel diritto romano, che prevede una serie di accordi compiuti “per aes et libram” (letteralmente “per mezzo del bronzo e di una bilancia”, ossia quindi “pesando il bronzo ricevuto in cambio”); e, infine, perché ci sono importanti testimonianze archeologiche, dato che sussistono diversi casi in cui i pezzi informi di bronzo sono stati rinvenuti insieme a monete vere e proprie. Interessantissimo, in proposito, è il deposito votivo scoperto nel 1852 a Vicarello e ora parzialmente ricostruito nei sotterranei del Museo Nazionale Romano: infatti, si trattava di un pozzo dove i fedeli gettavano una moneta (come oggi si fa a Fontana di Trevi) e lo strato più basso era composto da pezzi di bronzo informe; subito sopra di essi c’erano monete del tipo “aes grave” (di cui si dirà nel prosieguo), a testimonianza che i pezzi informi avevano effettivamente una funzione di tipo monetale ed erano in uso prima dell’aes grave. Per questo tipo di proto-moneta si usa oggi il termine di aes rude (sulla base del citato passo di Plinio, “rudi …”); il suo utilizzo è attestato in contesti archeologici databili dall’VIII secolo a.C. (forse, addirittura dall’XI) sino al IV. Quando Romolo fondava Roma, gli scambi si facevano con l’aes rude. Fra i pezzi di bronzo rinvenuti in contesti archeologici alcuni non sono informi, ma presentano forme ben precise, di natura geometrica (gocce, barre, lingotti, dischi, etc.) o naturalistica (ghiande, astragali, etc.). Non c’è alcunché di strano: se il bronzo veniva scambiato a peso, ben si poteva utilizzare anche metallo dotato di una forma, magari anche per immagazzinarlo meglio. Peraltro, fra quelli di forma geometrica, molti risultano frammenti, ossia sono stati tagliati (a caldo) per ottenere lo specifico peso di cui c’era bisogno. Alcuni studiosi usano la locuzione (inventata) aes formatum per distinguere queste proto-monete da quelle informi, ma sono solo un tipo di aes rude. È importante fare una precisazione: qualunque pezzo di bronzo poteva essere scambiato a peso, per cui oggi c’è un unico modo per distinguere un vero aes rude o formatum da un qualunque altro pezzo di bronzo, ossia ritrovarlo in un preciso contesto archeologico (come a Vicarello); poiché tuttavia i reperti archeologici non possono essere liberamente venduti, ne consegue che non c’è alcun modo di sapere se i pezzi in bronzo venduti da negozi e case d’asta siano effettivamente aera ruda o meno. Si possono inserire in collezione al fine di “riempire un vuoto”, ma occorre sapere che non c’è alcuna possibilità di avere certezza che siano antichi e, quand’anche lo fossero, di sapere se siano stati veramente scambiati a peso (e quindi effettivamente utilizzati come aera ruda) o fossero solo residui di fonderia. Un discorso a parte deve essere fatto per molti oggetti a forma di conchiglia, spesso in piombo e talvolta in bronzo, che vengono rinvenuti in scavi archeologici (databili ai secoli VI-III a.C.) eseguiti nella Pianura Padana e nell’area governata dagli Etruschi. Alcuni studiosi (ad esempio Franco Pezzi, Conchiglie di piombo, Mantova 2010) ipotizzano che siano proto-monete (e, quindi, aes formatum), ma altri non sono d’accordo e propongono che si tratti di oggetti votivi (spesso presentano un forellino di sospensione; la conchiglia simboleggiava la vulva, quindi la fecondità), oppure proiettili asimmetrici per le fionde o ancora pesi per le bilance. L’ipotesi più probabile è che si trattasse di decorazioni o paracolpi per utensili fittili, cui venivano saldate con mastici, argilla o di piombo fuso (spesso infatti presentano tracce di terracotta sulla faccia piatta), oppure di piedini per pentole metalliche. Comunque sia, nulla esclude che le conchiglie in bronzo venissero anch’esse scambiate a peso, come aes formatum, quando occorreva. ________________________________________ A partire da una certa data, ai pezzi di aes rude e formatum cominciano ad aggiungersi altri, che recano un segno inciso nel metallo. Si parla al riguardo, sulla base del citato brano di Plinio, di aes signatum; sotto questo nome si distinguono, tuttavia, tre categorie di oggetti abbastanza differenti. La prima categoria è composta pezzi di bronzo sostanzialmente informi, che recano tuttavia una o più contromarche (cioè, disegni elementari o lettere incise nel metallo). I più diffusi, rinvenuti sia in varie località dell’Italia centrale sia nei Balcani, presentano due contromarche sulle facce contrapposte, una costituita da un punto centrale e 4 raggi che se ne dipartono, l’altra da un arco di cerchio; si ritiene che raffigurino rispettivamente il sole e la luna. Haeberlin, importante numismatico tedesco del XIX secolo, dopo aver esaminato numerosi esemplari di questa tipologia di aes precisa che su altri pezzi esistono anche le combinazioni sole/nulla, sole/sole e luna/luna. Una seconda categoria, molto interessante, è quella del cosiddetto “ramo secco”. Si tratta di lingotti di bronzo a forma di parallelepipedo schiacciato, di peso variabile e fattura grezza, che recano un'immagine in rilievo somigliante a un ramo privo di foglie (più raramente sono presenti altri segni, altrettanto grezzi: lisca di pesce, clava, delfino, crescente lunare), la cui esatta natura è tuttavia discussa (secondo alcuni autori sono un espediente tecnico per far fuoriuscire i gas durante la fusione, oppure segni utili a facilitarne la frammentazione). I lingotti con “ramo secco” sono stati rinvenuti in tutta la penisola e in Sicilia, interi o (più spesso) tagliati in frammenti; quelli interi hanno pesi compresi fra 0,8 e 2,1 kg. Il fascino del “ramo secco” è quello di costituire un oggetto sicuramente utilizzato a Roma (esemplari sono stati infatti rinvenuti in scavi eseguiti in città) e sicuramente databile all’epoca in cui i re governavano sull’Urbe: infatti, un frammento di 0,425 kg rinvenuto presso il santuario di Bitalemi (Sicilia), in uno strato sigillato databile al periodo 570-540 a.C.[1], dimostra l’esistenza di questi manufatti nel VI secolo a.C. Una terza categoria di aes signatum è costituito da un altro genere di lingotti di bronzo, che si distinguono dai “ramo secco” per una iconografia più varia ed elaborata, una forma più definita, un peso più leggero ma anche più omogeneo (tra i 1,8 e 1,2 kg), definiti correntemente “quadrilateri”. A differenza dei “ramo secco”, sono molto rari. Gli studiosi sono concordi nel ritenere che siano stati prodotti a Roma (un tipo presenta anche la legenda “ROMANOM”, forma arcaica per Romanorum); Crawford, inoltre, è convinto che avessero funzione monetale, per cui li elenca nel RRC. Giova comunque precisare che altri studiosi non sono così sicuri che i quadrilateri fossero monete, sebbene indubbiamente alcuni siano stati rinvenuti in ripostigli[2] (a Santa Marinella, La Bruna, Ariccia) assieme a esemplari di aes grave. Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se uno dei tipi di aes formatum noti possa essere quello di cui parla Plinio, inventato da Servio Tullio (che avrebbe regnato dal 578 al 535 a.C.), e permetta così di affermare che la moneta, a Roma, è nata nel VI secolo a.C.; la risposta, tuttavia, sembra essere negativa. In primo luogo, se quella testimonianza fosse attendibile la prima moneta romana dovrebbe essere stata un lingotto con pecora, ma un simile lingotto non è stato rinvenuto (il che ovviamente rende improbabile, ma non impossibile, che sia esistito). I lingotti romani che ci sono pervenuti - ossia i quadrilateri -, peraltro, sono molto posteriori all’epoca regia, probabilmente dell’epoca compresa fra la fine del IV secolo a.C. e gli inizi del III, come dimostrano i ripostigli[3], la legenda ROMANOM (che, ancorché arcaica, appare molto posteriore al Latino di epoca regia, attestato dal lapis niger e dalla fibula praenestina) e la circostanza che un tipo rechi l’elefante (animale ignoto ai Roma prima della guerra contro Pirro, iniziata nel 280 a.C.). Certo, il “ramo secco” esisteva già all’epoca di Servio Tullio, ma non è affatto sicuro che avesse uno scopo monetale (è stato rinvenuto in contesti votivi a Bitalemi e a Terravecchia di Grammichele, ma qualunque oggetto d'arte o di valore, non solo le monete, può costituire l'offerta a un dio) e comunque la sua ampia diffusione fa ritenere che non fosse un manufatto esclusivamente romano (Roma, ai tempi di Servio Tullio, esercitava la sua influenza politica e commerciale su un territorio molto più piccolo). Il passo di Plinio non può quindi essere accettato alla lettera; probabilmente non è vero che la moneta, in Italia, sia stata inventata da Servio Tullio. ________________________________________ Come detto, varie civiltà arcaiche usavano un sistema proto-monetale consistente nel baratto tra le merci e un metallo prezioso; la moneta vera e propria nacque quando alcune autorità statali decisero di far punzonare questi metalli, per garantirne il peso (e quindi il valore) e velocizzare, così, i commerci (perché diveniva inutile pesare il metallo). Questa evoluzione si verificò dapprima in Cina (tra l’VIII e il VII secolo a.C.), poi, in modo separato e indipendente, in Asia Minore. Qui infatti era tradizione scambiare le merci con palline di elettro (una lega di argento e oro); a un certo punto (secondo la tradizione, nel VI secolo a.C., a opera di Creso re della Lidia; secondo gli studiosi moderni prima, attorno alla metà del VII secolo a.C.) i governanti cominciarono a far punzonare queste palline, che presentavano quindi un segno “in incuso” (cioè incavato, rispetto alla superficie della moneta). Poco dopo si cominciò ad apporre un segno anche sull’incudine e nacque, così, la tecnica della coniazione; inoltre, furono prodotte anche monete d’argento, oltre che di elettro. La moneta ricosse subito un grande successo; tutte le città greche dell’Asia Minore cominciarono a produrla e a diffonderla, attraverso la loro fitta rete di contatti commerciali, in tutto il mediterraneo, occidente compreso. Tornando alla Roma arcaica, sembra strano che all’epoca dei re dentro l'Urbe non si usassero monete (come si vedrà in seguito, le prime monete romane, aes grave e monete romano-campane, sono probabilmente databili alla fine del IV secolo a.C.) e ci si limitasse a ricorrere al baratto fra le merci e il bronzo a peso (aes rude e formatum). Si ritiene, infatti, che il tempio eretto nel Foro Boario nel 495 a.C. (l’Ara massima di Ercole) non fosse altro che la monumentalizzazione di un altare preesistente (e, quindi, risalente all’epoca regia), dedicato a una divinità locale assimilata al fenicio Melqart, protettore dei mercanti; sarebbe quindi questa una testimonianza indiretta che in quel luogo in epoca antichissima, addirittura prima della fondazione di Roma, esistesse un sito di scambio fra merci portate dai mercanti fenici e prodotti locali, ma è tuttavia difficile immaginare l’esistenza di scambi commerciali di portata addirittura internazionale senza l’utilizzo di un qualche genere di moneta. Per queste ragioni, uno studioso[4] ha ipotizzato che la Roma arcaica non abbia emesso proprie monete perché utilizzava proprio monete greche arcaiche; non c’è alcuna prova archeologica al riguardo, però c’è un importante indizio. Infatti, tra il 1862 e il 1867 sono stati rinvenuti una serie di ripostigli di piccole monete di tipo ionico, risalenti al VI-V secolo a.C., a Morella e Pont de Molins (in Spagna), Auriol[5] (presso Marsiglia, città fondata dai Greci) e Volterra, città etrusca; ciò dimostra che gli Etruschi utilizzavano monete greche. Siccome a Roma, nel VI secolo a.C., dominava una stirpe etrusca (i Tarquini), è molto probabile che monete analoghe siano state utilizzate anche nell’Urbe. NOTE [1] Si definisce “sigillato”, in archeologia, uno strato di terreno che appare chiaramente separato dagli strati sovrastanti (generati da eventi o attività successivi), senza interruzioni o intrusioni (causate da riutilizzo del terreno, erosione, contaminazione o distruzione) che potrebbero averne alterato il contesto originario. Gli oggetti rinvenuti in uno strato sigillato sono sicuramente databili all’epoca dello strato. Su questi scavi ha scritto Piero Orlandini in “Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica”, 1965-1967. [2] È molto frequente trovare gruppi di monete duranti gli scavi, perché nell’antichità nasconderle era un modo per conservare i propri risparmi; tali gruppi sono oggi definiti “ripostigli” o “tesoretti”. [3] È bene notare, tuttavia, che i ripostigli, anche quando possono essere datati con relativa sicurezza (come negli strati sigillati), forniscono solo indizi e non certezze sull’epoca di emissione delle monete, perché non si sa per quanto tempo esse abbiano circolato prima di essere state nascoste. [4] Amisano, La storia di Roma antica e le sue monete, vol. 1, 2004. [5] Siccome il rinvenimento di Auriol è il più numeroso (circa 2.130 monete), si parla al riguardo di “monetazione tipo Auriol”. ILLUSTRAZIONI Esposizione di aes del Museo nazionale Romano. Al centro, frammenti di aes rude raccolti in una bilancia. In alto, due quadrilateri, RRC 4/1 (con pegaso e ROMANOM) e RRC 7/1 (con raffigurazione di uno scudo). A destra, un “ramo secco” Ricostruzione del deposito di Vicarello, dal Museo Nazionale Romano Ramosecco del Museo Civico Archeologico "A.C. Simonini" Il "ramosecco" rinvenuto a Bitalemi Monetazione "tipo Auriol" rinvenuta a Volterra2 punti
-
PREMESSA Un amico, del tutto profano in materia numismatica, mi ha chiesto perché la monetazione romana repubblicana mi affascini tanto. Ho deciso allora di scrivere queste poche righe pensando a lui, a come spiegargli la mia passione. Questo non è quindi un trattato di numismatica, e men che meno di storia. Contiene sicuramente approssimazioni, probabilmente imprecisioni, forse errori. La scelta degli eventi narrati e delle monete che li illustrano è del tutto arbitraria e priva di una vera logica. Questo è un racconto, un tentativo di comunicare emozioni: le emozioni che promanano dalle monete repubblicane, per chi ama il ricordo di quei sette secoli in cui la città di Roma creò, dal buio della preistoria italica, la storia stessa dell'Occidente. INTRODUZIONE La storiografia romana antica è carente e contraddittoria in materia di monetazione. L’unico riferimento alle origini è un passo di Plinio[1], in cui si afferma che “Servius rex primus signavit aes. Antea rudi usos Romae Timaeus tradit. Signatum est nota pecudum unde et pecunia appellata” (“Il re Servio [Tullio] per primo segnò il[2] bronzo. Timeo[3] riferisce che a Roma, in precedenza, era in uso il[4] [bronzo] rude[5]. [Il bronzo] fu segnato con un’immagine di pecore e perciò [le monete] furono chiamate «pecunia»”). Questo passo è tuttavia ritenuto attendibile solo in ordine al fatto che venisse usato bronzo rude e poi segnato, mentre il riferimento a Servio Tullio è oggi ritenuto leggendario. La moneta più importante della storia di Roma, che continuò a essere emessa per molti secoli e si diffuse in tutto il mondo antico, fu il denario, moneta in argento. La data di introduzione del denario è molto dibattuta, come si vedrà; anche riguardo a essa abbiamo due testimonianze di Plinio[6], che però non aiutano perché sono molto oscure e parzialmente contraddittorie. La prima testimonianza afferma “Populus Romanus ne argento quidem signato ante Pyrrhum regem devictum usus est” (“Il popolo romano neppure usò argento segnato prima della sconfitta del re Pirro”, avvenuta nel 275 a.C.). La seconda invece riferisce che “Argentum signatum anno urbis CCCCLXXXV Q. Ogulnio C. Fabio coss. quinque annis ante primum Punicum bellum. Et placuit denarium pro X libris aeris valere” (“L’argento [fu] segnato quando erano consoli Quinto Ogulnio e Gaio Fabio, nell’anno 485 della città, cinque anni prima della prima guerra punica. E si decise che il denario avesse valore di 10 libre di bronzo”; l’anno indicato è il 269 a.C.): si noti che le due frasi, quella sull’ “argentum signatum” e quella sul “denarium”, sono giustapposte; considerato che l’opera di Plinio è estremamente sintetica, non è detto che egli parli in entrambre della stessa moneta. A partire da un certo anno in poi si verificò a Roma un fenomeno unico nella storia antica (e forse anche moderna): l’iconografia[7] dei denarî cambiava ogni anno; la città che dominava ormai il mondo poteva infatti permettersi il lusso di emettere migliaia di monete differenti e nessuno, nel suo vasto impero, dubitava che quei dischetti d’argento provenissero dall’Urbe. Questa mutevolezza si spiega con la volontà dei nobili che prestavano la loro opera come monetieri (ossia la magistratura preposta all’emissione delle monete, in Latino “tresviri aere argento auro flando feriundo”, “tre uomini responsabili di fondere e battere bronzo, argento e oro”), di utilizzare le immagini impresse sulle monete per fare pubblicità alla propria gens (e quindi, indirettamente, a sé stessi). Questa situazione ha portato gli studiosi moderni a cercare di indovinare l’anno esatto di emissione di ogni moneta (tenendo conto che in uno stesso anno potevano esserne emesse anche più di una); non c’è alcuna sicurezza su queste datazioni, però sono state ottenute incrociano una serie indizi[8] e pertanto si possono ritenere abbastanza indicative, per il periodo più antico (fine del IV e III secolo a.C.), e sostanzialmente attendibili, per quello più recente (II e I secolo a.C.). Questi sforzi sono stati raccolti e compendiati da Michael Crawford in un’opera fondamentale, Roman Republican Coinage, edito nel 1974, in cui egli elenca tutte le monete note al suo tempo (alcune, rarissime, sono state scoperte dopo[9]), le raccoglie in “serie”, assegna loro un numero di elenco e ne propone la datazione. Quindi, quando si trova scritto nei testi di numismatica “RRC 100/1” oppure “Cr. 100/1” significa “la moneta che Crawford, nel libro «Roman Republican Coinage», elenca come la n. 1 della serie n. 100”. ________________________________________ Esistevano nell’antichità due tecniche per produrre le monete, fusione e coniazione. Nella fusione, l’immagine della moneta viene riprodotta in negativo all’interno di uno stampo (di terracotta o, in epoca moderna, di materiali sintetici), dopo di che viene fatto colare il metallo fuso all’interno dello stampo; quando il metallo si raffredda viene aperto lo stampo e se ne estrae la moneta. I disegni che nell’antichità si potevano ottenere con questa tecnica erano, tuttavia, molto molto grezzi. Nella coniazione, invece, l’immagine della moneta viene riprodotta in negativo sulla faccia di un’incudine e su quella di un martello, detto “martello di conio” o anche solo “conio”. A questo punto si appoggia sull’incudine un dischetto di metallo riscaldato, detto “tondello” (preparato prima, per fusione) e lo si batte con forza con il martello, imprimendovi così il disegno. La coniazione, a differenza della fusione, permette di realizzare monete con disegni piccolissimi e precisissimi. Osservando le differenze nei disegni delle singole monete (dovute al fatto che i conî venivano incisi a mano), si può oggi distinguere quali di esse provengono dallo stesso conio e, quindi, calcolare quanti conî sono stati usati per produrre i pezzi giunti fino a noi. Supponendo che ciascun conio di rovescio venisse sostituito, a causa dell’usura, dopo che erano state battute (secondo le diverse opinioni degli esperti moderni) da 10.000 a 30.000 monete (un po’ meno per quelli di dritto, maggiormente esposti all’usura), si può oggi stimare il volume di emissione di una moneta; talvolta, ammonta a milioni di pezzi. Quando si illustrano le due facce di una moneta, ci si riferisce a esse come “dritto” e “rovescio”. Nelle monete coniate, il rovescio è la faccia risultante dal colpo di martello, il dritto quella appoggiata sull’incudine. Siccome inoltre i Romani avevano l’abitudine di raffigurare spesso, al dritto, la testa di un dio (e in seguito quella dell'imperatore), si parla di “dritto” anche per le monete fuse, con riferimento alla faccia su cui è presente tale testa. ________________________________________ Viene naturale chiedersi, a questo punto, quanto valevano le monete romane? Possiamo farcene un’idea con riferimento alla metà del II secolo a.C. Polibio infatti narra (II, 14, 35) che in Gallia Cisalpina, ove egli si recò fra il 151 e il 150, “un medimno siciliano di frumento costa per lo più 4 oboli, uno d’orzo 1 obolo e un metrete di vino costa quanto un medimno di orzo”; egli stesso riferisce che l’obolo, moneta di tradizione greca, era cambiato per 2 assi romani. Considerato che un medimno (misura di capacità corrispondente a 51,8 l) poteva contenere circa 40 kg di grano mentre il metrete era paro a 39 l, si ricava che con una asse si potevano comprare 5 kg di grano o 20 l di vino. Si capisce tuttavia, dal resoconto di Polibio, che egli riteneva questi prezzi estremamente bassi; supponendo che a Roma essi fossero circa 5 volte più elevati[10], ne consegue che con un asse si potesse comprare 1 kg di grano oppure 4 litri di vino (non pregiato). Si può quindi affermare che a metà del II secolo a.C. un asse valeva circa 4 €[11]; per quanto riguarda il denario, non sappiamo se all’epoca fosse cambiato a 10 o 16 assi (ci fu una riforma, proprio in quegli anni), per cui poteva valere da 40 a 65 €. Ovviamente, prima di tale data l’asse valeva di più, in seguito invece di meno (perché ci fu un costante fenomeno di svalutazione, nei secoli). Sappiamo che un secolo dopo, ossia alla metà del I secolo a.C., i braccianti di Pompeo ricevevano da 5 a 16 assi al giorno. NOTE [1] Naturalis Historia, XXXIII, 3, 13. [2] Nel senso di “fece apporre un segno al”. [3] Storico di cui non ci è pervenuta l’opera. [4] Letteralmente: “riferisce gli utilizzi in precedenza, a Roma, del”. [5] Nel senso di “grezzo”. [6] Naturalis Historia, XXXIII, 42 e XXXIII, 44 [7] In numismatica, per “iconografia” o “tipologia” si intende la scelta dei “tipi”, ossia dei disegni riportati sulle due facce delle monete. [8] Fra cui: i risultati archeologici (se una moneta è rinvenuta nelle rovine di un tempio distrutto nell’anno X a.C., deve essere precedente; se due monete sono rinvenute assieme e una è nuovissima, l’altra molto usurata, è probabile che la seconda sia stata emessa prima); il peso (nei secoli, il peso delle monete è diminuito sempre più); l’identificazione del monetiere (se una moneta è firmata “Pinco Pallo” e sappiamo che un certo Pinco Pallo è stato console nell’anno X, supponendo che sia la medesima persona se ne ricava che possa essere stato monetiere alcuni anni prima di X); il significato delle immagini (una moneta che inneggia alle vittorie di Silla non può essere stata emessa quando a Roma governavano i seguaci di Mario). [9] Tutte le monete repubblicane oggi note possono essere visionate nell’archivio al link https://numismatica-classica.lamoneta.it/. [10] A conferma di questa supposizione rileva la notizia per cui, poco dopo il 124 a.C., la lex frumentaria di Gaio Gracco impose di riabbassare i prezzi del grano (che, nel frattempo, erano aumentati) a 6 assi al modio; considerato che un modio (circa 8,75 litri) poteva contenere circa 7 kg di grano, si ricava che Gracco fece riabbassare i prezzi a 1 asse per 1,15 kg. [11] Solo per dare un’idea, dato che un conto esatto imporrebbe di conoscere il prezzo di un ampio paniere di prodotti.2 punti
-
Al rovescio credo sia il monogramma di Gesù, simbolo cristologico una rappresentazione del nome di Gesù. IHS2 punti
-
Salve,data l' impossibilità per la tecnologia dell'epoca di ricavare argento puro dalla composizione,essendo composta da tracce di più minerali come piombo stagno oro,etc con il tempo queste si manifestavano a secondo delle loro caratteristiche a volte omogeneamente dando vita secondo me a belle patine a volte a chiazze.molte volte sono indice di genuinità per l'occhio esperto.qualche chimico sarà più esaustivo2 punti
-
Oltre alla data mettiamo l’indirizzo che e’ sempre all’Hotel Sina De La Ville, Via U. Hoepli 6, Milano.2 punti
-
io ho già preso questa decisione. di IPZS mi tengo solo le divisionali e qualcosa in più se riesco. ora ho solo il problema di "liberarmi" degli euro a condizioni eque..2 punti
-
Innanzitutto Vi ringrazio tutti per le informazioni, sapevo della bassa conservazione leggendo da tempo i vostri post e quindi ero preparato in questo senso. Le banconote verranno conservate in modo appropriato essendo secondo la mia umile opinione opere d'arte. La ricerca per queste banconote mi ha portato ad arricchire la mia libreria di due volumi di numismatica che mi hanno allietato la mattinata gradevolmente.. .. mi chiedevo da neofita di queste meraviglie se secondo voi ho fatto un buon acquisto bibliografico .. ?2 punti
-
La tua domanda è un po' generica, bisognerebbe capire di quali monete parli. Ti do comunque un quadro conoscitivo generale. In primo luogo, dobbiamo distinguere fra monete repubblicane "ufficiali", monete "coloniali" (emesse dalle coloniae per loro esigenze), monete "locali" (emesse da città o comunità sostanzialmente assoggettate a Roma, ma formalmente indipendenti) e monete "non ufficiali" (emesse piccole comunità, di carattere quasi privato). Moltissime monete coloniali, locali e non ufficiali provengono dalla Campania. Presumo però che tu ti riferisca alle "ufficiali" (ossia sostanzialmente, con qualche eccezione, le monete censite da Crawford nel catalogo RRC). Ebbene, anche molte "ufficiali" furono emesse zecche collocate fuori Roma, per tre ragioni diverse: 1) in origine Roma non aveva la capacità tecnica di produrre monete coniate (la zecca dell'Urbe fu inaugurata nel 269 a.C., mentre le prime monete romane coniate risalgono a 50 anni prima), per cui ne appaltava la produzione ad altri popoli italici o italioti; 2) oltre alla zecca urbana, il Governo della Repubblica si servì saltuariamente di zecche site nelle colonie (Luceria, Canusium, Narbo Martius) o nelle capitali delle province (ad esempio, il denario RRC 365/1 è attribuito a Massalia, il 393/1 a una qualche zecca ispanica, il 445/1 ad Apollonia, etc.); 3) i magistrati dotati di imperium avevano anche la potestà di emettere monete e, pertanto, quando le legioni erano in marcia coniavano proprie monete in zecche cosiddette "itineranti". Non si sa dove siano state emesse le monete della categoria (1), ma è estremamente plausibile che molte provengano dalla Campania dove Capua (all'epoca, sembra, la città più popolosa d'Italia) offrì spontaneamente sè stessa a Roma (con la cosiddetta "deditio"), diventandone parte, e portandole in dote una zecca di livello tecnico molto elevato. Non conosco monete della categoria (2) attribuite alla Campania, ma ci sono molte emissioni ritenute provenienti dall'Italia centro-meridionale; è probabile che alcune provengano quindi anche dalla Campania, ove c'erano varie colonie di diritto latino sicuramente dotate di zecca (lo sappiamo, perché coniarono monete "coloniali" per le proprie esigenze). Per quanto infine riguarda la categoria (3) ... le legioni coniavano là dove si trovavano stanziate, sicuramente sarà successo anche in Campania. Detto tutto ciò, ti chiederai su che base una moneta è attribuita a una zecca campana, piuttosto che a quella di Roma o - tanto per dire - a quella di Apollonia. I criteri sono quattro e vengono utilizzati incrociandoli tra loro: 1) i luoghi in cui le monete sono state rinvenute; 2) il loro stile (alcune hanno uno stile dei disegni chiaramente differente da altre, attribuibile alle tradizioni degli incisori - resta da capire, ovviamente, quali "mani" operassero a Roma e quali in altre località); 3) i segni e le legende presenti nell'iconografia (ad esempio, la "L" con grafia osca è attribuita a Luceria, la spiga di grano alla Sicilia); 4) l'abbinamento a fatti storici (ad esempio, RRC 359/2 reca la legenda "L. SVLLA" ed è datata all'84-83 a.C., per cui dovrebbe essere stata emessa ad Atene ove, all'epoca, Silla stazionava). Come vedi, nessuno di questi criteri fornisce risposte tassative; in materia pertanto non ci sono certezze, solo ipotesi più o meno probabili.2 punti
-
E' successa la stessa cosa anche a me con la ciambella Vespucci, fattene una ragione, ho scritto più volte per avere delle delucidazioni in merito ma nulla ( e non ne sono sorpreso), per quanto mi riguarda la mia collezione IPZS è terminata.2 punti
-
o le code sul sito si sono formate perché oggi emettevano anche la moneta per Spadolini?? 🤣2 punti
-
DE GREGE EPICURI Non credo ci sia stata alcuna comunicazione/garanzia scritta. Anch'io sono pessimista: mi pare che il comune sia sensibile (da qualche anno) solo agli eventi che "rendono molto" e attirano grandi masse di turisti e cittadini. Credo sarebbe buona cosa bombardare di messaggi preoccupati e indignati l'assessore alla cultura, la segreteria generale e anche il sindaco. Visto che sono sensibili solo alla quantità...2 punti
-
Nonostante la tiratura delle Carli/Ripa del 1961 sia la più bassa per questa tipologia (ricordo che anni fa erano classificate rare), in queste condizioni il mercato collezionistico tende ad emarginarle ugualmente. Queste due presentate non hanno particolarità tali da generare un plus valore, concordo sulla conservazione già espressa e mi fermerei ad un massimo di 15 euro per entrambe. Nel 1961 abbiamo l'ultima emissione della Banca d'Italia per questo taglio, la prerogativa di emettere biglietti da 500 lire passava al Ministero del Tesoro. Sono andati anzitempo in prescrizione rispetto tutti gli altri tagli in uso in quel periodo, hanno avuto la cessazione del corso legale dopo l'estate del 1966 e sono stati accettati per il cambio sino al 31 dicembre dello stesso anno. Proprio nel 1966 va in circolazione il Biglietto di Stato da 500 lire mod. Aretusa.2 punti
-
NUOVA EDIZIONE 2025 - NOMISMA SPA Dopo circa sette anni l’autore Pietro Magliocca presenta il nuovo e aggiornato Manuale delle Monete di Napoli (periodo 1674 – 1860), un’opera indispensabile per i collezionisti e gli operatori del settore. Questa seconda edizione porta alcune novità: l’inserimento di monete rarissime e di prova, una completa rivisitazione rispetto all'edizione precedente con l’aggiornamento dei prezzi delle singole monete e l’aggiunta di cenni storici relativi al periodo trattato. È stata, inoltre, migliorata la grafica e sono stati realizzati ingrandimenti specifici dei particolari delle varianti catalogate. Nomisma Edizioni 2025 Autore: Pietro Magliocca Ha collaborato: Giovanni Massa Formato 17 x 24 cm 504 pagine a colori Copertina cartonata 130 euro In spedizione dal 19 maggio 2025 https://nomisma.bidinside.com/it/sitem/28788/pietro-magliocca-manuale-delle-monete-di-/1 punto
-
Gli ultimi arrivi Tallero senza data. Esemplare splendido al dritto, al rovescio il conio è stanco Tallero del 1607, condizione non eccelsa, ma millesimo rarissimo: 5 esemplari noti, di cui uno nella Collezione Reale, più altri 2 con data corrotta di difficile lettura. un bell'R4 Tallero del 1613. Un R5. In tutto sono noti 2 esemplari1 punto
-
Controlla ogni tanto ebay ed anche amazon, il mio proviene proprio da quest'ultima piattaforma di vendita, l'ultima edizione del secondo volume è sempre quella del 2010, non è facile acchiapparlo come il primo volume ma ogni tanto capita.1 punto
-
Riccardo Paolucci è andato nel mondo dei più ne da il triste annuncio anche Panorama Numismatico di maggio 2025, di cui egli aveva contribuito con i suoi articoli fin dal 1984. Studioso di Zecche di Gorizia e di Trieste soprattutto, sulle quali pubblicò diversi libri. Gestì diverse case d'aste in Lussemburgo, a Londra ed anche in Italia. Esperto in bibliografia numismatica: riusciva a reperire qualsiasi libro di Numismatica. R.I.P. odjob1 punto
-
I cataloghi che hai acquistato vanno benissimo, magari raccontano un po’ meno la storia e le curiosità che ci stanno dietro ogni singola tipologia ma per un neofita va benissimo iniziare così. Se vuoi approfondire un po’ di più il punto di vista divulgativo ti potrei consigliare di seguire sui social la mia pagina “Collezione Giaquinta”. Li sopra da anni parlo di cartamoneta, do consigli e uso sempre fonti affidabili che cito sempre. Se ti va di seguirmi sei il benvenuto. Senza dimenticare che comunque siamo sul forum numero uno in Italia, tutti gli utenti presenti in questa sezione sono grossi esperti di cartamoneta, quindi per ogni dubbio puoi benissimo chiedere qui! Ciao e una buona serata.1 punto
-
Ciao Pino,penso che dopo quasi un mese di ricerche non aver trovato nemmeno una moneta che si avvicina,deve essere per forza un inedito.Per quanto riguarda chi l ha emessa,se lo dicono gli esperti e anche Nino the best lo conferma penso che l identificazione dovrebbe essere completa. 🙂1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Bronzo pseudoautonomo del Koinon di Macedonia, tempo di Alessandro Severo, zecca di Beroea che raffigura la testa diademata di Alessandro Magno al dritto e lo stesso Alessandro in piedi, di fronte, con lancia rovesciata e parazonio al rovescio (Nomos, Obolos Web Auction 9, lot 670). Lot 670. Startpreis: 75 CHF. Ergebnis: 140 CHF. Beschreibung MACEDON. Koinon of Macedon. Pseudo-autonomous issue, temp Severus Alexander, AD 222-235. (Bronze, 28 mm, 12.80 g, 1 h), Beroea. AΛEΞANΔΡOΥ Diademed head of Alexander the Great to right. Rev. KOINON MAKEΔΟΝΟΝ NEΩ Alexander III standing facing, head right, holding reversed spear and parazonium. AMNG III 359. Rare. Glossy dark patina with fine details. Early example of the series. Nearly very fine. apollonia1 punto
-
Medaglia devozionale, rame/ottone, coniata, della seconda metà del XIX sec. - Olivieri. Napoli.- Ciao Borgho1 punto
-
Il discorso vale anche per gli euro, a meno di non buttarsi sulle commemorative, che però sono monete solo di nome. La numismatica italiana è finita con Vittorio Emanuele III.1 punto
-
Entrambe queste emissioni appartengono alle serie RRC 38, che Crawford attribuisce alla zecca di Roma. Non so su che base Artemide le attribuisca a Cales o Capua ma, come ti ho detto, in materia non esistono certezze; potrebbe anche essere. Cales (odierna Calvi Risorta) era una delle colonie di diritto latino che battevano moneta "coloniale"; potrebbe quindi benissimo aver emesso anche monete "ufficiali", come queste. Capua rimase fedele a Roma fino a poco dopo la disfatta di Canne (216 a.C.) e potrebbe benissimo, quindi, aver emesso queste monete, se la loro datazione è effettivamente 217-216 (anche le date, in materia, non sono sicure; Crawford propone, per questa serie, 217-215)1 punto
-
1 punto
-
Si anche a me è già successo, pure con la ciambella. E mi sa che anch'io termino con IPZS. Vedremo come va a finire col Vaticano ....altrimenti termino tutto per quanto riguarda gli Euro, vendo quello che ho e forse passo al Regno....forse!!!1 punto
-
Da quanto scrivi credo che tu sia piuttosto un ottimista anziché il contrario....le amministrazioni pubbliche non rilasciano mai nulla, nemmeno per opere di interesse internazionale (e anche quando lo fanno rimangono comunque nel vago indicando "tempistiche come da normativa"), figuriamoci se prendono in considerazione un mercatino rionale!1 punto
-
È proprio Zenonide, è certamente ufficiale. Direi Costantinopoli, ma la classificazione è incerta a causa del dritto molto consumato. Comunque bel pezzo difficile da mettere in collezione1 punto
-
1 punto
-
Salve Pino,avevo ventilato quella ipotesi,comunque per stile di area italica1 punto
-
poi in basso al mento c'è un cratere. il punto di separazione più piccolo.. le lettere..1 punto
-
Io devo essere un po' la pecora nera dei collezionisti: quelle rare volte che ho sostituito un pezzo della mia collezione è stato solitamente per fare un downgrade: possedendo un esemplare in SPL mi capitava magari di trovarne un altro in BB; compravo il secondo, poi rivendevo il primo recuperando le spese e avendo un budget extra da reinvestire per altri acquisti... Chiaramente una moneta in FDC è più bella di una in BB, ma di solito a me piace di più la seconda, con il vissuto che porta con sé. Se il discorso pare strano, penso possa starci un parallelismo di questo tipo: Jennifer Lawrence è indubbiamente più bella di mia moglie, ma a me piace di più la seconda... E apprezzo anche monete forate e appiccagnolate, segno del riuso dell'oggetto monetale. Non accetto invece monete bulinate, per il medesimo motivo: con il bulino si cerca di cancellare la storia di una moneta vissuta per renderla più appetibile al mercato collezionistico. Quindi concordo con chi dice che una moneta debba piacere e non debba altrimenti essere collezionata, ma ricordatevi che la conservazione non è (o quantomeno non dovrebbe essere) l'unico parametro della numismatica.1 punto
-
Questo l’esemplare esitato alla NAC AG n. 92/1a Lotto 72 del 23/5/2016 con la seguente descrizione: GREEK COINS Umbria, Hatria As circa 275-225, Æ 421.00 g. Head of Silenus facing, with animal’s ears; on r., L. Rev. Dog lying asleep; below, H – AT. Haeberlin p. 205, 2 and pl. 74, 1 (this coin). Sydenham Aes Grave 180. Weber 216 (this coin). Campana p. 233, 1. ICC 236 (this coin illustrated). Historia Numorum Italy 11. Extremely rare and undoubtedly the finest specimen known of this interesting and intriguing issue. An exceptionally detailed portrait and a superb green patina. Good extremely fine Ex Naville XI, 1925, Levis, 44, and New York sale XIV, 2007, 3 sales. From the Weber collection. Hatria (now Atri in the Abruzzo region of Central Italy), a town of Picenum in eastern Italy, was situated close to the Adriatic Sea between the rivers Vomanus and Matrinus (modern Vomano and La Piomba). The town of Matrinum located at the mouth of the latter river served as its principal port. Although Hatria’s origins are obscure, it was perhaps originally an Etruscan colony, first settled by colonists from Atria in Padanian Etruria. During Rome’s steady rise to dominance over central Italy during the 4th and 3rd centuries B.C., the town came under its sway, becoming a Latin colony shortly after 290 B.C. The city flourished under Rome’s patronage and later, after the roads were built, served as the junction of the Vias Salaria and Valeria. The city was attacked by Hannibal in 217 B.C., and eight years later in 209 B.C. it was one of the eighteen Latin colonies that stayed loyal to Rome during the Second Punic War, providing support to its ally in the form of both material aid and soldiers. During imperial times, during the reign of the emperor Hadrian who himself was from Spain but whose family hailed from the region of Hatria, the city received the title Colonia Aelia Hadria. Hatria’s small and rare coinage must be considered in light of the developments of coinage at Rome. At Rome and in central Italy, while bronze was plentiful, both silver and gold were extremely scarce, with the latter being practically non-existent. Commerce therefore, when not in kind, was facilitated by the use of bronze ingots. Initially these came in the form of lumps, called by numismatists aes rude, sometimes found inscribed or counterstamped, and later formed into figural quadrilateral bars and other recognizable shapes, often erroneously referred to by numismatists as aes signatum. Around 280 BC or perhaps a little later, lead-rich ingots formed into the shape of quadrilateral bars similar to the earlier figural bars and occasionally bearing the legend ROMANOM ”of the Roman” appear. These probably served as war booty during the Pyrrhic and First Punic Wars (275-241 B.C.). Concurrent with these currency bars was the introduction at Rome of the first cast round coins, struck from the same sort of leaded bronze, all clearly denominated with symbols and pellets and based on a libral as of 324 grams to which they readily adhere. It was at precisely this same time that coinage at Hatria and other central Italian mints subject to Roman influence first appears. The coinage of Hatria itself is quite scarce, and consisted of cast round coins in nine denominations from as to semuncia. Attested Provenances for the early cast issues of Hatria are Rimini and Atri itself. The largest, the as, was struck at a standard of about 372 grams, although specimens as heavy as 435 grams and as light as 323 grams are known. Other than the head of Silenus found on the as and the Pegasus which appears on the quincunx, the types are a mixture of both animate and inanimate objects common in everyday life, such as male and female heads, anchors, cocks and fish, shoes and craters, as well as letters and denominational marks. The types used on the as were the facing head of Silenus, depicted bald and bearded, with thick lips, slanted eyes, and having the downturned ears of a mule, on the obverse, and on the reverse a sleeping dog curled up to the right. The legend HAT (sometimes appearing retrograde) can be found on either the obverse or reverse, as can the denominational markings I or L that often appear in the field. It is not known why these types were chosen, but it could be that viticulture played some role in the Hatria’s economic development; if so, as the tutor and drinking companion of Bacchus, Silenus would have made an appropriate type for the city’s first and only coinage. The dog, an animal noted for its ability to hunt and to protect, has always been man’s companion, and its use here perhaps was meant to compare the fierce loyalty it showed its owner to Hatria’s loyalty to Rome. The specimen offered here is undoubtedly one of if not the finest known examples of the type if not the finest. Venduto a 47.500 CHF con partenza 28.0001 punto
-
Se non fosse che il D ed il R non sembra combacino: Medaglia RDT 1983 per Martin Luther https://bawue.museum-digital.de/object/18033 hai tagliato le spade di Meißen (Meissen) vedi un po' qui:1 punto
-
Buongiorno, bellissima discussione sui denari della gens Carisia ricca di spunti. Colgo quindi l'occasione di postare questo denario di lecita provenienza appena entrato in collezione: 3,70g d/ Vittoria a destra (busto) dietro S•C (Senato Consulto) r/ Vittoria su quadriga che procede verso destra in esergo T• CARISI Zecca di Roma RRC 464/51 punto
-
1 punto
-
Buon fine settimana a tutti, Poiché nessuno si esprime, provo a dare il mio opinabilissimo parere. @sgama1975 La moneta oggetto della discussione è un R4 ed è oggettivamente una moneta che raramente si vede in asta, per cui è difficile avere dei riferimento certi. Ma è anche una moneta di nicchia, nel senso che sono relativamente rari anche i collezionisti a questa interessati. Purtroppo le zecche Siciliane attirano collezionisti ma fino ad un certo punto e non ai livelli di altre zecche italiane. La moneta inoltre non fa tipologia, chi colleziona per tipologia (tanti, ivi incluso chi scrive) si limita a collezionare un anno comune in ottima conservazione, senza spendere troppo. Questo limita ulteriormente la platea dei possibili acquirenti. Io sono un pò più esperto di monete medioevali Siciliane, e monete similari per rarità, conservazione e metallo (il rame tira di meno rispetto ad argenti e ori) sono vendute intorno ai 500-600-700 Euro. Mettendo insieme tutte queste informazioni, io presumo che il suo valore non sia così facilmente definibile, perchè dipende da quanti collezionisti siano interessati a quella moneta in quel momento, e con quale disponibilità economica si presentano sul mercato sempre in quel momento. Monete molto rare e di nicchia compiono salti di prezzo di vendita impressionanti. Magari un anno 5-6 collezionisti si contendono una moneta e questa è venduta ad un prezzo elevato. 2-3 anni dopo vi è un solo collezionista interessato nello specifico momento in cui la moneta è messa in asta, e la moneta si vende alla metà o anche meno del prezzo precedente. Dato che non è possibile associarle un valore ben definito, ti dico cosa farei io in caso volessi venderla. La affiderei ad una casa d'aste (seria, che sa cosa vende!) e chiederei un prezzo di partenza di 400-max 500 Euro (prezzo minimo al quale questa moneta andrebbe ceduta secondo me) come protezione qualora non ci sia in quello specifico momento nessun compratore interessato. Poi l'asta darà il suo valore alla moneta. Se si è fortunati, diversi utenti italiani e spagnoli, gli unici che collezionano questa tipologia, se la dibattono e il valore può probabilmente avvicinarsi ai 1000 euro o superarlo di poco. Se sono sfortunato e vendo nel momento sbagliato, la moneta andrà alla base sopra specificata o invenduta (meglio invenduta che svenduta). In definitiva, se proprio vogliamo darle un valore, secondo me potremmo associarle un range tra i 400 e 1000 Euro, in funzione dello stato del mercato nel momento in cui vendo (chiamiamolo anche potere della botta di culo). Vendere ad un commerciante questo tipo di moneta potrebbe invece essere svantaggioso, in quanto il commerciante, dovendo rivendere e assumendosi il rischio di non trovare collezionisti interessati, ti darà il 30% in meno del prezzo minimo cui sa che quasi certamente riuscirà a rivenderla (se ipotizziamo il prezzo minimo sia 400 Euro, credo che non ti darà più di 250-300 Euro). Quello che scrivo ovviamente è e rimane un parere personale, che però spero stimoli l'intervento di altri collezionisti, magari più esperti di me delle monete del 1600-1700. Buon fine settimana!!1 punto
-
È il diktat che ogni studioso o amatore di numismatica dovrebbe seguire!! Anche perché i libri scritti sono sempre punti di partenza per altre ricerche e mai punti di arrivo1 punto
-
Prima si cerca di capire perché manca la M,poi si fa una ricerca per verificare se esistono altri esemplari simili... Se poi si avrà la certezza che si tratta di omissione volontaria della M allora si può stabilire un grado di rarità,ma, ripeto, bisogna avere un buon margine di certezza che la mancanza della M sia volontaria e non causata da problematiche in fase di coniazione, in tal caso rimane solo una curiosità...1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?








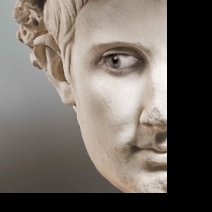








.thumb.jpg.49bf7893ab8deb0b9efbfc02c41b7421.jpg)












