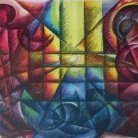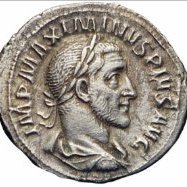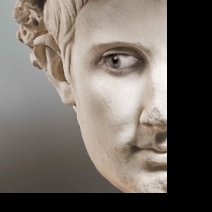Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 06/18/25 in Risposte
-
Perdonatemi una battuta: Da tutti i post che vedo su questi fantomatici errori di conio, mi viene da pensare che se tutte le ore perse dagli italiani a ricercarli fossero utilizzate a lavorare alzerebbero di due punti il PIL!4 punti
-
3 punti
-
IL SIMBOLO DELLA POTENZA DI ROMA: L’AES GRAVE A Roma l'emissione di moneta arrivò seguendo due strade: la cosiddetta “monetazione romano-campana”, di cui si dirà oltre, e l’aes grave. Si definisce aes grave un sistema di monete di bronzo, fuse, a valore intrinseco (cioè, valevano tanto quanto il metallo che contenevano). In sostanza, la nascita della moneta a Roma è simile a quella avvenuta in Asia Minore, con la differenza che là i governanti decisero di garantire il peso dell'elettro, qui quello del bronzo; là fu adottata la punzonatura (che si può ritenere una forma arcaica di coniazione), qui la fusione. Le monete di aes grave sono quasi lingotti circolari: hanno infatti un peso ragguagliato all’unità di misura in uso a Roma, la libra, suddivisa in 12 once. Le monete principali, del peso e del valore di una libra, erano gli asses (“assi librali” in Italiano) nome probabilmente derivante da asser, “palo”, essendo il palo la rappresentazione visiva dell’unità (come per noi, oggi, l’indice alzato); il simbolo del valore impresso su di essi era infatti “I”. Furono inoltre emesse le frazioni dell’asse, ossia semisse (mezzo asse, simbolo “S”), triente (la terza parte dell’asse, ossia 4 once, simbolo “····”), quadrante (“···”), sestante ( “··”) e oncia (“·”). Più raramente fu emessa la semioncia (simbolo “S”) e, ancor più raramente, i multipli dell’asse, ossia dupondium (due assi, “II”), tressis (“III”) e quincussis (“V”); in un solo caso (la moneta RRC 41/1) fu emesso il decussis (“X”). Ma quanto pesava una libra (e, quindi, un asse)? Le monete, proprio per la loro fattura grezza, presentano una grande variabilità (ad esempio, gli esemplari dell’asse RRC 14/1 oggi noti vanno da 240 a 400 g). Tuttavia si ritiene che Roma abbia utilizzato, nel tempo, tre differenti valori di riferimento: la libra propriamente romana da 327 g, la libra italica da 341 g e quella osco-latina da 273 g[1]. Le monete di aes grave sono quindi massicci pezzi di metallo, di fattura grezza, con iconografie assolutamente essenziali: molta sostanza e poca forma. Il loro fascino è proprio quello di simboleggiare la più antica cultura romana, improntata a rusticità, praticità, sobrietà, ben lontana dalla raffinatezza e dal gusto del bello che connotavano, invece, la cultura magno-greca (e che traspaiono anche nell’iconografia della monetazione romano-campana). Scrisse Romolo Calciati nel 1978: “Raramente una moneta riesce a dare una tale impressione di potenza, di realismo, di aderenza storica del soggetto monetario alla realtà sociale e politica della nazione che intende rappresentare. Immaginiamo questo asse poderoso e ponderoso gettato sul piatto della bilancia dello scambio come una spada di Brenno: esso dava la sensazione precisa della potenza di Roma repubblicana. Diremmo, col linguaggio contemporaneo, che questo asse librale era un efficacissimo mezzo di comunicazione, il corrispettivo della stampa, della televisione, delle parate militari”. _____________________________ L’aes grave è sicuramente molto antico ma è difficile oggi, per noi, capire a quando risalga. Vista la fattura grezza e la natura di monete a valore intrinseco (quindi, concettualmente molto vicine al bronzo scambiato a peso), si potrebbe pensare che sia estremamente antico: in effetti, in passato gli studiosi ipotizzavano i Romani avessero iniziato a produrlo tra il VII e il V secolo a.C.[2]; del resto le leggi delle XII tavole, promulgate nel 451-450 a.C., parlano frequentemente di asses, per cui sembra logico che questa moneta dovesse esistere. Tuttavia i rinvenimenti archeologici fanno pensare che le monete di aes grave siano più recenti; fra i numismatici moderni solo Corradi[3] crede ancora in una datazione al V secolo a.C., mentre gli altri autori sono convinti che sia comparso nella seconda metà del III secolo a.C. (più precisamente tra il 338 e il 311 a.C.)[4] oppure addirittura agli inizî del III secolo a.C.[5]. La difficoltà di datare l’aes grave comporta tre problemi interpretativi. Primo problema: capire in che rapporti si pongano aes grave e monetazione romano-campana. Come si vedrà in seguito, le monete romano-campane sono diversissime e (almeno apparentemente) incompatibili l’aes grave: comprendono infatti, oltre al bronzo, anche argento e oro; sono coniate anziché fuse; presentano iconografie estremamente raffinate, anziché grezze; soprattutto, presentano anche quelle di bronzo pesi molto ridotti (fra 2 e 15 g, in un solo caso 19 g) e, quindi, non potevano avere un valore intrinseco. Eppure, sembra che i due sistemi monetarî siano stati in uso in contemporanea, tra la fine dei IV secolo e la metà del III. Per spiegare questa anomalia si è pensato che i Romani usassero l’aes grave per i commerci interni e per quelli con i popoli italici, le monete romano-campane invece per i commerci con i popoli magno-greci (culturalmente più evoluti e, quindi, abituati a monete meno grezze). Secondo problema: capire se l’aes grave sia un’invenzione romana, o meno. Infatti, monete di aes grave (oggi molto rare) furono emesse, oltre che dai Romani, anche da Etruschi e da numerosi altri popoli italici (Umbri, Osci, Apuli e popoli della costa adriatica), ma non si riesce a determinare quali di esse siano le più antiche. Inoltre, molte delle città che emisero aes grave furono assoggettate da Roma proprio tra la fine dei IV secolo e la metà del III, per cui non si riesce a capire se la loro monetazione sia iniziata prima della conquista romana o dopo. Per queste ragioni, alcuni storici pensano che l’aes grave sia stato inventato dai Romani ed essi abbiano esportato tale idea nelle altre città italiche; altri invece ritengono che sia nato in Etruria e poi copiato dai Romani; altri ancora che sia comparso in modo spontaneo e indipendente fra popolazioni differenti, a causa di circostanze economiche comuni. Terzo problema: capire quali siano le emissioni di aes grave più antiche, fra quelle stesse romane. Qui serve un’ulteriore precisazione: nei secoli, il peso medio delle monete romane (soprattutto quelle di bronzo, più limitatamente quelle d’argento) calò progressivamente. Questo successe perché lo Stato, quando non aveva abbastanza metallo prezioso da monetare ma doveva comunque pagare i debiti, cominciava a emettere monete un po’ meno pesanti. È evidente che queste iniziative spingevano i venditori ad alzare i prezzi delle loro merci (per ricevere una stessa quantità di metallo prezioso) e, per questo, tale meccanismo è oggi definito come “svalutazione” (di monete a valore intrinseco), un fenomeno ben conosciuto e che si è manifestato anche in altre culture antiche. Tanto premesso, si è visto che Roma emise assi librali di pesi medi differenti, 341 g, 327 g e 273 g; tuttavia, siccome Varrone afferma che “habet iugerum scripula CCLXXXVIII, quantum as antiquus noster ante bellum Punicum pendebat” (“lo iugero comprende 288 scrupoli[6], tanto quanto pesava il nostro asse prima della Guerra Punica”) molti studiosi[7] ritengono che l’emissione più antica non sia la più pesante, ma quella da 327 g. Le serie di aes grave più antica sarebbe allora la RRC 14 e sarebbe, secondo la testimonianza di Varrone, precedente alla prima della Prima Guerra Punica (“ante bellum Punicum”). Successivamente, l’Urbe sarebbe passata a emettere assi più pesanti, da 341 g, probabilmente perché, ampliando la sua sfera di influenza, avvertiva il bisogno di commerciare non solo con i Romani stessi, ma anche con altre popolazioni italiche (la libra da 341,1 g è infatti ritenuta lo standard italico). Appartengono a questa categoria di peso le serie RRC 18 e RRC 19. Dopo queste due serie, Roma sarebbe passata a emettere aes grave basato su un asse di 273 g. Al riguardo, ci sono due opinioni fra gli studiosi: o fu adottato (sempre per ragioni commerciali) lo standard della libra osco-latina, oppure si era tornati alla libra romana ma ne era stata effettuata la prima svalutazione (è significativo, infatti, che 273 sia i 10/12 di 327: lo Stato, forse, aveva cominciato a produrre assi contenenti solo 10 “once-peso” di metallo, sebbene continuassero essere suddivisi in 12 “once-moneta”). Fra le serie di questo periodo la più interessante è RRC 24, che presenta in tutti i nominali, al rovescio, una ruota a sei raggi: alcuni studiosi ritengono che, per tale ragione, anche queste monete fuse (come la didracma RRC 14/3, di cui si dirà in seguito) siano state emesse in occasione della costruzione della via Appia (312-308 a.C.; Crawford invece data questa serie al periodo tra il 265 e il 242 a.C.). ___________________________________________ Come detto, esistono monete di aes grave anche presso altre popolazioni italiche, oggi abbastanza rare (a testimonianza del fatto che ne furono emesse relativamente poche). Esiste però un gruppo di monete fuse che presenta interessanti peculiarità: la cosiddetta serie ovale, i cui nominali presentano tutti su una faccia una clava (attributo di Ercole), sull’altra il simbolo del valore (“I” per l’asse, “C” - ossia sigma uncinato - per il semisse e i pallini per gli altri nominali, sino all’oncia). Lo standard ponderale di riferimento dell’asse sembrerebbe di circa 151 g (ma non è certo). Le caratteristiche di questa serie sono: - la forma, che non è tonda (unico caso nella penisola) ma ovale e, peraltro, con una grande variabilità (ovali perfetti, rettangoli arrotondati, tronchi di cono, etc.); - la grande distribuzione del sestante, di cui sono stati rinvenuti molti esemplari da Trento a Termoli; - l’estrema variabilità del peso; in particolare, sebbene in teoria i sestanti dovessero pesare 25,17 g, in realtà gli esemplari rimasti vanno da 9 a 51 g. Gli studiosi ritengono, sulla base dei ritrovamenti, che queste monete possano essere state emesse da Tuder (odierna Todi, città umbra), Tarquinia o Velzna (città etrusche; la seconda, ridenominata “Volsinii” in epoca romana, oggi non esiste più). Per la data, tenuto conto del peso, si propone la fine del IV secolo (circa 320 a.C., epoca in cui gli etruschi usavano una libra di circa 150 g, detta appunto “etrusco leggera”) oppure la metà del III (epoca in cui i romani, a seguito di una forte svalutazione, cominciarono a emettere aes grave - cosiddetto “semilibrale” - con un asse di metà libra romana, quindi circa 163 g). Sussiste però, nella mia opinione, un’altra possibilità di interpretazione. Esiste infatti un rarissimo lingotto di aes signatum, coevo o poco più recente del “ramo secco”, che presenta il disegno della clava; è stato quindi ipotizzato un collegamento tra questo lingotto e l’aes grave ovale[8]. Allargando il discorso, potrebbe darsi che le monete ovali siano proprio un elemento di passaggio tra l’aes signatum più antico, con disegni di “ramo secco”, “lisca di pesce” e clava, e le monete tonde; in altri termini potrebbero essere una specie di “lingottini” e ciò spiegherebbe sia la forma (a metà tra il parallelogramma dei lingotti e il disco delle monete) sia la grande variabilità della forma stessa (derivante dal fatto che si trattava, appunto, di un primo tentativo di trasformare i lingotti in monete) e del peso (come appunto i lingotti con “ramo secco” e “lisca di pesce” che, appunto, avevano un peso abbastanza variabile). Infine, credo che dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità che queste monete siano riconducibili a Roma, quanto meno sotto forma di monete “coloniali”: infatti, questa è l’unica serie di aes grave (a parte, ovviamente, quelle romane) ad aver avuto una diffusione così ampia, che si spiegherebbe solo se fosse la moneta di una città capace di intrattenere commercî dal Trentino al Molise, come alla fine del IV secolo poteva essere Roma. Inoltre queste monete sono state rinvenute, nei ripostigli, insieme all’aes grave romano (ma questo accade anche per altri aera grava italici). Del resto, delle tre città proposte come sede della zecca, sappiamo che Velzna fu resa tributaria da Roma dal 294 a.C. e soggiogata nel 280, Tarquinia fu conquistata nel 295 e anche Tuder fu in qualche modo assorbita da Roma nel III secolo. Se la serie ovale fosse attribuita alla Roma arcaica, tuttavia, andrebbe chiarito il problema del peso, troppo leggero per gli standard romani arcaici[9]. NOTE [1] La più piccola unità di misura del peso usata a Roma era lo scrupolo, corrispondente (secondo l’opinione prevalente - non è sicuro) a 1,137 g. Sappiamo, da Varrone, che la libra romana pesava 288 scrupoli (cioè, 12 once da 24 scrupoli ciascuna), quindi appunto 327,45 g. La libra italica doveva pesare 300 scrupoli (341,10 g), quella osco-latina 240 (272,87 g). [2] Nel 630 a.C., secondo Marchi e Tessieri (1839); nel 539, secondo Eckhel (1792); nel 450, secondo Mommsen (1860). [3] Dissertazione sull'aes grave fuso e coniato di Roma e relative riduzioni, in “Nummus et Historia” VII, Formia 2003. [4] Secondo Hill, Cesano, Breglia, Alteri, Panvini Rosati, Babelon, Soutzo, Grueber, Haeberlin, Millingen, Sear. [5] Crawford, in particolare, propone il 280 a.C. [6] I Romani suddividevano in 288 scrupoli sia la libra (12 once da 24 scrupoli), sia il giorno e la notte (12 ore da 24 scrupoli), sia lo iugero; si chiamava quindi allo stesso modo (scrupulum, letteralmente “sassolino”) la più piccola unità di misura sia del peso, sia del tempo, sia della superficie. [7] Sono di questa opinione Thomsen, Crawford e Coarelli. [8] Ambrosini, Le monete della cosiddetta serie ‘ovale’ con il tipo della clava, in “Studi Etruschi”, 1987. [9] Roma, a seguito delle svalutazioni, arrivò a emettere aera grava con assi del peso di mezza libra (detti, perciò, “assi semilibrali”) ma solo alla fine del III secolo. Se le monete ovali fossero così recenti, non potrebbero rappresentare una forma di passaggio fra lingotti e monete tonde. In alternativa si potrebbe pensare che siano monete coloniali, commisurate alla libra etrusca leggera. ILLUSTRAZIONI Asse RRC 14/1 Asse RRC 24/3 Sestanti della serie ovale Pezzi di aes grave esposti nei musei italiani3 punti
-
AVVISO per i nuovi lettori: i contenuti di tutta la discussione, sino al post #51 compreso, sono raccolti e meglio organizzati nel pdf al post #52, di cui pertanto consiglio la lettura.2 punti
-
Buonasera, ecco uno dei miei ultimi acquisti in asta, un bel BB Buona serata.2 punti
-
Essendo uscito il mio ultimo lavoro tra le diverse "novità" presenti vorrei segnalare questo Bezzo da 6 l'esemplare, fino ad oggi non segnalato (al momento sono censiti 3 esemplari*) di questo bezzo da sei bagattini presenta S. Marco in piedi e la legenda ✿ S • MΛRCVS ✿ ✿ VENETVS ✿2 punti
-
Buonasera Alan, il francobollo è decisamente buono e bello, Vaccari sono una sicurezza, Valeria tiene sempre alto il nome del padre Paolo , è una cara amica e persona molto seria. La mia domanda era solamente per sapere se vi era un certificato, in quanto la firma di Sorani a lato sx in verticale significa francobollo senza gomma o con gomma parziale, a vederlo in foto sembra senza gomma , era solo questo che mi piaceva sapere, saluti F.P.2 punti
-
Ma infatti! La consegna a mano in questi casi dovrebbe essere d'obbligo! E poi crea un buon rapporto venditore-cliente, con la possibilità di conoscersi di persona e poter fare di nuovo affari insieme!2 punti
-
Ecco 2 ultimi acquisti in asta: Gian Galeazzo Visconti (1385 - 1402) - Grosso da 1 e mezzo Filippo Maria Visconti (1412 - 1447) - Grosso da 2 Buona serata.2 punti
-
Segnalo l'uscita de: Le monete anonime della Serenissima di Andrea Keber La monetazione anonima, ovvero priva del nome del Doge in carica, emessa dalla zecca veneziana: Il testo tratta le emissioni sia per i domini della terraferma che quelli "de mar": Dalmazia, Isole ed Armata, Isole del Levante (Corfu, Cefalonia e Zante), Candia, Cipro, Antivari, Lesina, Ravenna, Rovigo, Sebenico, Spalato, Traù, Treviso, Zara, la zecca di Cattaro e Scutari. 136 pagine.2 punti
-
Stiamo cercando di fare un aggiornamento importante, bisognerà portare pazienza un altro po'.2 punti
-
2 punti
-
Caspita! Ha ragione @PostOffice quando dice che hai sempre materiale interessante. Questo è materiale storico! Complimenti davvero.2 punti
-
Buungiorno, dopo una forzata assenza, riprendo se pur a tempi strettissimi, la mia partecipazione al forum nella nostra sezione, avevo chiuso con il giorno 11 giugno, ma vorrei postare alcune cose dei giorni precedenti prima di ripartire con l'odierno, le avevo preparate e vi sono tra loro dei pezzi interessanti, a partire dal 12 Giugno 1946 , giorno in cui De Gasperi, a seguito dei sanguinosi scontri di Napoli, con 11 morti e circa 300 feriti . tra monarchici e repubblicani, si reca dal re per convincerlo a dimettersi ed vitare di accrescere il malumore dell'opinione pubblica,il re risponderà di attendere l'esito della Cassazione. Tra la notte del 12 e del 13 Giugno 1946 il Consiglio dei Ministridecide di deporre io re e proclama Alcide De Gaspari Capo Provvi pro tempore dello Stato.2 punti
-
Anche per questo Antico stato, aggiungo i miei francobolli.2 punti
-
Buongiorno ,chiederei cortesemente se qualcuno può identificare questa moneta ed eventualmente una valutazione anche approssimativa. vi ringrazio e saluto Alberto1 punto
-
2 Ho incollato l’immagine da telefono. C’è anche l’immagine prima che sia stata chiusa1 punto
-
Amici Filatelici Buon Sabato e Buon pomeriggio ! Il Regno delle due Sicilie comprendeva il Regno di Napoli ed il Regno di Sicilia. I due Regni furono poi riuniti in un solo Stato retto dalla dinastia dei Borboni, per effetto del trattato di Vienna del 1815. Oggi condivido un francobollo del 1859 Sicilia, da 20 grana, colore ardesia-grigio, privo di annullo, effigie del Re Ferdinando II° ( che morì proprio a Maggio del 1859 ). Sul retro la firma dei periti fil. S. Sorani e P. Vaccari. La serie ( prima emissione del Regno di Sicilia ), fu emessa il 01.01.1859, poco più di un anno prima dello sbarco dei Mille di Garibaldi, è composta da 7 esemplari di diverso colore e valore, detti comunemente anche "testoni"; è ricercata in quanto considerata una delle serie più belle della filatelia classica. Chiamo per cortesia al commento gli esperti @fapetri2001 e @PostOffice ma anche altri appassionati del settore. Grazie.1 punto
-
fai un confronto con un francobollo molto più comune e sicuramente con colla, potrai notare le differenze1 punto
-
DE GREGE EPICURI Non esistono monete "babilonesi" nel senso che diamo generalmente a questo termine; ci sono però monete coniate nella bassa Mesopotamia da Alessandro Magno e dai diadochi suoi successori. Questa dovrebbe essere una moneta greca ( si leggono alcune lettere: A, B, forse Λ...) ma per oggi non so dirti di piu'.1 punto
-
1 punto
-
Dall'immagine sembra acmonital prematurato anzichè bronzo con scappellamento a destra1 punto
-
Ah per fortuna c'è la garanzia di ebay. Allora si è in una botte di ferro! In fondo al mare.1 punto
-
Gettone Autolavaggio Self BONO Metallo bianco: 8 g, 26 mm L’Autolavaggio è in Viale Campania 15, 20900 Monza (MB). apollonia1 punto
-
Staremo a vedere, come ho già detto ce la stanno mettendo tutta a fare stancare i collezionisti. Nel caso, prenderò le mie decisioni.1 punto
-
Convinto tu Probabilmente lo avrai letto in qualche articolo-spazzatura, o vista messa in vendita da qualche buontempone su ebay, ma quelle sono solo bufale, il valore reale è quello che ti ha appena mostrato @nikita_ e solo se in perfette condizioni, altrimenti nemmeno quei pochi centesimi. petronius1 punto
-
Se la fotografo, non si nota l'asse alla francese, che Voi mi insegnate. Comunque vedrò di aggiungere una goto appena posdo. Non ha valore????? La moneta cosi descritta vale migliaia di euro. La fomanda era " la mia vale di più?". Conunque mi avete risposto.1 punto
-
La Zecca va alla guerra Dopo l'elezione di Lincoln alla presidenza, per un po' di tempo le cose continuarono senza scossoni alla Zecca di Charlotte. I conii per le monete del 1861 vennero spediti da Philadelphia il 13 dicembre 1860, e il Sovrintendente Caldwell continuò a compilare i suoi rapporti mensili. I fondi per le operazioni della Zecca furono inviati fino al marzo 1861, dopodiché ogni comunicazione formale con Philadelphia cessò. Allo scoppio della guerra, il 12 aprile, fu chiaro che era solo questione di tempo prima che la Zecca di Charlotte cadesse in mano Confederata. Il North Carolina aderì alla secessione il 20 maggio, ma fin da prima c'erano pochi dubbi sulla parte che avrebbe scelto. Infatti, già il 20 aprile, un distaccamento della milizia del North Carolina si presentò presso la Zecca, con l'ordine del Governatore John Ellis di consegnare la Zecca e tutti i suoi beni e depositi allo Stato del North Carolina. Ma, a dispetto del loro supporto alla causa sudista, gli uomini d'affari e le banche del North Carolina, chiesero al Governatore di consentire al personale qualificato della Zecca di continuare le operazioni. Con loro era d'accordo il Sovrintendente Caldwell, che avvisò il Governatore Ellis che la gran parte dell'oro della Zecca non era nello stato di metallo raffinato, e avrebbe potuto essere perso se maneggiato da personale non qualificato. Il Governatore capì le ragioni di Caldwell, e consapevole dell'importanza della Zecca per la comunità, rispose: "Riponendo piena fiducia nella vostra ben nota devozione alla causa del Sud, e agli interessi del North Carolina, vi chiedo di assumere la direzione della Zecca di Charlotte." E così, sebbene alcuni soldati del North Carolina fossero stati messi di guardia, la Zecca riprese le sue normali operazioni. Che, per il 1861, consistettero nella coniazione di sole half eagles, essendo terminata l'anno precedente quella delle quarter eagles, con 7.469 esemplari. (foto da Heritage Auctions) Continua...1 punto
-
Asse alla francese ,nessun errore di conio.1 punto
-
Da nessuna zecca, devi rivolgerti ai negozianti solo i commercianti provvisti di VAT possono acquistare direttamente dall’Istituto emittente di Andorra1 punto
-
@Antonino1951 ipotizziamo la tua ipotesi la quale, sia chiaro, non ho detto sia sbagliata. Sono però curioso di vedere foto per intero della moneta in questione. Potrebbe anche essere che ci abbiamo azzeccato entrambi. Io per la parte già evidenziata e tu per le presunte ossidazioni più piccole nelle immediate vicinanze.1 punto
-
Come altre centinaia con leggenda Sabella al posto di Isabella. Il concetto non cambia su tutta la tipologia di questi tornesi, emessi solo inizialmente esclusivamente in Grecia franca.1 punto
-
Buonasera @carripotti22, se autentico, 1/4 di fiorino del I° tipo, il suo peso dovrebbe essere di grammi 5,34. Zecca di Milano raro R2. Conservazione : a diritto con tutte quelle hair lines sembra che sia stato lucidato, inoltre i rilievi sono un po' piatti, ad esempio la basetta del Re, l'orecchio ed il nastrino che scende sul collo che si vede a malapena. Anche il rovescio ha le sue hair lines. Secondo me complessivamente non più di BB.1 punto
-
L'Iran continua a subire gravi danni alle infrastrutture militari e civili dei settori nucleare, petrolio/gas ed elettronico, anche perchè la forza aerea israeliana ha la superiorità aerea totale su diverse zone, compresa Teheran che ormai è difesa solo da pochi cannoni antiaerei da 23 e 35 mm. Nel paese operano circa 50 squadre del Mossad (con un migliaio di collaboratori iraniani) che colpiscono obiettivi militari e civili. Continua anche il massacro delle alte sfere militari, ad esempio in uno dei raid degli UAV (droni) armati Eitan su Teheran è stato ucciso Ali Shadmani, da poco nominato capo delle operazioni belliche iraniane dopo la morte del predecessore Gholam Ali Rashid. L'Iran risponde ancora con salve di missili (dall'inizio della guerra ne sono stati lanciati circa 400) e UAV Shaded-101/136 (come quelli dati alla Russia) e di altro tipo. I danni principali in Israele sono ad infrastrutture critiche del porto di Haifa, con la centrale elettrica e la raffineria pesantemente danneggiate o distrutte. E' stata anche colpita la fabbrica di chip Intel di Kriyat Gat.1 punto
-
ex Kruso, ex Varesi, ex Ratto 1965… chissà dove prima! N.1 punto
-
1 punto
-
per scoprirlo puoi basarti sul catalogo di Andrea Pucci, LE MONETE DELLA ZECCA DI FIRENZE EPOCA MEDICEA. Cosimo II i gradi di rarità messi sul volume di Alessandro Mantagano, Monete italiane regionali (MIR) Toscana - zecche minori, sono molto meno attendibili. i riferimenti ai numeri di esemplari che ho messo nel post si basano sulle mie ricerche e su un corpus di quasi 400 esemplari comparsi in aste, collezioni private, musei e che sto catalogando. .1 punto
-
Salve,ci provo. Per me potrebbe essere un ae4 Pax Pvblica di Flavia Helena Augusta madre di Costantino I. Comunque aspettiamo pareri autorevoli. https://www.acsearch.info/search.html?id=36455631 punto
-
Ottimo, mi fa piacere allora che la "cosa pubblica" ogni tanto si ricordi anche dei cittadini1 punto
-
1 punto
-
Salve, di quale votiva puo trattarsi? @borghobaffo pensaci tu? Grazie infinite di cuore1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
QUANDO A ROMA GOVERNAVANO I RE In origine, a Roma si diffuse l’idea che anziché barattare le merci fra loro, fosse più utile scambiarle con un bene prezioso e durevole; nacque così l’idea di barattare il bronzo con le merci. Questa cosa la sappiamo per quattro motivi: perché è stato così in tutte le civiltà di cui si hanno notizie (seppure usando beni-rifugio differenti: argento, conchiglie, etc.); perché ce lo riferisce Plinio (“rudi usos Romae”); perché ne resta memoria nel diritto romano, che prevede una serie di accordi compiuti “per aes et libram” (letteralmente “per mezzo del bronzo e di una bilancia”, ossia quindi “pesando il bronzo ricevuto in cambio”); e, infine, perché ci sono importanti testimonianze archeologiche, dato che sussistono diversi casi in cui i pezzi informi di bronzo sono stati rinvenuti insieme a monete vere e proprie. Interessantissimo, in proposito, è il deposito votivo scoperto nel 1852 a Vicarello e ora parzialmente ricostruito nei sotterranei del Museo Nazionale Romano: infatti, si trattava di un pozzo dove i fedeli gettavano una moneta (come oggi si fa a Fontana di Trevi) e lo strato più basso era composto da pezzi di bronzo informe; subito sopra di essi c’erano monete del tipo “aes grave” (di cui si dirà nel prosieguo), a testimonianza che i pezzi informi avevano effettivamente una funzione di tipo monetale ed erano in uso prima dell’aes grave. Per questo tipo di proto-moneta si usa oggi il termine di aes rude (sulla base del citato passo di Plinio, “rudi …”); il suo utilizzo è attestato in contesti archeologici databili dall’VIII secolo a.C. (forse, addirittura dall’XI) sino al IV. Quando Romolo fondava Roma, gli scambi si facevano con l’aes rude. Fra i pezzi di bronzo rinvenuti in contesti archeologici alcuni non sono informi, ma presentano forme ben precise, di natura geometrica (gocce, barre, lingotti, dischi, etc.) o naturalistica (ghiande, astragali, etc.). Non c’è alcunché di strano: se il bronzo veniva scambiato a peso, ben si poteva utilizzare anche metallo dotato di una forma, magari anche per immagazzinarlo meglio. Peraltro, fra quelli di forma geometrica, molti risultano frammenti, ossia sono stati tagliati (a caldo) per ottenere lo specifico peso di cui c’era bisogno. Alcuni studiosi usano la locuzione (inventata) aes formatum per distinguere queste proto-monete da quelle informi, ma sono solo un tipo di aes rude. È importante fare una precisazione: qualunque pezzo di bronzo poteva essere scambiato a peso, per cui oggi c’è un unico modo per distinguere un vero aes rude o formatum da un qualunque altro pezzo di bronzo, ossia ritrovarlo in un preciso contesto archeologico (come a Vicarello); poiché tuttavia i reperti archeologici non possono essere liberamente venduti, ne consegue che non c’è alcun modo di sapere se i pezzi in bronzo venduti da negozi e case d’asta siano effettivamente aera ruda o meno. Si possono inserire in collezione al fine di “riempire un vuoto”, ma occorre sapere che non c’è alcuna possibilità di avere certezza che siano antichi e, quand’anche lo fossero, di sapere se siano stati veramente scambiati a peso (e quindi effettivamente utilizzati come aera ruda) o fossero solo residui di fonderia. Un discorso a parte deve essere fatto per molti oggetti a forma di conchiglia, spesso in piombo e talvolta in bronzo, che vengono rinvenuti in scavi archeologici (databili ai secoli VI-III a.C.) eseguiti nella Pianura Padana e nell’area governata dagli Etruschi. Alcuni studiosi (ad esempio Franco Pezzi, Conchiglie di piombo, Mantova 2010) ipotizzano che siano proto-monete (e, quindi, aes formatum), ma altri non sono d’accordo e propongono che si tratti di oggetti votivi (spesso presentano un forellino di sospensione; la conchiglia simboleggiava la vulva, quindi la fecondità), oppure proiettili asimmetrici per le fionde o ancora pesi per le bilance. L’ipotesi più probabile è che si trattasse di decorazioni o paracolpi per utensili fittili, cui venivano saldate con mastici, argilla o di piombo fuso (spesso infatti presentano tracce di terracotta sulla faccia piatta), oppure di piedini per pentole metalliche. Comunque sia, nulla esclude che le conchiglie in bronzo venissero anch’esse scambiate a peso, come aes formatum, quando occorreva. ________________________________________ A partire da una certa data, ai pezzi di aes rude e formatum cominciano ad aggiungersi altri, che recano un segno inciso nel metallo. Si parla al riguardo, sulla base del citato brano di Plinio, di aes signatum; sotto questo nome si distinguono, tuttavia, tre categorie di oggetti abbastanza differenti. La prima categoria è composta pezzi di bronzo sostanzialmente informi, che recano tuttavia una o più contromarche (cioè, disegni elementari o lettere incise nel metallo). I più diffusi, rinvenuti sia in varie località dell’Italia centrale sia nei Balcani, presentano due contromarche sulle facce contrapposte, una costituita da un punto centrale e 4 raggi che se ne dipartono, l’altra da un arco di cerchio; si ritiene che raffigurino rispettivamente il sole e la luna. Haeberlin, importante numismatico tedesco del XIX secolo, dopo aver esaminato numerosi esemplari di questa tipologia di aes precisa che su altri pezzi esistono anche le combinazioni sole/nulla, sole/sole e luna/luna. Una seconda categoria, molto interessante, è quella del cosiddetto “ramo secco”. Si tratta di lingotti di bronzo a forma di parallelepipedo schiacciato, di peso variabile e fattura grezza, che recano un'immagine in rilievo somigliante a un ramo privo di foglie (più raramente sono presenti altri segni, altrettanto grezzi: lisca di pesce, clava, delfino, crescente lunare), la cui esatta natura è tuttavia discussa (secondo alcuni autori sono un espediente tecnico per far fuoriuscire i gas durante la fusione, oppure segni utili a facilitarne la frammentazione). I lingotti con “ramo secco” sono stati rinvenuti in tutta la penisola e in Sicilia, interi o (più spesso) tagliati in frammenti; quelli interi hanno pesi compresi fra 0,8 e 2,1 kg. Il fascino del “ramo secco” è quello di costituire un oggetto sicuramente utilizzato a Roma (esemplari sono stati infatti rinvenuti in scavi eseguiti in città) e sicuramente databile all’epoca in cui i re governavano sull’Urbe: infatti, un frammento di 0,425 kg rinvenuto presso il santuario di Bitalemi (Sicilia), in uno strato sigillato databile al periodo 570-540 a.C.[1], dimostra l’esistenza di questi manufatti nel VI secolo a.C. Una terza categoria di aes signatum è costituito da un altro genere di lingotti di bronzo, che si distinguono dai “ramo secco” per una iconografia più varia ed elaborata, una forma più definita, un peso più leggero ma anche più omogeneo (tra i 1,8 e 1,2 kg), definiti correntemente “quadrilateri”. A differenza dei “ramo secco”, sono molto rari. Gli studiosi sono concordi nel ritenere che siano stati prodotti a Roma (un tipo presenta anche la legenda “ROMANOM”, forma arcaica per Romanorum); Crawford, inoltre, è convinto che avessero funzione monetale, per cui li elenca nel RRC. Giova comunque precisare che altri studiosi non sono così sicuri che i quadrilateri fossero monete, sebbene indubbiamente alcuni siano stati rinvenuti in ripostigli[2] (a Santa Marinella, La Bruna, Ariccia) assieme a esemplari di aes grave. Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se uno dei tipi di aes formatum noti possa essere quello di cui parla Plinio, inventato da Servio Tullio (che avrebbe regnato dal 578 al 535 a.C.), e permetta così di affermare che la moneta, a Roma, è nata nel VI secolo a.C.; la risposta, tuttavia, sembra essere negativa. In primo luogo, se quella testimonianza fosse attendibile la prima moneta romana dovrebbe essere stata un lingotto con pecora, ma un simile lingotto non è stato rinvenuto (il che ovviamente rende improbabile, ma non impossibile, che sia esistito). I lingotti romani che ci sono pervenuti - ossia i quadrilateri -, peraltro, sono molto posteriori all’epoca regia, probabilmente dell’epoca compresa fra la fine del IV secolo a.C. e gli inizi del III, come dimostrano i ripostigli[3], la legenda ROMANOM (che, ancorché arcaica, appare molto posteriore al Latino di epoca regia, attestato dal lapis niger e dalla fibula praenestina) e la circostanza che un tipo rechi l’elefante (animale ignoto ai Roma prima della guerra contro Pirro, iniziata nel 280 a.C.). Certo, il “ramo secco” esisteva già all’epoca di Servio Tullio, ma non è affatto sicuro che avesse uno scopo monetale (è stato rinvenuto in contesti votivi a Bitalemi e a Terravecchia di Grammichele, ma qualunque oggetto d'arte o di valore, non solo le monete, può costituire l'offerta a un dio) e comunque la sua ampia diffusione fa ritenere che non fosse un manufatto esclusivamente romano (Roma, ai tempi di Servio Tullio, esercitava la sua influenza politica e commerciale su un territorio molto più piccolo). Il passo di Plinio non può quindi essere accettato alla lettera; probabilmente non è vero che la moneta, in Italia, sia stata inventata da Servio Tullio. ________________________________________ Come detto, varie civiltà arcaiche usavano un sistema proto-monetale consistente nel baratto tra le merci e un metallo prezioso; la moneta vera e propria nacque quando alcune autorità statali decisero di far punzonare questi metalli, per garantirne il peso (e quindi il valore) e velocizzare, così, i commerci (perché diveniva inutile pesare il metallo). Questa evoluzione si verificò dapprima in Cina (tra l’VIII e il VII secolo a.C.), poi, in modo separato e indipendente, in Asia Minore. Qui infatti era tradizione scambiare le merci con palline di elettro (una lega di argento e oro); a un certo punto (secondo la tradizione, nel VI secolo a.C., a opera di Creso re della Lidia; secondo gli studiosi moderni prima, attorno alla metà del VII secolo a.C.) i governanti cominciarono a far punzonare queste palline, che presentavano quindi un segno “in incuso” (cioè incavato, rispetto alla superficie della moneta). Poco dopo si cominciò ad apporre un segno anche sull’incudine e nacque, così, la tecnica della coniazione; inoltre, furono prodotte anche monete d’argento, oltre che di elettro. La moneta ricosse subito un grande successo; tutte le città greche dell’Asia Minore cominciarono a produrla e a diffonderla, attraverso la loro fitta rete di contatti commerciali, in tutto il mediterraneo, occidente compreso. Tornando alla Roma arcaica, sembra strano che all’epoca dei re dentro l'Urbe non si usassero monete (come si vedrà in seguito, le prime monete romane, aes grave e monete romano-campane, sono probabilmente databili alla fine del IV secolo a.C.) e ci si limitasse a ricorrere al baratto fra le merci e il bronzo a peso (aes rude e formatum). Si ritiene, infatti, che il tempio eretto nel Foro Boario nel 495 a.C. (l’Ara massima di Ercole) non fosse altro che la monumentalizzazione di un altare preesistente (e, quindi, risalente all’epoca regia), dedicato a una divinità locale assimilata al fenicio Melqart, protettore dei mercanti; sarebbe quindi questa una testimonianza indiretta che in quel luogo in epoca antichissima, addirittura prima della fondazione di Roma, esistesse un sito di scambio fra merci portate dai mercanti fenici e prodotti locali, ma è tuttavia difficile immaginare l’esistenza di scambi commerciali di portata addirittura internazionale senza l’utilizzo di un qualche genere di moneta. Per queste ragioni, uno studioso[4] ha ipotizzato che la Roma arcaica non abbia emesso proprie monete perché utilizzava proprio monete greche arcaiche; non c’è alcuna prova archeologica al riguardo, però c’è un importante indizio. Infatti, tra il 1862 e il 1867 sono stati rinvenuti una serie di ripostigli di piccole monete di tipo ionico, risalenti al VI-V secolo a.C., a Morella e Pont de Molins (in Spagna), Auriol[5] (presso Marsiglia, città fondata dai Greci) e Volterra, città etrusca; ciò dimostra che gli Etruschi utilizzavano monete greche. Siccome a Roma, nel VI secolo a.C., dominava una stirpe etrusca (i Tarquini), è molto probabile che monete analoghe siano state utilizzate anche nell’Urbe. NOTE [1] Si definisce “sigillato”, in archeologia, uno strato di terreno che appare chiaramente separato dagli strati sovrastanti (generati da eventi o attività successivi), senza interruzioni o intrusioni (causate da riutilizzo del terreno, erosione, contaminazione o distruzione) che potrebbero averne alterato il contesto originario. Gli oggetti rinvenuti in uno strato sigillato sono sicuramente databili all’epoca dello strato. Su questi scavi ha scritto Piero Orlandini in “Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica”, 1965-1967. [2] È molto frequente trovare gruppi di monete duranti gli scavi, perché nell’antichità nasconderle era un modo per conservare i propri risparmi; tali gruppi sono oggi definiti “ripostigli” o “tesoretti”. [3] È bene notare, tuttavia, che i ripostigli, anche quando possono essere datati con relativa sicurezza (come negli strati sigillati), forniscono solo indizi e non certezze sull’epoca di emissione delle monete, perché non si sa per quanto tempo esse abbiano circolato prima di essere state nascoste. [4] Amisano, La storia di Roma antica e le sue monete, vol. 1, 2004. [5] Siccome il rinvenimento di Auriol è il più numeroso (circa 2.130 monete), si parla al riguardo di “monetazione tipo Auriol”. ILLUSTRAZIONI Esposizione di aes del Museo nazionale Romano. Al centro, frammenti di aes rude raccolti in una bilancia. In alto, due quadrilateri, RRC 4/1 (con pegaso e ROMANOM) e RRC 7/1 (con raffigurazione di uno scudo). A destra, un “ramo secco” Ricostruzione del deposito di Vicarello, dal Museo Nazionale Romano Ramosecco del Museo Civico Archeologico "A.C. Simonini" Il "ramosecco" rinvenuto a Bitalemi Monetazione "tipo Auriol" rinvenuta a Volterra1 punto
-
Devo dire che sono molto contento che ci sia così tanta partecipazione in questo sito. Comunque credo che questa esperienza sia capitata a quasi tutti i numismatici. VIVA LA NUMISMATICA!1 punto
-
DE GREGE EPICURI E' una delle ultime arrivate, ed appartiene a questa categoria piuttosto misteriosa. Per prima cosa, non è affatto chiaro che cosa significhino queste due lettere, che campeggiano sul rovescio: Commune Asiae (monetazione comune dell'Asia)? Oppure Caesar Augustus? Oppure Caesaris Auctoritate (per autorità di Cesare)? E ci sono altre ipotesi. In secondo luogo, non è nota la zecca di produzione. L'ipotesi classica parlava di Pergamo, ma successivamente si è pensato invece ad Efeso, oppure ad una zecca di Siria. Non ho controllato la preferenza espressa da RPC. Forse, qualcuno ha addirittura dubitato dell'origine asiatica: ad esempio, non compare nel catalogo della collezione Lindgren (Ancient coins of Asia Minor and the Levant, 1985). Infine, la corona che circonda le lettere CA può essere di fronde vegetali, oppure costituita da una serie di prore, allusione abbastanza trasparente alla vittoria di Azio (ed è questa la tipologia della presente moneta). La datazione è fissata agli anni 27/26 a.C., e quindi coincide col conferimento del titolo di Augusto da parte del Senato; data che per noi rappresenta l'inizio del "periodo imperiale". Tutte le monete che ricordo sono in oricalco; ve ne sono di due misure, una più grande (sostanzialmente un grosso sesterzio) ed una più piccola, sui 12 g., probabilmente un dupondio. Questa che vi mostro è abbastanza lisa, specie al D, e in effetti pesa solo 8, 52 g. ; risulta molto ovalizzata, da 26 a 30 mm. Classificata in RPC/1 come 2234. Compare anche nel RIC, da 499 a 502. La sua area di circolazione sembra sia stata piuttosto ampia, ed anche per questo è difficile individuare la zecca.1 punto
-
Purtroppo io sono di parte ma questa serie insieme alla prima emissione di Napoli del 1858 sono effettivamente di fattura notevole. La serie di 7 valori con l'effigie di Ferdinando II del 1859 fu incisa dal celebre messinese Alojso Juvara che realizzò un'opera di elevato valore artistico e tecnico oltre che per la bellezza dei colori stampati. L'effigie del re fu racchiusa all'interno di una sottile cornice bianca, un vero quadro in miniatura, risaltandone ancor più il valore e l'importanza. Tale cornice venne contornata dalla scritta BOLLO DELLA POSTA DI SICILIA con in basso il valore in grana. La scelta dei colori utilizzati fu fatta con molta attenzione affinché fosse impossibile combinare un'affracantura tricolore, non voluta dai Borboni. Infine anche per l'obliterazione di tale serie fu creato un annullo particolare, detto a morsa di cavallo, su un disegno di Carlo La Barbera. Questo annullo permetteva di non deturpare l'effigie del Re e allo stesso tempo rendeva leggibile il valore stampato in basso sul bollo. Una serie indubbiamente bellissima. Complimenti a @Alan Sinclair e @marco1972 per gli esemplari postati1 punto
-
1 punto
-
@Carlo. il collezionismo esiste anche per le basse conservazioni, ci sono anche appassionati del vissuto MB - BB1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?