Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 09/23/25 in Risposte
-
DE GREGE EPICURI Mi pare sia un AE4 di Anniballiano, lontano parente di Costantino e, se ben ricordo, fatto uccidere a buoni conti dai figli di Costantino subito dopo la molte del padre. Al rovescio, SECURITAS PUBLICA con il fiume Eufrate. Moneta rara (valutata da Sear 400£ nel 1982) e molto falsificata, da vedere in mano da un esperto.3 punti
-
@urza1 qui se ti può interessare un piccolo lavoro sulle piastre di Francesco I. Saluti.3 punti
-
Buona sera. Se, da come ho capito, sia dritto che verso sono in incuso si tratta quasi certamente di un artefatto ottenuto pressando un tondello liscio tra due monete da dieci centesimi. Cordiali saluti. Gabriella3 punti
-
Moneta in alta conservazione con qualche lieve usura sui capelli e qualche piccolo graffio. È il classico esemplare dal bordo largo al D/. Io non amo le patine troppo scure poiché alla lunga nascondono dettagli ed il lustro. Per confronto e condivisione posto un mio esemplare:2 punti
-
Ciao a tutti, in un'altra discussione mi avevano consigliato di postare qui questo argento come un "orrore" - ERESIA! a parte il R un po' liscio, tutto sommato è ancora un qualcosa da conservare con riguardo ed in effetti è finita in buona compagnia. Guardacaso, proprio nello stesso lotto c'era un altro oggetto che si merita una citazione in questo luogo: Credo 10 Pfennig 1921 di Wilhelm II la composizione in zinco placcato alluminio spiegherebbe il degrado ed il diametro di ca. 20mm è compatibile. Qui due foto con più contrasto per poter meglio decifrare i dettagli. Sperando di non aver deluso le aspettative, Njk2 punti
-
Medaglia devozionale e celebrativa, bronzo/ottone, del primo quarto del XVIII sec. (dopo il 1712)- Roma.- D/ La Natività di Gesù, anepigrafe.- R/ Quattro santi: da SX, S. Felice di Cantalice (Rieti), S. Pio V, S. Andrea Avellino, S. Caterina da Bologna, esergo : ROMA. - Ciao Borgho2 punti
-
Salve a tutti, vi presento una delle mie ultime aggiunte, forse la piu’ cara, ma piacendomi la moneta ho scelto un esemplare sopra la media che compro di solito. Curiosa la mancanza di metallo nella “O”. Al solito, ogni parere e’ ben accetto.2 punti
-
Tecnicamente sono scorie all' interno della lega metallica che poi si dissolvono a causa del calore causato dal processo di fusione lasciando dei "vuoti" quando la lega si raffredda,a volte queste carie le troviamo anche sul dritto o sul rovescio o addirittura su ambedue le facce,lo stesso problema si riscontra anche nei 10 tornesi di Ferdinando II di Borbone nei primi anni di regno...2 punti
-
Un buon giorno e un grazie sarebbero graditi: a mio modesto parere una riproduzione moderna.2 punti
-
Per non dimenticare la discussione, condivido volentieri due recenti ingressi in raccolta: a) un ducato di Tomaso Mocenigo (1414-1423) (g 3,54); e b) uno zecchino di Francesco Morosini (1688-1694) (g 3,50).2 punti
-
Ciao @Ale75e @Antonino1951non colleziono ne studio monete del basso impero però ne ho viste diverse in vendita di cosidette " doppie maiorine" con peso e diametro che possono corrispondere a quelle del post. Anche la forma un po anomala come osservato da Nino potrebbe essere frutto di modifiche successive alla sua coniazione per chissà quale motivo. Quindi potrebbe anche essere. Il problema è che non si riesce ad identificare neanche la personificazione sul rovescio percui rimarco quando da me già detto in un mio precedente intervento, resta purtroppo una moneta non identificabile 🙂. ANTONIO2 punti
-
2 punti
-
Immagino provenga dallo stesso venditore belga dell' altro Francobollo, visto che anche questo lo cataloga con lo Scott. Gia' di per se catalogare un Francobollo degli A.S.I. (Antichi Stati Italiani) con un catalogo americano lascia perplessi, avesse usato il Michel tedesco straricco di informazioni avrei concordato, ..ma che ci vogliamo fare ha usato il catalogo che possiede, ecco quando dico che molti venditori non sanno bene quello che fanno, ma sicuramente non e' il caso nostro e a noi comunque conviene così. Il tuo esemplare è il 5c verde senza punto dopo il 5 e con punto grosso dopo cent, emesso esattamente il 2.9.1852, la mancanza del punto dopo il 5 e' già una varietà che e' quotata di più dell' altro. Nel tuo esemplare compaiono a dx e in basso le linee tipografiche e anche questo è un altro plus valore non da poco perché delineano margini ampi, ma e' comunque ben marginato sia in alto che a sx dove le linee non compaiono, e' un linguellato che a vederlo a schermo sembrerebbe non nascondere nessun difetto occulto, immagino tu lo abbia controllato in controluce. Sotto un esemplare con la linea tipografica tra due esemplari Sotto un esemplare come il tuo senza punto dopo il 5 ma della variante di colore verde oliva Al momento non mi viene di aggiungere altro, mi scuso per la polemica sul venditore che magari non interessava e curiosità mi muove a chiedere quale fu la spesa e il commento del venditore se ci fu..?? E' comunque un altro bel n.#1, complimenti. PS. Annullo a sei barre.2 punti
-
2 punti
-
Condivido volentieri questo esemplare del Manin “ribattuto” da poco in raccolta. Salvo errori, non è presente in questa discussione. Saluti.2 punti
-
HONI SOIT Q MAL Y PENSE Per chi fosse interessato in questa discussione si trova la spiegazione del significato del motto da parte di @Cinna74 post 822 punti
-
Mah... io la prenderei con le molle... Potrebbe essere non un brokage ma un artefatto truffaldino fatto con una moneta pressata su un tondello.. Proprio il fatto che abbia l'asse ruotato mette il dubbio... Il doppio brockage è difficile come errore di conio.2 punti
-
2 punti
-
La cifra che ne ricaveresti non ti cambierebbe la vita ma conservare il ricordo del nonno non ha valore...2 punti
-
Genova città etrusca Da cosa derivi il nome di Genova è ancora una questione controversa. Gli scrittori di lingua greca la citano come Genua. Gli studi moderni di glottologia fanno derivare l’appellativo dall’indoeuropeo g(h)enu “bocca”, acquisito nella lingua celto-ligure parlata nella Liguria dell’età del ferro, con riferimento alla posizione geografica. Il nome fu in seguito probabilmente fatto proprio dagli Etruschi insediati sulla collina di Castello e reso in etrusco con il vocabolo “kainua” “città nuova”, che rientra in un gruppo di nomi etruschi di città come Mantua-Mantova. Genova, già piccolo insediamento tribale ligure, nasce dunque come città etrusca : un grande centro commerciale (emporium) attorno ad un tempio dedicato ad una divinità protettrice. L’esistenza sulla collina di Castello di uno o più luoghi di culto è suggerita da alcuni graffiti, con iscrizioni, come le parole “ais” (dio) e “al” (dono), dunque un luogo dove si facevano offerte alla divinità, e da un’iscrizione incisa su un ciottolone in serpentino lavorato per essere infisso verticalmente in un supporto, che riporta il nome dell’autore della dedica, un certo Nemetie di origine celto-ligure. La divinità venerata sarebbe Sur(i)/Soranus, oggetto di culto in Etruria e nel Lazio, con un importante santuario nell’emporio di Pyrgi da dove provengono molti reperti ritrovati in loco. Oltre alle merci, gli etruschi portano anche la scrittura, come dimostrano le iscrizioni rinvenute negli scavi, redatte infatti in lingua e caratteri etruschi. L’ortografia segue le norme dell’Etruria settentrionale. Fin dalle sue origini Genova appare legata alle vicende del porto, creato in uno degli approdi più favorevoli e protetti dell’arco costiero ligure, lungo le rotte battute dalle navi mercantili, etrusche e greche. Le rotte sottocosta, già utilizzate fin dal Neolitico, come dimostrano i rinvenimenti di ossidiana da Lipari nelle grotte del Finalese e, con maggiore frequenza a partire dal VII secolo a.C., come documentano i materiali di importazione marittima rinvenuti negli scavi dei centri della Liguria orientale, offrivano protezione dai violenti venti di scirocco e libeccio che tuttora, in alcuni periodi dell’anno, rendono pericolosa la navigazione. Le alture dell’entroterra di Genova risultano già frequentate nella Preistoria. Tali presenze dimostrano la vitalità di percorsi di crinale intensamente frequentati, sia per la caccia, sia, più tardi, per lo sfruttamento delle risorse dei boschi, la pastorizia e l’agricoltura. In occasione dei lavori per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza della Vittoria è stato individuato a circa 12,5 metri sotto il piano stradale, un livello di frequentazione che conteneva un frammento di legno lavorato, datato, con analisi radiocarboniche, al Neolitico. La scoperta ha suggerito l’ipotesi dell’esistenza di una palafitta presso la foce del torrente Bisagno, zona allora paludosa ed anche oggi segnata da frequenti allagamenti. Maggiori informazioni restituisce un insediamento individuato nel cantiere della metropolitana in piazza Brignole, rimasta fuori del centro abitato fino alla costruzione della settima cinta muraria del 1626 e rimasta campagna fino ai grandi interventi urbanistici ottocenteschi. Durante i lavori di costruzione sono stati raccolti alla profondità di circa 5 m dal piano di calpestio materiali che risalgono ad un periodo tra il 3000 e il 2000 a.C.o (età del Rame/Bronzo Antico) e alla prima età del Ferro. Una grande struttura muraria in pietre a secco, della lunghezza di circa 12 metri che delimita un ampio spazio con tracce di focolari. Dunque alla fine dell’età del Bronzo e nella prima età del Ferro lungo l’arco costiero fra il capo del Promontorio e la penisola del Molo sorgevano piccoli nuclei abitati, di cui restano solo pochi frammenti di ceramica e di intonaco cotto, raccolti nel cantiere della metropolitana di Principe e nell’area del Portofranco. Ma le prime consistenti tracce archeologiche di frequentazione dei luoghi ( frammenti di anfore vinarie etrusche) sono state identificate nella zona del porto antico, materiali databili tra la fine del VII e la fine del VI secolo a.C., che costituiscono la prova dell’utilizzo come approdo, da parte di mercanti stranieri, del tratto di costa che divenne più tardi il porto medievale. Situato al centro dell’arco ligure, all’inizio l’approdo svolgeva probabilmente funzioni di scalo tecnico, per l’abbondanza di acqua potabile e combustibile, la presenza di una spiaggia riparata su cui tirare in secca le imbarcazioni (che a quel tempo navigavano solo di giorno) e la protezione della penisoletta del Molo in caso di burrasca. Il complesso dei materiali dei livelli della fine del VII e VI secolo di Portofranco mostra una notevole varietà di provenienze e costituisce una sorta di repertorio delle merci commerciate lungo le coste tirreniche, con una netta maggioranza di oggetti provenienti dall’Etruria costiera (vasellame in bucchero, recipienti da cucina e da dispensa e anfore vinarie. Un numero consistente di materiali proveniva da Caere (Cerveteri), importante città etrusca, vicina al Tevere e al territorio dei Latini, che dalla fine del VII secolo esportava a Nord (attraverso il porto di Genova) i prodotti della sua ricca agricoltura. Genova dunque nasce già come è oggi, il porto della pianura padana e oltre questa, attraverso i passi alpini, la via principale per il nord Europa per le merci provenienti dal Mediterraneo. Già da allora venivano utilizzati percorsi lungo la Val Polcevera in seguito ricalcati dal tracciato romano della via Postumia e oggi dalle moderne autostrade. Grande importanza aveva il commercio di ambra e di schiavi che arrivavano da nord tramite i Celti. In cambio gli Etruschi fornivano soprattutto il vino accompagnato dagli oggetti necessari per il suo consumo: vasi in bucchero, ceramiche dipinte e recipienti in metallo. Tra la fine del VII e i primi decenni del VI secolo a.C. ebbe inizio anche un commercio con la Gallia, dove nel 600 a.C. era stata fondata in territorio ligure la colonia greca di Marsiglia. Ma Genova riserva altre sorprese. Nel corso dei lavori di scavo per la realizzazione di un pozzo per la metropolitana nella Spianata dell’Acquasola è stata messa in luce, a 14 metri di profondità dal piano di calpestio, parte della base di un grande tumulo sepolcrale che si ritiene simile a quelli di Cerveteri, che misurava in origine circa 15 metri di diametro ed era circondato da un muro di sostegno. All’interno del tumulo sono stati rinvenuti i resti di alcune tombe a incinerazione, costituite da quattro lastrine di pietra infisse verticalmente per delimitare uno spazio quadrangolare entro cui doveva essere deposto il corredo. La struttura monumentale della tomba e le sue dimensioni suggeriscono che fosse destinata ad un personaggio importante, la cui sepoltura doveva trovarsi in posizione centrale, attorniata da altre, forse di parenti stretti. I corredi ritrovati conservano frammenti di bucchero di produzione etrusco meridionale, di alcune coppette, due piccoli perni in bronzo attribuibili ad un gancio di cinturone e due fibule in bronzo, oggetti provenienti da siti tra Lazio e Campania frequentati da mercanti etruschi. Il ritrovamento nella tomba dei resti di una donna di circa trent’anni che dagli oggetti di ornamento dovrebbe aver indossato un costume tipico dell’area campano laziale hanno fatto pensare che allora fosse già in atto a Genova una politica di scambi e alleanze suggellate da matrimoni. Dunque una nobildonna etrusca del sud andata in sposa a un ricco genovese forse di etnia ligure a stringere un patto di alleanza finalizzato al commercio. Alla fine del VI secolo a.C. risalgono le prime tracce di frequentazione del colle di Castello, uno sperone roccioso sul crinale che si prolunga fino alla penisola del Molo (vicino agli attuali Magazzini del sale e a Porta Siberia), che offriva una buona visibilità sull’intero arco costiero, da Portofino fino a Capo Mele. Le buche per palo e per i focolari ritrovati nell’area del convento di San Silvestro, fanno pensare a capanne in legno, probabilmente con copertura di paglia o stoppie. Anche due edifici in pietra sono attribuibili a questa prima fase di vita dell’oppidum, come il sito fu più tardi definito dagli storici di età romana: il primo era un recinto monumentale, con un’apertura delimitata da pilastri, costruito accuratamente in blocchetti di pietra disposti in filari regolari. Il vasellame ritrovato era in netta maggioranza importato. Si tratta prevalentemente di recipienti da cucina proveniente da vari centri dell’Etruria, mentre fra le ceramiche fini da mensa sono attestati vasi di fabbricazione attica a figure nere e figure rosse. Essendo un grande emporio, Genova etrusca commerciava, come si è visto, anche con i Greci della attuale Francia meridionale e in particolare di Massilia (Marsiglia). La realizzazione di un centro stabile a Genova sembra rispondere, ad un’esigenza di mercato. La convergenza sul porto di una rete di percorsi di crinale e di fondovalle in corrispondenza di valichi, che collegavano la città ai territori padani, e la posizione costiera in un punto centrale del golfo ligure facevano della città una cerniera tra Etruschi, Greci di Marsiglia, Celti e Liguri dell’interno. Nel V secolo Genova era già un importante centro portuale che riceveva derrate alimentari e prodotti artigianali da tutto il Mediterraneo, in parte utilizzandoli direttamente, in parte smistandoli verso il Piemonte meridionale e i siti costieri della Liguria centrale. Insomma “l’emporio dei Liguri” di cui parla Strabone. Nel corso della prima metà del V secolo l’abitato sulla collina di Castello si ingrandisce. Nell’oppidum trovavano posto anche officine per la lavorazione dei metalli, principalmente del ferro, come dimostrano le abbondanti scorie di lavorazione e un resto di forno fusorio, Tracce che testimoniano della presenza di artigiani provenienti dall’Etruria, all’epoca all’avanguardia nella siderurgia. Qualcuno ha ipotizzato la presenza di esperti etruschi che esploravano l’entroterra alla ricerca di giacimenti da sfruttare. Sono stati rinvenuti anche ovili, pollai e recinti per animali. Lo studio delle ossa documenta la presenza oltre che di animali allevati per l’alimentazione, anche di cani e cavalli. Circa alla metà del V secolo l’oppidum fu circondato da una poderosa cinta muraria di circa due metri di spessore. Nel tratto occupato nel medioevo dal palazzo del Vescovo sono stati ritrovati i resti di una torre quadrangolare che permetteva il controllo dell’intero arco portuale e di un vasto braccio di mare che a Ponente arrivava fino a Capo Noli. All’estremità nord, nell’area ora occupata dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie la nuova, si apriva una porta che costituiva l’accesso all’oppidum per chi proveniva dal porto. Lo spazio interno era pavimentato in ciottoli, mentre all’esterno del muro una rampa gradinata di pietre sovrapposte, in discesa è stata interpretata come ciò che resta della antica via che dai moli saliva alla città posta sulla cima del colle. Come tutti i centri etruschi la città dei vivi era circondata da quella dei defunti. La necropoli preromana si estendeva sulle colline di Santo Stefano e Sant’Andrea, separate dal corso del torrente Rivotorbido. Gli oggetti di corredo più antichi risalgono al primo quarto del V secolo a.C., cioè a circa due generazioni dopo la fondazione dell’oppidum, ma nel corso dei lavori in piazza Dante, nel 1910, furono raccolti anche alcuni frammenti di vasi etruschi a figure nere del VI secolo a.C. che fanno supporre che le tombe più antiche siano andate distrutte nel corso dei secoli. La forma delle sepolture, radicalmente differente da quella a cassa in lastre di pietra, adottata invariabilmente presso le popolazioni Liguri dall’VIII secolo a.C., è tipica dell’Etruria settentrionale interna e padana, e dimostra come questo tipo di sepolcro sia stato introdotto a Genova dagli immigrati Etruschi. Ciascuna tomba ospitava uno o più defunti, legati da rapporti famigliari. La composizione dei corredi rispecchia un benessere diffuso. Dunque, fin dai suoi primi secoli Genova fu una città ricca, ma anche un centro multietnico proprio per la frequentazione di mercanti provenienti da ogni zona del Mediterraneo e dell’Europa. La città non aveva una composizione etnica omogenea, ma formata di genti provenienti da aree diverse, portatrici quindi di differenti culture, tuttavia proprio da ciò che è stato ritrovato appare chiaro che sono gli Etruschi l’etnia dominante. Essi introducono la metallurgia, controllano l’emporio, introducono la scrittura, influenzano fortemente culti e rituali funerari, la cerimonialità collettiva (corredi da vino), le tecniche artigianali ed edilizie. I nomi di persona documentati a Genova, talvolta abbreviati o suggeriti dalle sole iniziali, graffiti con uno strumento appuntito sulle pareti o sul fondo di vasi di uso quotidiano per segnalarne il possessore, sono in maggioranza etruschi. Gli etruschi soprattutto controllavano il commercio. Dall’area di Golasecca proveniva la donna di alto rango sepolta in una delle tombe della necropoli insieme a un ricco apparato di gioielli fra cui spiccano una elaborata collana di ambra con pendenti intagliati a forma di stivaletto o vaso. La presenza di una ricca e probabilmente donna straniera sepolta a Genova rappresenta un’ulteriore conferma dell’uso di cementare alleanze commerciali medianti matrimoni. I gioielli della tomba, indicano anche strette connessioni con i centri dell’Etruria padana dove operavano botteghe orafe che producevano fibule in metalli preziosi e raffinate collane e pendagli intagliati nell’ambra importata dal Mar Baltico attraverso i Celti. Molti altri elementi di collana in ambra sono stati rinvenuti nella necropoli e nell’abitato, insieme ad altri oggetti di importazione come alcune raffinate fusaiole in pasta di vetro prodotte principalmente fra Veneto e Slovenia e diffuse specialmente in sepolture nel Veneto, in Etruria padana e nel Piceno. Ma Genova era anche un importante luogo di reclutamento e imbarco di soldati mercenari. Lo testimonia l’elevato ritrovamento di armi e complementi di abbigliamento militare prodotti in tutto il Mediterraneo, un elemento in contrasto con l’immagine di una società dedita prevalentemente al commercio e all’artigianato e dunque sostanzialmente pacifica. Questo ha fatto pensare non alla presenza di una forte guarnigione a protezione della città e del porto, ma al possibile ruolo di Genova come porto di imbarco e reclutamento di truppe mercenarie. Le fonti storiche sono infatti ricche di testimonianze sull’impiego di mercenari liguri e celti, specialmente da parte dei Cartaginesi e dei Greci. di Giorgio Amico http://storiaminuta.altervista.org/genova-citta-etrusca/2 punti
-
1 punto
-
Nel variopinto mondo dei monogrammi della repubblica romana ne esistono alcuni ai quali risulta difficile collegare un personaggio mitico o un piu' semplice Magistrato , si va quindi per supposizioni cercando tra i passi scritti degli storici i probabili collegamenti tra monogramma e personaggio . Uno di questi monogrammi , diciamo misteriosi , e' il PT o TP , al quale riesce piuttosto difficile collegare il nome del personaggio di riferimento . Provo a collegare a questo monogramma il personaggio Publio Baebio Tamphilo , ma chi era costui , nel caso fosse lui ? La strada della memoria che mi porterebbe a collegare PT al suddetto personaggio e' vaga , infatti non ricordo bene a sola memoria ed ora non ho sottomano i testi per la verifica , se la notizia provenga da Tito Livio (ab Urbe condida) o da Dionigi di Alicarnasso (Antichita' romane) o da Plutarco (Vite parallele) o da altro storico antico della repubblica romana . Chiunque sia lo storico il passo e' questo : Sotto il consolato di P. Cornelio e P. Bebio Tamfilo , in un terreno di L. Petilio , alle falde del Gianicolo , furono rinvenute delle antiche arche (cassa , sacello , tomba) di pietra . Letto che in un' iscrizione posta sulla prima delle due arche era indicato che c' era il corpo di Numa Pompilio , mentre nella seconda arca erano stati nascosti sette libri latini sul tema delle leggi dei Pontefici , ed altrettanti libri ma scritti in lingua Greca sul tema di una materia straniera , i libri latini vennero conservati per volontà del Senato , invece il Pretore Q. Petilio bruciò quelli Greci , tramite i Vittimari , uomini che erano gli addetti al sacrificio e che avevano il compito di condurre la vittima all’ ara e ucciderla estraendone quindi le viscere , in base a queste e sul modo in cui si presentavano , gli aruspici , cioe' i Sacerdoti , emettevano un giudizio se favorevole o contrario alla comunita' o al comandante in caso di guerra , o nel caso di prodigi . Quindi dopo aver allestito un rogo al cospetto del popolo , dal momento che aveva dichiarato che essi sarebbero stati di danno alla città , quei libri greci vennero bruciati . Dopo che il duumviro M. Atilio , dopo essere stato corrotto , aveva dato a Petronio Sabino affinché lo ricopiasse un libro affidato alla sua custodia e contenente i segreti dei rituali sacri , il re Tarquinio ordinò che quello , dopo essere stato messo in un sacco , venisse gettato in mare ; molto tempo dopo per mezzo di una legge , lo stesso genere di supplizio venne usato verso i parricidi , perché la violazione dei genitori e degli dèi doveva essere eseguita con la medesima punizione . Ora letta questa storia sarebbe assurdo pensare che il P(ublio) Baebio Tamphilo sia il personaggio di questa storia il cui monogramma compare nell' Asse , al tempo di questa storia leggendaria la “moneta” di Roma era forse l' AES rude , non certamente il bronzo coniato . E' probabile , ma impossibile dimostrarlo , che un antico discendente della Gens Baebia , forse il Console nel 182 a.C. e precedentemente Pretore nel 199 a.C. , Cneo Baebio Tamphilo , oppure suo figlio con lo stesso prenome e cognome del padre Console , i cui soprannomi o cognomi erano rimasti invariati fin dalla remota antichita' : Tamphilo , vollero ricordare il loro antenato comune Publio Baebio Tamphilo tramite il monogramma PT o TP, a ricordo di quei fatti leggendari risalenti all' eta' regia . Quasi tutti i passi della storia sopra narrata , di cui non ricordo la sorgente , provengono dal sito : https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4ea2230805fcb1f1a31269736e3396abc290cf2c4b1997dc69a376322bbb1f16JmltdHM9MTc1ODU4NTYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0fc354c2-4a46-699f-259b-42e34b31682d&psq=Publio+Baebio+Tamphilo&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc2t1b2xhc3ByaW50Lml0L2xpYnJvLWxhdGluby90YW50dWNjaS1wbHVzL3AtY29ybmVsaW8tYmFlYmlvLXRhbXBoaWxvLWNvbnN1bGlidXMtaW4tYWdyby1sLXBldGlsaS1zdWItaWFuaWN1bG8tYXJjYWUtYW50aXF1YWUtbGFwaWRlYWUtcmVwZXJ0YWUtc3VudC1MXzk2NTMyLmh0bWw Allego un mio Asse con il monogramma PT o TP a secondo di come lo si vuol leggere , personalmente penserei piu' a leggerlo come PT , ma e' solo una personale opinione derivante da quanto esposto . Pesa 36,6 grammi ed e' un Cr.177/11 punto
-
Ciao, oggi condivido un sesterzio dell'imperatore Commodo ( 180-192 d.C) con la raffigurazione sul rovescio del dio Ercole coniato a Roma nel 183-184 d.C. (mi auguro 🙂). Figlio dell'ottimo Augusto Marco Aurelio capace governante, di grande cultura e molto amato dal popolo, lo sostituì per successione alla sua morte nel 180. Di carattere totalmente diverso dal padre, molto eccentrico e stravagante per usare degli eufemismi, si distinse per la sua crudeltà e libertà di costumi e per la sua insofferenza verso il Senato e quindi la politica che gli causarono numerosi tentativi di congiure per eliminarlo, l'ultima delle quali andata a buon fine nel 192. A strangolarlo fu il suo maestro di lotta ed ex gladiatore Narcisso sotto l'impulso di alcuni senatori e grazie alla complicità della sua amante Marcia che lo tradì. Fu decretata per lui la "damnatio mamoriae" che fu revocata poco tempo dopo da Settimio Severo che addirittura lo divinizzo' a dimostrazione che tale pratica era più un fatto politico che di sostanza, ma tant'è. Grande appassionato di spettacoli gladiatorii amava anche esibirsi nell'arena in combattimenti (per amore della verità sicuramente aggiustati a suo favore) contro animali e persone. Si riteneva invincibile (strano 🙄) e si diede a tal proposito l'appellativo di Ercole Romano facendo coniare anche monete dove il suo busto e la sua testa erano coperti dalla pelle di leone, uno degli attributi appunto di Ercole. E qui mi ricollego al rovescio del mio sesterzio dove si vede lo stesso stante, con un arco nella mano sinistra, sullo stesso braccio ben visibile la pelle di leone ed ultimo attributo la clava sulla quale si appoggia con il braccio destro. Da esame diretto risulta coniato, abbastanza centrato, con modulo ridotto perché chiaramente di barra che ha penalizzato le legende mancanti già in origine ed ha circolato svolgendo la sua funzione di moneta. Qualsiasi intervento integrativo o di condivisione di monete sarà molto gradito. Grazie ed alle prossime ANTONIO 29,50 mm. 20,87 g. RIC 3651 punto
-
Mi sembra che in questa discussione non se ne sia parlato, e, quindi, approfitto per postare questa “chicca”. Lotto 408 Asta Scuotto 4 del 20 settembre u.s.: Regno delle Due Sicilie. Ferdinando IV di Borbone (1759-1816). 4 Cavalli 1788 (senza valore nominale). Moneta di prova. Cu. Magliocca 337a. RRRRR. Estremamente rara. Con slab NGC n. 6894101-012 sigillata MS 65 BN. (miglior esemplare conosciuto). Grading/Stato: MS 65 BN Note: Un esemplare simile (sigillato MS 64) nell'asta HeritAge 3029 del 2014 (lotto 30776) ha realizzato 16.450$ + diritti. Ex Lotto 792 Asta Cambi 9/11/2023 (terza tornata) Asta Numismatica I Busto di Ferdinando a d. R/ Grappolo d'uva; sotto, 1788. Gig. 164 (R/5). MIR 406/1 (R/5). Pannuti-Riccio 136. Della massima rarità. g. 2,15. Diam. 19,02. Rame. q.FDC Vi segnalo il seguente link dove si può apprezzare anche un video dell’esemplare: https://www.biddr.com/auctions/cambi/browse?a=3953&l=4667998 Ex Lotto Lotto 1993 Asta Sincona World Coins and Medals SINCONA Bullion Auction Coins, Medals and Banknotes from Switzerland - Auction 94 22-23 October 2024 Zurich L’esemplare Heritage richiamato e’ il seguente: cosi descritto: Naples & Sicily. Ferdinando IV copper Pattern 4 Cavalli 1788-P, MIR-406/1, MS64 Red Brown NGC. Beautifully struck on a broad flan with substantial mint red remaining, this extreme rarity is listed in MIR as R5. This pattern is identified by the lack of a denomination on the reverse. As with the 10 Tornesi listed below, no examples of this type could be found having sold at auction. Considering the fact that early patterns are so prized by collectors, a rarity such as this will demand a premium bid from the serious Neapolitan specialist. SOLD ON JAN 15, 2014 FOR: $16,450.00 Il Pannuti-Riccio fa riferimento proprio a questo ultimo esemplare (Heritage) al n. 136 con riferimento al lotto n. 2727 della famosa asta di M. Othon Leonardos: Riportato dal MIR al n. 406/1 (con riferimento al P/R 136) con rarità R5 e senza alcun tipo di valore. Interessante iniziativa di un’azienda del Casertano che ha fatto riconiare i 4 cavalli di prova del 1788 per impreziosire un vino amato già da Ferdinando IV Prova, senza indicazione di valore, dei 4 cavalli di Ferdinando IV del 1788: qui l’esemplare passato in asta Heritage nel 2014 di Antonio Castellani | Come gli appassionati di numismatica meridionale sanno, nel 1788 la zecca di Napoli realizzò un progetto per la nuova moneta da 4 cavalli in rame che avrebbe dovuto raffigurare sua maestà Ferdinando IV di Borbone, per sostituire le vecchie monete precedenti con lo stesso valore. Questo progetto in rame (mm 18 per g 2,1, gigante 164), di estrema rarità, manca al rovescio del valore e raffigura un grappolo d’uva, simbolo di fecondità ed emblema della coesione del Regno sotto l’egida dei Borbone, affiancato da due pampini e accantonato dalla data 1788 ai lati. Emblematico il profilo del grappolo, che ricorda la forma di un cuore. Attorno al ritratto sovrano sul dritto, per mancanza di spazio, la titolatura è quella di SICIL[iarum] REX e il ritratto si caratterizza per i lunghi capelli fluenti e il profilo verista, che nulla nasconde della fisionomia di re Ferdinando. La moneta di serie, molto simile ma con l’indicazione del valore C. 4 (CAVALLI 4) ai lati del grappolo, fu battuta dal 1788 al 1792 e anche nel 1804. Oggi quel progetto di moneta, grazie a un’idea dell’azienda campana Vinum Fabulas, è tornato d’attualità dal momento che una versione in argento della prova da 4 cavalli 1788 – fatta coniare dal laboratorio presso il laboratorio della Fondazione Antica Zecca di Lucca – è andata a impreziosire una tiratura limitata di bottiglie di vino bianco e rosso Pallagrello, quello che era chiamato – non a caso – “il vino del re”. Le bottiglie della collezione “Vinum Fabulas” portano all’esterno la riproduzione in argebnto dei 4 cavalli 1788 realizzata in collaborazione con la Fondazione Antica Zecca di Lucca Vitigno preferito da Ferdinando IV, il Pallagrello è un antica varietà citata già in una lapide celebrativa fatta installare nel 1775 per volere del sovrano a Piedimonte Matese, nel Casertano, in località Monticello. A questa fece seguito un decreto emanato dallo stesso Ferdinando IV che vietava a tutti il transito nelle zone adibite alla coltivazione del vitigno destinato alla produzione del Pallagrello (all’epoca chiamato “Piedimonte”). Moneta di normale circolazione del Regno delle Due Sicilie, valore 4 cavalli, anno 1788: il valore, C. 4, è sul rovescio ai lati del grappolo d’uva Simbolo ricorrente anche nella monetazione classica, presente ad esempio su magnifiche monete antiche di Naxos, Iguvium, della stessa Neapolis, il grappolo d’uva si impone per il suo valore iconico di comunicazione, legato com’è al vino, uno dei pilastri, assieme al pane e all’olio, dell’alimentazione dei popoli mediterranei. Fa piacere dunque che in un settore così importante per l’economia italiana – il settore vitivinicolo, noto in tutto il mondo – anche la moneta, per una volta, possa fare da testimonial impreziosendo un prodotto da collezione e, al tempo stesso, rivelandosi a tanti “profani” in tutto il suo fascino di documento storico. https://www.cronacanumismatica.com/la-prova-dei-4-cavalli-del-1788-diventa-dargento-sul-vino-del-re/ https://zeccadilucca.it/?p=470 https://vinumfabulas.it/ferdinando-iv/1 punto
-
1 punto
-
DE GREGE EPICURI La "associazione" non è nè il CCNM, nè la SNI, ma la "Associazione di via Armorari" che riunisce i gestori dei banchi, e non ha mai brillato per sensibilità culturale o iniziative; non credo che presidente e vicepresidente seguano questo Forum, e comunque non sono numismatici. Quello che vale la pena fare (e lo dico veramente a tutti) è inondare il Comune di Milano di lettere di protesta, indignazione, stupore per la lunga chiusura del mercatino, ecc. Si può scrivere ai 3 assessori più o meno competenti (Commercio, Cultura e Lavori Pubblici). Non preoccupatevi troppo del livello culturale delle lettere, tanto per loro quel che conta sono i numeri (perchè i numeri sono voti): quindi, devono credere che gli interessati ( e gli indignati) siano tanti, tantissimi.1 punto
-
1 punto
-
Mettila in acqua demineralizzata per qualche giorno, dopo spazzolarla leggermente con uno spazzolino da denti, asciugarla bene, e se le concrezioni sono sparite mettergli sopra un leggero strato di cera microcristallina, ciao Borgho1 punto
-
Non mancano sicuramente gli appassionati, che dispongono di grosse possibilità economiche, ma nessuno compra a 100 ciò che domani farà fatica a realizzare 50, quando ci sono alternative valide di investimento che hanno garantito guadagni sicuri, vedi l'acquisto di oro borsa. Finché dura .....1 punto
-
Altra piastra arrivata oggi, consumata quanto basta per piacermi . A voi ogni commento!1 punto
-
1 punto
-
Heritage World Coin Auctions > Showcase Auction 61555 Auction date: 6 October 2025 Lot number: 24061 Price realized: This lot is for sale in an upcoming auction Lot description: Ancients CILICIA. Tarsus. Pharnabazus, as Satrap (380-374/3 BC). AR stater (24mm, 10.89 gm, 1h). NGC AU★ 5/5 - 4/5. Ca. 380-379 BC. B'LTRZ (Aramaic), Ba'altars seated left on backless throne, grounded scepter surmounted by lotus in right hand / FRNBZW-HLK (Aramaic), bearded male head left, wearing crested Attic helmet. SNG Levante 71-72. Stunning splashes of aqua and amber on highly defined dies. Ex Classical Numismatic Group, Auction 102 (18 May 2016), lot 568; Classical Numismatic Group, Trion XVII 1&2 (7 January 2014), lot 350; Tkalec (October 1992), lot 150. www.HA.com/TexasAuctioneerLicenseNotice1 punto
-
Una funzione che è tutt'ora presente nella versione 2022, fu tolta durante l'ultimo aggiornamento nella versione 2021, successivamente, pur diventando la vecchia versione di default, la funzione non è stata più reinserita. Va da se che in mancanza di questa funzione chi utilizza la versione 2021 deve esclusivamente usare il cursore. A suo tempo era stato detto chiaramente che la vecchia versione non avrebbe avuto questo pulsante, ma dopo qualche anno, non trovandomi ancora a mio agio con la versione 2022, vorrei chiedere a @Reficul , se non è tecnicamente difficoltoso, se si può reinserire nuovamente questa funzione nella versione 2021. Grazie per l'attenzione1 punto
-
Eccomi, è indubbia la somiglianza e la rispondenza di molti particolari che mi fanno propendere per essere daccordo, il dubbio è nel nastro che hai evidenziato al dritto e nella lettera "C" vicina alla punta dell'arco al rovescio. Riguardando il nastro sono daccordo con te, la prima impressione è eccesso di metallo o possibile ritocco, non ho però sotto occhio altri esemplari al volo, in altri sesterzi, identità di conio a parte, risulta che sia allungato sulla C il nastro? Per quanto riguarda l'altra C al rovescio può essere semplicemente diversa conservazione 😃1 punto
-
Arzano zona remota? Non ci si crede. Ma non è che in UPS lavora qualche ex UFN che si vuole vendicare del licenziamento?1 punto
-
Piccolissima postilla,non abbiamo considerato che uno stesso conio poteva subire aggiustamenti stante la consunzione da stress1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Concordo totalmente. Il valore affettivo non ha prezzo e se qui sta anche quello numismatico,dettato tra l'altro da una bella peculiaritá, meglio ancora.1 punto
-
Quest'oggi ho trovato questa interessante web-serie in cui viene mostrato il museo Napoleone al Castello di Fontainebleau. La puntata che vi propongo, intitolata "La medaglia, un'arte al servizio del potere", tratta proprio della medaglistica e monetazione napoleonica. Il video è in francese ma inserendo i sottotitoli diventa abbastanza comprensibile anche per chi non mastica particolarmente questa lingua.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
newsletter 309 del 19.09.2025 Vite esemplari da non dimenticare Cari lettori, amici numismatici, è un dato di fatto che la quantità di informazioni con cui veniamo bombardati genera in noi, talvolta, un meccanismo di reazione al punto che tante cose essenziali vengono dimenticate mentre troppe, che sarebbe importante tenere a mente. Tra queste ultime ci sono "le vite esemplari", nel nostro caso quelle di alcuni numismatici del passato che la nostra rivista online - grazie all'impegno e alla bravura di Damiano Cappellari - di quando in quando riporta alla nostra attenzione di lettori. Questa settimana è la volta di Michele Baranowsky ed è davvero una vita che ha il fascino e il sapore di un film. A voi il piacere della lettura di questa nuova puntata della serie che potete scoprire per intero cliccando qui. Buona lettura da Cento anni fa le 100 lire Vetta d'Italia Genesi artistica, storia e curiosità sull'ultimo massimale del Regno coniato secondo i canoni dell'Unione Monetaria Latina. Continua a leggere Michele Baranowsky, una vita avventurosa Da fedelissimo dello zar Nicola II a mercante numismatico a Milano, conosciuto in tutta Europa: un'esistenza da raccontare. Continua a leggere La Metro C e le medaglie di Palazzo Venezia Il cantriere nel centro di Roma restituisce preziose testimonianze di fondazione del complesso architettonico voluto da papa Paolo II. Continua a leggere Monete del mondo in mostra ad Arezzo Inaugurata una nuova esposizione temporanea alla Casa Museo Ivan Bruschi tra coniazioni e biglietti strani, esotici e curiosi. Continua a leggere A quando le prossime euro monete italiane? Belle, bellissime ma forse ormai datate le facce nazionali tricolori fanno riflettere sull'opportunità di un futuro restyling. Continua a leggere In arrivo la divisionale fior di conio 2025 Ridotta a una tiratura di soli 6000 astucci, la serie delle euro monete di normale circolazione di quest'anno è prossima all'emissione. Continua a leggere La nuova 2 euro del principe Alberto II Novità nella numismatica monegasca: un ritratto "nuovo di zecca" per la bimetallica del Principato destinata alla circolazione. Continua a leggere Monete italiane, di Savoia e degli USA da Rinaldi La casa numismatica veronese, che compie cento anni, presenta una nuova offerta a prezzi fissi di esemplari selezionati. Continua a leggere La medaglia per la corazzata Viribus Unitis Orgoglio dell'Imperial regia marina di Vienna, la maestosa nave da battaglia è protagonista di una coniazione dalla storia curiosa. Continua a leggere Le alterazioni di colore nelle banconote Un nuovo punto di riferimento per riconoscere i biglietti da collezione genuini da quelli modificati per creare varianti cromatiche inesistenti. Continua a leggere Le foglie d'oro dei boat people Una pagina di storia del Novecento: come dei sottili lingotti salvarono la vita e gli averi di migliaia di persone nel Vietnam in guerra. Continua a leggere Nemici nella storia, uniti in moneta Giulio Cesare e Bruto, la vittima e l'omicida, in una emozoionante moneta commemorativa ad alto rilievo e in tiratura limitata. Continua a leggere buona lettura odjob1 punto
-
Buongiorno a tutti. Al Convegno di Rende ho trovato questa Piastra del 1787 di Ferdinando IV...presenta al rovescio un "ripensamento" da parte di chi ha approntato il conio madre. H(S)SPANIAR... Magari rara ma non introvabile ☺️1 punto
-
1 punto
-
denaro di Ginevra (fine XII sec - inizio XIII sec) dritto: +SCSPETRVS // testa di san Pietro a sinistra. verso: + GENEVACITAS // croce con S in 2° e 3° QUARTO https://fr.numista.com/catalogue/pieces199993.html Mario1 punto
-
Sicilia, recuperato in mare un elmo della battaglia delle Egadi del 241 a.C. Straordinaria scoperta nelle acque delle Egadi: i subacquei riportano in superficie un elmo in bronzo in eccezionale stato di conservazione dall’area della storica battaglia navale delle Isole Egadi del 241 a.C. Con il reperto anche una maniglia in bronzo e armi individuate tramite indagini radiologiche. Un recupero che getta nuova luce su uno degli episodi più significativi della storia antica del Mediterraneo. Nelle acque delle Isole Egadi, lo scorso agosto (ma la notizia è stata data solo stamani), è stato riportato in superficie un elmo in bronzo del tipo “Montefortino”, in straordinario stato di conservazione e completo dei paraguance. A individuarlo e sollevarlo dai fondali sono stati i subacquei altofondalisti della Società per la documentazione dei siti sommersi (Sdss), guidati da Mario Arena, sotto la supervisione della Soprintendenza del Mare, con il supporto dell’Area marina protetta, del Comune di Favignana e della Capitaneria di porto. Il manufatto proviene da un’area di mare carica di memoria: quella in cui, nel 241 a.C., si combatté la battaglia delle Egadi, scontro decisivo della prima guerra punica tra Roma e Cartagine. L’elmo, del tipo utilizzato dalle truppe romane tra IV e I secolo a.C., rappresenta uno dei ritrovamenti più importanti degli ultimi anni, sia per l’integrità del reperto, sia per il contesto storico a cui rimanda. “L’elmo Montefortino è uno dei più belli e completi mai recuperati”, commenta l’assessore ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato. “Questi ritrovamenti non solo arricchiscono la conoscenza storica della battaglia del 241 a.C., ma rafforzano l’immagine della nostra Isola come custode di un’eredità culturale unica al mondo. È un risultato straordinario, frutto del lavoro congiunto della Soprintendenza del Mare, delle professionalità impegnate nelle ricerche e del sostegno di istituzioni e fondazioni internazionali. Continueremo a investire nella tutela e nella valorizzazione di questo patrimonio, consapevoli che rappresenta una risorsa identitaria e culturale fondamentale per la Sicilia”. L’elmo ritrovato L’elmo ritrovato L’elmo ritrovato Il recupero dell’elmo si inserisce in un’attività di ricerca più ampia, che negli anni ha portato alla scoperta di numerosi reperti legati tanto alla battaglia delle Egadi quanto ad altre epoche. Durante la stessa campagna è stata riportata in superficie anche una grande maniglia in bronzo, proveniente dal cosiddetto “relitto del banco dei pesci”, datato al V secolo d.C. La funzione precisa dell’oggetto resta incerta, ma la sua lavorazione e le dimensioni ne fanno un pezzo di grande interesse per gli studiosi. Tutti i reperti recuperati sono stati sottoposti a un primo trattamento conservativo grazie all’intervento delle restauratrici della Sdss. Le operazioni sono state rese possibili anche grazie al contributo del mecenate statunitense Michel Garcia, che ha sostenuto le attività di tutela e conservazione. Parallelamente, le ricerche si sono avvalse delle più avanzate tecniche diagnostiche. Presso lo studio radiologico del dottore Giuseppe Perricone, a Trapani, sono state eseguite tomografie computerizzate (Tac) su circa trenta reperti metallici recuperati in anni precedenti e ancora fortemente ricoperti da incrostazioni. Le indagini hanno permesso di identificare all’interno delle concrezioni spade, lance e giavellotti, armi che furono impiegate nello scontro del 241 a.C. e che per oltre duemila anni sono rimaste celate dal mare. La combinazione tra indagini scientifiche e recuperi subacquei conferma il ruolo centrale della Soprintendenza del Mare nel coordinare attività che uniscono professionalità diverse, dalla ricerca archeologica alla conservazione, fino alla diagnostica radiologica. Il lavoro della Sdss, con il supporto delle istituzioni locali, ha consentito di arricchire un patrimonio che, già oggi, costituisce un unicum nel panorama della ricerca mediterranea. Un ruolo decisivo in questa attività lo ha avuto anche la Rpm Nautical Foundation, fondazione privata statunitense che da anni affianca la Soprintendenza del Mare con proprie risorse e mezzi tecnologici. Grazie all’impiego di una nave oceanografica e a strumenti di indagine avanzati, la fondazione ha contribuito a mappare e documentare i fondali delle Egadi, individuando relitti e aree di interesse archeologico. La battaglia delle Egadi, combattuta il 10 marzo del 241 a.C., rappresentò la conclusione della prima guerra punica. Lo scontro vide la flotta romana, guidata da Gaio Lutazio Catulo, prevalere su quella cartaginese comandata da Annone, decretando la vittoria di Roma e l’avvio della sua supremazia sul Mediterraneo occidentale. I ritrovamenti subacquei di elmi, armi e rostri navali hanno restituito negli ultimi decenni testimonianze concrete di quell’evento epocale, arricchendo il racconto storico con evidenze materiali. Il nuovo elmo Montefortino si aggiunge a questa serie di scoperte, distinguendosi per lo straordinario stato di conservazione. La presenza ancora integra dei paraguance lo rende un reperto rarissimo, capace di offrire agli studiosi dati preziosi sulla tipologia di equipaggiamento utilizzata dai soldati romani e sulle tecniche di fabbricazione del periodo. La sua integrità consente anche di ipotizzare future esposizioni museali, che potrebbero permettere al grande pubblico di ammirare da vicino un oggetto che ha attraversato ventiquattro secoli di storia. Il recupero della maniglia bronzea dal relitto tardoantico e l’identificazione radiologica delle armi testimoniano come l’area delle Egadi non sia soltanto legata alla battaglia del 241 a.C., ma rappresenti un vero archivio stratificato di vicende storiche e commerciali. I traffici marittimi, gli scontri navali e la vita quotidiana delle imbarcazioni trovano eco in questi ritrovamenti, che restituiranno, grazie a futuri studi, ulteriori tasselli di conoscenza. Infine, è stato pulito il rostro numero 25 già recuperato in una precedente campagna: è romano e presenta l’iscrizione “Ser.Solpicio C.F. Quaestor Probavi(t)”, probabilmente: “Servio Sulpicio, questore, figlio di Gaio, approvò”, sottinteso il rostro. Il Gaio, di cui il questore nominato era figlio, potrebbe ipoteticamente essere Gaio Sulpicio, console dal 243 a.C. e dunque in piena prima guerra punica. Il rostro 25 https://www.finestresullarte.info/archeologia/sicilia-recuperato-in-mare-elmo-battaglia-isole-egadi1 punto
-
Conoscendo Marco da tanti anni, uno degli organizzatori, sono sicuro che sarà un bellissimo convegno. La Calabria è una regione stupenda che merita eventi del genere. Il mese di settembre poi, è l'ideale per passare una settimana di ferie tra il mare cristallino e i borghi di montagna, veri e propri gioielli medievali. Sei giorni dedicati allo svago e alla famiglia, e uno per voi al convegno. Sono sicuro che la moglie non avrà niente da dire.1 punto
-
Salve,dovrebbe essere un bronzo greco di Kyme. È troppo consumata per capire quale,le posto un link per riconoscerla moneta in mano. https://www.acsearch.info/search.html?term=Greek+horse+kyme+ae&category=1-2&lot=&date_from=&date_to=&thesaurus=1&images=1&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1¤cy=usd&order=01 punto
-
Come da titolo posto una tessera mercantile 1,66 gr per 2 cm con al dritto una croce tra una stella ed una falce di luna mentre sul retro una una valva di conchiglia.Ho cercato anche sul sito ma non ho trovato nulla di simile.Vi rigrazio per eventuali risposte1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?













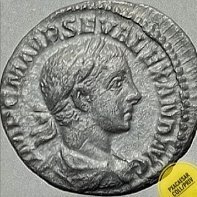





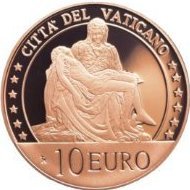







.thumb.jpg.49bf7893ab8deb0b9efbfc02c41b7421.jpg)




