Tutte le attività
Questo elenco si aggiorna automaticamente
- Ultima ora
-

ID moneta 2
gennydbmoney ha risposto a un topic di Carlo. inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Il catalogo del forum purtroppo non è aggiornato... -
Quadrante di Vespasiano
Antonino1951 ha risposto a un topic di AntonioPiano95 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Salve.la luce diretta non aiuta molto ma anche alcune infiorescenze verdi e la patina fanno propendere per la genuinità -
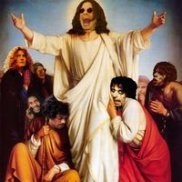
100 lire minerva
Massimiliano Tiburzi ha risposto a un topic di Steki92 inviato in Repubblica (1946-2001)
ti do un consiglio, posta sempre le foto della moneta altrimenti parliamo del nulla senza vedere, magari la conservazione è più alta o più bassa di quanto riportato -

cartoline Basilica SS. Annunziata del Vastato - Genova
Carlo. ha risposto a un topic di Carlo. inviato in Filatelia e Storia Postale
Grazie mille!! -
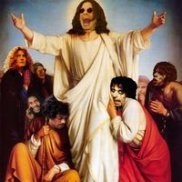
Richiesta Valutazione: 1 Euro Italia 2002 con Triplo Errore (Misaligned Core/Double Rim/Understruck)
Massimiliano Tiburzi ha risposto a un topic di 27uk.it777 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
nessuna evidenza di errori di conio o altro -

cartoline Basilica SS. Annunziata del Vastato - Genova
PostOffice ha risposto a un topic di Carlo. inviato in Filatelia e Storia Postale
La coppia e' del 5c verde, emissione umbertina del 1893 sino al 1897, stemma valore in cifre grandi. Cartolina in perfetta tariffa per l'interno. Due belle cartoline veramente, che hanno trasportato pensieri e che li hanno mantenuti sino ad oggi. -
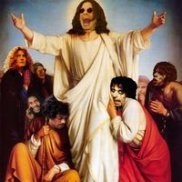
1 euro Francia 1999 tondello interno decentrato
Massimiliano Tiburzi ha risposto a un topic di 27uk.it777 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
cosa avrebbe di errore? non mi pare di ravvisare nulla -
1 EURO SENZA TONDELLO CENTRALE
andrea78ts ha risposto a un topic di elledi inviato in Tecniche, varianti ed errori di coniazione
Questa è una domanda frequente che mi fanno le persone. Ma come è possibile che escano delle monete con errori dalla Zecca? Non ci sono dei controlli? La risposta è: si, ci sono i controlli come ogni società industriale ha dei controlli di qualità, ma questi controlli non possono essere tali da verificare moneta per moneta. Per avere un'idea una pressa moderna conia 600 monete al minuto, 10 monete al secondo, una velocità pazzesca. L'IPZS è una società privata con scopo di lucro che riceve dallo Stato la commessa di produrre X miliardi o milioni di pezzi di monete. Come ogni società produttiva deve ottenere il miglior risultato con il minimo sforzo secondo gli standard di qualità che si è posta. Ora, la perfezione assoluta richiederebbe di controllare moneta per moneta, magari oggigiorno con sistemi digitali, ma ciò avrebbe come immaginabile dei costi molto elevati che andrebbero ad erodere i suoi utili oppure ad aumentare il prezzo da richiedere allo Stato (e quindi indirettamente su noi contribuenti). La perfezione assoluta che benefici avrebbe? Questi maggiori costi sono giustificati tanto da farli pagare ai cittadini? Che danno fa alla collettività se in modo episodico qualche errore scappa ed entra in circolazione? Sul punto è famosa una storica dichiarazione fatta dalla Zecca statunitense che nel 2000 ammise di aver commesso un clamoroso errore, cd. Sacagawea Mule, una moneta che oggi vale $150.000 circa. La Zecca USA dichiarò quanto segue: “The U.S. Mint goes to great lengths to avoid making mistakes when it manufactures coins. In fact, in its 208-year history, coin errors are a rare occurrence, but occasionally, misstrikes [sic] happen. … Of the 29 billion coins we’re producing this year, at least one billion Golden Dollars will be struck. As of today, there have been four confirmed error Golden Dollar coins found. Recently, there were unconfirmed reports that another 15 were discovered. To put this in perspective, if 19 error coins have been found, based on production figures, that means there is a 0.0000019 percent chance that an error Golden Dollar has been produced this year.” Ecco la traduzione in italiano: "La Zecca degli Stati Uniti (U.S. Mint) compie grandi sforzi per evitare errori durante la produzione delle monete. Infatti, nei suoi 208 anni di storia, gli errori di coniazione sono un evento raro, ma occasionalmente si verificano coniazioni errate [sic]. ... Dei 29 miliardi di monete che stiamo producendo quest'anno, almeno un miliardo saranno di tipo Golden Dollar. Ad oggi, sono state trovate quattro monete Golden Dollar coniate con errore confermato. Recentemente, ci sono state segnalazioni non confermate che ne siano state scoperte altre 15. Per mettere questo dato in prospettiva, se sono state trovate 19 monete con errore, in base ai dati di produzione, significa che c'è una probabilità dello 0,0000019 percento che una Golden Dollar con errore sia stata prodotta quest'anno." Dobbiamo farcene una ragione, la perfezione assoluta non è di questo mondo ed è anche assurdo pretenderla ad ogni costo. Gli errori ci sono e ci saranno sempre. Ogni settimana ricevo almeno una segnalazione di una persona (non collezionista) che trova un errore evidente: decentrature, occhi di bue, etc. nei rotolini oppure in circolazione. Peraltro gli occhi di bue, l'euro del 2009 dell'altro post o la corona di questo post, non sono errori della Zecca, sono errori del fornitore di tondelli della Zecca. I tondelli bimetallici arrivano alla Zecca già assemblati, quindi un addetto della Zecca non avrebbe neanche volendo la possibilità di creare ad arte un occhio di bue oppure l'euro 2009 che ho postato prima. Questa corona avrebbe potuto produrla, smontando prima un tondello da 1 euro e inserendo una corona vergine dentro la pressa. Ma se ho la possibilità di fare un errore perchè far fatica a smontare una moneta da 1 euro per creare un errore che anche in pochi capiscono? L'ho postato su facebook e la maggior parte delle persone pensava che fosse un normale euro smontato. Se avessi la possibilità di creare ad arte un errore farei un errore bello evidente e ben remunerativo come è stato fatto con il "centesimo mole". -

Buono/gettone da 20 centesimi del 1906 Esposizione di Milano
nikita_ ha risposto a un topic di Alan Sinclair inviato in Regno D'Italia: approfondimenti
L'esemplare che posseggo l'ho trovato più di dieci anni fa al mercatino in mezzo a della ferraglia varia, lucchetti, chiavi, posate, borchie di mobili ecc ecc e porta pesantemente i segni di tutti questi compagnetti che non si sono limitati a schiacciargli solo il naso -
danielo93 ha iniziato a seguire Dal 26% al 12,5%? Le ipotesi sulla nuova imposta per l’oro da investimento
-

Dal 26% al 12,5%? Le ipotesi sulla nuova imposta per l’oro da investimento
danielo93 ha aggiunto un nuovo link in Questioni legali sulla numismatica
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2025/11/13/spunta-la-tassa-sulloro-2-miliardi-in-dote-per-la-manovra_9ca39b39-f9ac-40a2-bb17-2f4d582b5ae1.html?fbclid=IwY2xjawOC1rVleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETBuRE1qRW1UU25sUVoyZkJDc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHm9n5PR31aRS8SvZV3jYOe1tvOJ8rLTwcvEZoSIoroLgOX5IitAlOhT9OWlQ_aem_leeOXAjvzRPj1UVjSkYSRg Ciao a tutti, potrebbe interessare a qualcuno. Riporto il testo dell'articolo dell'ANSA: E' sempre caccia alle risorse per le possibili correzioni alla legge di bilancio. Un'aliquota agevolata del 12,5%, anziché quella del 26%, per chi decida, entro il 30 giugno 2026, di rivalutare l'oro da investimento in proprio possesso (lingotti, placchette o monete). E' questa, secondo quanto risulta da una proposta parlamentare, una delle ipotesi allo studio per la cosiddetta tassa sull'oro che potrebbe essere inserita in manovra. Ipotizzando un'adesione del 10%, la misura darebbe un gettito stimato tra 1,67 e 2,08 miliardi. L'obiettivo della misura, si legge nel documento, è "facilitare l'emersione e la circolazione di oro fisico da investimento, garantendo al tempo stesso un incremento del gettito". I punti della manovra sui quali si concentrano le ipotesi di limature sono quelli emersi in questi giorni: dai dividendi alle forze dell'ordine agli affitti brevi. Su quest'ultimo capitolo a insistere sono in particolare FI e Lega mentre fonti di FdI spiegano di considerarlo un tema "importante ma non prioritario". Tra le misure che vengono date per assodate quella del rifinanziamento per 49 milioni (che andrebbero ad aggiungersi a 25 residui) della legge cosiddetta Cisl sulla partecipazione dei lavoratori alle imprese. Se ho capito bene, al momento non c’è ancora nulla di definitivo, ma la misura potrebbe rappresentare una buona occasione per rivalutare l'oro prima di una futura vendita Ad oggi, quando si vende oro da investimento: si paga il 26% sulla plusvalenza, cioè sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto; se non si possiede la documentazione d'acquisto, l’intero importo della vendita viene considerato plusvalenza e quindi tassato integralmente al 26% Con la nuova norma ipotizzata, invece, sarebbe possibile rivalutare il valore dell'oro applicando un’imposta agevolata. In questo modo, al momento della vendita futura, la tassazione verrebbe applicata su una plusvalenza molto più bassa (prezzo di vendita – valore rivalutato), riducendo quindi l’imposta finale da pagare. Staremo a vedere come va a finire... -

Euro tedeschi in argento, una bella sorpresa
NeroCupo ha risposto a un topic di NeroCupo inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.
Se ben ricordo, ho acquistato un paio di rotolini da 10€ a 11€ cadauna (più le spese di spedizione) da un tedesco, che ovviamente le aveva acquistate a 10€ cadauna. Poi, se uno voleva, le poteva spendere o collezionarle, come ho fatto io. E il tempo mi ha dato ragione. -

Quadrante di Vespasiano
antonio bernardo ha risposto a un topic di AntonioPiano95 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Autentica -

lista euro banconote rare
Giggen84 ha risposto a un topic di vitt.emanumi inviato in Cartamoneta e Scripofilia
Buonasera a tutti, sono in possesso di alcune banconote a firma Duisenberg e prima di cederle (le avevo conservate ma non sono più interessato alla cartamoneta) vorrei un vostro parere circa un presunto valore di realizzo. Come al solito non riesco ad allegare le immagini, comunque sono in ottime condizioni, direi almeno in SUP. Prendendo per buone le mie parole quanto si potrebbe spuntare per ciascuna? Di seguito la lista: 500 euro S00266114329 codice corto J001F3 200 euro S00161419678 codice corto J001E1 100 euro S03196378996 codice corto J003D3 100 euro S03196378978 codice corto J003D3 100 euro S03196378987 codice corto J003D3 100 euro S02976378532 codice corto J003F1 100 euro S03196378951 codice corto J003D3 100 euro S04126159969 codice corto J004A1 100 euro S03196379005 codice corto J003D3 Grazie a tutti quelli che vorranno fornire il proprio contributo. -

Frosinone, nuove scoperte e lavori di valorizzazione per le terme romane
ARES III ha aggiunto un nuovo link in Rassegna Stampa
Frosinone, nuove scoperte e lavori di valorizzazione per le terme romane sul fiume Cosa Grazie ai fondi del PNRR e ai programmi europei, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Frosinone e Latina avvia la riqualificazione dell’area delle terme romane sul fiume Cosa. Il progetto prevede ampliamento dello scavo, restauro dei mosaici e nuovi percorsi di visita. A Frosinone prende forma un importante intervento di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino. È infatti prevista la riqualificazione dello scavo delle terme romane situate lungo la sponda del fiume Cosa, un complesso di straordinario valore storico riportato alla luce a partire dal 2021 grazie alle indagini della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Frosinone e Latina. L’intervento, sostenuto dai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1, Componente 3, Investimento 4.3 – “Caput Mundi Next Generation EU” – rappresenta uno dei progetti più significativi di tutela e promozione del patrimonio culturale del territorio. Il progetto elaborato dalla Soprintendenza prevede l’ampliamento delle aree di scavo per proseguire le indagini archeologiche e approfondire la conoscenza del complesso termale. Le analisi preliminari, condotte negli ultimi anni, hanno infatti indicato la presenza di ulteriori strutture ancora da riportare in superficie. L’obiettivo principale è garantire la piena conservazione e la valorizzazione di tutte le testimonianze archeologiche emerse, che costituiscono una parte essenziale della complessa stratificazione storica e urbanistica del territorio frusinate. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, il progetto punta a unire ricerca scientifica, tutela e accessibilità, così da restituire alla città e al pubblico un sito di grande rilievo storico. “Il progetto di valorizzazione predisposto dalla Soprintendenza – ha spiegato il sindaco – prevede l’ampliamento dello scavo, poiché dalle indagini preliminari è emersa la presenza di ulteriori strutture archeologiche. L’obiettivo è garantire la conservazione di tutte le strutture riemerse, testimonianze della complessa stratificazione storico-archeologica che caratterizza il territorio. I reperti rinvenuti saranno oggetto di restauro conservativo: tra questi, spiccano i preziosi mosaici dell’ambiente del frigidarium. Il sito, nella sua interezza, sarà al centro di un intervento importante, con la realizzazione di una copertura per la protezione dei mosaici, una passerella che ne consenta l’accessibilità e la fruizione, l’installazione di pannelli didattici e la sistemazione del percorso di accesso all’area archeologica”. Terme romane di Frosinone. Foto: Comune di Frosinone L’intervento, che punta a rendere l’area fruibile e accessibile al pubblico, sarà condotto in sinergia tra la Soprintendenza e il Comune di Frosinone. Il progetto prevede infatti non solo la tutela del sito, ma anche la sua valorizzazione attraverso infrastrutture leggere che permettano ai visitatori di osservare da vicino i reperti senza comprometterne la conservazione. L’installazione di pannelli didattici e la creazione di un percorso di visita attrezzato contribuiranno a trasformare l’area in un vero e proprio polo di conoscenza e divulgazione del patrimonio archeologico cittadino. Il sindaco Mastrangeli ha voluto ringraziare pubblicamente il Soprintendente alle Belle Arti e Paesaggio delle Province di Frosinone e Latina, Alessandro Betori, insieme al personale della Soprintendenza e agli uffici comunali coinvolti, per l’impegno e la professionalità che hanno permesso di realizzare un progetto di tale portata. Parallelamente al progetto PNRR, l’amministrazione comunale di Frosinone ha inserito l’asse del fiume Cosa al centro della propria Strategia Territoriale, individuandolo come direttrice portante per lo sviluppo urbano e la valorizzazione culturale. Nell’ambito di tale strategia, il Comune è destinatario di un finanziamento di 16.180.000 euro, ottenuto attraverso il Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Tra gli interventi previsti figurano la messa in sicurezza dell’area archeologica del Ponte del Rio, nei pressi della rotatoria Brunella, e la valorizzazione delle terme romane scoperte lungo il corso del fiume. Le origini del progetto risalgono al marzo 2021, quando, durante i lavori di rifacimento dell’impianto fognario in località Ponte della Fontana, emersero inaspettatamente i resti di un edificio termale di epoca romana imperiale. Le prime indagini archeologiche misero in luce porzioni di pavimentazioni musive e rivestimenti parietali marmorei che decoravano gli ambienti del complesso. La scoperta, per importanza e stato di conservazione, spinse la Soprintendenza a disporre l’immediata prosecuzione delle ricerche a fini conoscitivi, in collaborazione con l’allora amministrazione Ottaviani, per avviare le procedure di tutela ministeriale e impostare un futuro progetto di valorizzazione pubblica dell’area. Le indagini successive consentirono di definire una prima mappa del sito e di stabilire la cronologia del complesso, databile al II secolo d.C. Gli archeologi hanno rinvenuto resti di ambienti costruiti in opera reticolata e laterizia, nonché una vasca quadrangolare appartenente probabilmente al settore del frigidarium. Tra le superfici pavimentali si distingue un mosaico bicromo a soggetto marino, decorato con figure ispirate al mondo acquatico, raffigurazioni tipiche delle terme romane, simbolo della funzione originaria dell’edificio. Pianta della passerella. Immagine: Comune di Frosinone Planimetria. Immagine: Comune di Frosinone La posizione dell’area, accessibile da via San Giuseppe, sembra ricalcare un tracciato viario antico che collegava la città romana con il fiume. Ciò conferma che la sponda sinistra del Cosa era già frequentata e urbanizzata in età imperiale, probabilmente nell’ambito di un più ampio processo di rinnovamento della città in quel periodo. Il complesso termale rappresenta così una testimonianza diretta della vitalità economica e sociale di Frosinone romana, centro urbano che, pur di dimensioni contenute, partecipava pienamente alle dinamiche culturali e architettoniche dell’Impero. Il progetto di valorizzazione delle terme romane sul fiume Cosa si inserisce così in una più ampia strategia di rigenerazione culturale del territorio, che mira a integrare tutela del patrimonio, promozione turistica e sviluppo urbano sostenibile. Un intervento che conferma il ruolo della Soprintendenza e del Comune di Frosinone come protagonisti di un percorso condiviso di riscoperta e salvaguardia della memoria storica, restituendo alla comunità un luogo di grande valore archeologico e simbolico. https://www.finestresullarte.info/archeologia/frosinone-nuove-scoperte-e-valorizzazione-terme-romane-fiume-cosa-
- 1
-

-
Pompei, nel Thermopolium ritrovato un vaso invetriato con scene di caccia in stile egiziano Nel Parco Archeologico di Pompei è stata rinvenuta, nella cucina del Thermopolium della Regio V, ovvero in una sorta di “tavola calda” dell’antica città, una situla (vaso) in pasta vitrea decorata con scene di caccia in stile egiziano, realizzata ad Alessandria d’Egitto. Nel Parco Archeologico di Pompei è stata rinvenuta, al centro della cucina del Thermopolium della Regio V, ovvero in una sorta di “tavola calda” dell’antica città, ambiente scoperto nel 2019, una situla (vaso) in pasta vitrea decorata con scene di caccia in stile egiziano, realizzata ad Alessandria d’Egitto. Questo contenitore invetriato, solitamente diffuso nell’area vesuviana come elemento ornamentale di giardini o ambienti di rappresentanza, era stato riutilizzato in questo caso come utensile da cucina. Le analisi in corso, condotte dopo i restauri, potranno forse rivelarne il contenuto originario. I nuovi scavi avviati nel 2023 nella Regio V di Pompei, con l’obiettivo di migliorare la conservazione degli ambienti vicini al Thermopolium, hanno portato alla luce locali di servizio e un piccolo appartamento al primo piano, abitato probabilmente dai gestori dell’attività. Nella stanza al piano terra, dotata di piano cottura, sono stati rinvenuti strumenti per la preparazione dei cibi – come mortai e tegami – insieme a numerose anfore vinarie provenienti da varie regioni del Mediterraneo. Al momento dell’eruzione, il vano attiguo al Thermopolium fungeva da ambiente di servizio. Gli spazi interni risultavano organizzati in modo funzionale: un piccolo bagno si trovava accanto all’ingresso che dava sul vicolo dei Balconi, mentre una zona era destinata allo stoccaggio di anfore e contenitori per la conservazione di liquidi. La restante area ospitava oggetti utilizzati per la lavorazione, la cottura e la conservazione dei cibi. Tra i reperti più significativi rinvenuti qui figura proprio la situla in faience finemente decorata, una preziosa testimonianza degli intensi scambi commerciali e culturali che caratterizzavano Pompei. La situla Il thermopolium Ambiente retrostante con anfore Il piano superiore rispetto all’ambiente di servizio era suddiviso in due piccole stanze, una delle quali affrescata e decorata in IV stile, con architetture prospettiche illusionistiche e un pavimento colorato di giallo. L’ambiente era arredato con mobili, alcuni probabilmente rivestiti da lastre marmoree policrome, e con oggetti personali custoditi in cassette lignee riccamente ornate. Il progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di questi spazi ha incluso anche il restauro delle strutture murarie e degli apparati decorativi emersi nei precedenti scavi, con lo scopo di preservarne l’integrità e la bellezza originaria. Per proteggere gli ambienti dagli agenti atmosferici e conservare i reperti, sono state installate coperture amovibili, progettate per armonizzarsi con il contesto archeologico. Inoltre, un impianto di illuminazione consentirà di valorizzare i dettagli e ammirare al meglio l’intero contesto. “Vediamo qui in atto una certa creatività nell’arredare spazi sacri e profani, cioè l’altare domestico e la cucina, con oggetti che testimoniano la permeabilità e la mobilità di gusti, stili e verosimilmente anche di idee religiose nell’Impero Romano”, spiega il Direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel. “E vediamo questo fenomeno qui non a un livello elitario, ma in una retrobottega di una popina, uno street food di Pompei, vale a dire a un livello medio-basso della società locale, che si rivela però essenziale nella promozione di forme culturali e religiose orientali, tra cui i culti egiziani, ma più tardi anche il cristianesimo". https://www.finestresullarte.info/archeologia/pompei-nel-thermopolium-ritrovato-vaso-invetriato-decorato-in-stile-egiziano
-

Monaco 2025
Giggen84 ha risposto a un topic di Capirobi inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.
Buongiorno, se qualcuno fosse riuscito a prendere un pezzo in più dell'ultimo due euro monegasco e volesse cederlo a un prezzo congruo mi scriva in privato. Grazie e scusate se ho approfittato della discussione già aperta. -
 Martedì 25 novembre dalle ore 20:45 al CCNM (via Kramer, 32 Milano. Citofono SEIDIPIU'), conferenza su "Le oselle del doge Francesco Morosini il Peloponnesiaco" tenuta da Andrea Costantini. La conferenza che avrà inizio dalle ore 21:00 potrà anche essere seguita da remoto, i link da utilizzare per seguire la conferenza verranno comunicati il mercoledì prima della conferenza.
Martedì 25 novembre dalle ore 20:45 al CCNM (via Kramer, 32 Milano. Citofono SEIDIPIU'), conferenza su "Le oselle del doge Francesco Morosini il Peloponnesiaco" tenuta da Andrea Costantini. La conferenza che avrà inizio dalle ore 21:00 potrà anche essere seguita da remoto, i link da utilizzare per seguire la conferenza verranno comunicati il mercoledì prima della conferenza. -

Cartagine: riemerge un volto di marmo dal tempio di Baal Hammon e Tanit
ARES III ha aggiunto un nuovo link in Rassegna Stampa
Antica Cartagine (Tunisia): riemerge un volto di marmo dal tempio di Baal Hammon e Tanit Durante gli scavi nel sito del tofet di Cartagine in Tunisia, un’équipe di archeologi ha rinvenuto un raro volto in marmo risalente alla fine del IV secolo a.C., raffigurante una figura femminile con acconciatura di stile fenicio. Il reperto potrebbe essere stato offerto in dono alle divinità. Durante gli scavi archeologici condotti presso il tempio dedicato alle divinità Baal Hammon e Tanit, nel sito del tofet(un santuario) dell’antica Cartagine, in Tunisia, è stato scoperto un volto di marmo, probabilmente una maschera, risalente alla fine del IV secolo a.C. Il ritrovamento, avvenuto nel pomeriggio di martedì 4 novembre 2025, rappresenta una nuova e importante testimonianza delle pratiche religiose e rituali della lontana città fenicia. Il reperto raffigura il volto di una donna, scolpito con un’acconciatura di ispirazione fenicia, tipica dell’iconografia cultuale legata al pantheon cartaginese. Secondo le prime ipotesi formulate dal gruppo di ricerca, il volto potrebbe essere stato offerto come dono votivo alle divinità del santuario. Il rinvenimento si inserisce all’interno di un progetto di ricerca e valorizzazione avviato nel 2024 grazie a una convenzione tra l’Istituto Nazionale del Patrimonio tunisino (INP) e l’Agenzia per la Valorizzazione del Patrimonio e lo Sviluppo Culturale. L’accordo, della durata di quattro anni, prevede lo svolgimento di campagne di scavo, studi scientifici e interventi di riqualificazione del sito, con l’obiettivo di restituire al pubblico un’area di straordinaria importanza storica. Come ha spiegato Imed Ben Jarbaniya, professore di ricerche archeologiche e storiche presso l’Istituto Nazionale del Patrimonio, il tempio di Baal Hammon e Tanit ha restituito nel tempo risultati notevoli. Già nel 2014, nel corso delle precedenti campagne di scavo, erano state rinvenute numerose iscrizioni in lingua cartaginese che avevano permesso di approfondire la conoscenza dei rituali e della vita religiosa nella città punica. Un altro momento importante si era verificato nel 2023, quando gli archeologi avevano portato alla luce nove monete d’oro risalenti alla metà del III secolo a.C. I reperti, attribuiti a un periodo di prosperità economica e di intensa attività commerciale, avevano rivelato l’esistenza di una classe dirigente cartaginese che frequentava il santuario. L’insieme dei ritrovamenti suggerisce che il tempio fosse un luogo frequentato da aristocratici e da figure di rilievo della società punica, che vi partecipavano offrendo doni preziosi in segno di devozione. La scoperta del volto di marmo rappresenta dunque un nuovo tassello nella ricostruzione delle pratiche cultuali legate alle due principali divinità cartaginesi. Il team di ricerca, composto da Imed Ben Jarbaniya, Nesrine Meddahi e Kawthar Jendoubi, sta attualmente procedendo con l’analisi dei materiali, lo studio delle tecniche di lavorazione e la redazione del rapporto scientifico finale. Il tofet di Cartagine, noto per i ritrovamenti di urne e stele votive, continua a restituire elementi che contribuiscono a una maggiore comprensione del mondo religioso e sociale punico. Ogni nuova scoperta consente di delineare con maggiore precisione le dinamiche spirituali di una civiltà che, pur scomparsa da secoli, continua a parlare attraverso i suoi manufatti. Il volto femminile di marmo ritrovato presso il tempio di Baal Hammon e Tanit, tofet di Cartagine. Foto: ©Facebook/Ministero degli Affari Culturali - Tunisia https://www.finestresullarte.info/archeologia/scoperto-a-cartagine-antico-volto-di-marmo-nel-tempio-baal-hammon-tanit - Oggi
-

Pola: ritrovata la statua del cupido dormiente
ARES III ha risposto a un topic di ARES III inviato in Rassegna Stampa
-

Martedì 11/11/2025 alle ore 20:45 - Al CCNM Milano: Conferenza di Enrico Lesino "L'emergere di Elmi e Cimieri nella monetazione italiana del XIV secolo: Simboli di idendità e strumento di potere"
Parpajola ha risposto a un topic di Parpajola inviato in Segnalazione mostre, convegni, incontri e altro
Altri momenti della serata... -

Pola: ritrovata la statua del cupido dormiente
ARES III ha aggiunto un nuovo link in Rassegna Stampa
Scoprono e recuperano ora dal terreno una statua romana di Amore dormiente, del II secolo. Accanto a lui una lucertola di marmo e una pelle di leone. Che significato avevano? Che funzione aveva la statua? È un’immagine di dolcezza e di abbandono, ma anche di potenza trattenuta, quella che emerge dal marmo bianco ritrovato nei giorni scorsi nell’antica Pola. Durante i lavori edilizi in via Castropola, nel centro storico della città istriana, gli archeologi hanno riportato alla luce una statua romana del II secolo d.C. raffigurante Cupido dormiente, un capolavoro che il direttore del Museo Archeologico dell’Istria, Darko Komšo, ha definito «uno dei tre ritrovamenti più importanti mai avvenuti in Istria». L’opera, bagnata dalla pioggia di questi giorni che rimuoveva la terra, evidenziando lo splendido biancore del manufatto , giaceva a tre metri di profondità, sul pavimento di una domus romana di straordinario pregio, appartenuta certamente a una famiglia ricca e colta. La statua rappresenta un giovane Eros disteso su una pelle di leone, con il capo appoggiato sulla testa dell’animale, mentre accanto, all’altezza dela coscia sinistra, compare una lucertola. Il marmo, di provenienza forse carrarina o attica, reca tracce di una lavorazione finissima, quasi carezzevole, che restituisce la morbidezza delle carni e la sensualità trattenuta del sonno. L’archeologa Aleksandra Paić, che ha diretto lo scavo, ha raccontato l’emozione del ritrovamento: «È il sogno di ogni archeologo – ha detto – trovare un’opera simile dopo duemila anni di silenzio». Per comprendere il contesto del ritrovamento, bisogna ricordare che Pola, in età romana, era una delle città più fiorenti dell’Adriatico settentrionale, colonia latina e snodo commerciale di primo piano. Qui si ergevano templi, terme, teatri e soprattutto l’imponente anfiteatro, uno dei meglio conservati dell’Impero. La città, organizzata secondo la tipica maglia ortogonale, era abitata da famiglie di funzionari, armatori e commercianti che investivano nell’arte e nel lusso domestico, importando marmi e statue dalle botteghe di Atene, Rodi e Roma. Il ritrovamento di via Castropola conferma dunque l’alto livello culturale e il gusto raffinato della società romana istriana, che amava ornare le proprie dimore con simboli di bellezza e conoscenza. Ma la figura di Cupido dormiente racchiude un significato che va ben oltre l’estetica. Nell’antichità, il dio dell’amore addormentato rappresentava la tregua delle passioni, l’intervallo in cui la ragione poteva riprendere il dominio sull’impeto dei sensi. Cupido, il fanciullo alato che lancia frecce invisibili e irresistibili, qui dorme: non è vinto, ma sospeso. Il suo sonno è un momento di equilibrio in cui l’ordine morale e la conoscenza possono tornare a prevalere. «Il sonno di Cupido equivale al richiamo alla ragione e al dominio dei sensi, alla stoica vittoria sui sentimenti e sulle pulsioni – osserva Bernardelli Curuz – solo con il sonno di Cupido, quindi dell’eros e dell’amore, è possibile essere sereni, evitare dolore e turbamento, desiderio di possesso, gelosia. Solo con il sonno del piccolo dio è possibile concentrarsi nello studio, nel lavoro, nella conoscenza, nel pensiero pacato della letteratura, della filosofia, della religione, della conoscenza». È la condizione in cui l’uomo si emancipa dal dominio delle passioni e ritrova la propria libertà dalle pulsioni. Un dubbio iniziale è stato sollevato dalla presenza della pelle di leone: potrebbe trattarsi di Ercole bambino, considerando che il leone è il suo attributo tipico. Tuttavia, l’analisi morfologica e iconografica della statua, con forme delicate e proporzioni efebiche, la presenza possibile di ali e la postura languida del sonno indicano con maggiore forza l’identificazione con Eros dormiente. La pelle di leone non sarebbe quindi un elemento di forza eroica infantile, ma una metafora del dominio sulle passioni: Cupido disteso su di essa mostra come l’amore, potente e disarmante, possa essere dominato dal sonno, dall’equilibrio e dalla ragione. “Bisogna però tener conto – afferma Bernardelli Curuz – della presenza di numerose rappresentazioni ibridate, nell’arte classica che offrivano percorsi articolati di lettura. Non una sola risposta, ma più percorsi. Dall’Amore che dorme, finalmente, alla necessità del risveglio del piccole Ercole, richiamato dal ramarro verso grandi imprese. La statua è dedicata soprattutto al sonno. Amore deve dormire. Il piccolo Ercole deve invece essere svegliato perchè deve iniziare a compiere grandi imprese”. “La lucertola o il ramarro, qui scolpita ha il significato — come avverrà nella pittura di Lorenzo Lotto, che recupera dall’antico questo simbolismo — di un avvertimento divino. – prosegue Bernardelli Curuz – un’irruzione misteriosa nella quotidianità dell’uomo che lo induce a cambiare. È probabile che il marmo si rivolgesse proprio a chi lo osservava, invitando alla rinuncia del piacere a favore di grandi imprese, come quelle di Ercole, ponendo l’accento sull’equilibrio tra piacere amoroso (da mettere in una situazione di controllo e di sonno) ragione e azione virtuosa. Nell’iconografia, spesso, Amore, con Venere, rappresentano l’antitesi di Marte, dio della guerra. Il sonno di Marte favorisce – come in Botticelli – il dominio della splendida dea e del dispettoso bambino”. Nella statua di Pola, questo concetto si manifesta con una grazia rara. Il corpo del dio, disteso e vulnerabile, si poggia su un trofeo di forza — la pelle del leone — e al tempo stesso è accompagnato dalla fragile presenza della lucertola. È come se la scultura racchiudesse in sé l’intero ciclo vitale: eros, lotta, sonno e rinnovamento. Un’immagine di equilibrio tra istinto e intelletto, materia e spirito, e un monito all’osservatore a dominare le passioni per affrontare le sfide del mondo. Dopo il restauro, la scultura entrerà nella collezione permanente del Museo Archeologico dell’Istria, diventando una delle opere simbolo della città. Il ritrovamento non è soltanto un colpo di fortuna archeologica, ma una rivelazione sul pensiero antico e sulla sua attualità. In un’epoca dominata dalle passioni e dalle tempeste dell’emotività, l’antico Cupido che dorme sotto la pioggia di Pola ci ricorda la necessità del silenzio, della misura, della ragione che doma l’impeto, e ci invita a compiere le nostre imprese con coraggio e consapevolezza. https://www.stilearte.it/che-meraviglia-scoprono-e-recuperano-ora-dal-terreno-una-statua-di-amore-dormiente-scultura-romana-del-ii-secolo-accanto-a-lui-una-lucertola-e-una-pelle-di-leone-che-significato-avevano-che-funzi/ https://lavoce.hr/attualita/tesoro-sotto-pola-scoperta-la-statua-del-cupido-dormiente -
Un Quadrante con incisione postuma , ingiuria ad Ercole o segno di valore ?
decio ha risposto a un topic di decio inviato in Monete Romane Repubblicane
Ciao @L. Licinio Lucullo , mi sono riletto poco fa tutto l' articolo , che gentilmente hai postato di ben quattro pagine , relativo a quei simboli impressi sui frammenti di bronzo con la X = sole e il crescente di luna . Facendo riferimento a quanto scritto e letto , si potrebbe ipotizzare che il simbolo della X impresso sul Quadrante oggetto del post indichi una moneta fusa anziche' coniata ? Con la moneta in mano non riesco a capire con certezza se il Quadrante e' coniato o meno . Come sai la fusione era un sistema semplice e veloce per produrre monete in quantita' e considerando che il periodo della seconda guerra punica era per Roma di estrema gravita' sia militare che socio-economica , potrebbe quella X essere interpretata come un "avvertimento" di moneta non ufficiale emessa in un grave periodo di crisi ? La domanda come formulata non e' di facile soluzione anche per la mancanza di altri esemplari con la X incisa , ma forse le foto della moneta possono aiutare i piu' esperti numismatici del Forum . -
Aquileia: scoperte rare monete d’oro, antichi mercati e un porto fluviale dimenticato Tre monete imperiali, strade acciottolate e magazzini sepolti raccontano la vita quotidiana e i segreti di una città tra IV secolo e antico porto romano. Un piccolo tesoro emerge dal cuore di Aquileia: tre monete d’oro, strade acciottolate, magazzini e anfore dimenticate restituiscono un ritratto inedito della città romana, fra pericoli, feste imperiali e traffico di merci lungo il fiume Natissa. Ogni reperto racconta storie di commerci, cibi e abitanti che animavano il mercato, testimoniando come anche l’area meridionale della città fosse centrale nel sistema economico di Aquileia. Una delle monete d’oro delle tre monete d’oro portate alla luce con gli scavi del 2025: solido di Valente (367-375 d.C.), coniato nella zecca di Costantinopoli. Credit: Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia Un tesoro sotto il portico – Monete d’oro tra storia e mistero Il ritrovamento che parla di imperatori e tesaurizzazioni La Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia ha reso nota la scoperta. Le tre monete d’oro rinvenute appartengono a Valente, Magno Massimo e Arcadio, imperatori della fine del IV secolo d.C. Il fatto che siano nominali diversi e rari suggerisce che probabilmente non erano destinate alla circolazione quotidiana, ma erano doni imperiali, forse celebrativi di eventi ufficiali o ricorrenze della corte. La loro collocazione sotto il pavimento del portico lascia pensare che possano essere state tesaurizzate durante un periodo di grave pericolo, come guerre o incursioni barbariche, e mai più recuperate. Ogni moneta, oltre al valore materiale, porta con sé una storia di tensioni politiche e ritualità di potere, offrendo uno spaccato unico sul rapporto tra imperatori e cittadini privilegiati. La vita quotidiana del mercato romano – Strade e solchi di ruote Come si muovevano merci e persone nell’antica città La strada acciottolata scoperta tra due edifici mercantili restituisce una scena vivida della vita urbana: carri carichi di cereali, frutta e verdure, uomini e donne che percorrevano i decumani per commerciare, piazzare merci o incontrare conoscenti. I solchi delle ruote lasciati sul pavimento acciottolato raccontano in modo tangibile il passaggio dei mezzi di trasporto e confermano la presenza di un mercato organizzato e frequentato. Questa strada, collegata al decumano principale, era arteria vitale del complesso commerciale, e insieme alle strutture mercantili restituisce una dimensione quasi cinematografica della quotidianità romana. Il porto nascosto di Aquileia – Anfore e magazzini dimenticati Scoperte che riscrivono la geografia fluviale della città L’area meridionale della città rivela ora un porto fluviale più esteso di quanto noto in precedenza. Il ritrovamento di 19 nuove anfore, oltre alle precedenti 23, suggerisce un sistema di stoccaggio funzionale al commercio e alla gestione dell’acqua. Le strutture recuperate indicano magazzini probabilmente collegati a una banchina fluviale che consentiva il trasbordo di merci provenienti dal mare lungo il fiume Natissa. In passato, il fiume era più ampio e navigabile, rendendo questa zona un polo commerciale strategico. Queste evidenze ridefiniscono il concetto di porto urbano, mostrando come Aquileia avesse un sistema logistico complesso e articolato, in grado di sostenere la sua fama di città commerciale di rilievo nell’Italia romana. Cibo e cultura materiale – Cosa mangiavano gli antichi aquileiesi Cariossidi bruciate e alimentazione romana Uno degli aspetti più affascinanti degli scavi riguarda l’alimentazione. Dal crollo del portico occidentale sono emerse numerose cariossidi di cereali bruciate, insieme a frammenti di alimenti carbonizzati, che offrono preziose informazioni sui prodotti consumati e sulle tecniche di conservazione. Le cariossidi rappresentano tracce di cereali come farro, orzo e grano, principali alimenti della dieta romana, spesso trasformati in pane o farina. Alcune erano probabilmente parte di scorte alimentari dei magazzini, mentre altre testimoniano episodi di cottura o incendio accidentale. Questi reperti permettono di ricostruire non solo cosa mangiassero gli antichi, ma anche le modalità di gestione del cibo: il commercio e lo stoccaggio erano strettamente legati al controllo delle risorse, alla prevenzione della carenza alimentare e alla pianificazione di feste e banchetti. Analisi future potrebbero anche chiarire se le varietà coltivate fossero locali o importate, aprendo uno spiraglio sulla rete commerciale mediterranea e sul ruolo di Aquileia come centro di scambio. Dopo il mercato – Continuità di vita e misteri delle sepolture Abitazioni, focolari e tombe senza corredo Anche dopo l’abbandono del grande complesso mercantile, l’area rimase frequentata. Sono stati individuati vanì abitativi con focolari, laboratori e una strada più tarda che seguiva il tracciato precedente, confermando la continuità di vita urbana. Alcune sepolture di inumati, prive di corredo, rappresentano un mistero: chi erano questi abitanti? Come vivevano? Le analisi al C14 in corso potrebbero collocarle temporalmente e fornire ulteriori dettagli sulla popolazione post-romana e sulle trasformazioni urbane successive. Oltre al valore scientifico, gli scavi hanno avuto un impatto culturale importante grazie all’apertura quotidiana al pubblico e alle visite guidate degli studenti. I due open day organizzati dalla Fondazione Aquileia hanno permesso a cittadini e appassionati di vivere in prima persona la scoperta archeologica, consolidando il concetto di archeologia partecipata: la storia non resta più confinata nei laboratori, ma diventa esperienza condivisa. Il gruppo di lavoro 2025 dell’Università di Verona, con la funzionaria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia-Giulia Serena Di Tonto, il presidente Roberto Corciulo e il direttore della Fondazione Aquileia Cristiano Tiussi. https://www.stilearte.it/splendore-romano-ad-aquileia-scoperte-rare-monete-doro-antichi-mercati-e-un-porto-fluviale-dimenticato/
-
- arcadio
- magno massimo
-
(e altri 1 tag)
Taggato come:
-

Marco Antonio - Galea Leg X
FlaviusDomitianus ha risposto a un topic di Atexano inviato in Monete Romane Repubblicane
Il denario in questione fa parte di una piccola serie di monete coniate sotto Vespasiano a soggetto agreste, che copiano denari repubblicani. Per questo in particolare il RIC 2.1 cita un denarius di L. Cassius Caecianus (102 BC, RRC 321). -

Richiesta identificazione
FlaviusDomitianus ha risposto a un topic di Duit72 inviato in Monete Romane Imperiali
Il catalogo più aggiornato e completo per la monetazione provinciale è R.P.C. (Roman Provincial Coinage) che è online, ma che al momento non copre la monetazione dei Severi, eccezion fatta per Elagabalo. Non mi sembra siano stati forniti i dati di questa moneta (peso e diametro), comunque tramite altre risorse online si trova questo stesso rovescio , ma per monete di grosso modulo (30cm circa). Ecco un paio di esempi: link 1 link 2
Lamoneta.it
Il network
Hai bisogno di aiuto?


