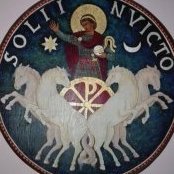Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 10/30/16 in tutte le aree
-
Io ho partecipato alla conferenza di Reggio Emilia il giovedì 27, ma a causa di motivi familiari non sono riuscito ad essere presente anche questo sabato a Brescello e mi scuso vivamente con quanti hanno sperato di salutarmi e conoscermi... In ogni caso ritengo utile e corretto per chi non è potuto venire alle conferenze riportare le diapositive e il sommario degli interventi che abbiamo riferito sia io sia l'ottimo amico e coautore Giovanni Santelli a Reggio Emilia, con interventi del moderatore prof. Macellari. Come dice il titolo, il libro tratta sia della storia sia delle monete coniate a nome dell’imperatore romano Marco Salvio Otone. Incominciamo dalla storia, cosa ci raccontate a questo proposito? Le notizie sulla vita dell’imperatore sono tratte, ovviamente, dalle fonti storiche, tra cui primeggia Vite dei Cesari di Svetonio che, per questo imperatore, si è avvalso di una fonte privilegiata, suo padre, che faceva parte dell’esercito di Otone e aveva vissuto in prima persona l’epilogo della vicenda, come amava raccontare spesso al figlio, così che i fatti ne risultano particolarmente vivi e arricchiti da dettagli interessanti e, qualche volta, anche da pettegoli, come la notizia del parrucchino che Otone portava abitualmente, come del resto si nota agevolmente sulle monete. La carriera politica di Otone si avvantaggiò indubbiamente del fatto che egli faceva parte della ristretta cerchia degli intimi di Nerone, imperatore dal 54 al 68. Lui e Nerone erano talmente intimi che ebbero in comune anche una moglie, la celebre Poppea che Otone sposò nel 58, dopo averla fatta divorziare da Rufino Crispino, cui aveva dato anche un figlio. Quasi subito, però, Otone la cedette o la dovette cedere a Nerone, su questo aspetto le fonti non sono concordi. In cambio ottenne, comunque, il governatorato della Lusitania, l’attuale Portogallo, anche se non aveva alcun titolo per ricoprire una carica così alta. Otone rimase in Lusitania per 10 anni, fino alla morte di Nerone, avvenuta nel 68. Sembra che abbia governato bene la provincia che, comunque, gli servì per accumulare le risorse finanziarie indispensabili per la scalata al trono imperiale. Nel giugno del 68 Nerone fu deposto dalla carica imperiale e sostituito da Galba che aveva l’appoggio sia del senato, sia dei Pretoriani. Come si comportò Otone in quell’occasione? Nonostante la sua antica amicizia con Nerone, Otone appoggiò subito Galba, arruolò truppe in tutta la penisola iberica e le portò a Roma a disposizione del nuovo imperatore, evidentemente contando di succedergli alla sua morte, visto che Galba aveva già 73 anni e, ragionevolmente, non aveva più molto da campare. A differenza di Galba, però, Otone aveva ben capito che gli arbitri del potere imperiale erano i pretoriani, perciò, appena giunto a Roma, iniziò subito a ingraziarseli con cospicue elargizioni di denaro. Quando, il 10 gennaio del 69 Galba commise l’errore di nominare come suo successore Lucio Calpurnio Pisone, Otone ruppe gli indugi e corruppe i pretoriani. Cinque giorni dopo vennero uccisi sia Galba sia Pisone e Otone fu proclamato imperatore. La proclamazione a imperatore fu convalidata dal senato e accettata dai quattro quinti dell’esercito romano, infatti solo le truppe schierate nelle province occidentali gli furono ostili. In particolare le legioni di stanza nelle due Germanie e le tre di Britannia già ai primi di gennaio proclamarono imperatore Aulo Vitellio che si mosse con le sue truppe verso l’Italia e Roma per impadronirsi del potere. Otone, a sua volta, dopo aver inutilmente tentato una composizione amichevole, marciò con il suo esercito per intercettarlo. Lo scontro avvenne vicino a Cremona, a Bedriaco, dove gli otoniati ebbero la peggio e lasciarono sul campo 40.000 uomini. Da una parte, quindi, c’era l’esercito di Vitellio che, passate le Alpi, scendeva verso Roma, mentre dall’altra c’era quello di Otone che fronteggiò l’avversario a Bedriaco, vicino a Cremona, dove fu gravemente sconfitto. Come mai Brescello, che si trova ben distante da Cremona, fu coinvolto in questa vicenda? Questo è stato, probabilmente, il grosso errore di Otone che causò la sconfitta di Bedriaco. Durante tutto il viaggio da Roma egli aveva marciato con l’esercito, come un soldato qualsiasi. Giunto nei pressi di Cremona, tenne un consiglio di guerra per decidere la strategia da adottare. Durante il consiglio emersero gravi divergenze fra i suoi generali: alcuni avrebbero voluto temporeggiare per dar tempo di arrivare ai potenti rinforzi che stavano giungendo dall’Oriente, altri, invece, erano del parere di attaccare subito. Alla fine Otone decise di allontanarsi dal suo esercito principale per non intralciare le decisioni dei suoi generali e di ritirarsi a Brescello. Così facendo, però, l’Imperatore privò le sue truppe non solo dell’indispensabile coordinamento, ma anche di un elevato numero di soldati che portò con sé a Brescello come sua scorta personale. Mi sembra chiaro il motivo per cui Otone si allontanò dal suo esercito principale, ma perché, fra le varie alternative possibili, scelse proprio Brescello? È ben noto l’importanza che aveva, nell’antichità, la posizione geografica di Brescello che consentiva di controllare non solo un punto di attraversamento del Po, ma anche l’accesso alle valli dell’Enza e del Parma, che allora era un affluente dell’Enza. La sua posizione strategica indubbiamente fu il motivo della fortuna di Brescello nell’antichità, a partire dall’epoca etrusca fino a tutta l’epoca romana, ma divenne poi il principale motivo delle sue disgrazie, quando fu oggetto di numerosi tentativi di conquista che portarono più volte alla sua distruzione. La sua posizione, quindi, concorse senz’altro alla decisione di Otone che, però, lo scelse anche perché, a quei tempi, Brescello era la città più importante della zona, probabilmente l’unica in grado di offrire un conveniente alloggio alla sua corte e al suo seguito, composto anche da numerosi senatori, con i rispettivi seguiti. L’importanza di Brescello in quel periodo è confermata dalle evidenze archeologiche, come i mosaici delle diapositive precedenti, o come il monumento funebre dei Concordi che vediamo nella diapositiva e che merita alcune considerazioni. Si tratta del più grande e più bel monumento funebre di epoca romana pervenutoci in Italia Settentrionale ed è databile con sicurezza al tempo di Nerone grazie alle pettinature delle donne del medaglione, molto simili a quelle di Giulia Agrippina, madre di Nerone, e di Statilia Messalina, la sua ultima moglie. Il monumento fu rinvenuto casualmente nel 1929 durante i lavori di scavo del canale Fiuma, in via Goleto a Boretto. Da allora giace negletto e incustodito nel Parco del Popolo a qualche centinaio di metri da dove ci troviamo adesso. Ci sembrano evidenti i motivi che, a quel tempo, avevano portato a questa collocazione, ma le esigenze dell’Italia imperiale fascista, che il monumento imperiale romano era chiamato a propagandare, sono tramontate da un pezzo e credo che ora il monumento dovrebbe trovare una più degna collocazione tra le mura di un museo. Personalmente non oso pensare al Museo Archeologico di Brescello, perché ciò scatenerebbe la guerra tra Brescello e Boretto, ma il Museo Archeologico di Reggio, che fin dalla fondazione custodisce numerosi reperti brescellesi, mi pare abbia tutte le carte in regola per ospitarlo. Nel frattempo il monumento ha già subito varie mutilazioni, come è facile rilevare confrontando lo stato attuale con le fotografie d’epoca e con i calchi fatti nel 1929. Nella diapositiva, ad esempio, si nota agevolmente quanto siano stati danneggiati i nasi dei due personaggi maschili e il fascio a sinistra. Cosa successe quando Otone giunse a Brescello con il suo seguito e le truppe che lo scortavano? Giunto a Brescello, Otone si sistemò nella villa di uno degli ottimati locali, non si sa esattamente dove. Dopo qualche giorno arrivò la ferale notizia della sconfitta di Bedriaco e l’imperatore decise subito di suicidarsi. Si accomiatò da parenti e amici, quindi si ritirò nella sua stanza lasciando la porta aperta. Si dice che abbia dormito tutta la notte, ma all’alba, appena sveglio, si suicidò gettandosi su una lama. Era il 17 aprile del 69 e aveva 37 anni. Una delle tante illustrazioni del libro è il disegno che rappresenta la lapide sepolcrale di una certa Velleia Afrodisia. Chi era e cos’ha avuto a che fare con Otone? Secondo una tradizione letteraria, documentata già all’inizio del XVIII secolo nell’ambiente dell’Accademia dell’Arcadia, e giunta ben viva fino a noi, infatti ne parla anche monsignor Mori in Brescello nei suoi ventisei secoli di storia, Velleia Afrodisia sarebbe stata l’amante di Otone che, affranta dal dolore, si sarebbe suicidata gettandosi sulla pira funebre dell’amato. In effetti la lapide di Velleia Afrodisia fu rinvenuta dall’abate Carlo Talenti, che la inserì nel suo manoscritto Compendio Istorico per Brescello del 1736. Il ritrovamento della lapide fu considerato, dallo stesso Talenti e da diversi altri, la prova incontestabile della veridicità della tradizione. Altri, invece, come il Mori, hanno ritenuto che il tenore della lapide, evidentemente dettata da un marito sconsolato, fosse troppo affettuoso per una moglie morta suicida sulla pira dell’amante, fosse pure l’imperatore. È da rilevare, poi, che le fonti storiche, pur particolarmente ricche di notizie sulla morte di Otone, non fanno il minimo accenno a questo evento. Particolarmente probante, a questo proposito, il silenzio di Svetonio, che ci ha tramandato dettagli ben più marginali su questo imperatore, come, ad esempio, il fatto che portava il parrucchino. Svetonio scrive del suicidio solidale di diversi soldati, ma non accenna a nessuna donna. C’è infine da ricordare che gli studiosi moderni hanno datato questa lapide a circa un secolo dopo il suicidio di Otone, quindi, sicuramente, Velleia Afrodisia in vita non ha mai avuto nulla a che fare con l’imperatore. Si sa dove fu sepolto Otone? Le fonti storiche raccontano che l’imperatore fu sepolto a Brescello dentro un modesto mausoleo che portava il suo nome e che non è giunto fino a noi. Secondo il cronista modenese Spaccini, il mausoleo fu abbattuto dal marchese Cornelio Bentivoglio che ne utilizzò i materiali per la costruzione, avvenuta tra il 1568 e il 1580, del suo palazzo di Gualtieri che vediamo nella diapositiva. La leggenda di Velleia Afrodisia ci offre uno spunto per la sua localizzazione. Ci sembra probabile che la leggenda di Velleia Afrodisia debba la sua origine dall’ultimo gesto d’amore di un marito affranto dal dolore. Prematuramente privato della sua rarissima consorte, Lucio Sabino ha voluto conferirle l’estremo onore, dandole sepoltura nel posto più prestigioso che esisteva a Brescello, che, ovviamente, non poteva essere che quello posto nelle immediate vicinanze del mausoleo imperiale. Dopo molto tempo, certamente dopo che la memoria di Velleia Afrodisia si era persa, qualche ignoto osservatore, drammaturgo, poeta o cantastorie che fosse, è rimasto colpito dalla vicinanza della tomba della donna con quella dell’imperatore, e ciò è stato probabilmente sufficiente per dar vita al mito. È impossibile, infatti, che il leggendario accostamento di Afrodisia a Otone sia stato casuale, visto che la donna è esistita veramente a Brescello, come documenta la sua lapide sepolcrale. Qualcuno quindi, in un qualche momento, deve aver visto i nomi dei due defunti uno vicino all’altro e ciò, ovviamente, deve essere avvenuto prima che il mausoleo venisse abbattuto nella seconda metà del XVI secolo. Sappiamo che la lapide di Velleia Afrodisia fu rinvenuta nella zona delimitata nella diapositiva dal rettangolo rosso, probabilmente non molto distante dall’asterisco giallo, che è il luogo in cui fu rinvenuto il famoso tesoro di Brescello del 1713. Lì vicino dovrebbe essere stato sepolto anche l’imperatore Otone. A proposito del grande tesoro di Brescello, condividete l’ipotesi, avanzata da alcuni, che tutto quell’oro fosse il tesoro di Otone? No, a nostro parere l’ipotesi è sicuramente da escludere e per diversi motivi, ne dico alcuni. Prima di tutto gli aurei del tesoro sono stati tutti coniati in un periodo molto ristretto: dal 46 al 38 a.C. e ciò fa ritenere che il momento dell’interramento sia stato molto a ridosso di questo periodo e, perciò, circa un secolo prima della venuta di Otone a Brescello. C’è poi da tenere presente che Otone ha coniato a suo nome aurei che avevano un peso inferiore del 10% rispetto a quelli del tesoro di Brescello. È evidente che, se il tesoro fosse stato suo l’avrebbe subito fatto riconiare con i suoi tipi, perché, così facendo, avrebbe guadagnato ben 8.000 aurei, che non era una cifra da poco neppure per un imperatore. Poiché il tesoro di Brescello conteneva monete coniate da molti eserciti che stavano combattendosi l’un l’altro ai tempi del II triumvirato, conteneva, infatti, le monete coniate dagli eserciti di Ottaviano, Antonio, Bruto, e Cassio, l’ipotesi più probabile è che il proprietario fosse un ricco commerciante di indumenti di lana, che aveva accumulato il suo tesoro vendendo mantelli e tuniche ai vari eserciti. In questo libro, perciò, non si parla del grande tesoro di Brescello che, invece, abbiamo pubblicato in un apposito libro di due anni fa. Abbiamo visto che Otone è stato imperatore per tre mesi, in questo brevissimo periodo, ha coniato molte monete? Le monete a nome di Otone sono state emesse a Roma e in Oriente in quattro zecche provinciali: Locri Opus (in Achea), Mallus (in Cilicia), Antiochia (in Siria) e Alessandria (in Egitto). Quella di Roma, ovviamente, è la monetazione “ufficiale” e sfoggia un ritratto dell’imperatore solitamente ben curato. Le emissioni provinciali, invece, sono state volute dalle varie autorità locali: magistrati, legati e senati cittadini. A Roma sono state coniate solo monete d’oro, gli aurei, e d’argento, i denari, solitamente in coppia, mentre non è stata battuta nessuna moneta di bronzo e, perciò, quelle esistenti in bronzo sono tutte false. La prima emissione a nome di Otone fu quasi sicuramente quella con il tipo Victoria Othonis, con il globo che vediamo nella diapositiva. Seguirono altri 14 tipi, contraddistinti da varie divinità: Victoria, Pax, Securitas, Aequitas, Ceres, Giove e Vesta. Può sembrare incredibile, visto il brevissimo periodo di governo, ma recenti studi hanno dimostrato che per coniare l’oro e l’argento di Otone sono stati utilizzati ben 521 coni di diritto e 639 di rovescio. Ciò nonostante non ci è pervenuto un elevato numero di monete e, di conseguenza, le monete di Otone vengono sempre considerate rare e, frequentemente, gli aurei raggiungono in asta quotazioni dell’ordine delle decine di migliaia di euro. È curioso rilevare come in diversi coni, come ad esempio nei quattro della diapositiva, si noti molto bene la presenza del famoso parrucchino dell’imperatore di cui ci fa fede lo storico Svetonio. Per la sola zecca di Roma abbiamo catalogato 25 serie di monete, serie che diventano 57 aggiungendo quelle emesse nelle varie province. A differenza di Roma, le province non coniarono l’oro, ma solo argento e bronzo, di cui vediamo due esempi, uno di valore ignoto della zecca di Mallus in Cilicia e un diobolo della zecca di Alessandria d’Egitto. In questa diapositiva vediamo, invece, un tetradramma in argento coniato ad Antiochia in Siria e un altro tetradramma, ma questa volta in mistura, coniato ad Alessandria d’Egitto. Ricordo che la mistura era una lega a cui l’argento partecipava con un titolo inferiore al 500 per 1000. È facile notare come le immagini dell’imperatore che appaiono nella monetazione provinciale non assomiglino minimamente a quelle della monetazione romana. Evidentemente le province avevano iniziato subito a coniare a suo nome, prima ancora di conoscere il suo aspetto fisico. Normalmente le zecche periferiche ricevevano da Roma un busto dell’imperatore da cui ricavare i giusti lineamenti da riportare sulle proprie monete. E’ ovvio che nel caso di Otone non c’erano stati tempi tecnici per conoscere il suo aspetto fisico. Un capitolo del libro è intitolato “Falsificazioni bronzi romani (incluso gruppo Cavino)”, di cosa si tratta? Come ho precedentemente accennato la zecca di Roma non ha coniato nessun bronzo per Otone e, perciò, tutti i sesterzi, gli assi e i dupondi pervenutici per questo imperatore sono falsi. Le più famose falsificazioni furono effettuate da Giovanni da Cavino (Padova, 1500 – ivi, 1570), che fu anche insigne medaglista e fu soprannominato il Padovano, per cui i suoi falsi sono chiamati anche padovanini. Egli creò soprattutto sesterzi, ma sono noti anche rari dupondi (a sinistra nella diapositiva) e assi “di fantasia”, che però sembrano essere opera di un falsario posteriore. È noto anche il falso medaglione che si vede nella diapositiva, anche questo forse opera di Giovanni da Cavino. La didascalia del rovescio ci permette di sapere che la donna che vi è ritratta vuole rappresentare Albia Terentia, la madre di Otone. Diversi di questi bronzi vantano una notevole accuratezza di esecuzione e non di rado raggiungono in asta quotazione di tutto rispetto, ovviamente non come monete di Otone, ma come medaglistica rinascimentale. Oltre ai bronzi, esistono anche aurei e denari falsi? Sono noti diversi aurei di Otone che sono riconosciuti essere moderne falsificazioni. Alcuni sono stati prodotti almeno nel XIX secolo e sono confluiti in alcuni medaglieri pubblici e un esemplare è stato perfino catalogato nel RIC, ma ne esistono anche di modernissimi fatti per imbrogliare i collezionisti, come nel caso che vediamo a destra nella diapositiva che è una modesta e tipica riproduzione bulgara (di un certo Lipanoff) ottenuta con pressa. Questo esemplare ha anche il peso incoerente. Per quanto riguarda i denari sono molto numerose le loro falsificazioni effettuate sia nell’Ottocento sia, soprattutto, in epoca recente e prevalentemente per mano bulgara. Esistono anche denari suberati creati in epoca moderna. Ricordo che le monete suberate sono monete con l’anima di bronzo rivestita da una pellicola d’argento. Com’è noto esistono numerosi tipi di denari suberati autentici, ma non per Otone. Il libro si conclude con alcune note dedicate alle contromarche e alle curiosità numismatiche, di cosa si tratta? Per quanto riguarda le contromarche abbiamo catalogato sia le contromarche a nome di Otone applicate su monete di bronzo di altri imperatori, un esempio lo vediamo nella diapositiva in basso, sia le contromarche di altre autorità applicate su monete emesse a nome di Otone, ne vediamo un esempio nella diapositiva in alto. Ci siamo occupati anche del denario che si vede nella diapositiva che ha la peculiarità di avere su un lato la testa in rilievo come tutti gli altri denari e sull’altro lato sempre la stessa testa, ma in incuso, ossia “scavata”. Questo dei cosiddetti denari incusi è un fenomeno già noto ma estremamente raro perché è il frutto di un errore in sede di conio e, perciò, merita di essere ricordato. La moneta veniva normalmente coniata al diritto con il conio d’incudine e al rovescio con il conio di martello. Per coniare, un inserviente appoggiava sul conio d’incudine un tondello d’argento ben caldo. Il battitore ci appoggiava sopra il conio di martello e dava una buona martellata; dopo di che la moneta così coniata veniva tolta dai coni e messa a raffreddare. Qualche rarissima volta la moneta non si staccava e restava attaccata al conio di martello che così presentava non il consueto rovescio in incuso, ma il diritto della moneta in rilievo che, battuta su un nuovo tondello caldo, imprimeva, ovviamente, il diritto in incuso. Quello della diapositiva è l’unico denario incuso che si conosca per Otone ed è stato battuto in un’asta del 2003. * * * * * Tengo a precisare che quanto sopra esposto copre solo una parte del libro, al quale si rimanda per conoscere maggiori dettagli e riferomenti. Ogni serie emessa da Otone, sia a Roma sia nelle zecche provinciali, è riordinata in corretta sequenza ed è illustrata sempre a colori (penso che già le diapositive rendono l'idea del nostro desiderio di curare al massimo la qualità delle immagine che ci sono nel libro). Chi è interessato al libro, può prendere accordi con l'editore (come si può evincere nel primo post).5 punti
-
falso d'epoca : 50 centesimi 1863 valore Napoli. Vittorio Emanuele II3 punti
-
Salve a tutti! Ho deciso di aprire una nuova discussione per non disturbare, ossia interferire con il corso di alcune interessanti discussioni all'interno di questa sezione e di non distogliere così l'attenzione dal loro scopo divulgativo. Spesso vedo che diversi utenti di questo forum spesso inciampano nella forma più palese di esibizionismo numismatico, dando parecchio rilievo e risalto alle monete in loro possesso e mettendo in secondo piano la descrizione tecnica, storica, artistica o, semplicemente, emozionale o contestuale alla discussione in cui vengono inserite. Vorrei sottolineare che solo quest'ultima modalità di presentare i nostri tondelli è la base della divulgazione, mentre la sola esposizione, spesso presentata in maniera alquanto barocca, di quello che si possiede ha la tendenza di appesantire le discussioni e nauseare i lettori. Non vorrei risultare troppo severo, spesso tutti cadiamo in qualche episodio di esibizionismo (a volte ben venga se contribuisce ad alzarci il morale...), tuttavia questo non deve poi diventare la regola. Vorrei mostrarvi un esempio di come un'ottima discussione può prendere la piega dell'esibizionismo: Credo che la maggior parte degli utenti di LaMoneta.it e soprattutto della sezione Monete Moderne abbia un debole per il collezionismo numismatico, quindi, se tutti iniziassero a mostrare senza limiti e contesto le proprie collezioni, tale sito si trasformerebbe in un ammasso di foto decontestualizzate, ossia in una gara continua di chi possiede la moneta meglio conservata o più rara. Spero, quindi, di non aver traumatizzato nessuno, tuttavia mi è sembrato necessario discutere di ciò. Grazie, attendo le vostre considerazioni!2 punti
-
Rare volte e quasi sempre in circostanze casuali vengono dissotterrati antichi tesori di epoca romana , e’ questo il caso del tesoro di Kaiseraugst . Kaiseraugst è un odierno piccolo Comune del Cantone svizzero Argovia ; in epoca romana , dopo il 260 circa , fu sede di un importante fortezza militare di Legione e di unità ausiliarie romane , il cui nome latino era Castrum Rauracense . Augusta Raurica e’ oggi un importante e grande sito archeologico romano ubicato nel Nord della Svizzera , situato a quasi 20 km ad est di Basilea , che corrisponde all’ attuale piccolo Comune di Augst o Kaiseraugst . Augusta Raurica e’ la più antica colonia romana sul Reno , fu infatti fondata da Giulio Cesare in prossimita’ del Reno . Augusta Raurica venne fondata nel 44 a.C. da Lucio Munazio Planco , luogotenente di Giulio Cesare nel corso della guerra gallica , era situata in un territorio occupato da una locale tribù gallica chiamata Raurica . Solo al tempo di Augusto si consolido’ la conquista di tutta l’ area alpina e la primitiva colonia cesariana prese il nome di Colonia Paterna Pia Apollinaris Augusta Emerita Raurica , probabilmente per aver ospitato la Legione XV Apollinaris fondata da Giulio Cesare proprio in occasione della guerra gallica ,Legione nota fino al V secolo . Vespasiano e poi Domiziano partirono da qui per la conquista degli Agri Decumates , pericoloso cuneo territoriale germanico che si spingeva all’ interno della linea difensiva romana del Reno . Durante i primi due secoli dopo Cristo fu una colonia ricca e popolosa , capitale della locale Provincia romana . Gli Alemanni distrussero la Città nel corso della grande crisi del III secolo , circa nell’ anno 260 . Al tempo di Diocleziano venne qui rafforzata la frontiera germanica con la costruzione di un Ponte stabile fisso presidiato sulla sponda germanica da una testa di ponte fortificata in pietra , di forma quadrata di circa 45 metri per lato , la Colonia divenne il quartier generale della Legione I Martia , preposta anche alla difesa del Ponte . Successivamente nel tardo impero da qui’ partirono Legioni per le guerre civili e per le spedizioni punitive romane contro le incursioni delle tribu’ germaniche all’ interno del Limes . Sempre nel corso del tardo impero essa perse la sua primitiva importanza a favore del vicino insediamento celtico di Basilea , di cui non si conosce il primitivo nome , che diventera’ Castrum Rauracense ; gli abitanti sopravvissuti all’ invasione germanica degli Alemanni si posero sotto la protezione del Castrum Rauracense , un grande castello romano sito nella vicina Kaiseraugst e posto da ora in poi a difesa del Limes germanico tardo imperiale . Durante il medioevo , le grandi rovine in pietra del sito vennero utilizzate per nuove costruzioni . Gli scavi archeologici moderni hanno dissotterrato Templi , Taverne , Edifici pubblici , un Foro , un complesso di bagni termali e il più grande Anfiteatro romano a nord delle Alpi che disponeva di circa diecimila posti , da poco restaurato . Questa in breve la storia di Kaiseraugst e del Castrum Rauracense . Il tesoro di Kaiseraugst fa parte dei pochissimi grandi tesori europei dell’ antichita’ romana comprendente opere di : oreficeria , oggetti personali , uso quotidiano ed anche di monete , rinvenuto praticamente intatto ; questo tesoro e’ paragonabile soltanto a quelli rinvenuti in altre localita’ europee , tipo quello di Mildenhall in Britannia , quello del Colle Esquilino a Roma , quello di Cartagine ed ai numerosi rinvenuti in Dacia : di Persinari , di Sarmasag , di Hinova , di Radeni , di Stancesti , di Cucuteni , di Agighiol , di Craiova , di Perutu , di Surcea , di Sarmizegetusa , di Sancraieni e di altre localita’ della Romania , a dimostrazione della ricchezza mineraria e personale della Provincia dacica . Il tesoro di Kaiseraugst e’ pero’ quello forse di maggior pregio artistico e secondo per peso complessivo , infatti il tesoro di Treviri trovato nel XVII secolo , purtroppo subito fuso , pesava in totale 114 Kg. , quello di Kaiseraugst 37 Kg. e quello di Mildenhall 26 Kg. , mentre di quello trovato a Cartagine non si conosce il peso , ma sicuramente dell’ ordine dei chilogrammi . Il rinvenimento del tesoro di Kaiseraugst avvenne dopo il Natale del Dicembre del 1961 mentre si eseguivano dei lavori stradali tramite una ruspa alle spalle di un edificio scolastico che corrispondeva come posizione ad uno dei lati lunghi del Castrum in prossimita’ dell’ angolo con il lato corto dell’ antico castello della fortezza romana ; nello scavare l’ antico tratto stradale romano ancora in uso dopo secoli , duro e compatto , ad un certo punto l’ addetto alla ruspa si accorse che in un punto della strada , la resistenza della strada romana era stranamente cedevole e penso’ che sotto dovesse esserci una buca . L' operatore addetto alla ruspa naturalmente non si rese conto di cosa stava per uscire da quella buca e continuando a scavare , la ruspa tiro’ fuori una grande “latta” che fini’ nel mucchio di terra accumulata nel bordo della strada ; poco tempo dopo nel sistemare la terra accumulata si ritrovo’ quella “latta” di forma rotonda che ad un successivo esame si rivelo’ essere argento ; si torno’ cosi’ sul luogo del ritrovamento dove venne rinvenuto tutto il tesoro che era composto principalmente da un ricchissimo e completo servizio da tavola , da tre lingotti d’ argento con impresso l’ immagine e la legenda di Magnenzio , piu’ 186 monete e 17 medaglioni , tutti in argento ; tutto il tesoro aveva un peso di circa 37 Kg. , da analisi metallografiche risulto’ che l’ argento aveva una purezza del 97% ( l’ odierna arriva al 99,9% ) mentre il rimanente 3% era composto da 2% di rame , 0,7% di oro e 0,3% di piombo , a dimostrazione di quale alto livello era la metallurgia e raffinazione dei metalli preziosi presso gli antichi romani del tardo impero . A chi poteva appartenere questo tesoro ? la datazione dei tre lingotti ci riporta a Magnenzio , quindi come datazione minima siamo all’ anno 350 , ma per il servizio da tavola la data potrebbe essere precedente o successiva , anche se in base alle monete e medaglioni trovati una data successiva sarebbe poco probabile , in base a questo si e’ pensato come proprietario del tesoro ad un altissimo personaggio legato a Magnenzio , un ufficiale o un funzionario della sua corte . Per risolvere forse il problema ci viene in aiuto una iscrizione incisa dietro un piatto che reca scritto P. ROMULO , un Publio Romulo in effetti e’ storicamente conosciuto come essere stato un Magister Militum proprio al tempo di Magnenzio , fu un ufficiale comandante della fanteria del suo esercito che mori’ nella battaglia di Mursa avvenuta nel 351 tra Magnenzio e il legittimo Imperatore Costanzo II ; il proprietario o uno dei proprietari del tesoro dovrebbe quindi avere una identificazione precisa . Un altro nome e’ pero’ inciso dietro i cucchiai , il candelabro e un altro piatto , questi oggetti recano inciso il nome di MARCELLIANO , quindi si presuppone che almeno il tesoro da tavola abbia avuto nel tempo diversi proprietari e che tutto il tesoro fu poi posseduto , riunito e seppellito probabilmente dall’ ultimo proprietario che fu Publio Romulo in previsione dell’ incerto esito della battaglia di Mursa . Questa in breve la storia di questo tesoro . Seguono in ordine foto di Kaiseraugst e del tesoro : Cartina geografica della localita’ di Kaiseraugst Cartina archeologica del sito Ricostruzione di Castrum Raurica in base alle scoperte archeologiche Posizione antica del ritrovamento del tesoro segnato dalla freccia rossa Foto di alcune fasi del ritrovamento del tesoro Panoramica con oggetti del tesoro Uno dei tre lingotti in argento con impresso il nome e l' immagine di Magnenzio Particolari di oggetti e statua in argento di Venere Alcune monete e alcuni medaglioni del tesoro2 punti
-
Premetto che la moneta non è mia, mi hanno solo permesso di fare le foto poichè sono rimasto affascinato dalla tipologia di moneta. Mi hanno detto che dovrebbe essere un tarì d'argento di Ferdinando il Cattolico, Sigla MC D + FERDINANDVS:D:G:R: E: Aquila volta a destra, MC R + FERDINANDVS:D :CASTELLE: Λ. Sui quaderni della "moneta.it" però ho visto che ci sono molte varianti.....questa quale sarebbe?!2 punti
-
Con diametro pressoché uguale, ma peso differente, la differenza poteva farla la lega o lo spessore. Presumendo che la lega sia nella norma, possiamo ipotizzare che il grosso veneziano sia stato martellato per cancellare un po' figure e lettere, poi è stato tosato della parte espansa dalla martellatura, e quindi si è proceduto alla coniazione. E' una ipotesi.2 punti
-
Certo che una saggiatura del metallo sarebbe determinante per stabilire se il "tondello" è Veneziano verace o imitazione, considerando pero' l'importanza che veniva data a questa moneta , infatti al consiglio generale stabilirono che. " modus et pondus monete florentine et pisane et aliarum monetarun tuscie". penso che il tondello usato fosse di buon argento, quindi riveniente da moneta ufficiale . Per quanto riguarda il perché utilizzare altre monete, , mi piace pensare ( con buona fantasia ) che motivi contingenti dovuti alle spese per la battaglia di Montaperti dispendiosa e determinante per i Senesi, ( pagamento di truppe e i tedeschi erano molto esigenti ) portarono a utilizzare questa "risorsa"2 punti
-
il valore di una moneta é quello che noi diamo. Ti piace? L'hai comprata? Sei contento? Allora il prezzo é certamente quello giusto... Altrimenti non parleremmo di collezionismo ma di speculazione... Il range di valore che ho dato io non significa nulla un caro saluto2 punti
-
Io credo che anche nel mondo delle prove ci siano esempi importanti.... Per esempio questa mezza lira di Pesaro in rame è interessante per più aspetti, siamo a Costanzo Sforza ( 1473 - 1483 ), il tipo è busto/ veduta del castello, il motto è : SA LVT I ET MEMORIA CONDIDIT potremmo dire : LO HA COSTRUITO PER SALVAGUARDIA E MEMORIA Ci si riferisce alla rocca Costanza costruita per la sicurezza della città e per memoria di chi la volle. ( NAC 85 ) E' un mix del potere, identità, ricordo di un castello fatto per la città, la moneta esprime e racconta, i giornali non c'erano d'altronde...la moneta raccontava i fatti, la moneta, essendo una prova non venne poi fatta, potremmo dire ora che l'idea era però buona ....peccato non averla concretizzata...2 punti
-
E allora procediamo.... NON NOBIS DNE SED NON TVO DA GLORIA NON A NOI SIGNORE ( MA AL TUO NOME DA' GLORIA ) Quello che conta non siamo noi ma tu col tuo Casato, col tuo nome....questo è quello che leggiamo sulla moneta, sembra messo in bocca al popolo, in realtà la moneta viene dal Marchese, quindi un po' di propaganda non guastava anche ai tempi.... Siamo ancora a MESSERANO in un tallero di Francesco Filiberto Fieschi ( 1584 - 1629 ) della NAC 85, altra moneta rarissima e significativa per quello che riporta.2 punti
-
Credo anche io come @appah che la moneta usata non sia per niente stata tosata ed inoltre ilgrosso che ci occupa , pare sia stato coniato fino al 1270, pertanto non credo sia pertinente la battaglia di Curzola del 1298, piu' probabilmente (forse) la battaglia di Montaperti del 1260...( per impellenti necessità') Eventuali Dogi potrebbero essere poi' Dandolo, Ziani,Tiepolo,Morosini, Zeno...... fino al 1268....2 punti
-
Buongiorno Adolfo e Antonio, chiedo scusa per il mio ritardo nel rispondere, ci sono e vi seguo (quando mi è possibile), appassionatamente! Per quanto riguarda il perché dei 3 nominali citati da @anto R circolanti nella metà del XIV secolo, io credo che in qualche modo sia legato al periodo storico e quindi al trasferimento della sede papale in Avignone. Credo che le monete con il SVDARIVS fossero coniate in occasione del giubileo del 1350 proprio per affermare ai numerosi pellegrini che Roma era ancora la città santa nonostante l'assenza del papa. In parallelo, la moneta con Roma in trono potrebbe significare l'affermazione di sovranità da parte del senato romano in una città dove regnava l'anarchia.2 punti
-
Salve, salvo imprevisti, dovrei esserci anch'io. Quindi, ci vediamo a Verona. Saluti!2 punti
-
Seguo questa discussione con molto interesse. Riguardo alla possibile tosatura del grosso veneziano che ha fatto da sottotipo, mi sembra però che il diametro che @Robin ha dichiarato, 20/21 mm, sia quello di un grosso veneziano integro. È possibile che il calo di peso (0,1/0.2 g) sia dovuto solamente ad un po' di consunzione, oppure che la bilancia utilizzata da Robin non fosse molto precisa?2 punti
-
http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-CE1/83 OPPORTVNE, cioè al momento giusto. Così si esprime Carlo Emanuele I, duca di Savoia su questo ducatone del 1588, raffigurantre un Centauro che scocca un dardo mentre calpesta la corona di Francia, facendo riferimento alla tempestività con cui il Duca occupò il marchesato di Saluzzo, anticipando sul tempo il Re di Francia. La risposta, a mezzo medaglia, tuttavia, non tardò ad arrivare da parte di Enrico IV... www.nicolas-salagnac.com/wp-content/uploads/2012/11/portrait-24.jpg P.S. Chiedo scusa, ma non sono riuscito ad inserire l'immagine, in quanto non funzionante il riferimento ai cataloghi.2 punti
-
Quando siete stanchi ditelo senza problemi , secondo me abbiamo fatto già un mezzo miracolo così... E come faresti a stancarti nel vedere meravigliosi esempi, dove il linguaggio espressivo offre tal maestria e conoscenza... E poi con tutti i tondelli che abbiamo batutto... Direi che potremmo fare ancora un piccolo sforzo per noi tutti. Eros2 punti
-
Faccio un ipotesi fantasiosa; e se avessero usato un Lorenzo Tiepolo molto tosato? Il Tiepolo è ovunque e Siena non è distante da Pisa. Nel periodo c'è la guerra con Genova e la battaglia di Curzola 1298. Interessante molto interessante2 punti
-
" bene, qua chiedo anche l'aiuto di @Marcus Didius che ha una capacità di lettura fuori dalla norma.... " Salve a tutti, concordo per il rovescio con Poemenius che sia tipo una Salus teodosiana e aggiungo che sotto il braccio nel campo sinistro è probabile uno staurogramma P+, talmente schiacciato da sembrare il braccio ripetuto tre volte, se si tratta dello staurogramma però non concorda con la crocetta sempre nello stesso campo, troppi segni per una moneta ufficiale, poi non c'è lo spazio in esergo per mettere la zecca e l'officina, il cerchio perlinato chiude subito sotto i piedi della "Salus". Al dritto, rovesciata di 180°, ci vedo subito un busto corazzato verso destra, il viso è sconvolto, si nota un serto sulla testa ma credo si tratti solo di altri segni non facenti parte della moneta in quanto le teste imperiali del IV secolo erano diademate. Tutto in ghirlanda e allora siamo lontani da una moneta ufficiale ma non da una imitativa. Marcus Didius2 punti
-
Venerdì 28 ottobre è venuto a mancare Norman Gorny (in foto), un bravo studioso della monetazione imperiale cinese. Era statunitense, di Portland (Oregon). Pochi mesi prima di morire aveva pubblicato la seconda edizione di un suo importante lavoro: Northern Song Dynasty Cash Variety Guide. L'opera approfondisce molto bene la monetazione della dinastia Song settentrionale (960-1127) ed è acquistabile su Amazon o su Lulu. Questi erano i suoi quattro blog: Fake Chinese Cash on eBay 北宋代钱币图说 Northern Song Dynasty Cash Variety Guide 2016 北宋钱币 Northern Song Cash Oriental Cash2 punti
-
Si pensa che Nicolò e Antonio Zeno, navigatori veneziani del XIV sec. impegnati nell'esplorazione dell'Atlantico del nord e dei mari artici, raggiunsero l'isola di Newfoundland (Terranova) più di un secolo prima la scoperta dell'America, ma la scoperta ufficiale spetta ai fratelli Caboto che nel 1497 le diedero il nome di "Terra Nuova", fu colonizzata appena tre anni dopo con un auspicio: FLOREAT TERRA NOVA (possa la nuova terra prosperare) (In base a un referendum svoltosi il 31 marzo del 1949, Newfoundland fu unita al Canada diventandone la decima provincia)2 punti
-
Quando siete stanchi ditelo senza problemi , secondo me abbiamo fatto già un mezzo miracolo così... AVERTISTI IRAM INDIGNACION HAI ALLONTANATO L'IRA DEL (SUO ) SDEGNO ( CIOE' DEL SIGNORE ) Siamo a Modena dove non mancano le belle monete, in questo caso addirittura un 4 scudi d'oro di Francesco I d'Este ( 1629 - 1658 ) della NAC 85 Abbiamo la raffigurazione come in molte monete della Beata Vergine adorante il Bambino : al Duca era molto cara questa immagine perché attribuiva alla Vergine il miracolo di averlo salvato e di aver fatto recedere la pestilenza che aveva infierito durante il 1630 nel ducato estense. E quindi si ritorna al motto con l'aver allontanato lo sdegno del Signore....2 punti
-
Ecco alcune foto del sito, i tre templi Hera,Poseidone e Atena , l'Anfiteatro e un po di parco archeologico.2 punti
-
Buonasera a tutti, Medaglia un po' maltrattata ma a 30 euro non ho resistito.. Mercatino di Montecatini Terme, un anziano venditore gentilissimo che mi ha pure rifilato un Dollaro Peace... Saluti e buon we lungo a tutti Silver1 punto
-
Vittorio Emanuele III 2 centesimi "Italia su Prora" Rame 960/1000 - diametro mm. 20 - peso gr. 2 Questo tondello viene classificato di Seconda classe: conio stanco Non mi è capitato spesso di osservarne, ho preso di recente questo esemplare per la mia collezione, non mi sembra affatto di conio stanco. Avete avuto modo di osservarne altri esemplari? Quali osservazioni si possono fare? A proposito di rame trattato, non trattato, pulito...cosa mi dite di questo esemplare? Renato1 punto
-
La seconda, dalla foto, è sempre a mio parere ha una tonalità più naturale. le debolezze sono congenite per tutta la tipologia.1 punto
-
Il grosso veneziano (I° tipo) aveva un peso di gr. 2,17 ca. e una differenza di 0,32 ca. non può essere data solo dalla consunzione. Evidentemente il grosso era già calante di peso all'origine, prima di ribatterlo, oppure l'hanno ridotto in questa occasione. Oppure non era un grosso veneziano ed era già calante di suo.1 punto
-
Il "sebeto"è una di quelle poche monete di Zecche italiane che sta bene anche da sola,senza essere associata da altre,è come un quadro1 punto
-
Buona Domenica Potrebbe essere stato un grosso a nome di ciascuno dei dogi nominati, oppure un imitativo. Impossibile determinarlo. Se venisse fatto un saggio sul metallo potremmo discriminare, almeno, se il titolo è quello del grosso veneziano o di un'altra moneta imitativa e questo sarebbe già un ottimo risultato. Sul perché si trovasse li ...... hai voglia; era una delle monete che più circolavano per il Mediterraneo e non solo; ho idea che, dove c'erano mercanti, c'erano grossi veneziani. saluti luciano1 punto
-
1 punto
-
Ciao @Artax, a me sembra il mec n.905..con al D: +FERDINANDVS: D:G:R:CASTELLE: A ed al R:+ FERDINANDVS:DG:R:SICILIE:ARA..attendi conferma e/o smentita dagli esperti di monete siciliane Saluti Eliodoro1 punto
-
1 punto
-
ne ho anch'io un esemplare simile,il lato del valore è ottimamente impresso con tracce di rosso mentre al rovescio si fa fatica a scorgere la mole antonelliana,credo anch'io che si tratti di un conio stanco...1 punto
-
http://www.astanumismatica.it/it/asta_numismatica_ranieri_n_6_632/monete_straniere_644/3_kreuzer_1790__1192_.aspx può essere?1 punto
-
Giancarlone: bellissimo esemplare che conclude, in questo post, la rassegna della tipologie delle silique dette di Pertarito. L'articolo suggerito da Poemenius chiarisce invece in modo esaustivo le diverse tipologie e pare citi, nella nota 25, la possibilita' di avere il solo monogramma e la corona d'alloro. Riprendo la nota "... La presenza o meno della corona potrebbe essere casuale, anche se, quanto meno per gli esemplari con il monogramma rilievo/incuso, sembrerebbero essere indice di una certa evoluzione, per la quale nei pezzi piu’ antichi si avrebbe la presenza della corona, poi abbandonata a vantaggio di un bordo liscio e molto rilevato. " Che ne dite? pare ragionevole e darebbe una prima risposta al mio quesito.1 punto
-
Hai ragione. Sono monete piuttosto piccole e nel maneggiarle devo aver fatto confusione. Appena posso, ricontrollo tutti gli esemplari e ti fornisco le immagini appropriate.1 punto
-
Ciao partendo dal presupposto che io sono convinto che la data del 1641 non esista (e qui qualcuno forse non sarà d'accordo con me..) quindi a mio giudizio si tratta di un 1647 posso solamente aggiungere che vi sono dei 7 più o meno "diritti" (prendiamo per esempio l'esemplare postato a catalogo da Pier) che se non ben visibili nella parte superiore possono essere scambiati per degli 1 comunque le savoiarde continuano a regalarci delle sorprese quindi non è mai detta l'ultima parola! mancando ancora nella mia collezione magari ho la fortuna di inserire un 1641 come mezzo soldo della reggenza!!! aggiungo ancora una postilla a quanto già detto... gli altri vari tipi di mezzi soldi della reggenza hanno tutti date precedenti al 1647, ma posteriori al 1641... sembra una cosa logica produrre una tipologia nel 1641 , anche di ridotta tiratura visti i numeri di esemplari ritrovati, poi due o tre tipologie diverse con date 1642 o 1646 e poi riproporre la vecchia tipologia cambiando il millesimo finale in 7 (stranamente molto simile all'1???) in una tiratura abbastanza copiosa visto gli esemplari presenti in circolazione? .... e nessun 1641 con data senza possibilità di dubbio? Accetterei al massimo la possibilità di errore in fase di preparazione del conio con lo scambio del punzone 7 con il punzone 1, ma si tratterebbe comunque di un errore di conio....1 punto
-
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/banche-in-difficolta-chi-paga-_26434.shtml1 punto
-
1 punto
-
Aggiungo questa moneta, manca il peso perchè di un amico non più rintracciabile,1 punto
-
Comprata cosi', riportata in Italia da oltre oceano.....il vantaggio principale e' che la posso dare in mano ai bambini che la possono maneggiare liberamente e anche buttare per terra (si rovina il parquet ma la scatoletta e' indistruttibile). Spero che cosi' si abituino alle monete sin da piccoli e coltivino questa passione.1 punto
-
La medaglia per i soggetti rappresentati al R/ è collocabile nel XVII sec. a partire dal 1622, anno di canonizzazione dei cinque santi rappresentati, che sono S. Ignazio di Loyola, S. Francesco Saverio, S. Isidoro Agricoltore ( al centro),S. Filippo Neri, e S. Teresa d'Avila. Ciao Borgho.1 punto
-
Ciao Max, la banconota, sempre per quanto si possa giudicare da una foto, è autentica, e in conservazione FDS, come è giusto che sia trattandosi di un biglietto non emesso, e che dunque non ha mai circolato. L'unico dubbio riguarda i colori, che risultano alquanto sbiaditi rispetto ad altre banconote (vedi ad esempio questa) ma potrebbe essere solo un effetto della foto. I biglietti non emessi, come questo, sono conosciuti dai collezionisti come remainder, e pur mancando di qualsiasi riferimento temporale, sono da ascriversi al periodo tra gli ultimi anni '50 dell'Ottocento, e la fine della Guerra Civile. A quel punto, centinaia di banche private, come la Citizen's Bank, avevano i forzieri pieni di questi biglietti, stampati ma non emessi (venivano datati, firmati e numerati uno ad uno, man mano che servivano, e nel tuo, come puoi vedere, non c'è niente di tutto questo), che non valevano più nemmeno la carta su cui erano stampati, e rimasero per decenni confinati nei caveau, fino a quando, agli inizi del nuovo secolo, furono scoperti dai collezionisti, che ne fecero incetta. Oggi rappresentano una parte consistente (e fiorente) del mercato delle banconote delle banche private americane (conosciute, nel loro complesso, come Obsolete Notes), ricercati e apprezzati dai collezionisti in quanto trattasi, nella maggior parte dei casi, di biglietti in alta conservazione e dal costo decisamente inferiore a quello dei corrispondenti biglietti emessi, per non dire del fatto che, per molti di essi, il biglietto emesso non esiste proprio, o è quasi impossibile da trovare. La Citizen's Bank of Louisiana, è una delle 28 banche di quello stato autorizzate a emettere cartamoneta, ed è famosa soprattutto per il suo biglietto da 10 dollari, sul quale compare la parola DIX, da cui sarebbero derivati i termini Dixie e Dixieland, che ancora oggi stanno a indicare gli stati del sud degli Stati Uniti, nonché la musica jazz delle origini. Qui, puoi leggerne la storia http://www.atjs.org/Dixie.html petronius1 punto
-
1 punto
-
Qualche giorno fa un utente chiedeva cosa poteva fare con venticinque euro... Mistero risolto.1 punto
-
Passiamo alla meraviglia del nuovo mondo, interpretazione sublime degli eventi e dell'aspetto stilistico e figurativo. Quando le monete favellano... REGNO DI NAPOLICarlo II (1674 – 1700). Ducato 1684. D/ CAROLVS. II. D. G. HISPANIAR . E. NEAP. REX. , busto con lunghi capelli sulle spalle, drappeggiato e corazzato a destra con Collare del Toson d’Oro pendente sul torace. Sotto IM (Giovanni Montemein). - R/ su nastro VNVS. NON. SVFFICIT., nel campo scettro sormontato da corona , ai lati due globi terracquei delle Americhe e dell’Euro-Asia, sotto a sinistra su due righe AG (Andrea Giovane, maestro di Zecca) e . A . (Antonio Ariani, maestro di prova), a destra lungo l’orlo 1684. CNI 247. Pannuti Riccio 1 (NC). Davenport 4045. Il rovescio esprime la potenza e la forza dei domini Spagnoli dopo la conquista dell’America centrale e delle sue risorse minerarie, fonte inesauribile di ricchezza per Carlo II d’Asburgo di Spagna. Carlo II non ha governato con vigore i propri domini, anzi ha demandato gli oneri della conduzione dello Stato ai propri Ministri che per interessi personali lasciarono andare in disfacimento la potenza spagnola. In breve tempo Luigi XIV si impossessa della Francia Contea e delle Fiandre, spagnole da 150 anni. Il Portogallo si dichiara completamente indipendente durante il suo regno ma non viene presa alcuna contro misura efficace. Anche la sua morte avvenuta nel 1700 non portò serenità al trono di Spagna, anzi avendo designato come erede al trono Filippo V di Borbone, secondogenito del delfino di Francia, al posto della linea di sangue della famiglia della Consorte Marianna di Neuburg austriaca, diede inizio alla guerra di successione spagnola. Il Regno di Napoli fu poco influenzato dalle vicende di casa spagnola grazie all’intervento del Vicerè Marchese di Los Velez che governò dal 1665 sino al 1683 , limitando le richieste iberiche e contenendo la tassazione secondo le possibilità dei sudditi. Eros1 punto
-
La monetazione napoletana è ricchissima di motti e legende altamente evocativi..... ...ne inserisco uno molto famoso... IN HOC SIGNO VINCES... rimanda a Costantino, a Ponte Milvio, diventa un baluardo dietro al quale schierarsi, "con questo segno vincerai"....1 punto
-
Questo è un chiaro esempio dove la moneta diventava veicolo importante e messaggero degli eventi.. REGNO DI NAPOLI Piastra 1791. AR, gr. 27,25 – ø 42,3 mm. D/ FERDINANDVS IV. ET MARIA CAROLINA, busti accollati, corazzati, e con la parrucca in capo, volti a destra dei sovrani, sotto al busto D P (Domenico Perger, maestro incisore). – R/ PRO FAVSTO PP REDITV V. S. , il Sebeto e Partenope volti di fronte in atto sacrificale, sullo sfondo il Vesuvio con fumata, a destra di Partenope A.P. (Antonio Planelli, maestro di zecca) sotto M. (Raffaele Mannara, maestro di prova), all’esergo 1791. – T/ cordonato in rilievo. CNI 209. Pannuti Riccio 60 (R). Cagiati 25. Davenport 1407. Nel mese di agosto del 1790 Ferdinando IV e la consorte Maria Carolina accompagnano le figlie Maria Teresa e Maria Luisa a Vienna andate in sposa a Napoli per procura con i figli del Gran Duca Leopoldo, gli Arciduchi d’Austria Francesco e Ferdinando. Maria Teresa diventerà Imperatrice d’Austria e Maria Luisa Amalia Gran Duchessa di Toscana La traduzione della leggenda al rovescio "Voti Assolti per il Felice Ritorno dei Sovrani." ne celebra il ritorno a Napoli dei regnanti. Don Basile appaltatore per la moneta di argento e di rame fece preparare a sue spese i conii. Antonio Planelli presentò i primi saggi a Novembre chiedendo l’autorizzazione a proseguire la coniazione. A Ferdinando IV non piacquero e ne fece sospendere la coniazione ma non fece ritirare quanto già coniato. In tutto furono coniate solo 9.476 pezzi. Per tipologia unica e dai rilievi marcati è una delle monete di Ferdinando IV maggiormente ricercate. Eros1 punto
-
@R.E.IN.SENA Il Grande Cuore del Collezionista...il più bel post che mi sia mai capitato di leggere in questo meraviglioso gruppo che siamo...1 punto
-
Per me le monete sono emozioni. Non le cerco e non le compro perchè mi mancano. Quando capitano le guardo, se mi innamoro, provo a prenderle. Apro il monetiere, mi innamoro, ogni volta. Non cerco quello che manca, ma esamino quello che mi capita. Quando prendo una moneta e decido di prenderla, è perchè mi si scaldano le guance, c'ho lo sguardo da pesce lesso e mi perdo nei colori e nei rilievi. Chiamarle monete è riduttivo. Sono Emozioni, sono storie. Non solo storia, ma Storie. Chi le ha avute, chi le ha messe da parte, cosa volevano dire e, cosa rappresentano. Quando prendo in mano la moneta mi gira la testa nei pensieri. Se la testa rimane ferma, è un brutto segno, la moneta non la compro A volte Gianky, Marfir, Renaro e gli altri amici, mi danno una botta per ''svegliarmi'', ma loro sanno che a volte mi perdo ai particolari. Emozioni che una moneta può dare? quali, quante e perchè? Ogni persona ha la sua risposta. Le briose sono eleganza, forza e vlocità. Sono ballerine di danza classica piene di potenza da trainare un carro. C'è la speranza di un futuro migliore e la forza di affrontarlo. Potenza del movimento, abbaglio di luce. Poesia e immagine. Cos'altro posso dire. Nulla, se non hai la sindrome di stendhal su una moneta o per altro, non sai cosa ti passa per la testa. Quando cel'hai, non ricordi cosa è passato ma solo freschezza e un sorriso. Gianky quando vuole comprare una moneta, lo vedi lontano 100 metri, ha un sorriso da pesce lesso e gli occhi che splendono. Marfir quando compra una moneta ha la faccia immobile, occhi sgranati e respira a fatica, tanto è concentrato e ammirato. Renato, quando ha in mano una moneta, anche da 20 euro, mette i guanti di cotone e lo vedi che si è innamorato, gli tremano le mani e non ti dice nulla, devi scuoterlo. Io forse, sono eccessivo, ma le emozioni son personali e singolari. Passione la chiamano, non so'. Secondo me siamo malati sani. Custodi di storie. Emozioni. La mia è una missione, dici? Può darsi che lo sia, fino a che avrò gli amici e stendhal con me Scusate se sono stato prolisso. :91 punto
-
1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?





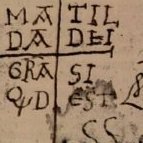


















.thumb.jpg.49bf7893ab8deb0b9efbfc02c41b7421.jpg)