Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 05/10/17 in tutte le aree
-
Buonasera, vi posto il mio ultimo acquisto, dal vivo è uno spettacolo- Che ne dite?3 punti
-
@El Chupacabra SPL- serebbe un qSPL? Diciamo condivisibile, soprattutto perché il perito l'ha potuta visionare in mano e noi vediamo una foto. Ti posto il mio esemplare del quale vado molto fiero, trovato dopo una lunga ricerca. Saluti Marfir3 punti
-
Ciò che può rivalutarsi sul mercato, a mio parere, sarà sempre ciò che sarà più ricercato, sia essa una moneta o un determinato grado di conservazione. Ma io non mi limito a raccogliere monete con la speranza che queste un domani possano piacere a tanti. Vivendo il presente, colleziono secondo ciò che più mi da emozioni. E non ragiono seguendo la logica di un mio profitto, ma mi abbandono all'idea che un domani ciò che oggi io ho investito oppure speso vada a mio figlio o magari al figlio di mio figlio... o chissà ancora oltre. E allora capisco che per ciò che mi muove l'investimento non sarà il mio e resto fermo sull'idea che più andrà oltre e più avrò saputo investire. "un mio pensiero da collezionista"3 punti
-
Identificata dagli archeologi come Troia VIII , Ilio era una rifondazione degli Eoli , attorno al VII° sec. AC . Nel II° sec. AC , al tramonto del regno seleucide , batteva moneta civica , soprattutto interessanti , rari tetradrammi di modulo piuttosto largo e sottile , con immagini dedicate ad Atena ilia per la quale nella città esisteva un famoso santuario .2 punti
-
Quell'anziano collezionista mi aveva avvisato di non pulire mai le monete e in particolare le 10 lire perchè l'italma è pericolosissimo e può dare delle reazioni anomale, ma io non gli ho creduto ed ecco il risultato! Saluti Simone2 punti
-
Dopo aver discusso e presentato in questa sezione molte ripostigli inglesi del III secolo, questa volta mi trasferisco in Francia, più precisamente a Reyssouze nell’Ain dove l’11 ottobre del 2014 durante alcuni lavori privati in un terreno, è stato fortuitamente scoperto un ripostiglio di 2096 monete di cui 17 denari e 2079 antoniniani. 1147 antoniniani appartengono all’Impero Gallico e 577 risultano essere produzioni irregolari. Tra le imitazioni vengono segnalati anche almeno 11 esemplari della serie DIVO CLAVDIO (conteggiati però con il gruppo di emissioni relative all’Impero Centrale). L’intero ripostiglio, dopo uno studio preliminare, è stato messo in vendita tramite asta pubblica. Questa è la composizione del ripostiglio per imperatori (e congiunti): Impero Centrale Settimio Severo Geta Caracalla Eliogabalo Giulia Mesa Alessandro Severo Massimino Gordiano III Filippo I Otacilia Severa Filippo II Traiano Decio Errenia Etruscilla Divi Treboniano Gallo Volusiano Valeriano I Gallieno Marianina Salonina Salonino Valeriano II Gallieno (regnante da solo) Salonina Claudio II Divo Claudio Quintillo Aureliano Severina Tacito Florian Probo Caro Carino Numeriano Diocleziano Impero Gallico Postumo Aureolo Mario Vittorino Tetrico I Tetrico II Imitazioni Il report preliminare attualmente disponibile (a cura di Isabelle Bollard-Raineau), costituisce l’unico studio esistente sul ripostiglio, ma non è completo e soprattutto non è privo di errori e refusi. Il blocco di monete degli imperatori gallici, per esempio, non è stato classificato completamente e nella lista dei sovrani ufficialmente non risultano emissioni di Mario, mentre a seguito di una revisione del materiale da parte della casa d’aste che ne ha curato la vendita, è emerso un antoniniano dell’imperatore gallico del tipo FELICITAS AVG. Leliano non risulta invece presente nel ripostiglio. Il deposito è stato trovato con il suo contenitore originario: una vaso in lamina di bronzo di fattura italica, ma di produzione locale. Si tratta di un normale vaso di uso comune di fatto presente tra le normali dotazioni domestiche. Si tratta quindi di un possibile ripostiglio apparentemente “domestico”. C’è un grande lasso temporale tra le emissioni più vecchie e quelle più recenti: il termine “post quem” è il 286 a fronte di un termine “ante quem” del 195. Tale tipologia di ripostiglio rientra in una serie di depositi analoghi come Goeblingen (2769 es; TPQ 279), Cléry (2787 es; TPQ 282), Reichenstein (2555 es; TPQ 283) ma è paragonabile anche a depositi più consistenti come Evreux (73373 es; TPQ 282), Sainte-Pallaye (8864 es; TPQ 283), Bavai (6659 es; TPQ 289), Annecy (10640 es; TPQ 281) o l’italiano La Venera (46077 es; TPQ 287). Il tesoro di Reyssouze presenta una parte di evidente tesaurizzazione (lampante la presenza di denari d’argento del periodo severiano, ma anche di buoni antoniniani in biglione con un discreto quantitativo di argento) e una parte che doveva riflettere parte della circolazione monetaria del periodo nonostante il mantenimento dello scopo iniziale dell'accumulo (la tesaurizzazione). La presenza di antoniniani di Probo in ottimo stato di conservazione fa propendere per una data di chiusura del ripostiglio anteriore al 300, approssimativamente collocabile tra il 286/290 e potrebbe quindi essere messo in relazione con le invasioni barbariche che interessarono le Gallie attorno agli anni ‘80 del III secolo e quindi condizionato proprio dal periodo di instabilità e scarsa sicurezza del territorio che gravava sulla provincia gallica recentemente riannessa all’Impero Centrale. Sulla composizione si possono fare alcune considerazioni. Per la componente di monete relative all’Impero Centrale, gli esemplari anteriori al 253 costituiscono una porzione consistente di una sessantina di esemplari di cui fanno parte 17 denari che di sicuro uscirono dalla circolazione monetaria attorno al 251 a seguito del loro recupero sistematico durante il regno di Traiano Decio prima e Treboniano Gallo dopo. Il grado di usura di questi pezzi non è elevato, anzi, alcuni esemplari godono di una buona conservazione come ad esempio il pezzo di divinizzazione emesso da Caracalla per Settimio Severo. (DIVO SEVERO PIO / CONSECRATIO; RIC 191e; 211 d.C.) Si tratta quindi di esemplari sottratti abbastanza repentinamente dalla circolazione e quindi di una sorta di ripostiglio iniziato e continuato nel tempo. Molto presumibilmente l’accantonamento dev’essere iniziato prima della sparizione totale dalla circolazione delle monete di argento puro e quindi sicuramente prima degli anni ‘50 del III secolo: una sorta di ripostiglio famigliare presumibilmente gestito da più generazioni. La presenza di antoniniani di buona lega della prima metà del III secolo è altrettanto rilevante: 22 esemplari di Gordiano III (20 della zecca di Roma e 2 della zecca di Antiochia) 13 esemplari di Filippo I e congiunti (di cui anche un denario a nome di Otacilia Severa, tutti della zecca di Roma), 9 esemplari di Traiano Decio e congiunti, 3 esemplari di Treboniano Gallo e 1 solo esemplare di Volusiano. La composizione di antoniniani dell’Impero Centrale da Valeriano a Quintillo è così strutturata: 52 sono gli esemplari della serie DIVO CLAVDIO di cui 11 ufficiali, 31 indetermnati e 10 imitativi. Complessivamente sono raggruppati in 40 di tipo Altare e 12 di tipo Aquila. Circa la componente “gallica” invece la ripartizione fatta nello studio preliminare è la seguente: Che va tuttavia rettificata dato che nel computo è “scappato” un esemplare di Mario confuso per un altro sovrano gallico. Mi soffermo ad approfondire alcuni aspetti di questo gruppo dato che, come ben sapete, il cuore dei miei interessi numismatici riguarda proprio la monetazione dell’Impero Gallico. la presenza delle monete galliche è piuttosto notevole (più della metà dell’intero ripostiglio se consideriamo le imitative) le imitative galliche sono quasi tutte di buon modulo e di buon peso. Si possono considerare pressoché assenti i cosiddetti minimi (diametro inferiore ai 10 mm). Le imitative presenti inoltre hanno uno stile molto aderente ai prototipi ufficiali o comunque abbastanza buono tale da confondersi con i tipi imitati o comunque da essere utilizzati con pari valore delle emissioni ufficiali. La presenza di moneta gallica così strutturata rispecchia l’evoluzione della produzione (e circolazione monetaria) senza tradire l’intento originario del deposito ovvero la costituzione di un gruzzolo di tesaurizzazione che riflette il progressivo impoverimento del materiale monetale pur tuttavia continuando a rispettare il principio della legge di Gresham: accantonamento della moneta con maggior contenuto di fino e mantenimento nel flusso circolatorio della moneta più povera. La qualità delle imitative presenti infatti rappresenta proprio un lavoro di selezione del circolante: tesaurizzazione della sola moneta rispondente a determinati standard (buon peso, buon modulo e stile vicino alle emissioni regolari) e conseguente scarto di imitative di bassa qualità, peso e moduli ridotti che erano comunque in circolazione (se non addirittura in produzione) al momento della formazione/occultamento del tesoro. Utilizzando le classi di catalogazione delle imitative proposte da Jean Marc Doyen nel suo studio sulla monetazione imitativa, nel ripostiglio di Reyssouze la produzione locale è da ricondurre sostanzialmente alle classi 1 e 2 con sporadici esemplari rientranti nelle classi 3 e 4 (quantitativi comunque non rilevanti): Quindi le classi 3 e 4, di fatto assenti nel deposito, erano in circolazione e in produzione proprio nell’ultimo periodo di accantonamento del deposito e della sua chiusura. L’ultimo blocco di Antoniniani a essere analizzato è quello riferibile agli anni 270/288 e riconducibile all’Impero Centrale con la riannessione dei territori gallici (dopo il 273 grazie ad Aureliano). La composizione è così strutturata: Aureliano: 199 esemplari (48,7% Milano; 21,1% Roma; 16,7% zecca incerta; 4,5% Serdica; 4% Siscia; 2,5% Lione; 2,5% Pavia; 0,5% Cizico) Tacito: 61 esemplari (70,5 % Lione; 23% Pavia; 4% Roma) Floriano: 7 esemplari (Lione) Probo: 177 esemplari (79,7% Lione; 14,7% Pavia; 2,3% Roma; 1% Siscia; 2,3% zecca incerta) Caro: 6 esemplari (5 Lione, 1 Roma) Carino: 19 esemplari (18 Lione, 2 Roma) Numeriano: 16 esemplari (Lione) Diocleziano: 4 esemplari (Lione) Gli esemplari appartenenti al periodo di chiusura del ripostiglio sono mal rappresentati e costituiscono un gruppo assai poco numeroso rispetto l’insieme del tesoro. Ampliando lo spettro d’analisi si può notare come con Aureliano il grosso dell’apporto al flusso monetario era garantito dalla zecca di Milano per poi passare il primato alla zecca di Lione che di fatto garantiva, assieme all’atelier di Pavia (aperto in concomitanza alla chiusura di Milano) la quasi totalità del circolante dell’area gallica. Verosimilmente la tesaurizzazione di esemplari nuovi e riformati di Aureliano prima e Probo poi, doveva essere bilanciata dal permanere in circolazione di un considerevole quantitativo di numerario imitativo abbondantemente svilito e sottopeso segnale di come vi fosse necessità di moneta spicciola per i traffici quotidiani e di come nei territori gallici abbia faticato a imporsi la moneta riformata che doveva sostituire le emissioni galliche. Chiudo ora la discussione allegandovi la mia rappresentanza del ripostiglio qui analizzato, ovviamente la scelta degli esemplari è ricaduta sostanzialmente nei sovrani gallici, imitative comprese, con l’inclusione degli imperatori centrali coevi Claudio, Quintillo e Aureliano (di quest’ultimo ho optato per l’ultima emissione uscita dalla zecca di Milano prima della sua chiusura). Purtroppo mancano all’appello Gallieno e Mario per la rappresentanza completa dell’arco temporale di mio interesse, ma mi ritengo comunque soddisfatto della composizione del mio “petit tresor monétaire”. 1) Postumo e Aureolo 2) Vittorino 3) Tetrico I e II 4) Claudio e Quintillo 5) Imitative 1/2 6) Imitative 2/2 7) Aureliano Portate pazienza per le foto... fatte al volo ieri sera con il telefono, poca luce e nessun accorgimento particolare. Nel gruppo, apparentemente alquanto "ordinario", ci sono alcune chicche per appassionati gallici e un pezzo interessante e anche, direi, abbastanza raro che è sfuggito sia in fase di catalogazione preliminare che in fase di verifica prima della vendita all'incanto e della successiva rivendita da parte del venditore professionale (purtroppo i miei sono acquisti di "seconda" tornata e quindi risentono di un leggero rincaro). Vediamo se notate gli elementi di maggior interesse... io non vi dico nulla2 punti
-
Buona sera a tutti, circa un paio di mesi fa ho acquistato questo grazioso tari. Oramai quelli di Carlo II ce li ho quasi tutti in collezione, quindi li sto lentamente sostituendo con esemplari sempre migliori. Voi che condizioni li dareste? In mano appare molto più bello che da queste immagini, per esempio quei graffi causati da pulizie poco raffinate nemmeno si notano.2 punti
-
2 punti
-
Salve, segnalo : https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-PGL/12 punti
-
@claudioc47Risultato finale L'ossidazione è scomparsa completamente. Per toglierla completamente ho rimesso a bagno in alcool per circa 30 minuti la moneta e poi con l'aiuto di uno stuzzicadenti, uno spillo metallico e sotto una lente di ingrandimento x 10 ho provveduto ad asportare molto delicatamente la restante ossidazione che si vede al post 12. Se paragoniamo le foto del post 10 con questa, direi che la differenza è notevole. (Mi sento di aggiungere che questo mio ultimo intervento può graffiare la moneta e rovinarla per sempre)2 punti
-
Ciao Rocco...potevi almeno aspettare un pochino di più, per dare il tempo di approfondire l'argomento ai giovani .... Ma qualcuno stava approfondendo l'argomento? In ogni caso, mi piace ricordare in questa occasione lo studioso Michele Pannuti che è stato il primo a documentare che il primo conio di questa nuova moneta, opera incisoria altissima di Don Filippo Rega, è stato quello coi capelli lisci. Il predetto studioso pubblicò sul Bollettino del CIrcolo Numismatico Napoletano all'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso il fondamentale saggio "Le monete di Ferdinando IV di Borbone del 1805 illustrate da documenti inediti". Il saggio è stato reso fruibile sul sito www.ilportaledelsud.org/bollettini.htm per merito di Francesco di Rauso @francesco77, cui va il mio ringraziamento per le preziose informazioni numismatiche che continua a divulgare. Saluti.2 punti
-
Buon giorno. Mi permetto di dare il mio contributo in merito. Alla data di pubblicazione del quaderno del Circolo Filatelico Molfettese (1998) la moneta in parola era nella collezione privata del Dr. Minervini (per espressa affermazione del'autore del saggio). Penso che trovavasi sempre nella medesima collezione l'anno successivo, quando la moneta venne pubblicata nel lavoro dei dottori Ruotolo e Minervini "Le grandi monete d'argento dei Borbini di Napoli" (ivi si legge soltanto che appartiene a collezione privata). Non sono a conoscenza delle sorti della moneta in parola in tempi successivi al 1999. Saluti.2 punti
-
Aspettiamo fiduciosi, senza colonne portanti come voi che Verona è ? Nell'attesa per chi extra pranzo volesse un Gazzettino focalizzi questo trolley anche per individuarmi eccolo....2 punti
-
E' vero, tuttavia la modalità con cui chi ha aperto questo ed altri post si pone testimonia in modo evidente che l'aspetto speculativo appare non solo prevalente ma addirittura esclusivo nel chiedere informazioni, tanto da equiparare la numismatica a un "settore" di investimento come fossero ETF o obbligazioni convertibili. Credo sia questo che abbia fatto sollevare le obiezioni di molti utenti, ma aspettiamo altri pareri.2 punti
-
Per chi ha un minimo di occhio per la numismatica c'è più o meno la stessa differenza che c'è tra un cane vero e uno di peluches.2 punti
-
Ciao a tutti, vi propongo questa divertente puntata della serie "Il testimone" che affronta il mondo del collezionismo nelle sue varie sfaccettature e che in molti passaggi mi ha fatto sorridere ritrovando parecchi aspetti (sia positivi che negativi) caratteristici della nostra categoria. "ll sesto appuntamento è dedicato al mondo sconosciuto e affascinante dei collezionisti. Scopriremo le collezioni più stravaganti di qualsiasi tipo di oggetto: dalle mutande alle Barbie, dai cimeli dei film di 007 alle bottiglie di whisky d’annata, dai Puffi alle carlinghe degli aerei. Una passione che, talvolta, può dar luogo ad autentiche ossessioni. " Saluti Simone1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Ahahah Dopo averlo smontato son convinto sia metallo. Lamina sottile. Potrebbe essere buono.1 punto
-
@El Chupacabra Sì, sì: SPL- = q.SPL. Il tuo è un esemplare veramente impressionante: possiamo parlare di q.FDC o superiore? Complimenti vivissimi!1 punto
-
1 punto
-
@miza direi un ottimo risultato. Quel piccolo lavoro di "chirurgia numismatica" fatto nella giusta maniera non danneggia nulla. Ovviamente su monete di alto pregio prima di operare in questo modo bisogna ragionarci un bel po', ma di fronte ad un eventuale cancro del nickel non ci sono molte vie di uscita.1 punto
-
confrontala con questa Francesco Farnese - monetazione di Piacenza -> sesino di Piacenza Dritto: Stemma di Francesco Farnese coronato, intorno FRAN • I • F • F • P • P • DVX VII •. Verso: Croce fogliata, intorno • SALVS • • MVNDI •.1 punto
-
1 punto
-
Ne ho anche qualcuna in fds Botswana Nel 1895, col nome di Bechuanaland il territorio fu dichiarato protettorato britannico. Il paese si distinse per la pacifica convivenza che ebbero i bianchi colonizzatori con i bantu del luogo per quasi un secolo. Nel 1966 il Botswana divenne indipendente come stato membro del Commonwealth. 1 Pula del 19831 punto
-
Ciao, sino all'anno di pubblicazione del catalogo Le grandi monete d'argento dei Borboni di Napoli, ossia il 1999, la moneta apparteneva alla collezione Minervini, oggi non so se è ancora in collezione presso il medesimo collezionista. Per quanto ne so, tutte le monete presenti nel catalogo sono del suddetto collezionista tanto che le schede delle monete sono compilate dallo stesso Minervini. Allego una porzione della descrizione della moneta dove sono trascritti i vari passaggi di aste.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Sono particolarità che si riscontrano abbastanza di frequente in questo tipo di monete, ne posseggo anch'io un paio di esemplari, come i tuoi, con le date "sfumate", che conservo con piacere, anche se non hanno alcun valore economico. Saluti1 punto
-
@claudioc47 buongiorno Approfitto della Tua esperienza e gentilezza per mostrare a te e coloro che sono interessati la moneta del 1916 che ho presentato nel post 10. (In questo post presento la stessa dopo averla pulita utilizzando il Tuo suggerimento) Premetto che non amo pulire le monete, ma in questo caso a mio parere era necessario! In particolar modo al R/ subdolamente nascosta sul profilo del bisonte avevo notato una brutta ossidazione che col tempo avrebbe sicuramente rovinato ulteriormente la moneta. Faccio un rapporto del lavoro eseguito: Dopo aver tenuto a bagno la moneta per circa un ora in alcool per uso alimentare 95% l'ho lavata con sapone di marsiglia eseguendo movimenti rotatori con un vecchio spazzolino da denti a setole morbide. In fine ho risciacquato la moneta con acqua distillata e tamponata con un panno morbido. Questo è il risultato: A me sembra un buon risultato, cosa ne pensate?1 punto
-
Coraggio.... 14 euro sono inferiori del costo di una lezione privata di matematica....e questa è comunque una lezione... : -D Per bonificare completamente i punti in questione devi rimuovere fisicamente la maggior parte possibile dei prodotti ossidativi (matita in vetroresina, bisturi o atro). Volendo dopo puoi fare anche un trattamento molto localizzato con EDTA: lo ottieni depositando una piccola quantità di cristalli direttamente nei crateri ed idratando con una goccia d'acqua o per mezzo di impacco fatto con un piccolo pezzo di scottex (tagliato sulla misura dell'area da trattare) su cui depositare i cristalli e la goccia d'acqua; in questo caso l'area bagnata rimarrà circoscritta a quella coperta dalla carta assorbente e non sarà condizionata dalla tensione superficiale della goccia d'acqua...che può progressivamente allargarsi. Una volta terminata la rimozione fisica delle incrostazioni superficiali e sciacquato il tutto con alcool etilico o acetone puro, dovrai trattare con il benzotriazolo che è il vero trattamento di inattivazione delle reazioni autocalitiche di corrosione del rame (benzotriazolo in concentrazione dal 3% al 6% in soluzione di alcool etilico puro, dalle 3 alle 48 ore, nel tuo caso specifico, considerata la qualità della moneta, puoi eccedere senza pericolo di alcun effetto negativo). Al termine del trattamento con BTA sciacquare abbondantemente con alcool etilico e poiiii... pensiamo a far perdere la lucentezza alla moneta... ciao Mario1 punto
-
1 punto
-
...Per quanto prosaico l'investimento è una faccia del collezionismo numismatico. E non dimentichiamoci che tra le funzioni della moneta è la riserva di valore: conservare un po’ di ricchezza per il futuro. Perciò è un po' ridicolo obiettare a chi vuole adoperare una moneta per quello per cui è stata inventata . Fatte salve tutte le considerazioni sul conoscere quel che si acquista e sull'incommensurabile soddisfazione nello studiare e possedere questi tondelli storici.1 punto
-
Medaglia devozionale ovale, bronzo/ottone, con appendici globulari o piolini, a ore 3,6,9,. ultimo quarto del XVI sec, probabile produzione romana.- D/ Madonna coronata a mezza figura, tiene con ambedue le braccia Gesù Bambino davanti al petto (tipologia bizantina) ,entro ornato floreale aperto, chiuso in basso da testa di cherubino, anepigrafe.- R/ Cristo in croce, con Maria a sx e S. Giovanni apostolo a dx, al centro in ginocchio la Maddalena che abbraccia la base della croce, medaglia rara.- Ciao Borgho1 punto
-
Contento vi siano piaciuti questi oggetti. Quello a sinistra é semplicemente il coperchio di una scatola tonda di lamierino/acciaio come quelle dei biscotti o del tea per capirsi. Ha un diametro di circa 16 cm circa e alta 5 cm. So che veniva data in omaggio dalla EDITALIA - IPZS a chi chiedeva una visita a domicilio informativa per l'acquisto della collana ''Storia della lira'' ma io l'ho trovata semplicemente in un mercatino tra ciaffi vari. (E pure piena di monete...preso tutto in blocco) È contenuta in una scatola di cartone e c'é incluso un piccolo libricino/dépliant. Il secondo oggetto é un fermacarte pubblicitario di un farmaco (il nome é scritto dietro in rilievo). Pesa ben 160 grammi per un diametro di 8 cm circa e uno spessore consistente: siamo sui 6 mm. Insomma un bel tondellone. La fattura é abbastanza grezzotta, l'impronta sembra ottenuta per fusione e poi verniciata. Il metallo pare sia ferraccio o forse ghisa ad essere ottimisti. Però come fermacarte fa sicuramente il suo dovere ? Saluti Simone1 punto
-
Se osserviamo i percorsi di Via IV Fontane e Via Panisperna,abbiamo ancora una idea(pallida)delle altimetrie antiche.1 punto
-
Ciao @apollonia questa è per te. tanto per parlare di capolavori guardate questa tetra di Alessandro e in particolare il profilo di Alessandro di quanto è stato cesellato, sembra un tuttotondo Silvio1 punto
-
A parte che l'"investimento" in numismatica è una chimera che tutti inseguono ma solo pochi (spesso abbienti) finalizzano, perché mai investire in oggetti che non si conoscono in maniera approfondita? Ad ogni modo se proprio desideri investire in monete, e non scommettere senza avere il necessario bagaglio d'esperienza, comincia dall'acquistare monete in oro o argento pagandole il valore del fino più il giusto aggio dovuto al commerciante. Anche così sarà un investimento a lungo, se non lunghissimo, termine ma almeno sarà difficile rimetterci. Se nel frattempo ti scatta l'"amore" per i nummi e deciderai di metterti a studiarli potrai capire da solo se e quando varrà la pena di esporti a scopo speculativo. Buona giornata.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Ri-ciao a tutti.... Fatemi imparare qualche cosa di nuovo. Nel link @santone in effetti ci sono esempi di falso in rame....ma sono molto meno palesi e alcuni sono dubbi e sembrano semplicemente monete usurate. Chiedo agli esperti e vi ringrazio in anticipo, chiaritemi se potete questi dubbi. (scusate per le troppe domande) come si fa a datare una "moneta" del genere? Secondo me non è detto che per il solo fatto di essere false e non rare siano necessariamente d'epoca! poi... conveniva rischiare la stessa galera facendo la cresta su 5 grammi di rame falsificando un 10 tornesi, invece di falsificare con lo stesso quantitativo di metallo una piastra?...mi chiedo come @nikita_ se ne valesse la pena? Poi sono falsi talmente palesi che chi diavolo si faceva fregare con una moneta del genere? e essendo palesi il rischio per chi le spacciava aumentava troppo. O no? O forse essendo così palesemente falsi non erano nemmeno considerati falsi? Grazie a chi mi chiarisce questi (molti) personali dubbi. Da inesperto di falsi, visto che non li ho mai seguiti e collezionati, vorrei capirci qualche cosa di più! Un'ultima curiosità...come sono i contorni delle monete postate?1 punto
-
1 punto
-
Sappiamo che in origine l'asse pesava una libbra di bronzo, e valeva quanto essa. Questa corrispondenza si era già persa al tempo dei trionfi che tu citi, ma immagino che nella mentalità fortemente tradizionalista di Tito Livio avesse lasciato la uno strascico: esprimere il pesodel metallo in termini monetari. Per questo, anche io sono convinto che le libbre di bronzo fossero effettivamente libbre; laddove invece leggi "81.000 denarii" significa "abbastanza argento che se ne potranno coniare 81.000 denarii"1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Luigi sono della tua stessa opinione. Già solo la risposta alla domanda "si può ottenere un mezzo baiocco di Clemente XI con entrambe le impronte in incuso?" ci porta a trarre le debite conclusioni.1 punto
-
Salve, la Y corrisponde alla sigla dello zecchiere, ossia Diego de Ybarbouro. Nel verso, prima della sigla dello zecchiere, sempre sulla prima riga, è possibile intravedere anche il valore 1 (real), mentre sulla seconda riga una parte della legenda (PLV)S VLTR(A) e sulla terza in centro la cifra 715, ovvero la data 1715. Nel dritto, accanto alla croce di Gerusalemme con due castelli e due leoni, si vede nuovamente la sigla dello zecchiere Y e una piccola parte della legenda (PH)ILI(PPVS V D G HISPANIARVM REX). Cordialità1 punto
-
1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?





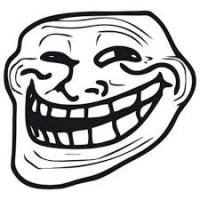










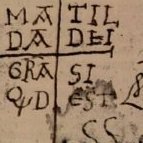




.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)



.thumb.jpg.1d3b56d02cc983aaeb9f4d6ee8eebe9a.jpg)








