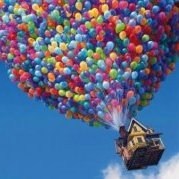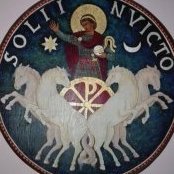Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 09/01/17 in tutte le aree
-
Ciao. Cadeva ieri, 31.8.2017, il ventennale della scomparsa di Lady Diana Spencer, già Principessa del Galles poichè consorte (divorziata) dell'erede al trono britannico nonchè Principe del Galles, Carlo d'Inghilterra. Il tragico decesso della Principessa Diana, come noto avvenuto a Parigi per un incidente stradale le cui cause sono tuttora molto discusse, suscitò un enorme cordoglio non solo nel Regno Unito ma in tutto il mondo. Al contrario, la Regina Elisabetta sembrò , almeno in un primo tempo, non manifestare un particolare sentimento di vicinanza alla vicenda, tanto da non interrompere immediatamente le consuete vacanze estive, in corso in quel momento in Scozia, nel castello di Balmoral. Fu solo a seguito delle pressioni della stampa e dell'opinione pubblica inglese nonchè dei consigli dell'allora Primo Ministro Tony Blair, che la Regina Elisabetta e la sua Corte decisero finalmente di rientrare anticipatamente a Buckingham Palace, dove presero diretta contezza della popolarità di Diana e della costernazione che la sua tragica morte aveva provocato nella gente. In numismatica, la coppia dei Principi era già stata celebrata, ma dopo il divorzio e gli scandali sentimentali che lo avevano caratterizzato, non era scontato che la memoria della ex "Altezza Reale" (Diana non perse invece il titolo di Principessa del Galles e incassò a seguito del divorzio una "buonuscita" di 17 milioni di sterline) venisse ricordata con un'emissione numismatica ufficiale da parte del Regno Unito. Fu quindi una decisione abbastanza sorprendente quella assunta dalla Royal Mint e ovviamente approvata dalla Corona, di emettere nell'anno 1999 monete celebrative di Diana in vari metalli, fra cui anche il massimo nominale aureo da 5 Pounds recante , al rovescio, il ritratto della sfortunata Diana, con dedica alla sua memoria: Nell'affiancare l'immagine del dritto, ove campeggia il ritratto rivolto a destra della Regina Elisabetta, al rovescio, dove è proposto il volto triste di Diana, anch'esso rivolto a destra, si crea involontariamente un effetto che sembra testimoniare il vero sentimento esistente fra la Sovrana e la Principessa, con Diana che rifugge e si sottrae allo sguardo imperturbabile della Regina. In questo caso la moneta non raffigura solo dei volti, ma riesce ad esplicitare anche i sentimenti dei protagonisti. M.4 punti
-
Recupero questa datata discussione che per me ha rappresentato una tappa importante per la mia formazione (ancora in corso!!!) sulla monetazione gallica. Proponevo una VITTORIA AVG di Postumo che, sebbene non fossi riuscito ad acquistare, avevo analizzato a fondo formulando diverse ipotesi circa la sua produzione. Ipotesi che hanno poi portato a un piccolo articolo uscito su Panorama Numismatico. Oggi come oggi rivedrei alcune parti e sarei tendenzialmente più determinato nella formulazione dell'ipotesi finale circa l'ufficialità o meno del pezzo in questione... ma tant'è, son passati tre anni e nel mezzo ci sono state molte monete e soprattutto molti libri, articoli e discussioni su forum anche internazionali che mi hanno portato a un confronto di ampio respiro che, per la monetazione in oggetto, è oltremodo necessario. Comunque, si trattava di un pezzo che avevo rincorso e che fece un realizzo (di cui francamente non ricordo l'importo) fuori dalla mia portata. Il rammarico di non aver in collezione quel Postumo me lo son portato dietro per un bel po'... in fin dei conti il rovescio era quello di una Vittoria andante verso destra... ricordava Leliano... possibili ibridi con Claudio II o Mario... insomma, era un pezzo ricco di fascino e interrogativi. Poi è arrivato in collezione un Tetrico imitativo con una vittoria analoga e, da ultimo, in tempi più recenti pure Leliano... cosa può volere di più un collezionista di galliche romane?!? Eppure... quel pezzo di Postumo, mannaggia! Se non era per lui non mi sarei buttato sulla "scrittura numismatica"... rimaneva ancora insoddisfatto quel desiderio tipico del collezionista, - irrazionale (e impossibile) - del "possedere tutto" che è poi la pulsione che ci spinge a collezionare. Orbene, dialogando e confrontandomi sulla monetazione gallica con il venditore della Vittoria di cui vi ho raccontato qui: è emerso che pure lui si era imbattuto in un'analoga Vittoria in corsa verso destra di Postumo e che ce l'aveva ancora... e così, eccola qua! Per una manciata di spicci, con un pizzico di soddisfazione, ve la presento: Antoniniano; Zecca Locale; 2.07 gr; 17 mm; D\ [...]POS[...] AVG, Busto drappeggiato e corazzato a d. R\ [...]RIA AVG, la Vittoria andante verso destra con in mano corona e ramo di palma posato sulla spalla Buonissimo stile, un rovescio che non ha nulla da invidiare alle analoghe emissioni ufficiali di Caludio II, dritto con un ritratto imitativo, ma ben realizzato. L'esergo non è visibile per cui... chi lo sa se c'era una lettera di officina come nel pezzo originario di questa discussione! ...ah... ora che ci penso... quel desiderio di cui parlavo prima... ancora non è soddisfatto appieno!4 punti
-
Partecipo a questa bella discussione con un sampietrino di San Severino con data particolare...4 punti
-
Siamo nella sezione del Sud...ed io parlo per la mia (di sudio intendo) mitica città "Napoli", questa zecca non ha eguali....; la gara non è a quale costa di meno....chi mastica bene la numismatica (e parlo sempre e solo per Napoli) comprende che basta comprare un Gigante oppure un Montenegro una sola volta (max ogni 4/5 anni). Il Montenegro è praticamente sempre fermo, il Gigante almeno qualcosa aggiorna (anche perchè Francesco "fa" inserire sempre, ogni anno qualcosa, perchè è attento a molte discussioni riportate proprio in questo Forum). Il problema è che vengono aggiornati sempre e solo i prezzi (sempre verso l'alto....mha !!) e di rado qualche rarità, ma nessuno dei due fa o fa fare una vera ricerca su tutto ciò che è riportato .....di errato. La discussione, vedo che si evolve (anche se in una sezione del sud) verso un carattere generalizzato dei due cataloghi...quindi fatto questo mio intervento, se non è Napoli....mi fermo.3 punti
-
Spenderei due parole su questo tondello. Non uso la parola moneta perché non è una moneta. L'India non ha Elisabetta come sovrana ed è evidente che questo gettone/medaglia non possa avere un decreto di emissione ed è quindi, anche se autorizzata dalla Royal Mint, una emissione privata. Fra tutte le menate inventate negli ultimi anni questa secondo me è la più deprecabile. Infatti il sito della zecca le vendeva come bullion (non hanno finitura BU come la sapphire) senza minimamente accennare alla differenza sostanziale con le bullion coniate a Londra. Dulcis in fundo pcgs la chiude come "sov" senza minimamente porsi il problema. Mi viene da pensare, a questo punto, che il disagio nel vedere ciò sia solo mio e che al resto dei collezionisti importi poco, dato che hanno coniato questi gettoni con vari millesimi. Nulla di male nel voler aumentare il fatturato ma andrebbe precisata la natura di ciò che si vende. Altro discorso per tutta la paccottiglia inventata nel 2017 venduta cara per via delle basse tirature. Il mercato dice che han ragione loro visto che è andato tutto sold out. Però mi domando: le han prese collezionisti o speculatori? Quando lo speculatore le vorrà cedere troverà un collezionista disposto? Fra qualche anno, quando appariranno nelle aste battute, avremo la risposta. Per quanto mi riguarda mi sono avvicinato a questa raccolta affascinato dall'attaccamento alla TRADIZIONE britannica. Un millesimo una sovrana, al massimo una seconda emissione proof ma di tipologia identica. Sfumata la tradizione sfuma il mio interesse e la mia raccolta si ferma al 2017. La paccottiglia la lascio ad altri e guardo indietro nel tempo a quando la sovrana era il simbolo della stabilità dell'impero. Sono vecchio, le novità non mi piacciono ed è evidente che il mercato vada in altra direzione ma passata la moda delle sovrane e quietata la richiesta speculativa io sicuramente non resterò con il cerino in mano.3 punti
-
Nonostante la bassa conservazione , e' stato un piacere inserire questo esemplare in collezione 2 Fiorini 1617 (assedio di Vercelli) Carlo Emanuele I2 punti
-
Mi raccomando, portate dietro il vostro miglior sorriso per le foto di gruppo2 punti
-
Riepilogo per la giornata del 10 settembre : 1) ritrovo, distribuzione del Gazzettino e aperitivo al Cordusio davanti al Bar Spadari alle ore 10,30 2) pranzo alla Salsamenteria di Parma, Via Ponte Vetero 11 ( vicino al Castello Sforzesco ) alle ore 12 ( mi hanno raccomandato questo orario perché è domenica ) - prenotato come da lista per 25 in saletta riservata Menù : affettati vari misti, formaggi vari misti, polenta fritta mix di due primi lambrusco, acqua minerale e caffè prezzo 30 Euro a persona2 punti
-
@Jacob641 ti consiglio senza volerti offendere assolutamente, di leggere un po' di discussioni e di risposte degli esperti (lungi da me da volermi mettere in quella categoria) prima di dare certezze nelle risposte... in questo caso abbiamo una firma Draghi, che è quindi la terza, considerando le firma, dopo Duisemberg e Trichet, di una banconota sì stampata PER la Finlandia (lettera L) ma prodotta in Germania (lettera R). La Finlandia non stampa le sue banconote da anni e anni. Comunque spendibile, questo sì penso Un caro saluto.2 punti
-
la prima è McAlee 1134c tre dot sotto il collo, definita rara. AVT K G ME KV TPAIANOC DEKIOC CEB ( RADIATO ) La seconda McAlee 1126c sempre tre dot sotto il collo definita comune.2 punti
-
2 punti
-
2 punti
-
Salve , avrei voluto pubblicare questo Post il 27 Agosto appena passato , ma la mancanza di alcune foto scattate solo ieri mi hanno impedito di farlo in occasione della ricorrenza della Santa . Ad Ostia Antica , oltre agli immensi ruderi dell’ antica Citta’ romana , ruderi che meritano una visita da parte di chiunque venga a Roma essendo in pratica una Pompei ricoperta dalle alluvioni del Tevere anziche’ dalla cenere vulcanica del Vesuvio , in piu’ esiste anche un piccolo quartiere del moderno borgo di Ostia antica , che risale al XV secolo , sorto intorno ad una Chiesa chiamata di Sant’ Aurea , la peculiarita’ di questa Chiesa e’ che venne costruita verso la fine del 1400 sopra un antico cimitero romano , nel quale vennero ritrovate le tombe delle due Sante ; di Aurea appunto e di Monnica , questo era il nome originale della madre di Agostino come risulta da un epitaffio marmoreo posto nella Cappella di destra dedicata alla Santa , poi ridotto a Monica . Tutta l’ odierna Ostia antica sorge praticamente sopra l’ antica , tanto e’ che quasi ovunque si vedono antichi ruderi e tracce del basolato della antica Via Ostiense spuntare dal terreno . Tutto intorno al borgo di Ostia antica si estende , specialmente sulla sinistra della Via Ostiense , venendo da Roma , un immenso cimitero antico ; questo al di fuori della grande area recintata degli scavi archeologici visitabili , ma area piccola in confronto all’ estensione della antica Ostia , insomma nel borgo di Ostia antica , come a Roma , si cammina sopra millenni di Storia . In breve la sua storia terrena di Santa Monica Monnica nacque a Tagaste in Numidia , Africa , nel 331 e mori’ ad Ostia il 27 agosto 387 , giorno fissato dalla Chiesa quale ricorrenza della Santa , ricorrenza da pochi giorni trascorsa ; fu la madre di Agostino d' Ippona , entrambi santificati dalla Chiesa Cattolica . Monnica era quindi una Berbera ma nacque in una famiglia profondamente cristianizzata e di agiate condizioni economiche . Ando’ in sposa ad un certo Patrizio , un proprietario terriero di Tagaste , non ancora cristiano il cui carattere lo portava spesso ad esserle infedele ma con il suo carattere mite e dolce alla fine ne ammorbidi’ i difetti . Nel 371 Patrizio si convertì al cristianesimo e si fece battezzare , appena in tempo perche’ l 'anno seguente mori’ ; Monica aveva all’ epoca 39 anni . Partori’ il primo figlio Agostino a 22 anni , nel 354 , che divenne poi famosissimo come Filosofo , Vescovo e Teologo , fu l’ autore di vari scritti , tra cui i maggiori furono le “Confessioni” e la “Citta’ di Dio” . Monica ebbe in seguito un altro figlio di nome Navigio e una figlia di cui si ignora il nome , ai quali dette a tutti e tre una educazione cristiana . Soffrì molto per la condotta giovanile spregiudicata e dissoluta di Agostino e quando Agostino si trasferì a Roma decise di seguirlo ma lui con uno stratagemma la lasciò a terra a Cartagine , mentre lui s' imbarcavano verso Roma . Monica passò la notte a Cartagine in lacrime sulla tomba di San Cipriano , fatto che narrera’ postumo lo stesso Agostino nelle Confessioni . Nel 385 Monica poté imbarcarsi per Roma e raggiunse il figlio Agostino a Milano , dove nel frattempo ricopriva la cattedra di Retorica . Il suo amore materno e le sue ferventi preghiere favorirono la conversione di Agostino , che ricevette il Battesimo ad Aprile del 387 , a 33 anni . Ritroviamo poi Monica accanto ad Agostino a Cassiciaco vicino Milano , discutendo con lui e altri familiari di Filosofia e di altri argomenti di carattere spirituale , partecipando anche con sapienza ai discorsi , al punto che Agostino volle trascrivere nei suoi scritti le parole della madre ; in questi anni si completa la missione spirituale di Agostino . Monica insieme ad Agostino lasciò Milano diretta a Roma e poi a Ostia dove affittarono una casa in attesa di una nave in partenza per l' Africa . Anche questo fu un periodo carico di spiritualita’ che Agostino riporta nelle sue Confessioni . Qui ad Ostia Monica si ammalò e morì , aveva 56 anni . Il suo corpo fu tumulato nel luogo in cui in seguito sorse la Chiesa di Sant' Aurea di Ostia . Il 9 Aprile 1430 le sue reliquie furono traslate a Roma , forse per il pericolo saraceno , nella Chiesa chiamata all’ epoca di San Trifone , oggi invece dedicata al figlio di Santa Monica , Sant' Agostino e poste in un pregiato sarcofago in marmo . Vediamo ora chi era Aurea a cui e’ dedicata l’ antica Chiesa di Ostia Antica : Nella Cappella di destra sono state sistemate due importanti lastre tombali , la prima reca scritto CHRYS... HIC DORM... (CRHYSE HIC DORMIT) , cioè “qui riposa Aurea” . Era questa la lastra che indicava il luogo delle reliquie di Sant' Aurea , la martire che ha dato il nome alla chiesa : Aurea era una nobile giovane romana che venne prima esiliata , poi torturata ed infine martirizzata tramite annegamento in mare ad Ostia , sembra intorno all' anno 229, cioè sotto l' Imperatore Alessandro Severo o forse nel 258 sotto l' Imperatore Claudio il Gotico , insieme ad altri cristiani . Credo sia piu’ probabile la seconda ipotesi , sapendo del carattere piuttosto mite di Alessandro Severo e favorevole verso il Cristianesimo . In questa Cappella di destra , entrando nella Chiesa , si legge anche l' antica lapide che ricorda la sepoltura di Santa Monica , che recita : Hic posuit cineres genitrix castissima prolis Augustine tui altera lux meriti cui servans pacis coelestia iura sacerdos commissos populos moribus instituis gloria vos maior gestorum laude coronat virtutum mater felicior subolis Che tradotto : Qui le ceneri lasciò la tua castissima madre , o Agostino , nuova luce ai tuoi meriti , tu che sacerdote fedele alle prerogative della pace ammaestri con la vita i popoli a te affidati , la gloria delle opere , maggiore di ogni lode , vi incorona : la madre , specchio di virtù , più beata del figlio . Il frammento qui’ conservato fu ritrovato casualmente da uno dei padri agostiniani nel 1945 e corrisponde fedelmente alla trascrizione che era nota da un pellegrino altomedioevale che erroneamente l' attribuiva al Console Anicio Auchenio Basso che ricopriva la carica consolare nell' anno 408 . Seguono in ordine di foto : Chiesa di Sant' Aurea , quartiere del XV secolo , Chiesa di Sant' Aurea altare Maggiore , epigrafe di Sant' Aurea (2) , epigrafe di Santa Monica (2) , quadro rinascimentale con Monica ed Agostino , reperto archeologico non leggibile , epigrafe di Santa Monica dove compare il nome Monnica , castello di Papa Giulio II attiguo alla Chiesa , antica fontana dentro il quartiere del XV secolo , portale di ingresso al quartiere pieno di reperti antichi , viale di ingresso alberato con Pini agli scavi archeologici di Ostia antica , tratti antichi della Via Ostiense con basoli e tracce dei marciapiedi piu' ruderi antichi (6) , Chiesa di Sant' Agostino in Campo Marzio dove riposa il corpo di Santa Monica , sepolcro di Santa Monica (2)2 punti
-
Beh.. attenzione perchè se andiamo avanti cosi.. dobbiamo cambiare location... A parte gli scherzi, chi è ancora indeciso non esiti, certi momenti sono irripetibili, è anche un'opportunità per conoscerci e per poter dire un giorno c'ero anch'io.. Eros2 punti
-
Mario lasciaci qualcosa anche a noi... Comunque stupendo excursus su Milano e i suoi magnifici volti. Alzate lo sguardo se vi capita di passare tra via Melzo e via Frisi: vi ritroverete catapultati in un’altra epoca. E nonostante il cinema Dumont (1910-1932) non esista più, c’è stato un tempo in cui Milano – dietro questa strepitosa facciata liberty – imparò ad amare le magie della Settima Arte. Siamo nel 1908, periodo di visioni incredibili. Una fase di mezzo in cui l’ingegno umano non smette di creare e i venti bellici soffiano ancora a debita distanza. Nel 1891 Nikola Tesla dà il via ai suoi coraggiosi esperimenti “wireless” per le comunicazioni-radio; quattro anni dopo due fratelli francesi (August e Louis Lumière) inaugurano a Parigi il loro “cinematographe” inventando una strana arte in movimento a cui verrà dato il nome di cinema; nel 1899 scendono in strada le prime rudimentali automobili grazie all’ausilio del motore a scoppio. In pratica sono anni in cui succedono “cose” e si guarda a Parigi esattamente come si fa oggi con Cupertino. Due imprenditori milanesi, i fratelli Galli, respirano a pieno quest’ebbrezza e –motivati dall’esperimento del Lumière di Pisa (prima sala cinematografica italiana in assoluto) – decidono di provarci nella loro città: anche Milano avrà la sua “lanterna magica” ospitata in un luogo a cavallo tra eleganza e fantasia. Il nome scelto sa di grandeur (Dumont) e il progetto affidato a due nomi di grido: gli architetti Tettamanzi e Mainetti. L’area scelta è quella all’angolo tra via Melzo e via Frisi (famosa in passato per il Lazzaretto) ed è lì che viene edificata una palazzina la cui facciata è un trionfo liberty. Dentro non manca nulla: una sala d’aspetto, il bar, una cabina di proiezione e il parterre arricchito da una pavimentazione lignea con 516 posti a sedere suddivisi in 20 file di comode poltroncine. È il 1910 e per un bel po’ saranno solo successi al botteghino. Poi qualcosa cambia: il locale comincia a ospitare seconde visioni e l’appeal viene imbruttito da un nuovo tipo di clientela, più rozza e turbolenta. Il lucido parquet viene ripetutamente calpestato da zotici che scambiano il luogo per una balera, i divieti di fumo vengono puntualmente disattesi e per terra è tutto un mix di noccioline, bucce d’arancia e “staccaganass” (dolci durissimi, il popcorn dell’epoca) per un triste carnevale di lerciume e maleducazione. Non può durare. Tant’è che nel 1932, alla morte dei Galli, scompare pure la loro “isola felice”. Scampato ai bombardamenti del ’42-’44, per il Dumont le agonie non sono ancora finite: nel 1953 viene addirittura decisa la sua demolizione, ma il comitato di zona insorge respingendo lo scempio. Il vecchio cinematografo si ricicla prima come autosalone e poi come deposito di ambulanze. Nel 1993, infine, l’idea di tramutarlo nell’attuale Biblioteca Venezia riconvertendone l’atrio e mantenendo le tre colonnine originali di Tettamanzi e Mainetti.2 punti
-
Lo stato di conservazione di una moneta non è dato dalla sua lucentezza ma dai rilievi. Se noti, vedrai che la figura femminile ha il seno dx appiattito, i capelli sembrano una cuffia per proteggersi dal freddo, i capelli del Re sono quasi scomparsi. Azzardo una cosa: quello che te l'ha venduta l'ha spacciata per spl? E come tale te l'ha fatta pagare? Bisogna essere critici con i vari commercianti e discutere, se necessario, i prezzi proposti. C'è la tendenza, per alcuni commercianti, di tenere un gradino più alto, in caso di vendita, e un gradino più basso in caso di acquisto da collezionista l'asticella della conservazione e di conseguenza il prezzo. Per farsi l'occhio sulle conservazioni, bisogna vedere tante monete. Qui nel forum hai la possibilità, spulciando nelle varie sezioni di vedere tante monete e leggere i giudizi che le vengono dati. Per imparare, prima di leggere le risposte, analizza le foto e dai un giudizio; poi leggi il seguito.2 punti
-
Ancora rame, nuovamente simboli, se si osserva attentamente da quella torre, si può udire il racconto che questo tondello vuole gentilmente elargire... Un piccolo nominale, ancora numeri, il 9 Anche questo mi ha sempre affascinato, ancora attrazione, inspiegabile ma ricca di significati, sarà che a me piacciono tutte... Napoli Ferdinando IV 1789 9 Cavalli.2 punti
-
Clemente VII, mezzo giulio coniato a Piacenza in occasione del Giubileo del 1525: Non in alta conservazione, ma se l'esemplare della collezione (ex) Reale è forato...direi che posso tranquillamente accontentarmi!2 punti
-
1 punto
-
Io ne so meno di @chievolan ma qualcosa aggiungo. La dracma in questione appartiene alla Satrapia Occidentale, nata dallo smembramento dell'Impero Gupta. Dietro la testa del sovrano trovi indicata la data, ma delle tre lettere se ne vede soltanto una; al rovescio (che devi abbondantemente ruotare a sinistra) trovi il nome del sovrano. Il brahmi non è difficile e - se trovo un po' di tempo nel fine settimana - ti sciolgo la legenda, peraltro perfettamente leggibile. La datazione è piuttosto ampia: dal I al IV secolo d.C. anche se la moneta in questione mi sembra appartenere alle ultime serie. Lo studio della monetazione indiana ti apre veramente un mondo. Anche se non c'entra molto, mi piace ricordare un maestro nel campo dell'orientalistica: Pio Filippani Ronconi. Un giorno, accogliendomi nel salotto, si meraviglió che - pur conoscendo il latino e il greco - non sapessi ancora il sanscrito. Un mito.1 punto
-
Non ne ho idea. Non conosco queste monete .... la mia identificazione (relativa e da accertare) viene perché ho letto di queste monete in una mia curiosità relativa alle leggende sull' Uccello Garuda (che forse è raffigurato, schematico, sulla tua moneta). Da una moneta come quella puoi partire per un lungo viaggio di conoscenza. Inizia a percorrerlo. Poi, in una sosta, puoi anche per curiosità fermarti un attimo e chiederti e chiedere il valore veniale della moneta. Il mito dell'Uccello Garuda, amico del dio Vishnu è molto interessante. Interessante (per lo studio delle lingue e delle antiche scritture e per i movimenti culturali nell'antichità) è anche la scrittura brahmi (o brahami) di derivazione semitica, probabilmente aramaica. Non credo comunque che queste dracme abbiano un gran valore.1 punto
-
Non ho il Gigante sotto mano ma da quando parte dal 1700???? Che io sappia è sempre partito dal 18001 punto
-
Questa è la foto che scattai al dritto della mia sapphire appena arrivata . Si puó ben notare la particolarità della finitura.1 punto
-
Buonasera, a proposito di denari di Corrado II con legende atipiche, questo esemplare (0.86 g, 16 mm, 0°) presenta, nella legenda del rovescio, una M al posto della N. Un caro saluto, Valerio1 punto
-
RESTAURO CONSERVATIVO Continuiamo sull'argomento restauro, con un altra medaglia devozionale dedicata a due Santi "francescani" dei quali allego due brevi profili. Maria Francesca delle Cinque Piaghe, al secolo Anna Maria Rosa Nicoletta Gallo (Napoli, marzo 1715 – Napoli 6 Ottobre 1791), è stata una religiosa italiana del terz’ordine regolare di San Francesco beatificata nel 1843, fu proclamata santa nel 1867. Nel settembre 1731 , entrò nel terz’ordine regolare di San Francesco Alcantarino e divenisse terziaria francescana. L'8 settembre 1731 Anna Maria pronunciò i voti assumendo il nome di Maria Francesca delle Cinque Piaghe, per la particolare devozione che aveva verso la Passione di Gesù. Vestì l'abito religioso e continuò a vivere nella casa paterna. A 38 anni andò, insieme ad un'altra terziaria, suor Maria Felice, a fare la governante nella casa del suo direttore spirituale, il padre Giovanni Pessiri, un sacerdote che viveva al secondo piano di un antico palazzo in vico Tre Re a Toledo, dove rimase per 38 anni fino alla morte. Morì a 76 anni il 6 ottobre 1791. Oggi è particolarmente venerata a Napoli, soprattutto dalla popolazione dei Quartieri spagnoli, che invocò la sua protezione anche durante la seconda gurra mondiale. La piccola chiesa santuario di vico Tre Re 13, ricavata vicino alla sua casa, è oggi meta di continui pellegrinaggi, In particolare, all'interno del convento vi è una sedia ritenuta miracolosa dai fedeli. Essa è la sedia dove solitamente Maria Francesca sedeva per riposare e trovare sollievo mentre avvertiva i dolori della Passione. Oggi chi vuol chiedere una grazia alla santa, vi si siede e le rivolge una preghiera. Questo rituale è particolarmente seguito dalle donne sterili che desiderano il concepimento di un figlio. Rocco di Montpellier, universalmente noto come san Rocco (Montpellier 1346/1350– Voghera, notte tra il 15 e 16 Agosto 1376/1379), è stato un pellegrino e taumaturgo francese; è venerato come santo ed è patrono di numerose città e paesi. È il santo più invocato, dal Medioevo per le grandi catastrofi come i terremoti, alle epidemie e malattie gravissime; in senso più moderno. Il culto di san Rocco è popolarissimo da secoli in Europa e nel resto del mondo. Appartenente ai Terziari francescani, pare affermino che la sua “francescanità” sia dovuta all'azione dei religiosi francescani, appunto, che ne diffusero il culto, sia su richiesta della Corte del Regno delle Due Sicilie (alcuni Borbone furono guariti per sua intercessione). Voghera rimane comunque il centro da cui si sviluppò il culto del santo pellegrino di Montpellier, la cui celebrazione è attestata a partire dalla fine del Trecento (il primo e più antico documento al mondo, attualmente disponibile, in cui se ne parli, è lo statuto comunale vogherese di quel tempo). A Penta, frazione del comune di Fisciano, (SA), nella chiesa di San. Bartolomeo Apostolo è conservata, oltre che a una piccola reliquia del santo, un'antica statua bronzea, risalente alla prima metà del 1500. Ogni anno, a Penta, si svolge, il 16 agosto, un'imponente processione. La medaglia in ottone (29x39 mm ) presentava vaste macchie e diversi ossidazioni sia al D/ che al R/. Dopo un primo lavaggio, si è provveduto all'asportazione meccanica al microscopio delle ossidazioni maggiori, e poi si è proceduto con un lavaggio particolare per l'eliminazione delle macchie. Si ringrazia il committente per aver autorizzato la pubblicazione.1 punto
-
1 punto
-
No,probabilmente l'italianizazzione di "su' da doss ,can!" Togliti di dosso cane!..1 punto
-
1 punto
-
Magnus Maximus AR Siliqua. Mediolanum, circa AD 387-388. D N MAG MAXIMVS P F AVG, pearl-diademed, draped and cuirassed bust right / VIRTVS ROMANORVM, Roma enthroned facing, head left, holding globe and reversed spear; MDPS in exergue. RIC 19a; RSC 20c. 1.53g, 17mm, 6h.1 punto
-
Eugenius (A.D. 392-394), Silver Siliqua. Mint of Mediolanum, struck A.D. 393-4. D N EVGENIVS P F AVG, pearl-diademed, draped and cuirassed bust facing right, rev VIRTVS ROMANORVM, Roma seated left on a cuirass, holding Victory on a globe and a spear, MDPS in exergue, 1.50g., 6h (RIC 32c; C 14; RCV 20689).1 punto
-
Buongiorno, ecco il millesimo successivo: Ferdinando IV Cavalli 9- 1790, Notate le differenze nella torre al rovescio, lati superiori dritti.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Buonasera, rispondo alla ‘evocazione’ di Adolfo postando un altro esemplare con S quasi verticale anziché coricata. Si tratta di un denaro con le caratteristiche delle emissioni di Enrico IV (H2c a mio avviso, 1.06 g, 16 mm, 0°)). Un caro saluto, Valerio1 punto
-
Mi permetto di aggiungere qualche notizia su S.Monica.La santa è protettrice delle madri di famiglia: perchè con bonta e mansuetudine riusci' ad addomesticare il marito avendo ragione dei pettegolezzi delle ancelle e perfino del caratteraccio della suocera, conquistandosi con cio l'ammirazzione (e l'invidia) delle amiche. La figlia prese il velo e la sua piu grande consolazione che Agostino divenne cristiano grazie a Sant'Ambrogio.1 punto
-
Ciao @bizerba62, bella storia . Che extraterrestri possano farci visita da altri mondi mi piace pensarlo e potrebbe anche essere fattibile visto che il nostro sistema solare ha "solo" 4,6 miliardi di anni , contro i circa 14/15 dell' intero Universo , quindi , in teoria , civilta' molto piu' evolute della nostra potrebbero esistere nella nostra Galassia o in altre . Il grosso problema , almeno per noi terrestri , sono le immense distanze , per risolvere le quali si fantastica di tunnel temporali che piegherebbero , accorciandolo , il tempo / spazio , aiutati in questo anche da sistemi di combustile per astronavi al Plasma o ad Elio 3 , elemento presente pare in abbondanza sulla Luna , ma per ora siamo nel campo della fantascienza . Viste queste difficolta' oggettive , si pensa che gli extraterrestri non esistano o se esistono , avrebbero le nostre stesse difficolta' dovute alle immense distanze , quindi si ripiega prospettando che UFO ed Alieni non siano altro che gli uomini del lontano futuro che hanno inventato la macchina del tempo , altro sogno dei nostri secoli , diversi di aspetto da noi contemporanei perché mutati , come del resto tutto nel tempo muta in natura , e' la vecchia teoria dell' evoluzionismo di Darwin . Ora , se cosi' fosse , verrebbe spontaneo chiederci per quale motivo i nostri lontanissimi discendenti verrebbero a visitarci , forse per motivi biologici di declino della nostra specie e questo potrebbe spiegare il perché dei rapimenti temporanei con tanto di analisi e prelievi , forse per mancanza di alcune materie prime o forse per modificare il corso della storia futura evitando in tal modo le loro future situazioni , le ipotesi sono tante e fantascientifiche . Un saluto1 punto
-
in questa giungla di supercazzole ed operazioni commerciali discutibili, sono sempre più contento della scelta fatta a fine 2016 prendere la 2017 bullion (scudetto) e proof. lasciar perdere le emissioni speciali BU si tratta di scelte ovviamente, il portafogli non è in grado di sostenere questa deriva pazza presa dalla royal mint (4 emissioni in un anno, è roba da matti) ma devo essere sincero, anche ad aver avuto un portafoglio a fisarmonica non avrei mai comprato (a fini collezionistici, quelli speculativi sono altra cosa evidentemente) le due emissioni speciali con finitura BU. Sicuramente belle, raffinate e pregiate, ma sempre più lontane dalla mia filosofia di collezionista di sovrane.1 punto
-
Una immagine storica potrebbe essere questa con le chiuse...1 punto
-
Chi fu il Conte Paolo Andreani ? Credo che a pochi dica qualcosa eppure... Paolo Andreani nasce a Milano nel 1763, di famiglia borghese, abita nel palazzo che ospita ora la Biblioteca Sormani. Andreani sa di tutto, filosofia, storia, lettere, matematica e... Ma ben presto capisce che le aspirazioni lo portano a diventare aeronauta. Il 13 marzo del 1784 compie una impresa storica, dal suo giardino di Brugherio nei pressi di Milano compie il primo volo umano su un aerostato, il primo volo italiano in assoluto e il quarto nel mondo. La medaglistica ricorda questa impresa di questo coraggioso e ingegnoso milanese con una medaglia del 1784 celebrativa dell'evento opera di Guillemard e di Ranieri 51 punto
-
Se andiamo alla ricerca di posti insoliti e storici uno è sicuramente la Conca di Viarenna in Via Conca del Naviglio. E' una conca di navigazione non utilizzata costruita dalla Veneranda fabbrica del Duomo tra il 1551 e il 1558. Serviva per collegare il Naviglio Grande alla cerchia dei Navigli. Ricollocata in fondo anche l'edicola che riporta il decreto del pedaggio e dei dazi per i barconi.1 punto
-
Ok, adesso mi è chiaro. Guardavo dietro la testa e non trovando nulla credevo fosse senza le iniziali. Sotto pensavo facesse parte della legenda.....grazie mille.1 punto
-
Ciao Ragazzi , a me interessano solo le monete napoletane, comprerò il catalogo del Prof. Pietro Magliocca. spero che lo pubblichi al più presto.1 punto
-
Sono già curioso di vedere le foto che saranno scattate all'evento! Emozionato, anche se non sarò presente, per il fatto del mio Articolo!1 punto
-
Ciao Simone. Ti assicuro che ci sono C.T.U. (ma anche Interpreti e Traduttori) che lavorano per Tribunali e Procure e che non hanno la partita IVA. L'iscrizione alla C.C.I.A.A. è considerata (generalmente) un presupposto per l'iscrizione al Registro dei Periti ed Esperti dei Tribunali e per questo tipo di specialità (così come per altre...vedi ad esempio la grafologia) non è richiesta necessariamente la titolarità di partita iva. Si parte dalla considerazione che se un soggetto ha ottenuto, attraverso un esame, l'iscrizione alla C.C.I.A.A., egli abbia i requisiti professionali per coadiuvare il Giudice o il Procuratore nelle valutazioni di tipo tecnico. In linea di principio il ragionamento è giusto, se il Sistema rispetta le regole che esso stesso si è imposto. In realtà, in alcuni luoghi, vuoi per la mancanza di esaminatori locali, vuoi per altre considerazioni, l'iscrizione per talune specialità si ottiene senza sostenere alcun esame, ma solo sulla base dei titoli esibiti. Il discorso dei titoli e delle referenze può essere molto discutibile, dal momento che non è tanto e solo un problema di valutare la qualità dei primi e delle seconde, ma piuttosto quello che chi è proposto ad operare queste valutazione con capisce nulla di numismatica e quindi la valutazione dei titoli e delle referenze è rimessa a chi è totalmente digiuno della materia. Non sarà certamente il caso del nostro amico Theodor Mommsen, che soltanto per il nick che si è scelto sul Forum metterebbe in soggezione chiunque.... La questione, come si vede, si può prestare più che ad abusi (che sono comunque possibili) a favorire iscrizioni di Periti numismatici con preparazione diversissima da un luogo all'altro. Non dimentichiamoci poi che in altre sedi, invece, gli esami vengono realmente svolti e talvolta anche con una certa severità. Quindi si pone anche un problema di disparità di trattamento tra Camere di Commercio, alcune delle quali sottopongono ad esame l'aspirante Perito mentre altre si accontentano dei titoli e delle referenze. Tutto ciò, comunque, è - come al solito - molto "italico". Quindi non mi stupisce più di tanto. Saluti. M.1 punto
-
Rispondo qui al commento/richiesta messo in calendario eventi di @FRANZOSI Giuliano per la spedizione o abbonamento del Giornale. E' una pubblicazione non periodica e non a fini di lucro ( ovviamente una offerta libera è sempre benvenuta ) con consegna a mano della copia cartacea nei luoghi dove qualcuno di noi sarà presente personalmente. Sicuramente dal 10 settembre in avanti ogni domenica mattina al mercato del Cordusio a Milano, ma anche dove saremo tipo a Bergamo al Convegno dei Circoli, sicuramente a Verona, ma magari anche in qualche presentazione tipo al CCNM di Milano o altro che valuteremo e che si presenterà, sarà buona per ritirarlo. Ciò non toglie che ci possa essere qualche volonteroso ambasciatore che venga a ritirarlo in qualcuna di queste sedi e portarlo a destinazione. Come per il primo anche per il secondo ci sarà un periodo di distribuzione manuale del cartaceo poi anche questo verrà messo dopo un tempo ragionevole on line con le consuete modalità sia su Lamoneta nel nostro forum dedicato a Quelli del Cordusio o sulla nostra pagina su Academia.edu. Uno degli obiettivi di fondo tra i tanti è quello di creare e cercare il contatto diretto con l'appassionato onde formare una rete di conoscenza , proselitismo e divulgazione della numismatica, tutto questo ti permette di rendere sempre più reale un gruppo che nasce virtuale e si ritrova ad essere molto reale e presente in moltissimi ambiti della numismatica, sempre a disposizione comunque per ogni ulteriore chiarimento1 punto
-
Ciao a entrambi, non sono in ferie ma "solo" un po' in ritardo... vi chiedo scusa. Grazie innanzitutto a @Rocco68 per la pazienza con cui segue questa sezione, e per le ottime foto abbinate al suo interessantissimo quesito. Grazie all'amico @petronius arbiter per l'attenta ricerca, e per le utili risposte rinvenute. --- Nel merito, la domanda di fondo rimane purtroppo senza risposte sicure. Dal punto di vista araldico, il numero delle torri nella bordura dello stemma del Portogallo è tradizionalmente e normalmente di sette. Questo vale per lo stemma ufficiale e normale del Paese lusitano, e per gli esemplari risalenti ai secoli moderni e contemporanei. Quindi, anche per le epoche in cui lo stemma portoghese entrava a far parte della complessa arma dei Borbone di Napoli. In precedenza, non era infrequente che l'arma di Portogallo contenesse in bordura un numero di torri diverso da sette: nel Livro do Armeiro-Mor, il più celebre e bello fra i manoscritti araldici di quella nazione (risalente al 1509), sono miniate varianti dell'arma contenenti torri in quantità variabile da otto a tredici. --- É da escludere che gli incisori delle zecche dei Borbone fossero a conoscenza di questi esempi rinascimentali dello stemma portoghese. Sembra più corretto dire che in antico il numero delle torri fosse ininfluente: ciò che contava era che fossero d'oro, e che occupassero con elegante armonia lo spazio della bordura di rosso a esse destinato. In epoca borbonica, invece, pare lecito pensare che l'incisore non si curasse della "perfezione filologica" del contenuto araldico di un quarto non principale dello stemma reale. Quest'ipotesi sembra confermata dal contenuto interno dello stesso quarto portoghese, dove al posto dei cinque quinas (scudetti) posti in croce ci sono sei palline che scimmiottano il più grande quarto dei Medici sulla sinistra del medesimo stemma... ...e per tacere del quarto dei Farnese (quello che sovrasta il quarto di Portogallo), nel quale i canonici sei gigli sono stati decurtati a cinque! Perchè tutto ciò? Forse perchè si trattava di quarti "lontani" dall'ambito sociale e culturale dell'epoca di quegli artisti incisori, i quali quindi avevano scarsa nozione e ancor più scarsa attenzione verso stemmi a loro quasi (se non del tutto) sconosciuti. --- Si tratta di ipotesi, certamente... ...ma la ricchezza di varianti negli stemmi borbonici coniati su monete di quel periodo (e presenti anche in esemplari di ambito non numismatico, vedi il link reperito da @petronius arbiter) induce a considerarle qualcosa di più che semplici congetture.1 punto
-
Allora vediamo di procedere con ordine in quella che è una storia che solo in Italia - penso - possa svolgersi... Innanzitutto la foto: probabilmente siamo nell'inverno (gennaio-febbraio) del 1944, a Milano, nei pressi del quartier generale di Rodolfo Graziani. Vi sono tre giovani soldati italiani (credo Arditi dalle mostrine) che sembrano - nonostante tutto - non aver perso lo spirito goliardico e due soldati tedeschi (in verità un poco perplessi) che si prestano a posare per la foto. Ovviamente per questi ultimi, la guerra è una cosa seria e sembrano un po' impacciati e rigidi in quella che per loro è una poco comprensibile sceneggiata. Il sergente, se non ricordo male, mi è stato descritto come un elemento di collegamento tra il Comando tedesco e quello italiano in qualità d'interprete e svolgeva anxhe un'altra incombenza: si occupava di aggiornare sulla cartina i movimenti del fronte puntando delle bandierine-segnalino che, con suo sommo dispiacere, vedeva di giorno in giorno, convergere verso la Germania. Ma torniamo ai tre soldati italiani: non so dirvi esattamente quale sia il soldato di cui ho sentito la storia nè ricordo il nome. Non so nemmeno se si trattasse di un lontano parente, di un amico di famiglia o di un semplice vicino di casa. Mi è rimasta impressa solo la sua vicenda umana. Era nato credo nel 1924, la sua giovinezza si svolse tutta nell'esaltazione della Patria: l'epopea del Risorgimento, il fresco ricordo di Vittorio Veneto, il Duce che aveva sempre ragione, la vittoriosa guerra d'Etiopia, l'Impero, le quattro Divisioni al Brennero a monito contro Hitler... insomma, mettetevi nei panni d'un ragazzo che crede di appartenere ad una grande e vincente nazione intriso fino al midollo di retorica fascista con cui era "nutrito" a scuola e capirete perchè, allo scoppio della guerra nel 1940, sedicenne, non ci pensa due volte e "corre alle armi" ad arruolarsi come volontario. Suo padre, che la guerra l'aveva fatta per quattro anni sul serio, compresa tutta la ritirata di Caporetto, non appena saputa la notizia, trascina il figlio all'ufficio reclutamento per tentare di annullare la domanda e deve subire la ramanzina dell'addetto al reclutamento. "Lei dovrebbe essere fiero di suo figlio... lo spirito guerriero... La Patria ha bisogno di tutti, va servita nel momento del massimo bisogno... si vergogni..." Il destino volle che, richiamato dalla discussione, intervenisse l'ufficiale in comando che, riconusciuto nel padre l'eroico sottufficiale di cui aveva potuto apprezzare l'abnegazione, richiamò il reclutatore al rispetto per l'uomo e gli ordinò di stracciare la domanda d'arruolamento. Passarono i mesi, il nostro ebbe modo di "assaggiare" la tanto esaltata guerra coi primi bombardamenti su Milano, coi razionamenti, con le notizie dal fronte che - sebbene edulcorate - lasciavano trasparire tutte le difficoltà di un esercito impreparato per un conflitto mondiale. Al compimento del diciottesimo anno d'età (1942) venne chiamato alle armi, ma già tutto l'ardore guerriero era scemato. Ebbe appena il tempo di terminare l'addestramento e tornare a Milano in attesa della nuova destinazione, quando giunse l'8 settembre 1943. A questo punto non ebbe esitazioni: buttò la divisa (e con lui altri migliaia di soldati) e tornò a casa convinto che la guerra fosse finita. Naturalmente non era così: il destino aveva in serbo per lui altri progetti. (fine prima parte)1 punto
-
Bel post, davvero, peccato ti sia perso nel finale. Può anche darsi che alcune (non certo tutte) "associazioni umanitarie" perseguano altri scopi, ma non mi pare sia il caso di fare di tutta l'erba un fascio, no? petronius1 punto
-
porto un parere e una vicenda personale a supporto. personalmente sono un amante del cartaceo, ma i tempi progrediscono, e il cartaceo non sempre riesce a rispondere alle esigenze del mondo in evoluzione, così accade che ottimi articoli, con ottimi contenuti, siano pubblicati solo online... il mio esempio è emblematico quando decisi di lavorare sul "Sirmium Group", pensai... " se ne faccio un libro, in Italia lo compreranno in 15" ... ed è così, spesso le "nicchie" finiscono per massacrare il povero editore che investe per un mercato minimo... decisi allora di fare un lavoro interamente libero su academia. da gennaio 2016 ad oggi ho avuto circa 400 contatti su quel "paper", i quali mi hanno portato a collaborare con il museo nazionale di Budapest e con l'università di Varsavia. è un testo stampato NO è un testo scritto con cura .... probabilmente si, visti i risultati... merita una citazione... a mio avviso SI ho fatto l'esempio su di me perché mi era molto facile, ancora oggi ne sono stupito, MA questo vale per un'infinità di testi, quindi per come la vedo io, SI vanno inseriti, e SI nel medesimo elenco ma con una specifica dicitura.... è un punto di vista, ma accetto le Vs critiche1 punto
-
[email protected] anche gli articoli presenti solo on line..con la creazione di una sitografia..1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?