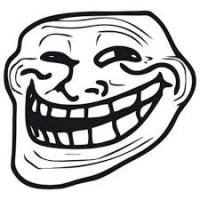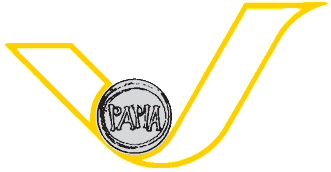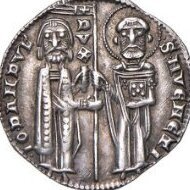Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 01/21/18 in tutte le aree
-
Cari amici, vi racconto questa “storiella” per farvi sbavare un po’ accadde qualche anno fa che io venni contattato dall’Hungarian National Museum di Budapest per aiutarli a catalogare le monete del V-VIII secolo dei regni romano barbarici, per i quali dovrebbe nei prossimi anni uscire il catalogo. Dopo numerosi scambi di foto etc, è stata d’obbligo una visita al museo per “passare sotto mano” tutte le monete romane e bizantine dal V secolo in poi per valutare se ve ne fossero in mezzo delle imitative (e infatti c’erano…), e per vedere se vi fossero dei falsi tra quelle dei regni romano barbarici. Sono stato quindi invitato a Budapest la settimana scorsa Quello che ho visto è incredibile…. Provo un po’ a riassumere…. – il museo ha circa 40.000 monete antiche non esposte, di tutte le epoche, quindi negli “intermezzi” del “lavoro” sono stato deliziato con varie chicche “fuori dal mio periodo”….. ho quindi visto e avuto in mano: 4 decadracme di siracusa di cui una qualitativamente eccelsa Alcuni lingotti d’oro romani del V secolo con contromarche imperiali (con scritte e con i volti dei 3 augusti), uno dei quali da 480 grammi Un diploma legionario in bronzo del tempo di Vespasiano Una cinquantina di contorniati romani di varie dimensioni con e senza monogrammi, uno dei quali con inserti in argento sulla corazza imperiale … anche un paio di quelli con Alessandro Magno fattin nel V secolo Un centinaio di medaglioni romano bizantini…. multipli in argento (tra cui il noto multiplo di Anastasio pubblicato da Hahn), multipli in oro (tra cui un 4 aurei di Massenzio da urlo, un multiplo di Costantino con “sguardo al cielo”, e una ventina di altri multipli d’oro di solidi e aurei) e medaglioni in bronzo (tra cui numerosi medaglioni anche bimetallici di cui uno inedito) Conii, basi di incudine, tenaglie, forbici e lastre di argento in parte già tagliate di un falsario di moneta locale del X secolo Un sesterzio di Nerone trasformato in antichità in una specie di scatolina, pur mantenendo la dimensione originale del sesterzio Un sesterzio di Traiano probabilmente fatto a inizio ‘900 con qualcosa che non si capisce,…sembra gomma vulcanizzata… ma da vedere sembra in ardesia…ma pesa 3 grammi …stranissimo…. Centinaia di solidi romani in qualità eccellenti tra cui moltissimi solidi da 20, 22 e 23 silique….nonché molti consolari anche di romani come Leone I…. poi Nepote, Romolo Augusto… tutto quello che potete sognare…. Solidi bizantini di zecca italica, tra cui il solido di Foca che Hahn assegnò alla zecca di Roma, un Costantino V zecca di Roma e un Teofilo zecca di Napoli!!!!! Veniamo alle “mie”….cos’hanno di barbarico? Di tutto….. vandali, longobardi, beneventane, avari, visigoti…….etc etc etc……ma soprattutto … udite udite…. Una moneta inedita longobarda… ovviamente censita “malamente” e quindi rimasta lì ignorata completamente….fino a che tra le foto io non ho detto…”scusate…ma sapete cosa avete lì? …. Un tremisse….di…….. Curiosi? Beh, vi lascio la curiosità perché questo inedito a mio avviso clamoroso è finito in un articolo che uscirà a brevissimo…a giorni…… l’attesa è la parte più bella del regalo no Cosa si trova nel “retro” di un grande museo allora? Il parco giochi di un numismatico…. Quello che ho potuto avere in mano mi emoziona ancora adesso a parlarne…..23 punti
-
Buona domenica a tutti, condivido con voi l'ultimo arrivato in collezione. Ho sempre avuto un debole per i Grani Cavalli di Ferdinando IV e quando ho visto in vendita questo 1790 non ho esitato un attimo a prenderlo! @Rex Neap, @Asclepia, @Martin_Zilli, @borbonik, @lamanna921, @Ledzeppelin81, @Silver70, @gcs, @Caio Ottavio,@ilnumismaticoe tutti del forum appassionati di questi nominali meravigliosi . (Chiedo scusa per non aver scritto tutti....ma per mancanza di tempo). Sarebbero graditi i vostri pareri su questo conio che personalmente considero molto raro.8 punti
-
Salve a tutti. Quest’oggi vorrei concentrarmi sulla presentazione di un paio di piccole monetine in mistura emesse in Italia meridionale durante i primi anni di regno di Carlo I d’Angiò come Re di Sicilia (1266-1282). Mi riferisco a: 1. D/ + K DEI GRACIA. Giglio fiorentino tra due globetti. R/ + REX SICILIE. Croce patente con quadrato nel mezzo, accantonata da quattro stelle a sei punte. Denaro in mistura databile al primo periodo (1266-1278) di zecca incerta tra Brindisi o Messina. Cfr. R. SPAHR, Le monete siciliane dai Bizantini a Carlo I d’Angiò (582-1282), vol. I, Zurich-Graz 1976, p. 230, n° 25 e MEC 14, p. 674, n° 632. Fig. 1 (ex LAC, auction D, n° 310). 2. D/ + K DEI GRA REX SICIL. Croce patente accantonata da quattro gigli. R/ + DVCAT APVL PRIC CAPVE. Giglio fiorentino con due globetti sottostanti. Denaro in mistura databile al primo periodo (1266-1278) della zecca di Messina. Cfr. SPAHR, Op. cit., manca e MEC 14, p. 676, n° 656-658/658A. Di questo stesso tipo esistono anche dei multipli di denaro (per questa dicitura e per il suo utilizzo in questo caso specifico si rimanda a MEC 14, p. 201) classificati in MEC 14, p. 676, n° 654-655. Fig. 2 (ex Ranieri 4, n° 667). Cosa hanno di così particolare queste due tipologie monetarie angioine del Sud Italia all’apparenza piuttosto “banali” e neanche troppo rare? Già lo Spahr, in una nota che accompagnava la descrizione della moneta qui riportata al n° 1, asseriva precisamente: «Questo denaro fu coniato nel 1267 quando Carlo ottenne la signoria di Firenze». Non a caso, infatti, l’interesse di un attento osservatore si focalizzerà necessariamente sul particolare araldico rappresentato dal giglio, elemento iconografico che unisce entrambe le tipologie oggetto di questa discussione. Il giglio, da sempre emblema della monarchia francese e della dinastia angioina (fig. 3), non deve essere confuso, in questo caso, con quello fiorentino (fig. 4), da cui si differenzia in primis per la mancanza dei pistilli laterali. Fig. 3: Stemma angioino. Fig. 4: Stemma fiorentino. Se ne deduce, quindi, che su questi denari di Carlo I d’Angiò sia effigiato un giglio fiorentino e non il consueto fiordaliso francese. Ma perché? Cosa centra l’Angioino con Firenze e come spiegare questo inconsueto richiamo su delle monete che forse non circolarono mai in Toscana? Cercherò di contestualizzare, di seguito, tali emissioni (per una prima analisi della monetazione in mistura di Carlo I nel Mezzogiorno italiano si rimanda a MEC 14, pp. 201 ss. con relativa bibliografia precedente). Tutto ebbe inizio verso la metà del XIII secolo, quando il Papato, nella persona di Innocenzo IV (1243-1254) si sentiva gravemente minacciato dall’ormai annosa questione dell’unificazione de facto delle corone del Regno di Sicilia e dell’Impero germanico sotto la dinastia sveva. Corrado I (1250-1254), nel 1252, aveva chiesto al Pontefice di poter unire ufficialmente i due poteri sotto un unico scettro, concentrando il dominio di una vasta compagine territoriale nelle sue mani. Lo Stato della Chiesa ne sarebbe risultato pericolosamente accerchiato ed Innocenzo IV non poteva permettersi di correre tale rischio. Pensò bene, quindi, di avviare delle trattative per scegliere un nuovo sovrano che prendesse il posto di Corrado I. Già a partire dal maggio del 1253 il Papa si mise in contatto con Carlo d’Angiò, inserendolo in una più larga cerchia di candidati. Il giovane rampollo francese non costituiva per Innocenzo la prima scelta, ma rimaneva di fatto il più ambizioso e predisposto per affrontare una simile impresa. Le trattative, però, fallirono e la morte sia del Papa che del Re svevo lasciarono il ruolo di Carlo ancora marginale per la politica italiana, anche perché in quegli stessi anni la Provenza stava attirando quasi tutte le sue attenzioni con rivolte continue difficilmente controllabili. Tuttavia i successori di Innocenzo IV non desistettero dal loro intento: sebbene Carlo penetrò in Italia già nel 1259, nel 1262 lo ritroveremo nuovamente in Provenza alle prese con l’ennesimo atto di ostilità verso il suo potere in quella regione. I continui tumulti provenzali riuscivano a tenere occupato l’Angioino abbastanza da stornarlo dalle sue mire italiane: i rivoltosi francesi, infatti, erano appoggiati, neanche tanto segretamente, dagli Aragonesi: l’Infante Pietro, futuro sovrano (1276-1285), terzo con questo nome, aveva infatti preso in moglie Costanza II, figlia del Re di Sicilia Manfredi di Svevia (1258-1266). Quest’ultimo era osteggiato dal Papato e presto si sarebbe trovato a fare i conti con le lance angioine. Con l’incoronazione di Urbano IV (1261-1264), originario di Troyes, iniziò un periodo felice per le ambizioni di Carlo e, nel contempo, segnò l’inizio della fine per la dominazione sveva in Italia meridionale. Le trattative, questa volta, furono così lunghe che si conclusero solo con il francese Clemente IV (1265-1268), successore di Papa Urbano. Il 6 gennaio del 1266 Carlo d’Angiò fu incoronato Re di Sicilia a Roma, nel Laterano, e già il 20 gennaio era in marcia verso Sud per combattere contro Manfredi, il quale, spinto da una rivolta dei Capuani, stava cercando di raggiungere la Puglia, le cui città si erano dimostrate molto più leali verso gli Svevi. Ma il 26 febbraio del 1266, in una località poco lontana da Benevento, le truppe francesi sbaragliarono quelle di Manfredi, il quale perse la vita sul campo di battaglia. Nonostante la netta vittoria di Carlo d’Angiò, questi non poteva ancora dedicarsi tranquillamente alla riorganizzazione amministrativa del Regno: numerose sacche di resistenza erano presenti su tutto il territorio, il quale richiese una conquista più “meticolosa” del previsto. Inoltre, i fuoriusciti ancora fedeli alla causa sveva si stavano riorganizzando in altre parti d’Italia per sferrare un nuovo attacco all’Angioino. Per questo motivo, i primi anni di regno di Carlo, tra il 1266 ed il 1268, furono da lui dedicati al consolidamento della sua posizione politica prima al di fuori dei confini regnicoli. I Ghibellini, in Italia settentrionale ed in particolare in Toscana, capeggiati da Guido Novello, avevano unito le proprie forze con quelle dei sostenitori svevi con la speranza di riuscire a contrastare il partito avverso dei Guelfi, i quali, al contrario, chiamarono in loro aiuto le truppe di Carlo I. Già all’indomani della vittoria angioina a Benevento si era verificato l’allontanamento da Firenze del Novello, nel novembre del 1266, ma i loro piani non vennero messi in discussione: in risposta alla cacciata operata da Carlo di tutti i mercanti senesi e pisani dal Regno di Sicilia, i Ghibellini ed il partito filo-svevo, nel marzo del 1267, gli opposero Corrado II, comunemente noto come Corradino, che era stato già Re di Sicilia dal 1254 al 1258. Egli era l’ultimo rappresentante vivente della dinastia sveva degli Hohenstaufen ed in quel tempo si trovava in Germania (1254-1268). Il trono siciliano di Carlo, appena conquistato con la forza e l’appoggio papale, si trovava ora in grave pericolo: Corrado II poteva contare sull’appoggio di un esercito più numeroso e meglio rifornito del suo, i cui ranghi potevano avvantaggiarsi dell’ausilio portato loro dai dissidenti italiani. La situazione richiedeva un intervento immediato: Carlo in persona, al comando del suo esercito, si mise in marcia verso Settentrione (aprile 1267), riuscendo ad entrare in Firenze il 17 aprile 1267. Nella città, egli ricoprì la carica di podestà almeno fino al 1273, favorendo senza troppi scrupoli la fazione guelfa. Nonostante l’azione di Carlo coinvolse, quasi sempre con esito positivo, gran parte della Toscana, Siena e Pisa continuavano a resistergli, anzi, costituirono delle ottime roccaforti per la conduzione della lotta filo-sveva. Ben presto, anche Clemente IV si affrettò a legittimare la posizione dell’Angioino a Firenze, nominandolo «pacificatore», senza opporsi alla sua autoproclamazione a vicario imperiale per la Toscana. Probabilmente, come credette lo Spahr, i denari ed i presunti multipli sopra elencati ricorderebbero proprio le felici gesta fiorentine di Carlo I da lui compiute nel corso del 1267. Corradino, nell’agosto di quello stesso anno, lasciò Augusta con l’intenzione di scendere in Italia ed affrontare Carlo d’Angiò sul campo. Contemporaneamente, gli Arabi di Tunisi, amici ed alleati degli Svevi grazie all’antica politica conciliatrice condotta a suo tempo da Federico II, organizzarono una spedizione navale contro la Sicilia, mettendo l’isola a ferro e fuoco. Gli Angioini si trovarono, così, accerchiati su due fronti. Mentre i Tunisini imperversavano in Sicilia, la colonia saracena di Lucera, da sempre fedele a Federico II e ai suoi discendenti, si sollevò (febbraio 1268), estendendo la rivolta a tutta la Puglia. Carlo, che aveva provato a bloccare la discesa di Corradino al Nord, fu costretto a lasciare Firenze per sedare i disordini nati all’interno del suo Regno: nonostante l’arrivo del Re e il conseguente assedio da lui portato senza successo a Lucera, la ribellione si propagò ulteriormente raggiungendo anche la Calabria. Ora, sia Carlo che Corrado II erano in cerca dello scontro definitivo per il possesso del Regno di Sicilia. La battaglia si registrò il 23 agosto 1268 in una località distante appena una decina di chilometri da Tagliacozzo: nonostante l’iniziale successo di Corradino, l’esperienza militare di Carlo I fu ripagata con la vittoria definitiva. Il destino riservato allo Svevo è tristemente noto: solo dopo la sua morte Carlo poté riorganizzare in tutta tranquillità i suoi nuovi possedimenti italiani. Ma l’Angioino conservò ancora per qualche tempo i suoi diritti sulla Toscana ed in particolare su Firenze, di cui era ancora podestà e vicario imperiale. Mentre il primo titolo fu perduto, come abbiamo visto, nel 1273, il secondo gli fu rinnovato da Innocenzo V nel 1276. Fu, infine, con l’intervento di Papa Niccolò III (1277-1280) che il vicariato non gli fu più concesso a partire dal 1278. A cominciare da quell’anno, l’influenza esercitata fino ad allora da Carlo I sulla Toscana e sugli altri centri dell’Italia settentrionale iniziò gradualmente a declinare, fino a sfuggirgli del tutto in favore di una politica filo-papale. La floridezza registrata nella Firenze della seconda metà del XIII secolo fu opera, soprattutto, dell’intervento carolino, che incentivò lo sviluppo di contatti diplomatici ed economici tra la città, il Regno siciliano, la Roma pontificia e la Francia, suo Paese d’origine.4 punti
-
Ciao Rocco e grazie del parere anch'io credo che per i 3 grana sian quelle le combinazioni, però nei dodici carlini da quanto ho potuto vedere l'abbinamento è anche tra fiore e I8I0, oltre a I8IO e stella ecco qui due esempi:3 punti
-
3 punti
-
Il ritratto non è verosimile e rispondente ai canoni tipici, così come il busto, manca la P di TR P a fine legenda al diritto, le lettere non sono romane, la perlinatura non è congrua, troppo spessa, il peso è basso, e SENZA SCAMPO la provenienza da un NOTO CONIO del Cavino ( era presente a Parigi, da cui è stata coniata un pezzo al British, vedi foto 2 e 3, dove sono presenti peraltro numerosi esemplari) Ti allego anche una lamina coniata del rovescio dal British... (foto 1) A ben vedere la patina non è naturale e la cuprite ricopre come una crosta ma non permea il metallo, come puoi notare sui rilievi della guancia... Anche l'esemplare della discussione è palesemente falso e se te lo dice Vitellio puoi fidarti... P.S. @PLOTINA non credo sia una coniazione coeva a Cavino, penso a un fuso posteriore, direi sette/ottocentesco , di queste patine ne ho viste parecchie... P.P.S. Ho aggiunto una foto dal British del pezzo coniato di cui sopra, ovviamente classificato Cavino3 punti
-
Caro Plotina, purtroppo si tratta di un noto FALSO, in questo caso vecchiotto, data la patina ... Il conio è tra quelli attribuiti a Giovanni da Cavino detto il Padovanino... confronta Klawans pag. 60 n.4 Ne sono stati prodotti moltissimi esemplari, spesso in fusione e in fusione di fusione... Martini nella sua monografia dedicata a quanto esistente a Milano nelle Civiche raccolte ne fotografa ben 14... Te ne allego alcuni esemplari simili, eseguiti in varie tecniche. Un cordiale saluto, enrico3 punti
-
Per gli appassionati come me di cose passate metto le foto di questa bilancia americana per pesare monete d'argento,foto tratte dalla trasmissione Affari di famiglia. Se ho sbagliato sezione chiedo scusa e di spostare il post nella sezione giusta,grazie.2 punti
-
Qualche ulteriore info per chi verrà : Sabato 27 gennaio, inizio ore 10,00 all'Hotel De la Ville, Via Hoepli 6, ingresso libero a tutti Conferenze in sala Duomo al piano primo per 80 posti a sedere Parcheggi silos in zona, il più vicino in Corso Matteotti Vicinissimo a Mm1 fermata San Babila o fermata Duomo Possibilita' per chi non potrà esserci di ascoltare la giornata sul nostro canale YouTube quellidelcordusio iscrivendosi prima in diretta o successivamente Possibilita' per i soli soci di ritiro immediato in loco dello Speciale a colori sulla Zecca di Milano in tiratura limitata e numerata di sole 111 copie Possibilita' per i nuovi soci di ritirare anche il secondo Gazzettino fino ad esaurimento copie Possibilita' di iscriversi in loco all'Associazione Culturale Quelli del Cordusio quote 20 Euro adulti, 10 Euro fino ai 29 anni compresi Bar Visconti al piano terra per soste Possibilita' finite le conferenze di uscita conviviale per uno spuntino per chi vorrà'.2 punti
-
@Poemenius Tra qualche mese andrò dietro le quinte del British Museum, nel settore numismatico... Non vedo l’ora! Qui in Inghilterra ogni studente deve fare una “work experience” per una settimana. Mi sono scelto un posto niente male.2 punti
-
2 punti
-
cercando indietro nelle mie discussioni son riuscito a trovare le foto di quello che avevo in collezione...prima di cambiare periodo. Metto le foto.2 punti
-
Questa volta, anziché proporvi una nuova moneta proveniente da qualche ripostiglio registrato, come ormai son solito fare, volevo portarvi un po' "dietro alle quinte" e farvi vedere come, questa attività (il collezionare monete da hoard) non sia cosa così semplice. Perché una moneta sia di provenienza certa bisogna comunque andare un po' a fondo e, per tutte le monete che finora ho acquistato, a monte (e talvolta anche a valle!) ho sempre fatto un certo lavoro d'indagine se non addirittura di intelligence. Le casistiche possibili sono molte, si va dal caso più semplice con l'asta di vendita iniziale con catalogo pubblico in cui viene presentato il ripostiglio, fino alla moneta che ormai è in circolazione da moltissimi anni e che ha subito un sacco di passaggi rischiando di perdere addirittura la traccia di provenienza originaria richiedendo quindi un attento lavoro di ricerca a ritroso. Accanto a questi vari gradi di difficoltà, ci sono poi i casi - come quello in cui recentemente mi sono imbattuto - in cui una moneta viene data come proveniente da hoard ma che in realtà, da hoard proprio non viene... perché? Sostanzialmente perché o il venditore vuole lucrare su questa caratteristica (che accresce il valore della moneta) o perché a sua volta l'ha presa come tale e quindi in buona fede la rivende così. Il caso concreto riguarda questa monetina: Claudio II (moneta di consacrazione), antoniniano; 18 mm - 1,60 gr - AE; Zecca: officina locale? D\ "DIVO C[...]IO", busto radiato e drappeggiato a destra. R\ "[...]ECRATIO", aquila stante frontalmente con testa girata a destra. La moneta viene descritta come proveniente dal ripostiglio di Morgat-en-Crozon (Finistère) il che ovviamente ha suscitato subito il mio interesse. Contattato privatamente il venditore mi riferisce di averla in collezione da più di 20 anni, di averla sempre classificata con questa provenienza ma di non disporre di particolare documentazioni né memorie circa la precedente provenienza, ma di essere piuttosto sicuro dell'attribuzione a questo ripostiglio in quanto non è cosa comune - dice lui - trovare un antoniniano di consacrazione con l'aquila vista frontalmente e che consultando un po' di bibliografia troviamo proprio un esempio di aquila frontale proveniente da questo ripostiglio. Orbene, pur tendenzialmente fidandomi della buona fede delle persone e trattandosi di un acquisto pulito e regolare in quanto per l'eventuale transazione avrei ricevuto documentazione regolare, restava comunque aperta la questione della provenienza da ripostiglio... e allora via, partiamo con le indagini! Cosa so di questo hoard? Nulla, se non che si tratta di un ripostiglio spesso citato in vari lavori e quindi di una certa importanza. Disponibile in rete non si trova nulla o quasi. Un buon punto di partenza però lo offrono il catalogo online della Biblioteca Nazionale Francese e il sito www.ric.mom.fr Il RIC online (www.ric.mom.fr) innanzitutto mi dice che: a) non esistono antoniniani ufficiali attribuiti alle zecche operative con Claudio II / Quintillo che presentino per la serie di consacrazione con Aquila un busto drappeggiato... primo elemento non proprio confortante. b) tra le opere di riferimento nel ric online trovo il titolo del saggio di studio di questo specifico ripostiglio "J.-Y. Éveillard, 'La trouvaille d'antoniniani de Morgat-en-Crozon (Finistère)', TM II (1980), 31-58" che dev'essere sicuramente una rielaborazione approfondita dello studio preliminare che avevo beccato in rete - sempre a livello di solo titolo: " Un Trésor monétaire du III siècle à Morgat en Crozon [Bulletiin de la Société archéologique du Finistère", 104, 1976] J.-Y. Eveillard et A.-H. Dizerbo". c) infine, sempre dal RIC online scopro che esiste un esemplare, il numero 780 del ripostiglio di Morgat-en-Crozon, con "Eagle stg. right, head turned left" e tre esemplari (781-783) con "Eagle stg. left, head turned right" Il catalogo della Biblioteca Nazionale di Francia invece mi riporta un po' di bibliografia di riferimento: a) "J.-Y. Éveillard, 'La trouvaille d'antoniniani de Morgat-en-Crozon (Finistère)', TM II (1980), 31-58" b) " Un Trésor monétaire du III siècle à Morgat en Crozon [Bulletiin de la Société archéologique du Finistère", 104, 1976] J.-Y. Eveillard et A.-H. Dizerbo" c) e un catalogo di vendita "Trésor du Rest-Menen en Plestin-les-grèves : 100 haches en bronze. Trésor de Sarcelles... Trésor de Morgat en Crozon... 2e partie du trésor de St-Colombier en Sarzeau...: [Vente à Marlaix, Galerie des ventes, le 5 mars 1978. commissaire-priseur Boscher] Di positivo ci sono alcuni aspetti interessanti: il ripostiglio conteneva alcuni - pochi - esemplari di antoniniani della serie DIVO CLAVDIO / aquila e che le monete (quali? quante?) sono poi state vendute in un'asta pubblica poco tempo dopo la loro scoperta e catalogazione, quindi è plausibile trovare in circolazione monete provenienti da questo ripostiglio. Rimane da capire come legare la moneta (busto non consono) con le monete catalogate... stiamo parlando degli anni '70, primi '80 quindi le attenzioni per queste monete erano ancora limitate sebbene si stesse iniziando un lavoro di catalogazione seria e di studi approfonditi sulle imitazioni locali proprio in quegli anni... può starci che il pezzo sia stato mal classificato o magari inserito in eventuali imitazioni locali e quindi non meglio precisato nella catalogazione... certo avere i libri di riferimento potrebbe aiutare! E qui arrivano in soccorso i forum di numismatica esteri, in particolar modo dalla francia dove, parlando con un po' di "colleghi collezionisti" riesco a recuperare due paginette interessanti tratti dal lavoro più recente: a) la composizione del ripostiglio b) il catalogo delle monete della serie di consacrazione Certo, non ci sono immagini... per sperare di trovar qualcosa bisognerebbe procurarsi questo: ma è alquanto introvabile e comunque, dalle informazioni che ho ricevuto dovrebbero essere riportate le immagini delle monete più rare e di maggior importanza. E quindi? A quali conclusioni si possono arrivare? Mi sono predisposto questa serie di punti fissi: 1) secondo il RIC online, la moneta in questione è quella che viene classificata come: "Eagle stg. left, head turned right", visto che non fa menzione di "eagle stg. front"... ma cozza con la descrizione del ripostiglio che invece farebbe cadere il pezzo nel numero 780, presente in un solo esemplare... e in più i concetti di left/right spesso sono equivocati: destra di chi guarda il tondello o destra di chi è raffigurato nel tondello?!? 2) non sono repertoriate imitative della serie DIVO CLAVDIO con aquila nel ripostiglio, quindi la presenza del busto anomalo non trova una possibile spiegazione in un'ottica di produzione locale 3) volendo attribuire per certo la moneta al ripostiglio, in assenza dei dati fisici precisi per i singoli pezzi (nel report viene riportato solamente il peso medio, ma non è in nessun modo indicativo), dobbiamo considerare unicamente la descrizione... mettendo da parte quella relativa al busto dell'imperatore e quella relativa alla posizione dell'aquila... rimane solamente la chiave di lettura della legenda: - il pezzo in esame ha rovescio con legenda leggibile "[...]ECRATIO", al più, essendo generosi, "[...[...]SECRATIO"; i due tipi (per complessivi 4 esemplari) descritti nel report del ripostiglio invece hanno legenda: "CONSECRA[...]" e "CONSECRATIO" quindi non ci sarebbe alcuna corrispondenza tra il nostro pezzo e quelli descritti nel ripostiglio. In sintesi quindi sia tipo di busto che legenda del rovescio attualmente leggibile sono in apparente contrasto con quanto descritto come appartenente al ripostiglio, certo, le immagini sarebbero l'elemento determinante, ma è alquanto probabile che di immagini non ve ne sia traccia nemmeno nel catalogo di vendita per cui, in assenza di una ricevuta d'acquisto che leghi la moneta alla vendita pubblica del 1978 si può dire con ragionevole sicurezza che la moneta in questione non proviene dal ripostiglio analizzato. Ad aver tratto in inganno il venditore attuale, di cui non metto assolutamente in dubbio la buona fede, potrebbe essere stata molto probabilmente una precedente catalogazione a livello di riferimento bibliografico: molto spesso gli antoniniani del III secolo, specialmente i gallici e certi pezzi di Claudio II, Gallieno e altri imperatori più o meno contemporanei, vengono classificati anche con i cataloghi dei principali ripostigli del periodo e Morgat-en-Crozon è proprio uno di questi. Il fatto di aver davanti un antoniniano di consacrazione con aquila rappresentata frontalmente deve aver spinto il classificatore iniziale a usare il riferimento di questo ripostiglio francese per la catalogazione del pezzo dando così origine all'equivoco. Perché ho scritto questo lungo post? Perché a volte credo si bello vedere anche cosa sta dietro alla ricerca di un singolo pezzo e, nel mio piccolo, per illustrare un metodo (non IL metodo!) di lavoro per offrire uno spunto anche a chi, per la prima volta, vuole provare a cimentarsi con un approccio un po' differente al semplice (e dignitosissimo!) collezionismo di sola sensazione (ovvero = prendo la moneta semplicemente perché mi piace). Sperando di non avervi annoiati, vi saluto e vado a caccia di nuovi pezzi!1 punto
-
1 punto
-
Buonasera, Era il 10 dicembre 2012 e Lanz metteva in vendita a Monaco la collezione di un importante diplomatico austriaco del secolo scorso, Robert Friedinger-Pranter (1894-7/12/1967) che con un lascito aveva donato la propria collezione alla Caritas 45 anni prima. Molte monete, e con molta storia, ma Lanz a quanto pare non pubblicò a catalogo i pedigree noti (ammesso li conoscesse o li avesse cercati naturalmente..). Al lotto 23 dell'asta Lanz 155 il nostro brutto anatroccolo aveva assunto le sembianze di uno statere o nomos o didramma (è stato definito in tutti e tre i modi) coniato a Thurii nella seconda metà del IV secolo a.C. ; i difetti purtroppo erano parecchi, la decenteatura del rovescio e l'usura generale dei conii ben visibile avevano decretato che nonostante l'offerta partisse da 240€ contro una stima di 400, restasse tristemente invenduto. https://www.sixbid.com/browse.html?auction=553&category=12426&lot=573209 Ma l'esemplare percorse la strada che lo portò a rivelare la sua vera "anima storica" quando cinque anni dopo Classical Numismatic Group raccontò sotto forma di pedigree quelle vicende del suo passato. Il risultato fu che al lotto 25 dell'asta online 409, da una base di 180$/150€ contro la stima di 300$/250€ (che corrispondevano alla base da cui partiva da Lanz) il brutto anatroccolo volava fino a 1100$/920€, un bel più 500% sulla partenza, forse abbastanza per diventare un cigno numismatico. https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=2272&lot=25 In sostanza questo è quanto venne alla luce: la moneta probabilmente fu acquistata da Friedinger-Pranter in un'asta di Ludwig Grabow tenutasi a Rostock il 27 luglio 1939, lotto 76. Mancavano 37 giorni allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Questo nomos proveniva inoltre da una importante vendita di Felix Schlessinger del 4 febbraio 1935, lotto 138, tenutasi in una Berlino che vedeva il ritorno della leva militare obbligatoria, l'avvento della Wehrmacht e della Luftwaffe. E l'ironia della Storia era quantomai singolare in quelle circostanze, poiché il conferente era nientemeno che l'URSS di Stalin, che aveva posto in vendita i doppi del museo dell'Hermitage di San Pietroburgo (le vendite furono diverse e si tennero nella prima metà degli anni '30 sostanzialmente). E qui si fermano le certezze, poiché la moneta potrebbe sia provenire dalle requisizioni operate dalle istituzioni sovietiche negli anni '20, sia essere già appartenuta alla raccolta del museo al tempo degli Zar quindi in un periodo di tempo che va dalla seconda metà del XVIII secolo alla Prima Guerra Mondiale. Che dire.. Non male per un invenduto brutto anatroccolo! Ma questa moneta potrebbe avere anche altro da tramandare. E qui chiedo un aiuto agli utenti del forum. Lanz nell'asta 155 aveva probabilmente notato che questo accoppiamento di conii non era molto comune e definiva la moneta rara, mentre Classical Numismatic Group si è astenuta dal fare menzione del possibile livello di rarità. Personalmente ho cercato di verificare tramite confronti con altre immagini la rarità di questi conii, e mentre il dritto sembra più comune il rovescio non mi è stato facile confrontarlo con altri esemplari, se non con due provenienti dal SNG Volume V Ashmolean (995-996), gli unici che ho potuto individuare con le sigle ΣΩ e ΦΙ al rovescio. Tuttavia mentre negli esemplari dell'Ashmolean sotto la linea di esergo al rovescio si vede un ippocampo (con coda da cetaceo) nell'esemplare ex museo dell'Hermitage sembrerebbe più un pesce (cernia per Lanz, tonno per Classical Numismatic Group). Potrebbe essere un difetto di coniazione invece? Ashmolean 995: Ashmolean 996: Non conosco, purtroppo, in maniera approfondita le serie di Thurii, mi piacerebbe però comprendere se oltre ad una grande Storia questo brutto anatroccolo non celasse anche una variante per nulla comune del rovescio. Sarebbe assai interessante se qualcuno potesse aggiungere altri elementi chiarificatori sia in merito alla storia della moneta che alle sue caratteristiche tecniche ed alla sua rarità. Io per il momento mi fermo, riflettendo su quanto sia fondamentale lo studio personale, fatto di montagne di dubbi da porsi e mari di risposte da darsi.1 punto
-
Provo a dirti quel che secondo me è, però aspetta altri pareri, perchè se avessi un euro in tasca non lo scommetterei su di me. Mir 534/9 con segno 68 (croce patente)1 punto
-
secondo me potrebbe essere una moneta argentina tipo questa http://worldcoingallery.com/countries/display_wd.php?dir=img7&image=7-7&desc=Argentina qui si vede meglio http://worldcoingallery.com/countries/coin_detail.php?dir=img7&image=7-7&desc=Argentina km32 1 Centavo (1882-1896)1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Ciao @Rocco68, scusa per il ritardo ma ero a spasso Complimenti per l’acquisizione, ottimo esemplare: bordi taglienti, niente incrostazioni e colore omogeneo1 punto
-
Ciao @Rocco68, ottimo acquisto, hai fatto benissimo ad accaparrarti questa moneta, soprattutto se rientra tra le tipologie che preferisci. La moneta è classificata in Gigante 2017, p. 545, n° 139 (anno 1790 con al R/ le sigle R e C). Sebbene la rarità riportata sia solo R, credo anch'io, come accade in molti altri casi per le monete napoletane, che in questa conservazione la rarità aumenti. Io direi che siamo oltre il BB, un qSPL ci starebbe bene, sempre a parer mio. A parte la schiacciatura di conio i rilievi sono molto ben definiti e la moneta è, nel complesso, leggibilissima. Inoltre, presenta dei fondi splendidi: mi piace molto il fatto che si vedano ancora bene quelle "striature" del metallo.1 punto
-
Un bel medaglione, mai visto prima. Opera dello scultore A.G. Girardet, nato a Roma nel 1855, commemora la nomina del primo Cardinale Veneziano, don Joaquim Arcoverde de Albuquerque ad opera di Papa Pio X. L'identificazione è facile, tutti gli elementi che possono interessare sono contenuti nella scritta al centro della medaglia. A te peraltro interessa conoscerne il valore commerciale, domanda alla quale non so assolutamente cosa rispondere. E' un bell'oggetto, nello stile dell'epoca, ma non so a quanti in Italia possa interessare. Non è una medaglia votiva, ma un cimelio della storia della Chiesa cattolica in Brasile. Se una medaglie del genere incontra un amatore, magari ciò che se ne può ricavare può essere anche interessante ma è la solita legge della domanda e della offerta....... Puoi provare a mostrarla a qualche commerciante in Numismatica, ma non credo che neppure per lui sia facilissimo rivenderla. Davvero non saprei, mi spiace. @Davide11541 punto
-
1 punto
-
Infatti nell'altra che hai postato (mi sono permesso di affettare una tua foto) si nota la correzione sulla R.1 punto
-
Grazie Asclepia, non è facile reperire i Grani 1790 della Regia Corte in buona conservazione.....sia perchè queste erano le monete che circolavano di piu' fra il popolo e anche per il breve periodo di coniazione. Molti presentano la lettera C corretta in R....di Regia, questo invece è un conio ( dritto e rovescio) approntato di sana pianta con le lettere ben definite.1 punto
-
Eccola Ottima conservazione, ha debolezze e schiacciature ma ha circolato poco... Confrontandola con l'altra che hai postato sempre Regia Corte 1790 qui le lettere R.C. sono più grandi e c'è un punto in alto dopo il 12. Complimenti per questo acchiappo1 punto
-
Gli amici del HNM di Budapest mi hanno regalato questi libri.... Li posto nel caso mai dovessero servire a qualcuno.... Perché in Italia sono decisamente rari Saluti da Budapest... Il cui gabinetto numismatico farebbe sbavare chiunque... Vi assicuro.... Alain1 punto
-
Pregevole indubbiamente, il 1771 e' per il Mir Milano dichiarato come R2 e classificato 425/11 punto
-
Visto che l'amico @Max68Busca, ciao Massimo, mi ha citato in questa discussione, esprimo per l'ennesima volta il mio pensiero. Iniziamo dal discorso "non circolata", secondo me una moneta si deve intendere non circolata fino a quando rimane nell'ambito della zecca; la circolazione ha inizio nel momento in cui la moneta viene utilizzata dall'utente finale. Il grado FdC nella mia scala lo riservo alle monete che praticamente non presentano alcun segno, altrimenti si passa a quello che definisco "Stato Zecca" (SZ). Come ha giustamente detto @azaad la nostra scala attuale è poco sensibile ed è per questo che io ho adottato una scala millesimale che permette di esprimere il grading in millesimi, molto più puntuale. Ma la cosa più importante è che il metodo stabilisce gli standards di esame, sia qualitativi che strumentatali. Tutto questo non elimina la soggettività, che non si può eliminare, ma viene ridotta al minimo. Certo che oramai la tecnologia può sostituire l'esame dell'occhio umano (questo nel mondo dei diamanti già viene applicato), ma purtroppo le apparecchiature destinate a questo scopo sono sempre di costo molto elevato e quindi appannaggio di aziende o società che dispongono di capitali adeguati, ma teniamo conto che anche in USA, nonostante che le società di grading hanno capitali non in differenti a disposizione, si avvalgono del giudizio di graders; quello che conta è IL SISTEMA. E qui cade l'asino! Fin'ora da noi nessuno ha ritenuto opportuno modificare l'attuale sistema, perché così fa comodo. Da alcune voci che mi sono giunte, sembra, "dico sembra", che qualcuno stia pensando di adottare la scala Sheldon, perché conosciuta in tutto il mondo, per evitare l'adozione di una nuova scala (tipo la mia) perché questo creerebbe ulteriore confusione. Ma adottare la scala USA non è una cosa che si fa dalla sera alla mattina. L'ANA, American Numismatic Association, ha creato un manuale ad hoc (370 pagine!), cosa che dovrebbe crearsi anche per le nostre monete, ma chi pensate che possa farlo? A voi la risposta!1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
bb se lo merita . per il valore 150 mi sembra un prezzo giusto visto che non si tratta di una moneta comune.1 punto
-
A rigore sarebbe sufficiente che gli operatori si mettessero d'accordo su una valutazione univoca (se fosse poi pan europea non sarebbe male). E' ormai risaputo che lo spendido di un operatore è diverso da quello di un altro operatore. Il futuro è rappresentato in larga parte dall'acquisto via internet (purtroppo è così). E' necessario quindi che chi compra abbia un'idea quando più chiara possibile di cosa sta comprando. In questo momento è necessario per chiunque voglia comprare in serenità sapersi valutare da se la moneta, cosa impensabile per i principianti e che taglia fuori molti stranieri, in secondo luogo bisogna conoscere le differenze di valutazione dei differenti operatori, cosa anche in questo caso impensabile per i principianti e incomprensibile per gli stranieri. Se si riuscisse a definire univocamente una scala di valutazione cui tutti i periti dovessero scrupolosamente attenersi sarebbe già un enorme passo avanti. Il secondo problema è che la nostra scala è poca sensibile, passando dal Spl al FdC in soli 5 passaggi (Spl, Spl+, Spl/FdC, qFdC e FdC). mentre in america si passa dall'AU 55 all'Unc 70, ossia ben 15 passaggi. La nostra scala limita la valutazione delle grosse differenze di prezzo per piccole differenze di conservazione. Purtroppo per fini commerciali (lasciando perdere la passione) le scale di grading utilizzate devono essere univoche e garantite, e devono permettere anche ad un'incompemtente di acquistare uno Spl che sia Spl in tutto il territorio italiano e che sia facilmente rivendibile (non dovendo quindi ricontrattare la conservazione). Non per forza bisogna mettere tutto negli slab o adottare la scala americana, penso e spero che noi italiani sappiamo inventarci qualcosa di diverso, garantendo però le carateristiche prima menzionate (univocità e garanzia del prodotto).1 punto
-
Cercavo proprio questo libro... Sapevo essere in tedesco Poi quando era a Budapest ho poi scoperto che avevano questa edizione in francese... Che almeno conosco a differenza del tedesco... Molto felice1 punto
-
1 punto
-
La domanda giusta è " come hai fatto a trovarne uno rotondo?" Quello in copertina sulla pagina del catalogo ho veramente fatto una faticaccia a trovarlo! Si trovano normalmente squadrati e piccoli.. venivano coniati su dei pezzi di metallo tagliati a cesoia per accelerare la preparazione, moneta di piccolo valore per l'epoca, non valeva la pena di perdere tempo per farle belle tonde...1 punto
-
Quindì per esempio io questa settimana da Heritage non avrei dovuto acquistare questo ducato a circa un terzo del suo reale valore solo perché slabbato ?? Su dai per favore non generalizziamo... Basta sapere le cose e tenerle a mente quando può risultare utile1 punto
-
In Italia stiamo rimanendo (volutamente?) all eta della pietra numismatica. Il nostro sistema di valutazione “classico” (mb-bb-spl-fdc con tutti i q, i + etc etc) lascia un’ aurea di soggettività e incertezza che sembra studiato a tavolino per gabbare il collezionista. Che piaccia o meno oggi un qspl italiano ha zero appeal all estero. Perché vuol dir tutto e nulla, esattamente come un qfdc o un bb+. Il mondo si sta evolvendo, molti su questo forum la considerano Un involuzione, e so che adesso ripartirà la tarantella anti slab, e anti grading americano, ma è la realtà dei fatti. Chi compra ha il sacrosanto diritto di veder la propria moneta valutata e catalogata in modo certosino e più dettagliato possibile. Oggi un ms 64 ha un mercato differente da un ms63 e abissale rispetto ad un ms62-61 io nn ci vedo nulla di male in questo. Preferisco tutta la vita questo tipo di “accanimento certosino” al pressappochismo del qfdc/fdc o del qfdc o spl+/qfdc scritto al volo su un cartoncino frutto dei “5 minuti” (in buona o in cattiva fede) di un singolo operatore (che poi, guarda caso, oltre a valutare la moneta, ... la vende anche..) cip cip cip (fanno i merli..)1 punto
-
Il secondo è il denaro con S.Ermacora barbuto, Bernardi n. 44. Anche questo pesa 1,0 g. Legenda del D: SKEHA - CORAS.1 punto
-
Anche se sono state appena tolte da un rotolino non sono fdc, in una vasca di raccolta successivamente la coniazione ci sono comunque andate a finire, ed i minuscoli segni da contatto ci saranno, e dopo una brevissima circolazione saranno ancora come dentro quel vascone. Senza segni al 100%? sarà difficile.1 punto
-
Mi unisco ai complimenti per il decennale.. ahimè io li ho fatti ad agosto..mi manca, però, l'altro requisito per far parte del circolo..saluti Eliodoro1 punto
-
anch' io li ho fatti 10 qualche giorno fà ...........sono proprio passati velocemente, anche troppo1 punto
-
Per quanto riguarda la familiarità delle persone comuni, con questa monetina, mio padre che era classe 1941 una volta mi raccontò che sua nonna o forse sua bisnonna, purtroppo non ho modo di verificare, svolgeva già da bambina dei lavoretti per un fornaio che la pagava ogni tanto con una manciata di monete in rame e talvolta qualche lira in argento. Una volta il padrone del forno le diede un 5 lire d'oro probabilmente non spiegandole che quella monetina valeva quanto tutte le altre che le dava solitamente e forse anche qualcosa in più... Tornata a casa la madre la vide in lacrime e chiedendole cosa fosse successo, le rispose che il proprietario del forno questa volta l'aveva presa in giro e mal pagata dandole solo questa unica moneta pure piccola. La madre allora sorridendo e rassicurandola spiego' che quella valeva quanto tutte le altre e che anzi era stata pagata anche meglio del solito. Sicuramente questa mia lontana nonna era bambina e quindi non aveva modo di vedere molte monete ma questo episodio ci fa capire che erano monete che circolavano non molto ma che cmq ogni tanto potevano comparire nella vita di persone semplici. Forse un venti lire d'oro era già più difficile da trovare nelle tasche di gente comune. Questa piccola storia che vi ho raccontato si è svolta a San Terenzo vicino la Spezia sul Golfo dei Poeti.1 punto
-
Una Domenica trascorsa all'insegna di nuovi amici che hanno assaporato il clima che si respira in quel del Cordusio, molti venuti da fuori, come i cari amici Novaresi, altri amici che non vedevano da tempo e si sono aggiunti al folto gruppo che caratterizzavano le vie di una Domenica molto fredda, ma sempre entusiasmante per contenuti e spirito di gruppo. Abbiamo potuto raccogliere anche diversi consensi per l'Aperitivo Numismatico che si terrà al bar Spadari a due passi dal Cordusio, praticamente accanto, Mercoledì alle ore 19.00 in poi, un primo momento aggregativo beneaugurante per un ricco calendario che ci vedrà protagonisti di diversi appuntamenti aperti a tutti i soci e non solo. Sono momenti itineranti che ci vedranno presenti in diverse realtà Milanesi, e dove potremo proporci insieme per iniziative che ci rispecchino di più. e per finalmente provare a fare gruppo in modo spensierato parlando non solo di numismatica... P.S. la nave continua la sua rotta, un vascello ricco di buoni propositi con a bordo la gioia di esserci... Eros1 punto
-
Sarà per deformazione professionale, ma questa associazione mi ricorda molto il movimento Impressionista di metà ottocento, un movimento artistico che diede una nuova visione al concetto pittorico e non solo. Sono gli anni dove un certo fervore porta un gruppo di amici a perseguire un'idea diversa ai canoni sino allora legati alle ultime correnti Romantiche, e alle accademie che limitavano le nuove tendenze espressive, perchè legate ancore agli schemi classicisti, dove la cultura del tempo vi era rilegata di fatto. Costretti perchè rifiutati dai canali ufficiali a dover esporre per la prima volta autofinanziandosi, nello studio del grande Nadar, fotografo anch'egli innovativo e propositivo alle nuove correnti culturali. La cornice è quella Parigina, però anche loro si ritrovavano come noi nei caffè, anche loro erano uniti da uno spirito aggregativo, anche loro in qualche modo volevano dar voce, anche loro erano rappresentati da diversi ambiti culturali, e anche loro volevano...volevano.. Un movimento che preferisce abbandonare l'atelier e riversarsi per le vie cittadine, incontrare la gente con le loro passioni, abbandonare il concetto del chiuso, avvicinarsi per ascoltare e confrontarsi, la pittura come la numismatica forse oggi più desiderosa d'essere vicina al popolo... Una Milano che sta crescendo sempre più, grandi mostre, grandi eventi, grande musica, grande voglia di mettersi in gioco, stanno nascendo molte associazioni, la cultura sta vivendo una nuova fioritura, il paese sta rispondendo, vedo altri capoluoghi propositivi, insomma un nuovo evo che mostra al mondo la vera natura del popolo di questa meravigliosa terra, unica sotto ogni punto di vista,,. E perchè no, anch'essa ammaliata da quella ninfa chiamata numismataica.. Eros1 punto
-
@gpittini hai perfettamente ragione. Per addentrarsi nelle imitative poi è fondamentale la conoscenza dei ripostigli per ricercare affinità stilistiche e ipotizzare aree di emissione. Ciao n ogni caso questo mio approccio è dovuto al fatto che, in qualche misura, devo soddisfare la mancata realizzazione del mio sogno di bambino: fare l'archeologo!1 punto
-
@Astericz, ti posto la stessa Piastra presente nella mia collezione, riferimento D'Incerti 200/s ma con variante: aquilette rovesciate1 punto
-
Hai ragione @ozacido, i gradi di rarità dovrebbero essere decisamente rivisti ed aggiornati. Probabilmente qualcuno avrà da obiettare, ma secondo il mio punto di vista, i gradi di rarità delle monete relative alla dominazione spagnola, soprattutto le zecche di Messina e Cagliari (marginalmente pure Milano e Napoli), dovrebbero essere ridefiniti non solo in base al fattore quantitativo, ma anche al grado di conservazione, quindi qualitativo. Saluti!1 punto
-
Ferdinando II di Borbone (1830-1859) - Piastra 1835Zecca: Napoli - Fronte: effigie del Re a destra con contromarca bomba in incuso - Retro: stemma coronato - In lotto con altra Piastra 1838 - (Pag. n. 194 var.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?