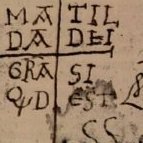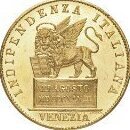Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 01/31/18 in tutte le aree
-
Buona serata Il 1° febbraio 1499 Venezia visse l'inaugurazione della torre dell'orologio che, ancora oggi, fa da "controcanto" al campanile di San Marco (chiamato dai veneziani: el paron de casa - il padrone di casa). Progettato dall'architetto Mauro Codussi e costruito tra il 1496 ed il 1499, fu inaugurato in gran pompa dal doge Agostino Barbarigo; l'orologio ha due caratteristiche peculiari, la presenza in sommità di due statue di bronzo che per il loro colore brunito sono soprannominati dai veneziani i Mori di Venezia e rappresentano due pastori, uno più giovane e l'altro più vecchio, che con una mazza tenuta tra le mani picchiano la campana, anch'essa di bronzo, situata tra i due; tanti rintocchi quante sono le ore da scandire. Il più vecchio batte le ore 2 minuti prima dell'ora esatta, così da segnalare il tempo passato, il più giovane batte le ore 2 minuti dopo l'ora esatta, così da segnalare il tempo nuovo. La seconda caratteristica è visibile solo all'Epifania e all'Ascensione; allo scoccare di ogni ora, dalla loggia posta sopra il quadrante, si aprono i due pannelli laterali dove sono rappresentate rispettivamente le ore ed i minuti e tra l'uno e l'altro transita un carosello di statue lignee che rappresenta la Natività ed i Re Magi. Allora c'era anche un'altra caratteristica. Come si può vedere ancora oggi, il leone stante sulla facciata non è posto nella mezzeria della stessa, ma leggermente spostato sulla sinistra di chi guarda; alla destra c'era la statua del doge Barbarigo, una delle sole tre statue esistenti a Venezia che rappresentavano le esatte sembianze di un doge. Quella statua venne distrutta, scalpellinata dai municipalisti giacobini alla caduta della Serenissima, insieme a tante altre statue che potessero rappresentare la Serenissima. L'unica sopravvissuta è l'immagine del doge Francesco Foscari, posta alla sommità della "Porta della Carta", che da accesso al Palazzo Ducale. (il viso è una copia perché l'originale è custodito nel Museo Correr) Dalla Torre dell'orologio e dall'arco posto alla sua base, si accede alle Mercerie, la strada che allora ed anche oggi è tra i luoghi più "commerciali" della città, con tutte le botteghe che si alternano ai suoi lati. Altra particolarità che lo riguarda è che i condannati alle sentenze capitali, che venivano effettuate su un palco costruito tra le due colonne poste in prossimità del molo, venivano rivolti verso l'orologio, così che l'ultima cosa che potessero vedere era l'ora dell'esecuzione. saluti luciano4 punti
-
Consiglio in tal caso la sua biografia, "Il re lazzarone", di Giuseppe Campolieti.3 punti
-
Dopo tanta ricerca sono riuscito a recuperare questa splendida medaglia in argento per il centenario della ormai scomparsa Banca Popolare di Sassari coniata dallo Stabilimento Jonson di Milano. Particolarità di questa medaglia è che rappresenta una patacchina di Guglielmo III di Narbona Giudice d’Arborea, simbolo anche della Banca.2 punti
-
Genova Dogi Biennali III fase, scudo stretto 1671 m° zecchiere Iohannes Stephanus Spinula2 punti
-
Nasone, il mio preferito. “Il Regno delle Due Sicilie aveva due volte più monete di tutti gli altri Stati della Penisola messi insieme" –FRANCESCO SAVERIO NITTI -2 punti
-
Ne esistono veramente poche in giro..questa di quelle che ho visto è la migliore conservata, anche se il conio @Brios non ha retto del tutto..forse già Lorenzo Maria Weber lavorava alla Zecca..infatti il busto al diritto è diverso dagli altri anni precedenti.. Non esiste 1723 di Cosimo III senza difetti di Tondello, forse dipende da Lui, dall'alievo Weber..2 punti
-
2 punti
-
Sicuramente un modo moderno di diffondere cultura, in linea con l’oggetto sociale2 punti
-
Non conosco l'analogo italiano del termine. In Russia c'è un termine: immagazzinamento in armadietto. Questo significa che la moneta dopo il conio ha dormito dolcemente, moneta in un cassetto di un tavolo, un baule, un lanciatore chiuso. Non sapeva della guerra, delle inondazioni, degli incendi, delle mani della gente. Moneta vergine. L'invidia obbliga. Devo dire cose spiacevoli. 295 anni vergine - questa è una perversione.2 punti
-
Confermo! Anzi, incoraggio tutti i "borbonici" a leggere anche le biografie del Campolieti, o per i più impavidi, direttamente il "mattone" di harold Acton sui Borboni di Napoli.2 punti
-
2 punti
-
Taglio: 20 cNazione: San MarinoAnno: 2017Tiratura: 1.328.015Conservazione: qSPLLocalità: Milano Note: NEWS!!!2 punti
-
Ciao a tutti, vi posto questo quadrante e vi chiedo gentilmente se lo riconoscete come versione B o rimane comunque versione A pur avendo l' altare stretto o trapezoidale ? Il link è della versione A. https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-AUGQDR/37 Grazie mille Roberto1 punto
-
Buona sera a tutti, vorrei segnalare nella prossima asta di InAsta n. 71 il passaggio di quello che dovrebbe essere un rarissimo obolo (R3) della zecca di MONCALVO - Guglielmo II Paleologo (1494-1518). Riferimenti: CNI 176/181; MIR 846/c (MI; 0,36 g) Questo il link: https://asta.inasta.com/it/lot/61502/zecche-italiane-moncalvo-guglielmo-ii-/1 punto
-
Ecco un Gian Gastone, data del 1723, ultimo erede di Cosimo III e ultimo Granduca Medici..dopo i Lorena..dopo la sua morte, la casata Medici verrà molto rimpianta dai Fiorentini.. Parrucca settecentesca e naso Aquilino... Al rovescio la fortezza vecchia di Livorno, dimora del Granduca Cosimo I a Livorno.. R31 punto
-
Nel frattempo mi era venuto in mente questo, magari potrebbe essere collegato. Purtroppo le foto sono orribili. Tratte dal Mec 12 Venne acquistato da Civitas Galleries nell' Aprile 2003. Magari si riesce ad ottenere immagini migliori1 punto
-
eh mi dispiace ma ora proprio non ricordo, anche perchè non avendo il mio archivio con me e non ricordandomi alla perfezione quella classe dettagliata non vorrei dire castronerie. Tuttavia guardando al catalogo online del forum noto gli esemplari VId presentano notevoli somiglianze: C e E chiuse e spina che nasce da globetto ( nel II quarto ). Gli esemplari del VI gruppo vengono datati a partire dal 1310/20 circa.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
E ci credo questo è super. citazione; Il collezionista si muove in una zona sospesa tra il visibile e l’invisibile, dal momento che la collezione è qualcosa che vive di vita propria, entità mossa da forze oscure e inconoscibili.(Marco Belpoliti)1 punto
-
Molto bella, in particolare le raffigurazioni della Beata Vergine e del Bambino1 punto
-
È mia impressione o, nella variante con cifre ravvicinate, anche la legenda sembra un po’ diversa? Guarda ad esempio la posizione della E di RE, nella prima foto la E arriva sotto al mento, nella seconda no. È una differenza da associare alle cose da notare che hai già descritto?1 punto
-
Però con altri mezzi abbiamo recuperato, le conferenze ci sono tutte ora in modo integrale sul canale YouTube di quellidelcordusio, a oggi siamo sulle quasi 300 visualizzazioni , un mezzo che ti permette indubbiamente di essere vicino a tutti comunque1 punto
-
Il dettaglio del ritratto è unico. Questa voglia è solo su questa moneta e busto Giovanni Piamontini. Sui ritratti dei dipinti non c'è questo dettaglio. Ho una supposizione. Questo busto era il prototipo di questa moneta.1 punto
-
1 punto
-
Non dal punto di vista chimico ma per un effetto fisico, precisamente la proprietà dell’elettro di riflettere la luce di una lampada più diffusamente e in modo più brillante dell’argento. Secondo le credenze dell’epoca, una tazza di elettro naturale poteva rilevare la presenza di veleno nel liquido che conteneva da certi effetti di propagazione della luce.1 punto
-
ciao @fofo bellissima moneta, praticamente il mio sogno numismatico, chissà se riuscirò mai a realizzarlo... un saluto1 punto
-
per esempio....questa è di Henry II https://www.cgb.fr/henri-ii-double-tournois-a-la-croisette-2e-type-1552-villefranche-de-rouergue-ttb,v16_0912,a.html questa di Francois I http://vso.cgb.fr/v09/gb/monnaiesgb29c6.html1 punto
-
beh, questa mi è stata... regalata! in effetti come credo tanti di noi ho iniziato le veneziane proprio con un soldo da dodici. Ora che ne ho a decine mi fanno ancora tanta tenerezza..1 punto
-
Off topic sull'uso dell'elettro. Mitridate VI Eupatore, re del Ponto, viveva nel timore di essere avvelenato e una precauzione adottata per proteggersi dall’avvelenamento da bevande era l’uso delle “poison cups” di elettro. Si credeva infatti che le tazze composte di questa lega metallica rivelassero la presenza di un veleno quando un colore iridescente increspava la superficie con un suono scoppiettante, apparentemente il risultato di una reazione chimica (Plinio 25.5 7, 33.23.81, 37.15.55-61).1 punto
-
Il rovescio va girato: E allora diventa un pò più comprensibile che si tratta di questo sesino anonimo di Mantova: https://catalogo-mantova.lamoneta.it/moneta/MN-FAN/91 punto
-
E come moneta metto questa, che non è la più bella ma è per me la più significativa, perché è la mia numero 1 delle antiche... avevo 16 anni, la comprai all'asta di Negrini e diede il via alla passione che segnò i vent'anni successivi della mia vita, cambiandola radicalmente: da lì vennero poi gli studi di storia e le lauree in numismatica antica...1 punto
-
L’unica che vorrei cedere è una delle 2 di Torino Valore, essendo doppie, le altre le metto in collezione1 punto
-
1 punto
-
Perchè è con lui che i sesterzi in bronzo riprendono per un attimo quota come stile e modulo prima del definitivo tramonto regalandoci ancora splendidi tondelli con ritratti barbuti di ottimo stile.1 punto
-
Allora devo sbrigarmi a smaltire le mie scorte come fanno i professionisti, prima del crollo delle quotazioni ! Ciao, RCAMIL.1 punto
-
Salve a tutti. Quest’oggi vorrei concentrarmi sulla presentazione di un paio di piccole monetine in mistura emesse in Italia meridionale durante i primi anni di regno di Carlo I d’Angiò come Re di Sicilia (1266-1282). Mi riferisco a: 1. D/ + K DEI GRACIA. Giglio fiorentino tra due globetti. R/ + REX SICILIE. Croce patente con quadrato nel mezzo, accantonata da quattro stelle a sei punte. Denaro in mistura databile al primo periodo (1266-1278) di zecca incerta tra Brindisi o Messina. Cfr. R. SPAHR, Le monete siciliane dai Bizantini a Carlo I d’Angiò (582-1282), vol. I, Zurich-Graz 1976, p. 230, n° 25 e MEC 14, p. 674, n° 632. Fig. 1 (ex LAC, auction D, n° 310). 2. D/ + K DEI GRA REX SICIL. Croce patente accantonata da quattro gigli. R/ + DVCAT APVL PRIC CAPVE. Giglio fiorentino con due globetti sottostanti. Denaro in mistura databile al primo periodo (1266-1278) della zecca di Messina. Cfr. SPAHR, Op. cit., manca e MEC 14, p. 676, n° 656-658/658A. Di questo stesso tipo esistono anche dei multipli di denaro (per questa dicitura e per il suo utilizzo in questo caso specifico si rimanda a MEC 14, p. 201) classificati in MEC 14, p. 676, n° 654-655. Fig. 2 (ex Ranieri 4, n° 667). Cosa hanno di così particolare queste due tipologie monetarie angioine del Sud Italia all’apparenza piuttosto “banali” e neanche troppo rare? Già lo Spahr, in una nota che accompagnava la descrizione della moneta qui riportata al n° 1, asseriva precisamente: «Questo denaro fu coniato nel 1267 quando Carlo ottenne la signoria di Firenze». Non a caso, infatti, l’interesse di un attento osservatore si focalizzerà necessariamente sul particolare araldico rappresentato dal giglio, elemento iconografico che unisce entrambe le tipologie oggetto di questa discussione. Il giglio, da sempre emblema della monarchia francese e della dinastia angioina (fig. 3), non deve essere confuso, in questo caso, con quello fiorentino (fig. 4), da cui si differenzia in primis per la mancanza dei pistilli laterali. Fig. 3: Stemma angioino. Fig. 4: Stemma fiorentino. Se ne deduce, quindi, che su questi denari di Carlo I d’Angiò sia effigiato un giglio fiorentino e non il consueto fiordaliso francese. Ma perché? Cosa centra l’Angioino con Firenze e come spiegare questo inconsueto richiamo su delle monete che forse non circolarono mai in Toscana? Cercherò di contestualizzare, di seguito, tali emissioni (per una prima analisi della monetazione in mistura di Carlo I nel Mezzogiorno italiano si rimanda a MEC 14, pp. 201 ss. con relativa bibliografia precedente). Tutto ebbe inizio verso la metà del XIII secolo, quando il Papato, nella persona di Innocenzo IV (1243-1254) si sentiva gravemente minacciato dall’ormai annosa questione dell’unificazione de facto delle corone del Regno di Sicilia e dell’Impero germanico sotto la dinastia sveva. Corrado I (1250-1254), nel 1252, aveva chiesto al Pontefice di poter unire ufficialmente i due poteri sotto un unico scettro, concentrando il dominio di una vasta compagine territoriale nelle sue mani. Lo Stato della Chiesa ne sarebbe risultato pericolosamente accerchiato ed Innocenzo IV non poteva permettersi di correre tale rischio. Pensò bene, quindi, di avviare delle trattative per scegliere un nuovo sovrano che prendesse il posto di Corrado I. Già a partire dal maggio del 1253 il Papa si mise in contatto con Carlo d’Angiò, inserendolo in una più larga cerchia di candidati. Il giovane rampollo francese non costituiva per Innocenzo la prima scelta, ma rimaneva di fatto il più ambizioso e predisposto per affrontare una simile impresa. Le trattative, però, fallirono e la morte sia del Papa che del Re svevo lasciarono il ruolo di Carlo ancora marginale per la politica italiana, anche perché in quegli stessi anni la Provenza stava attirando quasi tutte le sue attenzioni con rivolte continue difficilmente controllabili. Tuttavia i successori di Innocenzo IV non desistettero dal loro intento: sebbene Carlo penetrò in Italia già nel 1259, nel 1262 lo ritroveremo nuovamente in Provenza alle prese con l’ennesimo atto di ostilità verso il suo potere in quella regione. I continui tumulti provenzali riuscivano a tenere occupato l’Angioino abbastanza da stornarlo dalle sue mire italiane: i rivoltosi francesi, infatti, erano appoggiati, neanche tanto segretamente, dagli Aragonesi: l’Infante Pietro, futuro sovrano (1276-1285), terzo con questo nome, aveva infatti preso in moglie Costanza II, figlia del Re di Sicilia Manfredi di Svevia (1258-1266). Quest’ultimo era osteggiato dal Papato e presto si sarebbe trovato a fare i conti con le lance angioine. Con l’incoronazione di Urbano IV (1261-1264), originario di Troyes, iniziò un periodo felice per le ambizioni di Carlo e, nel contempo, segnò l’inizio della fine per la dominazione sveva in Italia meridionale. Le trattative, questa volta, furono così lunghe che si conclusero solo con il francese Clemente IV (1265-1268), successore di Papa Urbano. Il 6 gennaio del 1266 Carlo d’Angiò fu incoronato Re di Sicilia a Roma, nel Laterano, e già il 20 gennaio era in marcia verso Sud per combattere contro Manfredi, il quale, spinto da una rivolta dei Capuani, stava cercando di raggiungere la Puglia, le cui città si erano dimostrate molto più leali verso gli Svevi. Ma il 26 febbraio del 1266, in una località poco lontana da Benevento, le truppe francesi sbaragliarono quelle di Manfredi, il quale perse la vita sul campo di battaglia. Nonostante la netta vittoria di Carlo d’Angiò, questi non poteva ancora dedicarsi tranquillamente alla riorganizzazione amministrativa del Regno: numerose sacche di resistenza erano presenti su tutto il territorio, il quale richiese una conquista più “meticolosa” del previsto. Inoltre, i fuoriusciti ancora fedeli alla causa sveva si stavano riorganizzando in altre parti d’Italia per sferrare un nuovo attacco all’Angioino. Per questo motivo, i primi anni di regno di Carlo, tra il 1266 ed il 1268, furono da lui dedicati al consolidamento della sua posizione politica prima al di fuori dei confini regnicoli. I Ghibellini, in Italia settentrionale ed in particolare in Toscana, capeggiati da Guido Novello, avevano unito le proprie forze con quelle dei sostenitori svevi con la speranza di riuscire a contrastare il partito avverso dei Guelfi, i quali, al contrario, chiamarono in loro aiuto le truppe di Carlo I. Già all’indomani della vittoria angioina a Benevento si era verificato l’allontanamento da Firenze del Novello, nel novembre del 1266, ma i loro piani non vennero messi in discussione: in risposta alla cacciata operata da Carlo di tutti i mercanti senesi e pisani dal Regno di Sicilia, i Ghibellini ed il partito filo-svevo, nel marzo del 1267, gli opposero Corrado II, comunemente noto come Corradino, che era stato già Re di Sicilia dal 1254 al 1258. Egli era l’ultimo rappresentante vivente della dinastia sveva degli Hohenstaufen ed in quel tempo si trovava in Germania (1254-1268). Il trono siciliano di Carlo, appena conquistato con la forza e l’appoggio papale, si trovava ora in grave pericolo: Corrado II poteva contare sull’appoggio di un esercito più numeroso e meglio rifornito del suo, i cui ranghi potevano avvantaggiarsi dell’ausilio portato loro dai dissidenti italiani. La situazione richiedeva un intervento immediato: Carlo in persona, al comando del suo esercito, si mise in marcia verso Settentrione (aprile 1267), riuscendo ad entrare in Firenze il 17 aprile 1267. Nella città, egli ricoprì la carica di podestà almeno fino al 1273, favorendo senza troppi scrupoli la fazione guelfa. Nonostante l’azione di Carlo coinvolse, quasi sempre con esito positivo, gran parte della Toscana, Siena e Pisa continuavano a resistergli, anzi, costituirono delle ottime roccaforti per la conduzione della lotta filo-sveva. Ben presto, anche Clemente IV si affrettò a legittimare la posizione dell’Angioino a Firenze, nominandolo «pacificatore», senza opporsi alla sua autoproclamazione a vicario imperiale per la Toscana. Probabilmente, come credette lo Spahr, i denari ed i presunti multipli sopra elencati ricorderebbero proprio le felici gesta fiorentine di Carlo I da lui compiute nel corso del 1267. Corradino, nell’agosto di quello stesso anno, lasciò Augusta con l’intenzione di scendere in Italia ed affrontare Carlo d’Angiò sul campo. Contemporaneamente, gli Arabi di Tunisi, amici ed alleati degli Svevi grazie all’antica politica conciliatrice condotta a suo tempo da Federico II, organizzarono una spedizione navale contro la Sicilia, mettendo l’isola a ferro e fuoco. Gli Angioini si trovarono, così, accerchiati su due fronti. Mentre i Tunisini imperversavano in Sicilia, la colonia saracena di Lucera, da sempre fedele a Federico II e ai suoi discendenti, si sollevò (febbraio 1268), estendendo la rivolta a tutta la Puglia. Carlo, che aveva provato a bloccare la discesa di Corradino al Nord, fu costretto a lasciare Firenze per sedare i disordini nati all’interno del suo Regno: nonostante l’arrivo del Re e il conseguente assedio da lui portato senza successo a Lucera, la ribellione si propagò ulteriormente raggiungendo anche la Calabria. Ora, sia Carlo che Corrado II erano in cerca dello scontro definitivo per il possesso del Regno di Sicilia. La battaglia si registrò il 23 agosto 1268 in una località distante appena una decina di chilometri da Tagliacozzo: nonostante l’iniziale successo di Corradino, l’esperienza militare di Carlo I fu ripagata con la vittoria definitiva. Il destino riservato allo Svevo è tristemente noto: solo dopo la sua morte Carlo poté riorganizzare in tutta tranquillità i suoi nuovi possedimenti italiani. Ma l’Angioino conservò ancora per qualche tempo i suoi diritti sulla Toscana ed in particolare su Firenze, di cui era ancora podestà e vicario imperiale. Mentre il primo titolo fu perduto, come abbiamo visto, nel 1273, il secondo gli fu rinnovato da Innocenzo V nel 1276. Fu, infine, con l’intervento di Papa Niccolò III (1277-1280) che il vicariato non gli fu più concesso a partire dal 1278. A cominciare da quell’anno, l’influenza esercitata fino ad allora da Carlo I sulla Toscana e sugli altri centri dell’Italia settentrionale iniziò gradualmente a declinare, fino a sfuggirgli del tutto in favore di una politica filo-papale. La floridezza registrata nella Firenze della seconda metà del XIII secolo fu opera, soprattutto, dell’intervento carolino, che incentivò lo sviluppo di contatti diplomatici ed economici tra la città, il Regno siciliano, la Roma pontificia e la Francia, suo Paese d’origine.1 punto
-
Ciao @Rocco68, grazie mille per l'interesse: mi piace, ogni tanto, focalizzare l'attenzione anche sul periodo medievale della storia del Regno di Napoli.1 punto
-
Ciao! Sono d'accordo. Collezionare i soldini da 12 non è cosa da poco, anzi .... ce n'è tanti e con tantissime varianti; non c'è da svenarsi e - aspetto oltremodo intrigante - ancora oggi si trovano tipi non censiti. Ci sono poi anche quelli contraffatti ..... C'è anche una specifica discussione sul forum con una formidabile galleria di immagini. Che ne dici di inserire la tua anche in questa discussione? Servirebbe a portarla "a galla" giacché è attempata e ne beneficierebbero i nuovi utenti. Saluti luciano1 punto
-
Added to my collection over the weekend...and found one (US$0.25) with an interesting history but will let it stand on its own. (Viva Zapata!) v.1 punto
-
a sinistra, nella ultima asta NY Sale e a desta, nella prossima asta Tradart.... Per confronto, quello di obolos in HD1 punto
-
svenimenti dopo quello che ho visto, questo è normale. Confessa. Hai una macchina del tempo? Questa è una moneta magnifica. Invidio, ma senza rabbia. Una moneta degna ha trovato il vero proprietario. Caro signor Fofo, sei degno di questa moneta. Or. Questa moneta è degna di te. Bravo.1 punto
-
questa dopo aver studiato l'immagine, l'assegnerei al gruppo dei denari E denaro 168, tipologia forse battuta a Cortona. Mi sembrano ben chiari la barba e i baffi del santo diventati lunghi, noto anche sia nella mia moneta che in quella riportata in foto sul libro di @magdi, un segno d'interpunzione "." nella legenda del R DONAT.VS1 punto
-
Alcune osservazioni sulla moneta in questione. 1. Come giustamente osservato da @417sonia (ciao Luciano) l'esemplare è poroso e ciò è sempre foriero di sospetti. Comunque si tratta di microbolle in negativo in tutti i casi, e ciò fa pensare a un fenomeno ossidativo naturale 2. Le lettere sono quelle che ci si aspetta dall'utilizzo di punzoncini parziali nell'approntare la legenda del conio, anche se si perde in definizione in qualche punto, in particolare nei microcunei a livello degli snodi/estremità dei caratteri (usura/ossidazione?) 3. la C di Venecias presenta dei triangolini terminali tricuspidati atipici, ma ho trovato almeno un altro esemplare con queste caratteristiche (vedi sotto) 4. al D/ tra le lettere OV di LVDOVVICVS si scorgono dei detriti che potrebbero essere incrostazioni di terra (moneta recuperata dal terreno?) In definitiva: la moneta non mi piace ma sembrerebbe autentica, quantunque usurata e di dubbia provenienza.1 punto
-
E' proprio uno degli "ibridi" che citavo, non avevo conservato le immagini ma lo ricordo bene... ha anche realizzato 120 euro !! Ciao, RCAMIL.1 punto
-
Ciao, è un denario di Adriano. Diritto: HADRIANVS AVG COS III PP, testa laureata a destra. Rovescio: VOTA PVBLICA, Adriano stante a sinistra con patera sacrifica su un altare. RIC II 2901 punto
-
Ecco la parte che non era stata trasmessa in streaming per problemi di connessione Buona visione! Antonio1 punto
-
scusami, ora ricordo di averle viste. purtroppo con l'età sto perdendo la memoria. due bei pezzi di storia, quando Roma non aveva lo spelacchio ma la gloria.1 punto
-
@@antvwaIa la tua riflessione mi sembra molto giusta .... ho però una domanda da farti : se tutti i collezionisti cedessero la propria collezione alle istituzioni museali , i collezionisti del futuro dove le troveranno le monete ? .... indirettamente forse non si andrebbe ad incoraggiare ulteriormente l'uso del metaldetcor1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?




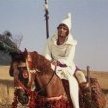


.thumb.jpg.0c713dd4d29897ec1aa5522233f464d8.jpg)