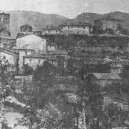Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 04/09/18 in tutte le aree
-
Inoltre va considerato che sui sentieri si trova di tutto. Ecco un piccolo campionario: A sinistra, un utensile di utilizzo ignoto (probabilmente agricolo moderno), a destra in alto un chiodo da ferratura di animale e in basso parte di bossolo (moschetto?). Gli altri sono tutti chiodi da scarpone militare degli eserciti che si sono succeduti nel tempo dalla I Guerra mondiale ad oggi. Come si riconoscono? Dalla forma, dalla presenza di bava di fusione, dalla lega componente. Vi invito a leggere l’articolo (in lingua inglese, essendo stato edito su una rivista internazionale) all’indirizzo http://journals.plos.org/plosone/article/comments?id=10.1371/journal.pone.0194939 Troverete l’abstract, l’articolo completo e le “supporting information” dove troverete varie immagini. Chiaramente, si tratta di un free-text per cui la visione è assolutamente libera e non implica alcuna iscrizione o pagamento. Spero di avervi interessato anche se il tema non ha trattato il tema numismatico… fate conto che sia un’estensione delle discussioni “l’importanza dei dettagli…”. Ciao Illyricum PS: ringrazio anche l'aiuto prestato nelle fasi iniziali della ricerca dall'amico Exergus .5 punti
-
Ritorno per aggiornarvi... Grazie a @Poemenius e a @snam per l'aiuto e le dritte. Ho trovato la conferma che cercavo, il riferimento indicato nella moneta coincide con il numero di lotto del listino di vendita del 1914: gentilmente un addetto della biblioteca del museo archeologico di Bologna mi ha fatto avere copia via mail della pagina in questione. Ovviamente, dato il tipo estremamente comune, non ci sono tavole fotografiche di supporto. Curiosità nella curiosità: l'antoniniano in questione era valutato all'epoca 1,5 Lire. Ai giorni nostri è stato messo in vendita a 5 euro. In questo simpatico link del sole24ore è possibile calcolare l'attuale potere d'acquisto della lira prendendo a riferimento un dato anno... orbene, le 1,5 Lire del 1914 corrispondono ai 5,93 € attuali... quindi chi dice che non conviene investire in numismatica sbaglia!!! C'è un delta di valutazione di ben 93 centesimi maturato in soli 104 anni... circa 0,89 cent. all'anno!4 punti
-
Si ipotizza una vendita di materiale classificato e studiato, una provocazione che date molte teste italiche provoca scandalo. Magari le stesse teste che se ne fregano degli scatoloni, dei furti, delle carenze museali. Proprio fessi gli inglesi....3 punti
-
3 punti
-
Pareidolia = Si tratta di un fenomeno istintivo, cioè la tendenza a vedere forme ed oggetti riconoscibili nelle strutture amorfe che ci circondano. Non mi sembra applicabile alla Sindone3 punti
-
Ciao a tutti, oggi ho migliorato il mio precedente tornese prendendone uno decisamente migliore che ve ne pare? considerato che le mie monete di questo periodo solitamente sono in mb. Non faccio questa operazione spesso perchè avrei sin troppe monete da migliorare, ma in questo caso la data 1858 del tornese che già possedevo non si leggeva nemmeno bene ed il pezzo che ho preso costava poco. Ogni volta resta il problema di smaltire la moneta sostituita... spero la prossima volta di cambiarla alla pari con una moneta estera da ciotola da 50 cent od un euro magari, fortunatamente quella delle monete mondiali di comune circolazione è una delle mie collezioni principali. Questa è quella che avevo in precedenza:2 punti
-
Meravigliosa canzone dei Kiss che non teme minimamente il passar del tempo..2 punti
-
E io le accetto, non le condivido ma le accetto.2 punti
-
Ciao. Allora siamo in due ad andare contro corrente... M.2 punti
-
2 punti
-
Mi hai fatto ricordare che anch'io calcolavo gli anni che avrei avuto Mi ricordo che cominciai quando avevo una diecina di anni con la serie UFO (lo mandavano in onda la domenica), nella sigla iniziale c'era quel 1980 a caratteri cubitali che sembrava irraggiungibile... Alla metà degli anni 70 eravamo incollati alla tv con la serie Spazio 1999, superata anche questa data di quasi 20 anni... Infine ben 33 anni fa con il primo episodio di Ritorno al futuro, con quel display sulla De Lorean che segnava 2015,.. _____ tempo spietato.....2 punti
-
2 punti
-
Ciao @And08 , l' unica spiegazione possibile circa la sorgente che avrebbe impresso l' immagine del corpo , presupponendo che il corpo per noi credenti sia quello di Gesu' , e' l' attimo della Resurrezione , una "esplosione" di una forma di energia non spiegabile umanamente .2 punti
-
sono d'accordo per i "paletti"se si tratta di reperti di un certo interesse ma limitiamoci a quelle montagne di monete del IV secolo riconosciute in migliaia di esemplari,cocci di vasellame,fibule ed altro,non sono un esperto in tal senso ne tanto meno un archeologo,anche se da bambino sognavo di diventarlo,ma bene o male sappiamo tutti che alcuni reperti sono noti in migliaia di esemplari,e allora perchè non venderli piuttosto che lasciarli a marcire nei depositi dei musei?quando poi c'è sempre qualcuno che ci fa la cresta,vedi la collezione di Vittorio Emanuele III del museo nazionale romano o la collezione Bovi del museo Filangieri di Napoli giusto per citarne qualcuno.... anch'io sono per non vendere il nostro paese ma poi a questo ci pensa la nostra classe politica...2 punti
-
Conosco alcuni degli studi scientifici fatti sulla Sindone, in particolar modo quelli del Prof Fanti, essendo attualmente mio professore universitario e posso garantire la validità scientifica delle pubblicazioni in quanto dell'argomento ne è stato largamente discusso a lezione. Che vi sia un'immagine di un uomo è innegabile e penso evidente a tutti, e gli ultimi studi hanno dimostrato come l'impressione di quest'immagine non sia operabile da nessuna, per quanto abile, mano umana, ma solamente da una enorme e brevissima fonte di energia...una sorta di "esplosione"2 punti
-
Questi obbrobri sono tutti tentativi casalinghi da "piccolo chimico", molta gente vede che ci sono dei pazzoidi che comprano qualsiasi cosa che possa anche solo lontanamente assomigliare ad un errore di conio, ed ecco i risultati. Questa non è numismatica, non è più nemmeno collezionismo, ma è follia pura. E, mi dispiace dirlo, siamo noi stessi collezionisti ad alimentare questa follia.2 punti
-
E' stato amore a prima vista per questo ripostiglio... e non so spiegarmi il perché... così oggi mi son fatto un regalone: TACITO Zecca: Ticinum (Pavia) - inizio 276 d.C. - Aureliano - 23,5 mm; 4,14 gr - or. assi 6h D\ IMP C M CL TACITVS AVG R\ FELICIT TEMP// V Riferimento: RIC.140 - La Venèra. II.2/1880 Provenienza: Ripostiglio di Reyssouze Priva di argentatura superficiale (chi ha pulito le monete del ripostiglio ahimé le ha pressoché spatinate...), ma in buone condizioni. Pagata più della media perché cgb è cara e per via del surplus da hoard... ma Tacito per questo ripostiglio mi mancava! E poi di Tacito non avevo esemplari in rappresentanza del ripostiglio... e se non ricordo male è pure il primo Tacito a entrare nella mia collezione. In merito alla presenza di questo imperatore nel ripostiglio, questo è quanto viene scritto nel report preliminare:2 punti
-
Come vedete, questo articolo non c'entra niente con la numismatica. L'ho inserito quasi come una provocazione. È triste che un museo debba cedere parte delle proprie collezioni per stringenti necessità economiche, ma non troverei niente di male se tutto ciò facesse parte di una strategia di autofinanziamento per importanti progetti, mostre, pubblicazioni o eventi importanti in genere. Ci arrivo: a quando la vendita di parte delle collezioni numismatiche o archeologiche (preciso: solo le cose ritenute non strategiche ed importanti) da parte dei nostri musei? So che molti non saranno d'accordo con me e lo capisco, ma è meglio lasciare che tutto prenda polvere o addirittura si rovini negli scantinati? Tutto ciò farebbe la gioia di molteplici collezionisti, ne creerebbe di nuovi, probabilmente, e darebbe una bella botta a tombaroli, ladruncoli e maneggioni vari. Che ne pensate?2 punti
-
Si colleziona di tutto, sottobicchieri, tappi, lamette, punti mira lanza, figurine formaggino Susanna... che c'è di male? io colleziono pure gli "spessori"2 punti
-
Ciao, le condizioni dei biglietti purtroppo sono modeste, realisticamente per il 1000 lire G.Verdi non arriviamo ad un euro, uno/due euro per il 100 lire di piccolo formato (è solo un valore simbolico), cinque euro per il 100 lire di grande formato. Poi ci sarebbero il 1000 lire ed il 500 lire, in medie/buone condizioni ma non tanto da poter valere più di 10/15 euro il biglietto da mille lire, e trattandosi di una serie speciale W227 15/20 euro per il biglietto da 500 lire. Se vedi in giro prezzi molto più alti per le medesime condizioni si tratta di solito di banconote proposte ad un prezzo fuori mercato, significa che rimaranno invendute per lunghissimo tempo se non per sempre.2 punti
-
2 punti
-
posto la foto di questa monetina, un quattrino di Filippo IIII 1621-1665 per Milano Crippa III n.27 il suo peso è di gr.1,30 la curiosità sta nella sua coniazione, riporta sia al diritto che al rovescio lo stemma inquartato la sua forma (sembra un cuore) chissà quante vicissitudini ha avuto questo è il bello della numismatica e le sue scoperte2 punti
-
Probabilmente la scarsa attenzione verso il falso tetradramma di Atene è dipesa dal fatto che ci sono relativamente pochi forumisti che si interessano a monete ateniesi. Io, che non sono un "tuttologo", non avevo nemmeno guardato la parte delle monete greche fuori della Magna Grecia e Sicilia.... L'importante è che ci sia stata una tempestiva segnalazione di almeno due attenti osservatori con adeguate prove a sostegno, nello spirito di una fattiva collaborazione. Per il Gela mancavano prove altrettanto inoppugnabili e, come succede anche nei processi penali, è meglio avere l'assoluzione se non si hanno adeguate prove a sfavore, anche se potevano esserci alcuni elementi "indiziari" che legittimavano almeno alcuni sospetti, che restano comunque limitati dal fatto che sono basati solo sulle immagini fotografiche e che andavano supportati da adeguati esami dal vivo e da dimostrazioni più obiettive.2 punti
-
Partendo dal buon proposito di iniziare a leggere qualcosa, su Milano la sua storia e le sue monete sono partito con i Quaderni di Lamoneta e la pubblicazione sulle monete e medaglie di Milano, trovando molti spunti non solo numismatici ma anche sulla storia della città. Allora oggi dopo tanto tempo ho finalmente deciso di andare a visitare il Castello Visconteo di Somma Lombardo, una vera meraviglia, un gioiello con stanze completamente affrescate ed arredi originali, che dire un vero spettacolo lasciato in dono dai Visconti a tutti noi, la visita si svolge con una guida che spiega di passo in passo la storia del castello e dei suoi propietari, delle evoluzioni dello stesso in ambito architettonico e in ambito artistico, con coloro che si sono avvicendati nella propietà e che hanno lasciato il loro segno sul maniero. Quale miglior modo se non andare a vedere di persona i posti dove i Signori di Milano ed i loro discendenti hanno fatto la storia, unica pecca non si possono fare foto degli interni, ma assicuro che sono meravigliosi, vi è nel salone centrale oltre ai vari affreschi che rappresentano i pianeti, Giove, Venere ecc. ed uno spòendido lampadario di Murano di forma non convenzionale, anche un meraviglioso scudo con le insegne dei Visconti, inquartato con biscione ed aquila, con colori vivaci come se fosse stato fatto ieri. Un castello che merita una visita sicura.2 punti
-
L’oro per sé non è responsabile delle macchie di color rosso o marrone nè delle striature rossastre o altre 'manifestazioni esantematiche' che possono svilupparsi sulla superficie di una moneta aurea. Infatti allo stato puro l’oro è incorruttibile, cioè non arrugginisce, è eterno, omogeneo. Però l'oro allo stato puro è troppo tenero per essere funzionale e quindi per le monete si usa in lega, in genere col rame o con rame e argento. Nella produzione dei tondelli e nella coniatura di monete d’oro può capitare che si formino sulla superficie della moneta piccole aree localizzate dei metalli alligati, che col tempo si ossidano assumendo un colore rosso o rosso-marrone più o meno intenso. Non si può però escludere che queste macchie provengano da tracce di altri metalli provenienti dal contenitore che hanno aderito alla superficie della moneta d’oro. Un’ulteriore possibilità è che tracce di altri metalli presenti sul conio prima della battitura del tondello vengano trasferite sulla superficie con la battitura e, inizialmente invisibili a occhio nudo, si rivelino in seguito per la colorazione assunta all’aria. Naturalmente queste minuscole impurezze potrebbero contaminare il tondello prima della coniatura e diventare visibili col tempo, dopo che esso è diventato moneta. Personalmente anch’io le lascerei, come segno che anche un metallo nobile come l’oro può… arrossire! Cordialmente,2 punti
-
Buona sera Chiedo umilmente scusa a tutti; per la mia azione Non succederà più. . Pensavo che i miei post fossero stati dimenticati. Un cordiale saluto2 punti
-
DE GREGE EPICURI Il poco che posso dirti è questo: le imitazioni delle dracme massaliote non sono iniziate in Italia, ma hanno avuto dei precursori in Francia. Sono però imitazioni molto più rare di quelle cisalpine, poco note e poco studiate. Alcune provengono da territori relativamente vicini a Marsiglia (diciamo, dalla Provenza), altre da zone molto più distanti, come questa, che effettivamente è molto originale.2 punti
-
2 punti
-
Cari amici Sono 3 anni che mi lamento ogni anno di bologna. Prima per il tendone scareggioso, poi peril servizio di sicurezza pessimo (e ripetuti furti). Finalmente posso dire di essere personalmente contento! Alla fine un convegno dove si paga qualcosa per parcheggiare o entrare. Entri dentro e trovi tutto in ordine, gente sorridente, nessuno che dice di aver subito furti. Parlo con amici commercianti e mi dicono che il servizio di sicurezza è aumentato e che si sono sentiti per la prima volta sicuri a bologna! giro tra i banchi, domando a 8 differenti commercianti amici, tutti sorridenti e con la solita risposta ! Porca miseria, alla fine hanno fatto una mossa giusta, anzi, giustissima ! bravi ! anche se mettete 5 euro a parcheggio o per l'ingresso alla mostra và benissimo ! sono arci contento di come è andata ! bravi ! Fregatevene se qualcuno dice che per 2 euro se ne è andato, pensate a cosa era venuto a fare se non voleva spendere 2 euro ! bravi, anzi, bravissimi, cotinuate su questa linea. Vigilanza, tranquillità e un pelo di qualità sempre più alta ! pagare 2 o 5 euro per un parcheggio o per l'ingresso ad un evento ben organizzato non sono nulla ! bravi.2 punti
-
Riapro questa discussione perche ieri sera nella trasmissione segreti trasmessa in tv mi è sembrato molto interessante cio che hanno affermato gli scienziati del centro ricerche dell'Enea. Cioè in poche parole ci sarebbero voluti 10.000 laser che agissero simultaneamente per formare l'immagine che è presente sulla sindone. Riporto quello che gli scienziati hanno affermato con le loro scoperte in questi ultimi anni: Nella prima parte dello studio è stata confutata la tesi secondo cui la Sindone sarebbe un’opera artistica, in quanto «negli ultimi decenni è stato scoperto che l’immagine corporea non è un disegno o una pittura eseguita con tecniche conosciute, e alcune macchie rossastre sono state causate da sangue umano». La Sindone, altrimenti, sarebbe stata «realizzata dal più geniale falsario mai apparso sulla Terra e ancora oggi sconosciuto», il quale avrebbe dovuto conoscere «alcune tecnologie o informazioni prima della loro invenzione e divulgazione […] non poteva essere a conoscenza di scoperte moderne sia perché le tecniche a disposizione a quel tempo non permettevano di eseguire una simile opera dal punto di vista macroscopico e microscopico». Ma chi sostiene questa tesi, assume una posizione irragionevole, in quanto: 1) L’immagine corporea della Sindone è un falso negativo: tecnologia scoperta ed utilizzata nella fotografia solo nel 1850. 2) I chiodi sono infissi nei polsi dell’uomo della Sindone: ma in tutte le rappresentazioni antiche della crocifissione i chiodi sono piantati nelle mani, anche se in questo modo il corpo non poteva rimanere appeso in croce. L’ipotetico falsario medioevale non poteva saperlo o comunque non avrebbe avuto motivi per contraddire le rappresentazioni della tradizione, rischiando così di dare adito a sospetti. 3) L’immagine della gamba sinistra è più corta della destra: una conseguenza del metodo di inchiodatura dei piedi e della rigidità cadaverica repentina, due aspetti sconosciuti nel Medioevo, essendo stati scoperti solo in tempi recenti. 4) Sul lato destro della cassa toracica c’è una grande macchia di sangue e siero: nessun ipotetico falsario medievale poteva sapere che ciò è una conseguenza della morte istantanea per rottura della parete del cuore, una scoperta recente della medicina. 5) Le macchie di sangue sono nette e sotto di esse non c’è immagine corporea: queste caratteristiche sono incompatibili con un’opera artistica. 6) Ci sono numerose macchie di sangue sulla fronte e sulla calotta cranica: la rappresentazione tradizionale di Gesù è sempre stata con una corona di spine mentre le ferite sulla Sindone presuppongono un casco di spine, un fatto sconosciuto fino a tempi recenti. Nessun falsario, ancora una volta,avrebbe avuto motivi per contraddire di punto in bianco la rappresentazione tradizionale. 7) L’immagine corporea è assente in alcuni punti quali la parte destra della faccia e della fronte e altre parti del corpo: solo recentemente se ne è spiegata la ragione che è collegata alle formalità rituali della sepoltura. L’immagine corporea contiene informazioni tridimensionali: i dipinti e le foto sono generalmente piatti e, a parte le difficoltà tecniche di riproduzione, non si spiegano i motivi che possono aver indotto l’ipotetico falsario a creare un simile effetto, inutile e sconosciuto nella storia dell’arte. 9) L’immagine corporea è estremamente superficiale e consiste di fibrille colorate giallo-seppia che risultano ossidate e disidratate: per le tecniche chimiche e fisiche antiche conosciute non sarebbe stato possibile, mentre esiste una tecnica optoelettronica moderna compatibile. Si deduce, dunque, che «la Sindone non è un falso e tanto meno medievale, ed ha contenuto realmente il corpo morto di un uomo crocifisso in tempi antichi». L’altra ipotesi è che la Sindone abbia contenuto un corpo di uno sconosciuto, non quello di Gesù, anch’esso crocifisso nello stesso modo più o meno alla stessa epoca. Una tesi ancora una volta irragionevole, perché: 1) Il lenzuolo funebre utilizzato per avvolgere il cadavere era pregiato e costoso: simili lini venivano utilizzati in Israele solo per persone di rango reale e/o posizione sociale elevata, ed in questo caso la storia ne avrebbe parlato. 2) L’uomo della Sindone è stato fustigato metodicamente su tutta la superficie del corpo: ci sono segni evidenti di flagello romano in numero così elevato che, a parte i Vangeli, nessun documento storico li ha mai riportati per qualsiasi altro condannato. 3) L’uomo della Sindone è stato incoronato con una corona/casco di spine: ci sono segni evidenti delle ferite delle spine e non si conoscono storicamente altre crocifissioni avvenute con questa aggiunta singolare. 4) Il costato è stato trafitto da una lancia: c’è una vistosa macchia di sangue e siero nel fianco destro dell’uomo causata da una ferita da lancia, un fatto piuttosto irrituale. 5) Le gambe dell’uomo della Sindone sono integre, mentre quelle dei condannati alla crocifissione venivano generalmente rotte per affrettarne la morte, che sarebbe avvenuta solo molto più tardi per soffocamento. 6) La Sindone non contiene tracce di liquidi e gas putrescenti: questi segni sono prodotti dopo circa 40 ore dalla morte, e quindi il corpo non c’era già più prima di allora ma non troppo prima, per via delle macchie di sangue che hanno richiesto del tempo per formarsi per la liquefazione del sangue già coagulato, processo di emolisi. 7) Il corpo non è stato rimosso manualmente: non ci sono tracce di trascinamento in corrispondenza delle macchie di sangue2 punti
-
Inoltre i soldati spesso hanno lasciato le loro impronte su superfici malleabili che si sono mantenute fino ai giorni odierni. (da Britannia e Israele) O ancora, dopo la consunzione della parte organica, sono rimasti solo i chiodini nella disposizione originale . (Germania) Camminando lungo i le strade ed i sentieri gli antichi romani perdevano questi manufatti ferrosi fabbricati a mano che nel corso del tempo quindi si accumulavano. Pressochè sconosciuti ai più, sono uno dei manufatti romani più diffusi. Quello che è curioso è che a seconda di alcune decorazioni vicine al punto di attacco dello stelo, gli hobnails possono esser collocati cronologicamente. Nel nostro caso coprono il periodo tardo repubblicano e quello imperiale. “Coprono”… perché i soldati camminando per le varie strade perdevano chiodini di caliga e quindi, trovandoli in superficie, possiamo delineare i percorsi stradali che utilizzavano. Certo, bisogna avere anche la fortuna di avere un fondo ghiaioso, non troppo umido, morbido e transitato (i chiodini verrebbero schiacciati nel fango e quindi celati alla vista), non troppo esposto a fenomeni di accumulo di terriccio o humus. Dalle tracce LiDAR si evidenzia che quello attualmente in uso è solo l’ultimo in senso cronologico dei vari percorsi; spesso nel tempo qualche tracciato si spostò, probabilmente per deterioramento del fondo (con buche e solchi) e determinando la formazione di vari solchi paralleli (impercepibili ad occhio nudo).2 punti
-
Il suo decorso è pressochè parallelo all’attuale strada moderna per Fiume/Rieka (Tarsatica) e al fine di individuare una eventuale rete viaria collegata al forte romano si iniziarono delle prospezioni di superficie, atte ad identificare la presenza di “solchi carrai” di epoca romana. Questa risultò negativa in tal senso ma portò al rinvenimento, tra il ghiaino del fondo, di un minuscolo, misconosciuto e spesso trascurato manufatto: un chiodino di caliga. La caliga era la tipica calzatura del soldato: assomigliava ad un sandalo ed in realtà era una sorta di stivale da marcia con suola rinforzata che si indossava di solito senza calze (salvo il periodo invernale). Tratte da un unico pezzo di cuoio, la suola presentava dei veri e propri chiodi con lo stelo piegato che la rafforzavano, miglioravano la trazione sulle superfici, ne consentivano anche l’uso quasi come arma offensiva e durante la marcia producevano un rumore che poteva intimorire l’avversario, conferendo marzialità nell’avanzamento. In casi eccezionali le caligae si sono conservate (es. terreni umidi britannici o viceversa terreni asciutti egiziani); la disposizione dei chiodi (hobnails) variava nella disposizione. Li usavano tutta la truppa fino al grado di centurione; Gaio, il figlio di Germanico, acquisì il soprannome di Caligola proprio perché da bambino nei campi militari al seguito del padre indossava delle piccole caligae. http://objects.prm.ox.ac.uk/pages/PRMUID130480.html2 punti
-
Riprendendo quindi da dove eravamo rimasti nell’articolo https://www.lamoneta.it/topic/136278-la-vera-nascita-di-tergeste/?tab=comments#comment-1553784 sull’altura denominata Grociana Piccola, sul Carso Triestino, è stato identificato un doppio forte romano che presenta due probabili episodi di frequentazione. Nel sito sono stati raccolti frammenti ceramici e “... un chiodino di caligae nel terriccio smosso da animali fossatori del tutto sovrapponibile per forma, dimensioni e decorazione a quelli presenti nei siti delle guerre cesariane in Gallia.” Perché fu scelto questo sito? Probabilmente per due motivi fondamentali: per il principio di intervisibilità con quello di San Rocco (ovvero i due sito potevano controllarsi e vigilare l’uno sull’altro) e probabilmente perché nei pressi doveva esserci una via di transito di origine pre-romana (nell’area sono presenti anche abitati pre-romani dell’età del ferro di grosse dimensioni). In effetti l’area è stata identificata di vari studiosi come punto di arrivo della mitica “via dell’ambra”, il percorso protostorico che veicolava la resina fossile dall’area baltica al bacino mediterraneo. Ambra che ricordiamo veniva lavorata dapprima anche dagli etruschi e successivamente fece la fortuna di Aquileia e dei sui laboratori. Percorso che a differenza di quello più tardo del periodo imperiale (che valicava le Alpi Giulie e si dirigeva verso Aquileia stessa) dalla zona di Lubiana/Emona allungava il tragitto in termini di tempo ma evitava grossi dislivelli dipanandosi a fondo valle e passando ai piedi del Monte Nanos. Un tracciato viario protostorico, quel che conta, che permetteva di addentrarsi nell’entroterra. Detto ciò, attirò la curiosità la presenza di ciò che attualmente è un semplice sentiero a est dell’insediamento, ad andamento leggermente curvo della lunghezza di circa 450 metri già proposto qualche anno da un non-addetto ai lavori come “possibile strada romana”.2 punti
-
Mi piacerebbe avere qualche informazione in più su questa medaglia devozionale. La medaglia è in bronzo, pesa 4,815 gr., e le sue misure, appiccagnolo escluso, sono di 25x30 mm. Come si può vedere, al retro è descritto chiaramente di cosa si tratta, medaglia commemorativa del centenario del miracolo del movimento degli occhi della B.V. delle Grazie in Fabriano, la cui storia si può leggere qui http://www.viaggispirituali.it/2013/01/santuario-della-madonnetta-de-le-grazie-fabriano-ancona/ Ma, al di là di questo, qualcuno è in grado di fornire qualche informazione in più sulla medaglia? O la si deve semplicemente classificare come una delle tante medagliette devozionali? Grazie fin d'ora a chi potrà aiutarci, io e il mio amico in possesso della medaglia, a saperne di più. petronius1 punto
-
Confermato e già prenotato lo stesso posto. Spero che il gruppo cresca. L'anno passato eravamo una quarantina no?1 punto
-
Diciamolo chiaro pero', l'Italietta da questo punto di vista e' un paese del terzo mondo, incapace di valorizzare il suo patrimonio, che tollera corruzioni e ruberie di ogni genere, furti nei musei e musei con magazzini stracolmi di materiale che nessuno vedra' mai se non quelli che la ruberanno. E capace solo di scandalizzarsi ipocritamente per questa iniziativa.1 punto
-
Dei mitici Oliver onions, la so a memoria mi ricordo di quanto sembrasse lontano il 1999 e facevo sempre il calcolo di quanti anni avrei avuto, in assoluto la mia serie di fantascienza preferita.1 punto
-
Posto questa moneta solo per cercare di capire la raffigurazione al rovescio della moneta da identificare..... Kleitor The coinage of Kleitor in the 2nd quarter of the 4 Estimate: CHF 175.00 Chalkous (AE, 2.39 g, 12.5 mm, 5), c. 360s-350s. Helmeted head of Athena to right. Rev. Horse with trailing reins galloping to right. BMC 11. Nemea 1943. SNG Cop 227. Traité III 919. Lovely green patina. Good very fine. Somewhat interestingly, only one example of this type was found at Nemea while four of the Helios chalkoi were. This is significant because the sanctuary of Nemea was pretty much abandoned during the first half of the 4th century, when we suggest this coin was issued; while the site flourished during the late third and fourth quarters of the 4th century and in the first quarter of the 3rd, at the time we suggest the Helios pieces were produced.1 punto
-
1 punto
-
CASTULO. https://www.acsearch.info/search.html?term=Castulo+CN+bull&category=1-2&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1&images=1&order=0¤cy=usd&company= Lu.1 punto
-
1 punto
-
Come sempre preciso ed esaustivo P.S. Mi permetto di lanciare un sondaggio... "vogliamo @nikita_ tra i cordinatori della sezione" chiaramente assieme agli "storici e imprescindibili" @petronius arbiter e @apulian PB1 punto
-
1 punto
-
@claudioc47 dimenticanza mia, grazie per la segnalazione. Saluti Simone1 punto
-
Ciao, dici molto bene secondo me, infatti all'inizio del Convegno vorrei fare un momento di riepilogo di come sta andando il coordinamento circoli nel reale ma anche nel virtuale qui su Lamoneta, so che ci sarà qualche rappresentante di queste realtà, come accennato già a qualcuno , mi piacerebbe sentire la loro voce se vorranno anche sul palco per coinvolgerli .1 punto
-
Fregature mai, qualcosa comprato compulsivamente agli inizi, poi rivenduto o regalato....perché non inerente a quella collezione o periodo. Ma, mai dire mai. Eheheh Roberto1 punto
-
Gli skiantos gli ho visti nel 79 a Milano allucinati.... Per noi giovani erano dei miti...trasgressione allo stato puro.. Il pezzo mi piacion le sbarbine ha spopolato.. ma questi erano tostissimi...1 punto
-
1 punto
-
Io feci vedere per la prima volta dei tondelli ai miei allievi circa trent'anni fa.. Riusci a contestualizzarli con il periodo storico-artistico che il programma prevedeva per quella classe. Fu un successone incredibile, riuscii ad avvicinarli al concetto simbolico del nummo, e di come il popolo potesse leggerlo pur non sapendolo fare... Domande infinite, sete di conoscenza, e finalmente grandissimo interesse.. La numismatica dovrebbe entrare di diritto nel periodo di formazione sin dai primi anni scolastici. Quello che acquisii negli anni attraverso la mia passione, non lo lessi in anni di notti passate sui libri... Ma forse con la nuova riforma scolastica, è apparso un barlume... Eros1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?









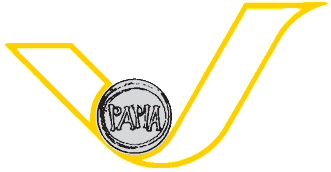








.thumb.jpg.49bf7893ab8deb0b9efbfc02c41b7421.jpg)