Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 11/01/18 in tutte le aree
-
A proposito di lavaggi, da un po’ di tempo mi sto dedicando a esaminare con il microscopio metallografico, varie tipologie di monete, con lo scopo di rilevare se e cosa succede alla struttura del metallo, sottoposto a tale trattamento. Partiamo prendendo in considerazione lo strumento necessario per poter eseguire queste osservazioni: il microscopio metallografico (foto 1-1a). Per chi non lo conosce, questo strumento, permette di illuminare il campione direttamente attraverso lo stesso obiettivo utilizzato per l’osservazione, dando una illuminazione uniforme del campo in esame, allego schema esemplificativo e foto dello strumento utilizzato (foto 2) che permette di raggiungere ingrandimenti molto elevati (400-600X). Il metallo osservato a tali ingrandimenti presenta una trama definita “granitura” che assume varie forme a seconda del trattamento subito dal metallo stesso. Per procedere nella ricerca, ho iniziato prendendo in considerazione il noto liquido per il “bagnetto” dell’argento e per fare ciò ho sacrificato una oncia d’argento canadese immacolata. Le osservazioni sono state fatte prima del bagno, dopo un bagno della durata di 4 secondi e dopo un bagno di 8 secondi. Qui di seguito le foto dei risultati degli esami che spiegano molto più delle parole. Ovviamente tutto questo ad occhio nudo si rileva solo con un leggerissimo cambiamento del LUSTRO per lavaggi max 4 secondi, ed un evidente cambiamento della freschezza del metallo per lavaggi superiori ed una opacità per tempi pari o superiori a 8 secondi. Meditate gente, meditate!!10 punti
-
Quali monete si trovavano nella cassetta di una bottega medievale, a pochi chilometri da Bologna? Ce lo racconta lo speziale Diotaiuti! Buona lettura https://www.academia.edu/37685439/Prestò_Diotaidi_da_la_cassa._Banca_e_moneta_a_Imola_fra_il_1356_e_il_13684 punti
-
Scusami ma ho la sensazione che tu abbia letto...ma senza capire... E qui viene buona la frase "Siamo responsabili di ciò che scriviamo...non di ciò che il lettore capisce". In tutte le discussioni su pulizia e restauro, che si tratti di EDTA, ammoniaca, bicarbonato, acido formico, elettrolisi chimica o intervento manuale (bisturi o matite abrasive), la regola fondamentale che viene sempre ricordata è che lo scopo degli interventi di pulizia delle monete è quello di permetterne la identificabilità e garantirne la conservazione. Si ricorda sempre che le condizioni di alcune monete, quando provenienti da secoli di giacitura in ambienti chimicamente aggressivi, non permettono la totale rimozione dei composti derivanti dai fenomeni ossidativi o degenerativi dei metalli. I fenomeni degenerativi dei metalli comportano la trasformazione degli stessi con generazione di composti; la rimozione di questi composti comporta la perdita di tutti i componenti chimici che ne fanno parte, con conseguente maggior evidenza dei punti di corrosione. I fenomeni degenerativi e/o corrosivi possono essere bloccati, i prodotti di questi fenomeni possono essere rimossi ma non si riesce ad invertirne il processo per cui non è possibile riconvertire in metallo (magari con rideposizione nella sua posizione originaria) ciò che è stato coinvolto dai processi corrosivi. Non esistono ricette miracolose, protette da chissà quali interessi commerciali...e di sicuro non esistono prodotti miracolosi nello spazio compreso fra cucina e garage (leggasi aceto, olio d'oliva, Cillit bang, sidol, svitol etc.). Esiste, e sempre dovrebbe essere valutata, la possibilità di fermarsi prima di rovinare una moneta (o un oggetto storico); inutile lamentarsi "dopo"... Specie se ci si è accaniti con ogni genere di prodotto... e ancora non ci si vuole fermare. Ora la vuoi anche ripatinare... Le monete che vedi migliori delle tue...lo erano prima di iniziare una qualsiasi operazione di pulizia. Ricorda che è possibile rovinare una moneta in condizioni splendide; non esiste metodo per rendere splendida una moneta corrosa da secoli di giacitura in ambienti aggressivi... Si prega di rileggere più volte e, se qualcosa risulta poco chiaro, si prega di chiedere chiarimenti... ciao Mario4 punti
-
Scusate..bisogna fare la cosa più semplice. Collezionare ragazze da giovani. Collezionare monete e ragazze giovani....da vecchi. ?4 punti
-
Quella di Aulisio e‘ una grave perdita persona forse non facilissima come carattere ma sempre molto disponibile nel condividere conoscenze di spessore da vero studioso, tra i migliori - nel suo campo - qui sul Forum. Personalmente mi duole molto la sua dipartita e non posso non domandarmi non solo cosa sia successo ma soprattutto se fosse stato possibile evitarla. Certe figure andrebbero quasi ‚tutelate‘ per le conoscenze che apportano e che condividono...3 punti
-
In un certo senso sì. Perché la numismatica richiede una maturità, uno spessore culturale e una capacità di riflessione e ragionamento che di solito gli adolescenti non hanno, travolti come sono da tempeste ormonali e da dinamiche di costruzione e consolidamento di un'identità individuale che è ancora debole, incerta e provvisoria (da cui tutti i fenomeni di sudditanza al "gruppo" e alla "moda"). Ovviamente tanto di cappello per quei pochi fortunati che hanno già una personalità e uno spessore "adulti" e sono quindi in grado di apprezzare fenomeni culturali più complessi - nel nostro caso la numismatica, ma il discorso varrebbe per molti altri campi, dall'arte alla letteratura.3 punti
-
DE GREGE EPICURI Una volta tanto, mi sono concesso una tetradramma. E' di Augusto per Antiochia, pesa 14,8 g. e misura 25 mm. Al D un discreto ritratto dell'imperatore, e la scritta ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥ. Al rovescio, dea turrita della città,seduta verso dx, che regge un ramo di palma; sotto, un dio fluviale. Nel contorno: ΑΝΤΙΟΧΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ. Nel campo: R invertita e coricata, A / ΔΝ / X AT in legame. In altre monete,queste lettere sono diverse (es. SA). Con queste lettere, dovrebbe trattarsi della RPC 4158, che risulta abbastanza comune (almeno 20 esemplari censiti).2 punti
-
In certe situazioni non è necessaria l'offesa diretta, il dileggio, lo scherno. A volte è sufficiente rendersi conto che l'ambiente che si frequenta è popolato da persone che hanno una base morale o ideologica opposta alla propria per decidere di allontanarsene. Penso sia capitato a tutti di decidere di non frequentare un bar, un circolo, una società, perchè non se ne condividono i presupposti "ideali" (tifoseria, politica o religione...che sia ...) A tal proposito, senza voler riaprire nessun confronto, devo dire che anch'io, e penso per gli stessi presupposti di @g.aulisio , mi trovo spesso in profondo disagio quando noto una propensione profascista (o neofascista) di molti frequentatori di questo forum. Certe frasi e le numerose adesioni (leggasi "mi piace") .... fanno Male, Molto Male. E questo non vuole essere un appello alla censura ideologica o una chiamata alle armi per gli antifascisti (l'antifascismo è già previsto in costituzione e l'apologia del fascismo è reato) ma una semplice motivazione: se scopro che non mi piace la compagnia a cui mi trovo associato... cambio bar, piazza, società, forum... Mario2 punti
-
Buonasera a voi, ringrazio @adolfos per aver richiamato la mia attenzione su questo topic. Mi dispiace deluderla @Giulicarp, ma la moneta in suo possesso purtroppo NON è un obolo. Sia il peso che il diametro sono troppo elevati e indicano chiaramente che si tratta di un denaro parvo. L’obolo, del quale conosco solo tre esemplari genuini e due falsi modernissimi - creati e “spacciati” sul mercato solo pochi anni dopo che questo nominale era stato “scoperto” - ha ESATTAMENTE le stesse tipologie del denaro parvo, ma peso e diametro più piccoli: circa 0,25/0,30 grammi il primo e circa 9/10 mm il secondo. Il suo pezzo, nonostante le piccole mancanze di metallo ai bordi, è in discreto stato di conservazione e benché non rarissimo è senz'altro di reperibilità più difficile rispetto al denaro parvo della stessa zecca emiliana emesso però a nome di Filippo di Svevia. Non mi chieda però di quantificarne il valore perché non ne sono in grado ? Spero tuttavia di esserle stato d'aiuto. Cari saluti, Teo2 punti
-
Non penso sia così .... Prima cosa ci vuole pazienza! Ovvio con aceto o succo di limone pulisci, sono degli acidi, ma pulisci tutto! Le ossidazioni, e le patine sono ossidazioni, si formano "mangiando" materiale se levi tutto lasci i buchi! Sono arrivato tardi.. Mario ha risposto prima e meglio di me...2 punti
-
Giusto @miza infatti la moneta è sotto osservazione e fra un mese farò il primo controllo e così via e vedremo se c'è una degenerazione progressiva o no.2 punti
-
Buona domenica a tutti, dopo questa carrellata di grandi nominali Voglio condividere alcuni piccoli Mezzi Tornesi di Ferdinando II, Per far vedere e capire attraverso queste monetine di pochi millimetri, La bravura dei Maestri incisori che operavano nella zecca Napoletana. Ferdinando II Mezzo Tornese 18352 punti
-
Salve a tutti. Quest’oggi volevo proporvi una nuova discussione “trasversale”, dato che l’argomento di cui andremo a trattare ci permetterà di spaziare in situazioni storiche e numismatiche dal Mezzogiorno al Settentrione della nostra penisola. Anche questa volta, al centro del nostro dibattito troviamo un sovrano napoletano della dinastia francese degli Angioini, Roberto d’Angiò (1309-1343), autore di una coniazione molto particolare ed estremamente rara che merita di sicuro un approfondimento. Ecco la descrizione del pezzo in esame: Gigliato. D/ + ROBERTUS • DEI GRA IERLM • ET SICIL • REX Robertus Dei gratia Ierusalem et Siciliae Rex. Roberto, per la grazia di Dio, Re di Sicilia e Gerusalemme. Il Re coronato, seduto frontalmente su di un trono con protomi leonine ai lati, tiene nella mano destra lo scettro gigliato e nella sinistra il globo crucigero. R/ + IPPETUU CU SUCCESSOIB DNS TRE PRATI In perpetuum cum successoribus dominus Terrae Prati. Signore in perpetuo della Terra di Prato con i suoi eredi. Croce piana ornata, con le estremità fogliate, accantonata da quattro gigli. CNI XI, p. 345, n° 1 (tav. XXII, n° 4). AR 3,90 g. e 27 mm. (esemplare della Collezione Reale, già ex Collezione Gnecchi, n° 3515). Un altro esempio trovato in rete, dal peso dichiarato di 3,78 g.: Si sa benissimo oramai che il gigliato fu una moneta ampiamente accettata in molti luoghi diversi tra loro, non solo d’Italia, ma anche d’Europa e addirittura fu imitata e scambiata nelle zecche e negli Stati dell’Oriente Latino. Tale fama scaturisce dalla bontà della lega utilizzata per la coniazione di queste monete, molto più ricca di fino rispetto ad altri nominali, non solo italiani, che si potevano trovare in circolazione all’epoca. Era, se vogliamo, una specie di “dollaro” d’argento del Basso Medioevo, utilizzato per i commerci locali nel Regno di Napoli, ma anche per quelli di più vasta portata, tant’è che si sviluppò un vero e proprio giro d’affari intorno all’imitazione del gigliato napoletano o robertino, come veniva chiamato per via del sovrano che lo fece diventare così celebre e ben accetto. Non ci si sorprende, quindi, di trovare una moltitudine di gigliati che si differenziano anche molto da quelli coniati a Napoli durante il regno di Roberto d’Angiò, ma il gigliato “pratese” ha avuto sempre un ruolo molto particolare nella numismatica non solo napoletana, ma italiana in generale, per via della sua esimia rarità, ma soprattutto per i risvolti storici che tale moneta potrebbe rivelare. E allora è il caso di vedere meglio le circostanze storiche che portarono alla realizzazione di questo strano pezzo. Innanzi tutto occorre spiegare perché la definizione di “pratese”. La caratteristica peculiare risiede proprio nella legenda di rovescio, ampiamente sciolta e tradotta in fase di descrizione. In pratica, Roberto d’Angiò, oltre che Re di Napoli, veniva riconosciuto anche come signore della Terra di Prato, la città toscana in provincia di Firenze. Il privilegio signorile si estendeva anche ai suoi eredi, quindi, dopo la morte del sovrano angioino, i suoi successori avrebbero beneficiato della signoria di Prato. Come si configura storicamente un tale potere? Come arrivò Roberto d’Angiò a detenere i diritti su città così lontane da Napoli e dal suo Regno, coinvolte in ben altre realtà politiche? E, soprattutto, come si giunse alla coniazione di una moneta, il gigliato, appunto, che per stile e standard ponderale rientra perfettamente nei meccanismi economici napoletani, ma che è di più difficile inserimento in quelli toscani? Dobbiamo pensare ad un’Italia divisa tra due principali fazioni: i Guelfi, sostenitori del partito filo-papale, e i Ghibellini, favorevoli invece nel riconoscere all’Imperatore di Germania un potere temporale superiore a quello della Chiesa di Roma. L’autorità imperiale, inoltre, voleva anche consolidare la propria influenza in Italia, ormai solo un ricordo rispetto a ciò che era stata nel corso del XIII secolo o anche prima. Gli scontri tra le diverse fazioni nelle città dell’Italia settentrionale portarono i liberi comuni ad indebolirsi per i dissidi e le divisioni interne: sia Firenze che le città limitrofe della Toscana, infatti, erano molto deboli militarmente e non riuscivano a fare fronte alle esigenze belliche che il tempo imponeva. Tra il 1305 ed il 1310, quindi, Roberto d’Angiò, uno dei sovrani più potenti d’Italia, era stato coinvolto nelle lotte politiche toscane e si schierò dalla parte dei Guelfi: il Re di Napoli, infatti, già nel 1305, quando era solamente Duca di Calabria, fu insignito della signoria di Firenze, che mantenne pressappoco fino al 1321, e messo a capo di una lega di città toscane che si opponevano al potere ghibellino ed imperiale in Italia. Prato, la cui situazione militare non era molto diversa da quella della vicina Firenze, aveva vissuto anni migliori dopo che, alla metà del XIII secolo, si era fissato lo Statuto cittadino e il centro aveva riconosciuto la propria qualifica di libero comune. La floridezza economica di quei tempi, dovuta al grande sviluppo dell’industria della lana, era solo un lontano ricordo. Dal 1312 la situazione peggiorò ulteriormente a seguito delle guerre intestine che affliggevano le città toscane: Prato, insieme alla lega di città che facevano capo a Firenze, composta da Siena, Pistoia, Arezzo, Volterra, Colle Val d’Elsa, San Gimignano e San Miniato, si trovò contrapposta alla Pisa di Uguccione della Faggiola, condottiero ghibellino e vicario imperiale in Italia. Uguccione si rivelò una minaccia concreta per i Fiorentini i loro alleati nel 1315, quando le armate ghibelline collezionavano sempre più successi sui nemici di parte guelfa. Fu proprio in quell’anno (tra l’altro, passato alla storia come il più fulgido per il partito ghibellino in Italia) che Firenze si decise a chiedere aiuto militare a Re Roberto. Quest’ultimo acconsentì, radunando in breve tempo un congruo numero di truppe che, inizialmente, dovevano essere guidate da suo figlio, nonché erede al trono, Carlo d’Angiò (1298-1328), Duca di Calabria dal 1309 e Vicario Generale del Regno. Il comando, però, passò poi all’ultimo momento nelle mani del fratello del Re, Filippo I di Taranto (1294-1332). La colonna partì dunque per Firenze per unirsi al resto dell’esercito guelfo che la lega toscana aveva raccolto per far fronte alla minaccia ghibellina. Lo scontro sembrava giocare a favore dei Fiorentini e dei loro alleati napoletani, vista la loro superiorità numerica. Uguccione, oltre ai Pisani, poteva fare solo scarso affidamento su Lucca, perché questa città era stata presa dai Ghibellini con la forza. Il confronto armato non si fece attendere: la battaglia di Montecatini (29 agosto 1315) sancì la gloriosa vittoria dei Pisani di Uguccione che, contro ogni pronostico, misero in fuga i Fiorentini con i loro alleati. Il comandante napoletano Filippo di Taranto neanche prese parte allo scontro perché, colto da febbre, fu costretto a ritirarsi dal campo di battaglia e a rientrare precipitosamente a Firenze, la cui situazione peggiorava giorno dopo giorno. Roberto d’Angiò, da parte sua, non si mostrò molto preoccupato della sconfitta subita dalle sue truppe in Toscana: Firenze, che dal 1305 si era costituita sotto la sua protezione, rimaneva, con il suo circondario, ancora salda e sicura. Qualche anno dopo, però, tale sicurezza crollò: nel 1325 il baricentro ghibellino da Pisa si era spostato a Lucca che, sotto il suo signore Castruccio Castracani, aveva riscoperto un nuovo periodo di riscossa militare, culminato con la vittoriosa (per i Ghibellini) battaglia di Altopascio il 23 settembre di quello stesso anno. Questa volta, Roberto non aveva inviato alcun aiuto contro il Castracani per favorire i Fiorentini, così, quando questi arrivò addirittura a minacciare la città stessa, essi si rivolsero al Duca di Calabria, Carlo, figlio di Re Roberto, il quale fu eletto dai Guelfi nuovo signore di Firenze a garanzia della protezione angioina sulla città. Carlo accettò e l’anno successivo, nel 1326, il 13 gennaio, si recò a Firenze per prendere possesso del nuovo incarico che gli era stato offerto. Ma la permanenza di Carlo e del suo seguito di Angioini nel capoluogo toscano fu breve: nel 1327, il Duca fu richiamato a Napoli, poiché le truppe tedesche di Ludovico IV il Bavaro (1328-1347), allora Rex Romanorum (1314-1328), minacciavano il Regno nella loro discesa in Italia verso Roma. Si ritiene che il gigliato “pratese” fosse stato battuto intorno al 1326, quindi durante la signoria fiorentina di Carlo d’Angiò, per l’infeudamento di Prato alla casata angioina. Le legende sulla moneta, che vanno lette in modo continuo tra diritto e rovescio, comunicherebbero che Roberto d’Angiò, già Re di Napoli, era anche signore (dominus) di Prato e che il privilegio si estendeva anche ai suoi successori, cioè a Carlo Duca di Calabria. Quest’ultimo, nato dal matrimonio celebrato il 23 marzo 1297 tra Roberto e Jolanda d’Aragona (1273-1302), era l’unico figlio maschio della coppia reale e, nel 1316, contrasse una prima unione, infruttuosa, con Caterina d’Asburgo (1295-1323). Nel 1324, poi, prima di essere chiamato dai Guelfi a Firenze, Carlo sposò in seconde nozze la giovanissima Maria di Valois (1309-1332), dalla quale ebbe la figlia, futura Regina di Napoli, Giovanna I d’Angiò (1343-1381). Appena Carlo si allontanò da Firenze nel 1327, Castruccio ne approfittò per occupare molte città che prima erano cadute sotto la giurisdizione feudale angioina: in nome dell’Imperatore tedesco, il condottiero ghibellino, divenuto intanto Duca di Lucca, arrivò ad attaccare anche Pistoia e Prato. Gli abitanti di questi due centri, soprattutto i contadini che erano quelli più esposti alle scorribande ghibelline nelle campagne intorno alle città, per non subire gli attacchi nemici, scesero a patti con il Castracani: in cambio di un tributo semestrale da pagarsi in denari, i Pistoiesi ed i Pratesi evitarono attacchi e saccheggi da parte dei Ghibellini del condottiero lucchese. In realtà, fino a quando gli Angioini si ersero a garanti della sicurezza dei Guelfi toscani, Firenze e gli altri centri toscani limitrofi non subirono mai il sopravvento della parte ghibellina avversa. Il gigliato “pratese”, dunque, costituisce una moneta commemorativa (e non una medaglia, come credeva Arthur Sambon e com’è riportato anche nel CNI XI) che aveva lo scopo di manifestare la sovranità signorile degli Angioini, di Roberto e di suo figlio Carlo, sui centri guelfi toscani minacciati dall’inarrestabile potenza militare ghibellina. Si potrebbe anche pensare che la moneta circolasse nel ristretto entourage del Duca di Calabria e che difficilmente abbia interagito con la moneta e l’economia locale fiorentina, poiché, come faceva già notare il Sambon, il gigliato era sì una moneta ben accetta all’epoca (quindi magari sarà anche stata accettata in alcune transazioni tra Angioini e Fiorentini), ma era profondamente diversa per caratteristiche fisiche rispetto al sistema monetario ed economico fiorentino. Dobbiamo poi pensare che Prato patteggiò un accordo per non essere occupata dai Ghibellini di Castruccio solo nel 1327, ovvero dopo la partenza di Carlo d’Angiò da Firenze. Dato che Prato non ebbe mai una propria zecca, sembrerebbe più logico ipotizzare che il gigliato in questione fu coniato nel 1326 a Firenze, durante il breve soggiorno del Duca di Calabria in città. Forse la sua breve permanenza e il circoscritto utilizzo del gigliato “pratese”, in unione con lo scopo commemorativo dell’emissione, non consentirono la coniazione di un gran numero di pezzi, anzi, ne frenarono la produzione allo stretto indispensabile per le esigenze degli Angioini, padroni della scena politica cittadina. Dobbiamo poi notare che questa teoria non sembra priva di fondamento, se pensiamo che, a Napoli, la locale zecca incrementò la produzione di gigliati, per volere regio, proprio nel 1326! In questo anno, infatti, furono assunti nuovi manovali in zecca per la lavorazione delle monete d’argento, in vista del successo e delle attenzioni che il gigliato napoletano stava ricevendo in molte parti d’Europa e del Mediterraneo. Ma non furono solo gli Angioini ad aiutare militarmente i Guelfi toscani e ad importare a Firenze il gigliato “pratese” di stampo e peso napoletani: sotto Roberto d’Angiò, le finanze del Regno di Napoli erano quasi monopolizzate da potenti banchieri fiorentini. Pensiamo che molte Compagnie bancarie avevano filiali a Napoli che costituivano il fulcro di importanti guadagni. Proprio con il governo di Roberto assistiamo spessissimo all’affidamento dell’incarico di Maestro di Zecca, ufficio fondamentale per la gestione della stessa, ad esponenti di queste potenti Compagnie. Tra questi ricordiamo: 1. Lapo di Giovanni di Benincasa, un mercante fiorentino, fattore della Compagnia degli Acciaiuoli, fu Maestro di Zecca nel 1317. Fu proprio tra il 1317 ed il 1319 che si decise di inserire sui gigliati dei simboli per poter distinguere l’operato delle diverse maestranze, poiché in molti casi si erano verificati dei cali nel peso effettivo delle monete rispetto a quello teorico stabilito (pari quasi a 4 grammi). 2. Donato degli Acciaiuoli, Maestro di Zecca nel 1324 (al 12 febbraio si data l’appalto per il suo incarico), proseguì la battitura dei gigliati di peso accurato, com’era già stato fatto sotto l’amministrazione dei suoi predecessori, Rainaldo Gattola, di Napoli, e Silvestro Manicella, di Isernia. 3. Petruccio di Siena, Maestro di Zecca nel 1325, anch’egli esponente della Compagnia degli Acciaiuoli. 4. Domenico di Firenze, Maestro di Zecca sempre nel 1325, esponente della Compagnia degli Acciaiuoli. 5. Dopo l’intermezzo del napoletano Rogerio Macedonio, nel 1327, a dirigere la Zecca partenopea troviamo nuovamente un fiorentino, un certo Filippo Rogerio, della Compagnia dei Bardi. 6. Pieruccio di Giovanni, ugualmente fiorentino, fu Maestro di Zecca dopo il 1327 ed esponente della Compagnia degli Acciaiuoli. 7. Sempre in una data posteriore al 1327 a capo della Zecca viene annoverato il fiorentino Matteo Villani, della Compagnia dei Bonaccorsi. Tutte queste Compagnie bancarie fiorentine avevano, attraverso il controllo dell’ufficio di Maestro di Zecca, oltre a rapporti commerciali di favore tra Firenze ed il Regno, anche il sopravvento sulla gestione della moneta regnicola e sulla sua circolazione. I Bardi, presso la cui filiale di Napoli lavorò anche il padre di Boccaccio, gli Acciaiuoli e i Bonaccorsi, insieme ad altre Compagnie fiorentine, fallirono a seguito del mancato saldo del debito che i Re si Francia ed Inghilterra avevano contratto con i Fiorentini a seguito dell’allestimento degli eserciti per la Guerra dei Cent’anni. Anche Roberto d’Angiò aveva un grande debito con gli Acciaiuoli, che di fatto erano i banchieri della Casa d’Angiò e tenevano in mano le finanze di mezza Napoli, in quanto questi ricevette un primo prestito di ben 50.000 fiorini d’oro e suo figlio Carlo, Duca di Calabria, beneficiò di un secondo prestito pari a 18.500 fiorini. Dopo la mancata restituzione delle somme dovute dai sovrani francese ed inglese, Roberto non saldò il suo di debito usando come precedenti le insolvenze degli altri due Re, Filippo VI ed Edoardo III. Ma gli Acciaiuoli beneficiarono grandemente della benevolenza regia: sotto Roberto, Niccolò Acciaiuoli fu nominato prima cavaliere e con l’avvento di sua nipote, Giovanna I, fu invece creato, nel 1348, Gran Siniscalco del Regno. Fu proprio Niccolò a farsi promotore del (secondo per la sovrana) matrimonio tra Giovanna I e Luigi di Taranto (1352-1362). Quando questi morì, il 26 maggio del 1362, l’Acciaiuoli fu il principale protettore dei diritti della Regina angioina (a cui, tra l’altro, doveva tutte le sue fortune) quando altri nobili ne minavano il potere. Ma, ritornando in Toscana, Prato rimase ancora per poco tempo in mano angioina: morto Roberto a Napoli, il 16 gennaio 1343, (Carlo era già morto il 9 novembre 1328) Firenze tentò, a partire dal 1350, di conquistare con la forza la città vicina, vedendo la morsa angioina allentarsi dai comuni toscani come un’occasione di rinascita politica. Nel 1351, con un atto cancelleresco approvato da Giovanna I, la Corona di Napoli cedeva i diritti feudali di Prato a Firenze dietro pagamento di una somma ammontante a circa 17.500 fiorini. Anche dietro questo atto si nasconde un disegno politico di Niccolò Acciaiuoli che, in virtù della propria influenza sulla Regina napoletana, spinse la sovrana a concludere un accordo remunerativo con Firenze. Da allora, la città di Prato non è mai uscita più dall’orbita fiorentina.1 punto
-
DE GREGE EPICURI Al CCNM (Milano, via Terraggio 1) martedì 30 ottobre 2018 alle 20.45 esamineremo insieme le monete "difficili" che ciascuno di noi porterà, quelle non classificate o quanto meno dubbie. Non siamo in grado di convocare degli esperti esterni: utilizzeremo la ricca biblioteca del Centro, e con l'aiuto dei soci più esperti nei diversi settori osserveremo e inquadreremo al meglio le singole monete. Chi possiede cataloghi di difficile reperimento e non presenti nella nostra biblioteca è pregato di portarli con sè. Si tratta anzitutto di utilizzare una metodologia adeguata; e di muoversi, passo passo, verso la soluzione appassionante dei problemi...Fare tutto questo insieme è molto bello, ma anche molto utile.1 punto
-
Buonasera, Riconfermo la mia presenza al tavolo delle mediovali e aggiungo che un evento con 'monete in mano ' che non sia un appuntamento a carattere commerciale è sicuramente una novità graditissima e benvenuta.1 punto
-
Ho avuto anch'io la stessa sensazione, certe volte mi sono trovato a disagio a leggere certe cose. far finta di niente o guardare altrove NON è mai una soluzione. ================== È solo grazie alle tante persone competenti, gentili ed altruiste che compongono in maggioranza questo forum, che posso sorvolare sulle minoranze estremiste, ma non vuol dire che le ignoro. Ricordiamoci: la mia libertà finisce dove comincia la tua! Servus, NJk1 punto
-
Beh, certo che accettiamo la decisione dell'Utente, ci mancherebbe...però mi pare anche giusto capire se l'allontanamento é causato da un comportamento offensivo o se invece e dovuto ad altro. In questo secondo caso non possiamo farci nulla. M1 punto
-
Ho sottomano il Corpus della Taliercio. Si tratta del suo Gruppo IIa, ma sembra essere un ibrido del suo diritto n. 33 (= Sambon 647, con monogramma AP dietro la nuca) col suo rovescio n. 31 (= Sambon 639, con scudo sopra il toro e spada nel fodero sotto l'esergo, qui non visibile a causa della fessura del bordo). Un pezzo raro e interessante...1 punto
-
Ciao @rickkk 4 anni di riposo in vassoio ha giovato alla moneta. E' notevolmente migliorata nell'aspetto e la patina le conferisce tridimensionalità accentuandone i rilievi. Ha acquistato personalità saluti1 punto
-
L'esemplare di Bertolami è effettivamente di grande interesse, sia per la rarità sia per l'alta conservazione. Una mia perplessità riguarda il muso del delfino, che appare essere troppo affilato rispetto ai pochi noti esemplari autentici. Ovviamente servirebbe una maggiore comparazione e invito a controllare questo dettaglio, come anche su alcune lettere dell'etnico retrogrado (alcune sembrano piuttosto schematizzate). Al momento confronto il Bettolami con il pezzo NAC (di sicura autenticità):1 punto
-
Visto che celebra la Monte dei Paschi di Siena magari è solo placcata d'oro .1 punto
-
i parametri per stabilire il grado di conservazione di una moneta penso che cambiano se parliamo di una moneta antica, medioevale puttosto che contemporanea lo scopriremo ...1 punto
-
Io direi che parlare di cose che non sappiamo non sia corretto, certo i curatori sanno di più per la discussione che ha fatto a luglio 2017 ma ognuno ha giustamente il suo sentire e agire di conseguenza, lasciamo almeno la libertà a ognuno di fare quello che ritiene, forse spropositato, ma legittimo, direi che c’e’ altro poco da dire, solo lui potrebbe aggiungere qualcosa ...spero che capiate ...1 punto
-
Aggiungiamo che non e’ dipartito nel senso non lamonetiano ...meglio dirlo non si sa mai ...1 punto
-
Ciao @Silver70 grazie. La microscopia per me è sempre stata una materia appassionante, tant'è che per alcune analisi gemmologiche il microscopio me lo sono auto assemblato recuperando tutti i componenti e montandoli in base alle mie esigenze. Questo che ho utilizzato (un vecchio Vickers acquistato usato per pochi euro ma perfettamente funzionante) ha una doppia funzione sia come mettalorafico che petrografico, che posso utilizzare anche in campo gemmologico, insieme ad altri due di altro tipo. Mi piacerebbe avere un microscopio elettronico, ma è fuori della mia portata, anche se ho visto che su ebay USA si può trovare usato, ma ci vorrebbe una stanza solo per quello!1 punto
-
se qualcuno è interessato all'acquisto di questi libri, che sono gli ultimi pubblicati da Storia Patria di Genova e dall' Astengo (Circolo Numismatico Ligure), li porto (la mattina), altrimenti il secondo non lo porto che pesa. I due libri sono: - Mazarakis 2018, il Ducato di Venezia e le sue imitazioni nell'Oriente Latino tra il XIV e il XVI secolo (costo 15 euro) - duemila monete della collezione Giovanni Dattari di Figari, Mosconi (costo 50 euro) a sabato 10 mattina. Marco p.s l'argomento del workshop è molto interessante1 punto
-
Moneta di difficile reperimento. Si tratta di pezzi rari. Ottima la conservazione! Complimenti per l’acquisto!!1 punto
-
Buongiorno Claudio, wow, ottima analisi scientifica, mi hai fatto venire in mente il laboratorio di microbiologia delle superiori (I.T.I.S G.Marconi di Forlì) , dove avevamo a disposizione sia questo tipo di microscopio ottico (uno a testa) che un microscopio elettronico che effettuava ingrandimenti pazzeschi (erano gli anni 80'). E' fantastico poter analizzare in tal modo gli effetti di un lavaggio e ti ringrazio per averci deliziato con queste belle immagini. Sto meditando, eccome se mi fai meditare! Buon fine settimana Silver1 punto
-
Ecco un'altra foto, la patina molto scura non permette alla mia fotocamera di captare bene il lustro che pero e notevole, se ne vede alcune tracce a sinistra dello scudo. Vicino alla R di regno la deformazione al bordo e causata da un nodo d'amore impresso molto decentrato. Anche le foto del venditore non erano un gran che, per questo l'ho presa a meno di 20 euro. Grazie a tutti dei vostri commenti! Lorenzo1 punto
-
Quoto in pieno il consiglio di @adelchi Io a 16 anni (nel ‘98, quando internet non era come adesso, e il forum non c’era), mi scervellavo dietro ai follari con San Demetrio e utilizzavo la tessera della biblioteca della mia ragazza per prendere in prestito libri di numismatica. Però appunto avevo una ragazza e non perdevo occasione di mollare le monete per uscire con lei o gli amici. L’adolescenza dura poco e non ritorna, quindi goditela a pieno e dai priorità a quello di unico che ha da offrire (ragazze e spensieratezza) per le monete hai tutto il resto della tua vita ?1 punto
-
Vabè, io compravo monete da quando andavo alle medie (o 5 elementare, quasi non me ne ricordo più). Non andava di moda allora come non va di moda adesso nè probabilmente 50 anni fa. Il fatto che sia considerato da vecchi non vuol dir nulla, implica solo che dai ragazzi non viene vista come una cosa appealing dal punto di vista sociale oltre che un hobby generalmente associata ad un pubblico anziano. Basterebbe vedere un video su youtube con Cristiano Ronaldo o la Ferragni che fanno i fighi con onze da 30 tarì siciliana o un sesterzio in mezzo a macchine superlusso e brand all'ultimo grido e da domani la numismatica verrebbe vista diversamente dai ragazzi. La numismatica è strana, perchè è un interesse che colpisce in maniera molto casuale persone che sono contemporaneamente attratte dal lato artistico-storico-culturale-sociale della moneta, oltre che dal desiderio di possederla (in senso non biblico ovviamente). Si arriva ad un certo tipo di collezionismo generalmente dopo anni di maturazione. Difficile per un ragazzo cominciare a collezionare monete di nicchia, come monete rinascimentali, normanne o bizantine. nella quasi totalità dei casi i ragazzi cominciano col mettere da parte la moneta corrente e ampliare la "raccolta" delle monete del nonno. Ossia si comincia con repubblica e V.E. III. Credo che il virus sia più o meno equamente distribuito e che il numero di collezionisti giovani sia grossomodo sempre lo stesso al variare degli anni L'unica differenza è che quando si è ragazzi si è più influenzati dalle mode e si ha meno coraggio di parlare di hobby lontani dalla mentalità altrui, in un certo senso si ha la tentazione di uniformarsi agli altri. Poi per fortuna gli anni passano e generalmente nel periodo universitario uno fa quello che ca..o gli pare, hobby compresi La tabella mostrata da Monetaio va presa con le pinze. Quella rappresenta la platea dei suoi clienti, non dei collezionisti. E' fisiologico che i suoi clienti siano prevalentemente persone con amplia disponibilità economica (questo elimina la fascia giovanile) e con propensione maggiore alla spesa in hobby (questo taglia gli under 35-40 che generalmente divisi tra lavori precari, figli in fasce e mutui da pagare). Che la numismatica sia prevalentemente maschile, invece, quello è un dato di fatto. Ricordo un bellissimo post a riguardo iniziato da @Antwalia (non riesco a citare correttamente il nome nè a ritrovare il post... peccato).1 punto
-
Posso darti un consiglio ? L'arte va bene ,la numismatica anche , ma cerca di non perdere di vista lo scopo ultimo dei ragazzi della tua eta : le ragazze ! Non mi diventare un secchione e cerca di usare il tuo hobby e la cultura acquisita grazie alle tue passioni come arma segreta per conquistarle , usala con parsimonia e oculatezza , senza pedanteria ,e I risultati non mancheranno .1 punto
-
@Giulicarp Bella la tua moneta . Conosco poco la monetazione di Parma ma dati ponderali simili fra denaro e obolo (nel caso 1/4 di denaro imperiale), come tu dici, mi intrigano. Generalmente le mezzaglie sono realizzate con punzoni appositi e presentano un conio di dimensoni più piccole. Se hai a disposizione un denaro di sicura classificazione potresti misurare il diametro del cerchio interno e confrontarlo con quello della tua moneta. Spero sia obolo, chiaramente. Conosci questo? https://www.academia.edu/543094/Moneta_e_circolazione_monetaria_a_Parma_nel_medioevo @teofrasto è un nostro caro amico nel forum ed è uno fra i grandi esperti della zecca di Parma. Vediamo se interviene Saluti1 punto
-
Se può essere d'aiuto una "foto" sull'utenza (clienti) del nostro sito... Direi che dia una panoramica abbastanza chiara sullo status.1 punto
-
Ciao a tutti, ciao @gennydbmoney! Era in asta sulla baia: Médaille de pèlerinage, Diocèse de Nice (medaglia del pellegrino) https://www.ebay.fr/itm/Medaille-de-pelerinage-Diocese-de-Nice-Ref-75-/292689062717?nordt=true&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.m43663.l44720 23 Servus, Njk1 punto
-
Buonasera a tutti, per non smentire la mia fama di amante dei catorci vi propongo stasera l'ultimo ingresso in collezione, un Mezzo Scudo di Pio VI del 1796 nella sua variante più rara, quella con le chiavi con impugnatura tonda, che il nostro catalogo considera R3. Il pezzo è molto vissuto, ma non è appiccagnolato e la legenda è perfettamente leggibile. Dato il prezzo contenuto (50 euro) mi pareva sensato chiudere il buco. In mano mi dà una bella sensazione e sono quindi soddisfatto del mio nuovo amico. Al di là di quello fotografato sul catalogo non ho trovato foto di esemplari analoghi nelle discussioni precedenti - l'unica che ho reperito era troppo vecchia e le immagini erano sparite - e volevo quindi chiedere se a qualcuno andasse di mostrare il proprio. Buona serata a tutti1 punto
-
Nikita indossato e senza data in Standing Liberty quarter è stato anche nei suoi ultimi giorni, quando ero un ragazzo--sono stati sempre un ritrovamento speciale, ma il piacere è stato sempre temperato: le cose darn non aveva date.... Una vecchia e divertimento Standing Liberty quarter. La posizione delle stelle inverse (che lei ha menzionato) e il originale incasso piedistallo significa che la tua moneta è un prodotto 1917-1924. Noto anche--per chi potrebbe aver bisogno di sapere più tardi—che il 1916-1917 Liberty Standing tipo possono essere accuratamente attribuito per data e zecca, anche con le loro date completamente logorato. v. -------------------------------------------------- Nikita’s worn and dateless Standing Liberty quarter was also in its last days when I was a boy—they were always a special find, but the pleasure was always tempered: the darn things had no dates…. A fun old Standing Liberty quarter. The position of the reverse stars (which you mentioned) and the original, unrecessed pedestal mean your coin is a 1917-1924 product. I note too—for anyone who might need to know later on—that the 1916-1917 Standing Liberty type can all be accurately attributed by date and mint, even with their dates completely worn off. v.1 punto
-
Ho visto molti di questi circulating all'inizio e alla metà degli anni sessanta. Li teneva e li ho spesi come un ragazzino--ma non troppi--un quarto era un sacco di soldi per un ragazzino allora. (Una soda pop, una barretta di caramelle, e cinque pezzi di gomma da masticare! Ma solo con il permesso parentale.) Le monete d'argento americane partirono in circolazione solo pochi anni dopo, quindi questo '42 Washington assomiglia a un pezzo tipicamente conservato da quei giorni. v. ------------------------------------------------------------- I saw many of these circulating in the early- and mid-1960s. Held them and spent them myself as a little boy—but not too many—a quarter was big money to a little kid back then. (A soda pop, a candy bar, and five pieces of bubble gum! But only with parental permission.) American silver coins departed circulation only a very few years later—so this ’42 Washington looks like a typically preserved piece from those days. v.1 punto
-
ciao a tutti, dalle foto direi che il rame non sia stato trattato. le zone nere sono punti di normale ossidazione del metallo, che non dimentichiamo rimane molto suscettibile all'ambiente circostante. Le macchioline verdi sono però degne di attenzione. come la frutta naturale che appare meno "invitante" (quella che per capirci a volte ci potrebbe regalare l'amico od il vicino col piccolo orticello) di quella che troviamo nella normale catena di distribuzione, il rame non lavato può avere zone annerite, punti di ossidazione tipici del metallo. A me piace. Preferisco un esemplare così, a quelli vistosamente rossi. Per me moneta non circolata. Nella zona del collo, dove c'è quel "colore più chiaro" è visibile il lustro del metallo. c'è anche da considerare che la foto potrebbe nascondere eventuale brillantezza, enfatizzare le zone di ossidazione o alterare la reale tonalità del rame. vista così, a me piace, e secondo me un qfdc ci sta1 punto
-
Mentre ci pensate vi mostro quest'altro scovato in rete con legenda sospetta, nella migliore delle ipotesi ha un segno (lettera?) in più tra la "R"e la "I"di ENRICVS secondo voi può essere la gambetta della R?1 punto
-
Taglio: 20 cent Nazione: San Marino Anno: 2008 Tiratura: 1.168.360 Conservazione: BB Località: Milano Note: 2 monete Taglio: 20 cent Nazione: San Marino Anno: 2016 Tiratura: ??? Conservazione: BB Località: Milano Taglio: 20 cent Nazione: San Marino Anno: 2017 Tiratura: ??? Conservazione: BB+ Località: Milano Note: 2 monete1 punto
-
Buonasera a tutti, Condivido l'ultima moneta appena entrata in Collezione: FERDINANDO IV PIASTRA 1798. Variante per punteggiatura: FERDINAN. IV D. G. SICILIAR ET HIE REX Ha al dritto dei graffi di conio sulla guancia, ma non presenta colpi e eccessiva usura sui rilievi. Come vi sembra.1 punto
-
naturalmente il pezzo in vendita e' FDC invece a quel morto di fame del Principe di Luynes hanno venduto un pezzo usurato perche' il poveretto non poteva permettersi di pagare di piu'1 punto
-
Ci sono dei particolari, visto lo stato di conservazione più elevato rispetto all esemplare nac, che andrebbero maggiormente evidenziati. Potete postare L esemplare di HNItaly? Provo a recuperare quello de luynes.. grazie skuby1 punto
-
ASTE MEDAGLIE PAPALI SETTEMBRE 2018 Nel decorso mese di settembre ha avuto particolare rilievo l'asta on line di SOLIDUS, riguardante esclusivamente una collezione di oltre 300 lotti, che spaziavano dalle medaglie di restituzione dei papi più antichi alla famosa medaglia con errore di papa Francesco. Sono state già illustrate in anteprima con i prezzi di aggiudicazione le foto delle medaglie più contese; ad esse vorrei aggiungere: - Pio VII - annuale oro anno XX - € 11.000 +diritti; - Pio VIII - Lavanda oro - €11.000 +diritti; Pio XI - Straordinaria elezione con stemma - Cusumano e Modesti 1 : oro - € 5.000 +dirittti; argento € 700+diritti. E' stato chiesto da numa numa se si conosca il collezionista. Non mi sono noti nome e residenza; ma posso ricordare che i pezzi più importanti di questa collezione sono stati acquistati in anni recenti e, quando necessario, contesi con grande decisione ed evidente impegno a realizzare una collezione importante. Spiace pertanto l'abbandono di un medaglista appassionato e impegnato. Nella vendita le aggiudicazioni si collocano intorno al 50% dei lotti offert e meritano una analisi: - medaglie di restituzione (circa 50 lotti) - aggiudicazioni 30%; - medaglie antiche (circa 70 lotti) - aggiudicazioni 50%; -medaglie secoli XVII-XVIII (circa 80 lotti) - aggiudicazioni 60%; - medaglie 1800 ( circa 75 lotti) - aggiudicazioni 35%; - medaglie moderne (circa 60 lotti ) - aggiudicazioni 40%, ma con vendita molto elevata per i papati Pio X/PioXI. Anche se alcuni esemplari hanno avuto buona richiesta da parte dei collezionisti (rinvio a foto e prezzi pubblicati in anteprima), l'invenduto è alto e molte quotazioni raggiunte sono al di sotto dei livelli normali registrati in precedenza nel mercato. Considerazioni oggettive impongono di segnalare che alcune medaglie erano state acquistate a prezzi molti elevati (e, in qualche caso, guardando attentamente, non manca il dubbio di fusioni o coniazioni posteriori). Aggiungo che il contorno, che affiancava le medaglie più rare, non era a mio giudizio adeguato. Le medaglie di restituzione sono medaglie "povere", soprattutto se non provengono da fusioni accurate; nelle medaglie antiche c'erano diverse copie fuse o coniazioni posteriori; quanto alla conservazione era buona, ma non particolarmente selezionata . Ciò mi porta a concludere che la discontinuità dei risultati non è forse da attribuire ad un mercato poco interessato, ma è da coordinare con una collezione certamente interessante, ma non eccezionale. ASTA V.L.NUMMUS E' stata proposta una selezione di medaglie papali (circa 30 lotti) con importanti esemplari, soprattutto in argento, fino a papa Pio IX. Le aggiudicazioni risultano del 60% circa e si collocano di norma su un livello medio-alto del mercato. Le quotazioni più rilevanti sono state pubblicate in anteprima con foto della medaglia e indicazione della conservazione. ASTA WAG Merita una evidenza questa asta, con circa 10 lotti di medaglie papali rare o molto rare , venduti quasi in toto e con quotazioni sostenute (anche per queste rinvio alle foto pubblicate in anteprima ). Evidenzio ancora come la bella medaglia annuale di Alessandro VII - anno VIII in argento sia stata aggiudicata per € 1.400+diritti) a fronte di un prezzo base di € 600; un po' eccessive mi sono sembrate le quotazioni raggiunte dalla medaglia in argento di Sisto V (Modesti la considera posteriore) e soprattutto dalla medaglia di Adriano VI (nella descrizione si parla di medaglia fusa). Passando a parlare delle aste con materiale abbastanza comune, ricordo quelle on line in Italia di ARTEMIDE e INASTA. ARTEMIDE ha proposto circa 20 lotti di medaglie antiche (con diversi riconi ) e ottocentesche, con prevalenza del bronzo, e ha aggiudicato il 50% circa di detti lotti a prezzi ordinari. INASTA ha proposto circa 50 lotti con prevalenza di materiale moderno. Alto è stato il livello delle aggiudicazioni (80%). Va precisato che i prezzi base erano molto invitanti; nella maggior parte dei lotti le quotazioni sono salite ai livelli ordinari; in parte il collezionismo attento ha potuto acquistare a prezzi vantaggiosi. Per le aste estere ricordo in particolare WAG on line con circa 20 lotti (in massima parte riconi Mazio in bronzo), venduti quasi in toto ad un prezzo medio di € 50+diritti. Una proposta quantitativa minore di medaglie papali era nelle aste Elsen, Leipziger e Teutoburger (mediamente 10 lotti con molti riconi e medaglie ottocentesche in bronzo), che hanno avuto ottime percentuali di venduto a prezzi consueti. La richiesta è invece mancata in analoga proposta della casa di aste FISHER.1 punto
-
@Archestrato Ciao, Dopo alcune ricerche, che ho fatto recentemente, ritengo che il padre di Tom Virzì potesse essere Ignazio Virzì nato nel 1852 (Gnecchi "Guida Numisamtica", 1904, pagina 343), anche se lo Gnecchi (per Ignazio) e il Cagiati (per Tom in "Annuario Italiano per I Numismatici e raccogliatori ect…", 1926, pagina 208) riportano due vie diverse per le rispettive abitazioni: via Cintorinai (per Ignazio) e Centurinai (per Tom), Palermo. Forse è un errore di stampa, il Rolla riporta invece via Centurioni (per Tom). Ignazio Virzì (console a Palermo per il Guatemala) era un collezionista di monete greche. Nel 1894 acquistò un ripostiglio di monete di d'Imera, erano tutti di tetradrammi (RIN 1894 pag. 399). Perciò, non è da escludere che parte della collezione del padre confluì in quella del figlio Tom. Inoltre, l'asta Hirsch 1907 non riporta il nome di Tom Virzi nel titolo. Se è corretto attribuire questa collezione ai Virzì si potrebbero avere tre differenti scenari: 1) Collezione Tom Virzì 2) Collezione Ignazio Virzì 3) Collezione mista padre e figlio Nel mio esemplare del catalogo Hirsch è riportato: "Ignazio Virzi according to Hirsch" però la scrittura non è coeva ma molto posteriore. Ciao1 punto
-
Il fiume Gelas, rappresentato come toro androcefalo con testa matura e barbuta, è emblema pressochè costante nella monetazione in argento di Gela : in alcuni rarissimi coni di fine V sec. è invece rappresentato con una testa giovane ed imberbe . Dalla rete 3 di questi esemplari di tetradrammi, 2 con testa di lato, il terzo,probabilmente unico noto, con testa di fronte . Di questa tipologia unisco anche l' ugualmente raro didramma con testa di lato e con la particolare scena di combattimento al diritto .1 punto
-
No, non è fortuna. E ' serietà di un operatore corretto che rispetta le regole e rispetta il cliente.1 punto
-
Salve a tutti, volevo chiedervi informazioni relative a questi tipi di brockage, visto che su internet ho trovato poco o niente, quanto sono effettivamente rari ? Vi ringrazio!!1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?






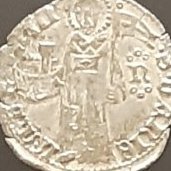














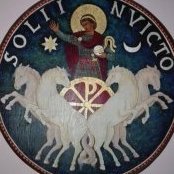
AdolfoViperetta.thumb.jpg.567df83d4aa18c98f435a6b9921cca31.jpg)






