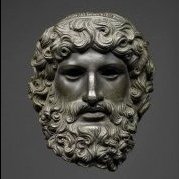Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 08/28/19 in tutte le aree
-
Come promesso vi allego il link del Gazzettino 5 ora pubblicato sul nostro sito in Accademia.edu. Dopo soli tre mesi dalla presentazione e consegna delle copie cartacee avvenuta al Convegno di Verona ora la pubblicazione per tutti on Line con la possibilità di leggerlo e poterlo anche stampare a colori Ci si augura che anche questa ulteriore fatica divulgativa per la comunità fatta a più mani, e che ricordiamo e’ a costo zero per l’utenza, possa essere piacevole e utile, indubbiamente lo sforzo di autori, editing, pubblicazione della stessa e’ stato totale e importante, buona lettura ! https://independent.academia.edu/QGazzettini5 punti
-
Buongiorno a tutti, Altro nominale del 1802 è il 6 Tornesi, difficile da trovare in buona conservazione e senza difetti di conio. Condivido il mio esemplare, spatinato ( non sono stato io) e con corrosione al dritto sul volto di Ferdinando IV.3 punti
-
Mi sa che questa sarà l’unica certezza di questo post... Le bruciature di luce presenti in foto (specie al rovescio) rendono poco chiara la valutazione dei dettagli. Inoltre bisogna tenere conto che molte volte i particolari più minuti come i dettagli dell’armatura dell’Italia (seni ed elsa della spada) potrebbero risultare un po deboli di conio, come anche il dritto, nei capelli. La luce quindi può benissimo dare impressioni altamente falsate. Personalmente darei una valutazione orientativa sullo spl/fdc. Lustro c’è, è palese, e ciò la rende oggettivamente incompatibile con un grading inferiore allo spl. la briglia del cavallo mi sembra invece al suo posto (dettaglio che coincide col punto più alto del modellato nel rovescio), quindi il rovescio teoricamente potrebbe non essere afflitto da tutta questa usura. Questo è quello che personalmente intuisco dalle foto.3 punti
-
Io sono di parte... Ma cercando di essere obiettivo bisogna ammettere che il periodo del regno e specialmente Vittorio Emanuele III ha sempre molti estimatori. Questo è dovuto, a parer mio, anche al fatto che il Regno ha interessato tutta la penisola, quindi un maggior numero di persone "toccate" da questa monetazione, senza voler sminuire il fatto che essendo stata prodotta da un numismatico sia una monetazione varia e curata, come già detto, anche con stili influenzati da mode e gusti del periodo. Non voglio sminuire neppure le classiche, romane in primis, che hanno una platea di interesse ancora maggiore, un carico di storia enorme ed il vantaggio di un gran numero di esemplari in circolazione, questo permette certamente di portare a casa, con poco, pezzi storicamente interessanti e di gran pregio stilistico. Però devo spezzare una lancia per le mie amate savoiarde... monetazione con nove secoli sulle spalle, non mi risulta nessuna produzione di una casata così lunga, ha attraversato il tempo dal pieno medioevo all'epoca moderna con quindi l'influenza e la variazione di stili come nessun'altra monetazione puo fare! Il guaio è che come me la pensano in tanti... troppi.. mi sarebbe più facile collezionare se fossimo in meno ad essere interessati a questi tondelli.. Resta il fatto, già rimarcato più volte, che il mercato è cambiato, la situazione economica porta ad avere persone benestanti sempre con maggiore disponibilità e persone che prima potevano permettersi qualche sfizio in più a dover rinunciare a qualcosa (leggasi : ricchi più ricchi e poveri più poveri) questo porta a cercare, per chi può, il pezzo più pregiato (conservazione+rarità) a discapito del valore del pezzo meno conservato. Per me può essere un bene per il semplice collezionismo numismatico, la moneta meno bella ha lo stesso carico storico (se non maggiore) del pezzo splendido, ed ora si può trovare più facilmente, ma parlo di numismatici e non di accumulatori.3 punti
-
Direi di sì, nel rispetto della responsabilità dei singoli autori, siamo disponibili a pubblicare anche ipotesi o riflessioni che magari non sarebbero accolte e pubblicate da tutti, oggi non e’ cosa di poco conto tenendo conto anche della scarsità ormai di pubblicazioni numismatiche cartacee e anche digitali. Sara’ poi la comunità scientifica e i lettori ad esprimersi, indubbiamente facendo questo prodotto andiamo controcorrente con una scommessa che vogliamo fare per scopi divulgativi e culturali, oggi al quasi sesto numero siamo già oltre alla scommessa ma di fronte a una realtà che si sta consolidando e che dovrebbe far felici tutti visto che poi e’ gratuita.2 punti
-
Per confronto, condivido il mio 1789 Riferimenti: MAGLIOCCA 338 Comune Cosa mi consigliate per levare quello spesso strato di sporco?2 punti
-
Già ci capisco poco della £ Rep.Italiana ,, e ho il mio bel da fare per imparare qui sul forum ; se mi avventuro anche nelle altre …..è sicuro che non ci capirò più nulla. Meglio concentrarsi su una tipologia e imparare bene quella... rischio di strafare e cadere nell'ignoranza numismatica globale------2 punti
-
Certo, si tratta di una pubblicazione aperta a tutti i possibili autori e a tutte le possibili tesi (ovviamente purchè siano ben presentate e fondate), anche a quelle che fanno storcere il naso ad altre testate "più impegnate"...2 punti
-
Con l'avvento di Diocleziano si pose fine a quel periodo noto come crisi del III secolo, un periodo che vide pressione ai confini e lotte interne caratterizzate soprattutto dalla volontà dell'esercito di elevare al rango di Augusto un generale piuttosto che un altro. Il nuovo Augusto si trovò a dover affrontare una profonda crisi economica e pose in essere una serie di iniziative atte a far fronte alle nuove esigenze del sistema tetrarchico che imponeva tra l'altro maggior circolante necessario a pagare un esercito tanto numeroso. Dopo aver nominato Massimiano come Augusto d'occidente e Galerio e Costanzo come cesari, Diocleziano nel 294 d.C. attua un riforma monetaria che prevede non solo la rivalutazione della moneta aurea portandola nuovamente a 1/60 di libbra romana (5,41gr) ma anche l'emissione di un nummus argenteus dal peso di 1/96 di libbra romana pari a 3,41 grammi con un valore pari a 100 denarii comunes. Viene inoltre introdotto un nummus argentiferous, oggi viene comunemente chiamato follis, dal peso di circa 10 grammi quindi corrispondente a 1/32 di libbra e con un valore nominale ancora oggi dibattuto che potrebbe essere di 10 o 12,5 denarii communes. I radiati continuano a essere battuti, ma a differenza di prima non più argentati e con un valore pari a 2 denarii communes. A questi si affianca la moneta laureata, proprio quel denario che da tempo non è più d'argento ma in metallo vile, la moneta di conto in cui vengono espressi tutti i prezzi. Questa moneta di rame con un peso approssimativo di 1,5 grammi e che successivamente diventerà effettivamente un terzo di follis o genericamente una frazione di follis. Questi divisionali avevano un valore troppo basso rispetto a quello nominale e la logica conseguenza fu quella che il mercato impose un proprio tasso di cambio con le monete di metallo nobile. L'inflazione dilagante generò una diminuzione del potere d'acquisto della moneta e portò all'emanazione di quello che oggi conosciamo come editto di Afrodisia. Questo editto emesso in un periodo imprecisato del 301 d.C., ma del quale è conosciuta la decorrenza dal 1° settembre, raddoppiava il valore nominale delle monete enee circolanti ristabilendo nelle intenzioni il potere d'acquisto originario. L'editto di Afrodisia, trovato parzialmente completo, permette di scoprire quindi che la bicharactam pecunia aveva un valore di 4 denarii communes (qvae in maiore orbis partec... qvattvor denariorvm) mentre la nostra monetina in rame passava dal valore nominale di un denario communes a due. L'editto scoperto nel 1970, e quindi successivamente alla pubblicazione del RIC, riporta quindi come detto in precedenza che la moneta radiata emessa in oriente viene comunemente conosciuta come Bicharactam Pecunia, chiara allusione all'iconografia del rovescio CONCORDIA MILIT che mostra sempre due figure distinte. Anche il nummus argentiferous (follis) aveva raddoppiato il suo valore arrivando adesso ad almeno 20 denarii communes, su questo cifra non tutti sono unanimemente convinti, sempre un frammento riporta "..]TIQVINQVE", che apparentemente si riferisce al valore della moneta dell'editto e che Hendy interpreta come [VIGIN]TI QVINQVE, quindi 25. L'editto di Afrodisia non portò i risultati sperati, anzi la situazione peggiorò rapidamente e drasticamente, si arrivò a un aumento vertiginoso dei prezzi ormai incontrollabili. Venne quindi poco dopo promulgato il conosciuto editto dei prezzi, "Edictum de pretiis rerum venalium", tale editto altro non era che un calmiere dei prezzi, imponeva quindi quale fosse il prezzo massimo da pagare per un determinato bene o servizio. Tornando ai nostri piccoli laureati cosa ci permettevano di acquistare con queste piccole monete? L'editto ci viene in aiuto e ci dà un'idea del potere di acquisto del tempo. Scopriamo così che con 4 denarii communes era possibile acquistare un sextarivs di lupini cotti o dieci mele di prima scelta. Un nostro follis ora valeva 20 o 25 denarii communes (a seconda della tesi sposata, affronteremo in un secondo momento i valori probabilmente inseriti nei campi dei follis orientali), dall'editto deduciamo che questa moneta era la paga giornaliera per un pastore o il costo di un sextarivs di Vino rosato o ancora il costo per miglio del trasporto di un moggio su una barca fluviale. Con l'abdicazione nel 305 d.C. l'editto di Diocleziano viene messo da parte, il nummus argentiferous mantiene il suo valore di 20/25 denarii ma viene portato nel 307 d.C. a 1/48 di libbra corrispondente a 6,5 grammi. Prima di questa riforma a Siscia e stranamente solo in quella zecca vengono emessi dei laureati con rovescio GENIO POPVLI ROMANI. Ormai l'editto dei prezzi era accantonato ma i prezzi sicuramente sarebbero stati visti al rialzo, con pugno di monete come quelle in foto ci saremmo forse potuti permettere dipendentemente dal valore della singola moneta una libbra di camoscio o una pelle di antilope o un pettine in legno. Constatino in occidente avvia il follis a una continua svalutazione seguito da Massimino Daia in oriente, Massenzio da parte sua invece non segue le riforme costantiniane e mantiene immutato il peso fino alla sua morte. 310 d.C. 5,4gr 1/60 libbra 312 d.C. 4,51gr 1/72 libbra 313 d.C. 3,38gr 1/96 libbra Dopo la morte in Massenzio anche la zecca di Roma si adegua alle altre zecche galliche ma mantiene il sistema monetario di Massenzio emettendo il 2/3 di follis da 16 denarii communes e il mezzo follis da 12 denari, monete con percettibili differenze di peso e modulo. Come possiamo vedere in queste emissioni del 312 d.C. vengono riportate nei campi i valori nominali della moneta. Non è ben chiaro se il follis aumenta il suo valore nominale da 20 a 25 o se continua semplicemente a valere 25 denarii communes come avveniva in precedenza. L'emissione VIRT EXERCIT GALL ha anche un’altra particolarità oltre all'indicazione del valore, come si vede dalla foto di questa bellissima moneta di @Tinia Numismatica abbiamo la presenza al diritto della corona radiata che solitamente è associata a un valore doppio (dupondi, doppi sesterzi e antoniniani). In realtà, come è riscontrabile anche nella serie elmata e radiata dei follis di Lugdunum si tratta di un chiaro riferimento all'iconografia Costantiniana del Sol. Come accennato nel 313 d.C. il peso del nostro nummus argentiferous viene ulteriormente ridotto ma da questo momento in poi non abbiamo molti riscontri su cosa accade tra Costantino e Licinio, dei loro diversi sistemi monetari e dell'introduzione del centenionale (100 denarii communes) con la VICTORIA LAETAE PRINC PERP, questo è un tema che va affrontato separatamente. Cope, Lawrence. "Diocletian's Price Edit and its associated coinage denominations", 1977, pages 7-12. Zschucke, Carl-Friedrich. "Die Bronze-Teilstuck-Pragungen der Romischen Mumzstatte Trier", 1989 Spink, "The Roman Imperial Coinage Volume VI", 1967 David G. Wigg "An Issue of Follis Fractions with Denominational Marks", 19911 punto
-
my idea... per una serie comune EUROPA basata sui musicisti europei, sperando che almeno la musica possa unire il nostro continente ? + grandi qui : http://www.friziodesign.it/coins23.html ?1 punto
-
Secondo me un vero FDC ,ovvero 10 della SCALA DI DENARI, può costare 80 - 120 euro solo se è un 10 però1 punto
-
DE GREGE EPICURI Si vede abbastanza poco, in particolare non si vedono globetti, nè al D nè al R. Immaginando che i globetti non ci siano proprio, l'unica ipotesi è quella di una semuncia (coniata, RRC 41/11) probabilmente quindi della riduzione semilibrale. La trovi nel nostro catalogo. Il ritratto è quello di Mercurio, anche se dalla foto gli somiglia poco...1 punto
-
Ma che belle monete, che belle illustrazioni, cercherò di seguirla questa bella discussione che può insegnarmi tanto1 punto
-
Ciao a tutti, ciao @apollonia! stesso conio di quella del catalogo? Servus Njk1 punto
-
Salve @Flaminius, si tratta di questa: AE quadrante anonimo databile tra i regni di Domiziano ed Antonino Pio, zecca di Roma. Al D/ busto elmato di Marte volto a destra. Al R/ armatura. Ai lati, S-C. Rif.: RIC II, n. 19.1 punto
-
Da principiante posso ritenermi soddisfatto di questa moneta coloniale tedesca1 punto
-
È solo questione di esperienza. Pensa che la prima moneta romana che ho avuto era un Valentiniano I sempre con la SECVRITAS. Il commerciante che me l'aveva venduta mi aveva scritto su un foglietto le legende del dritto e del rovescio. Ma nonostante questo ci ho messo due settimane per capire come si dovesse leggere. Poi ho imparato, come tutti... Arka Diligite iustitiam1 punto
-
Mah forse perche sono eventi piu vicini a noi sono anche piu’ facili e comodi da ricordare ma studiando bene la storia romana ( per non parlare della greca) di episodi interessanti ed eventi significativi ne avremmo altrettanti se non piu’ del Risorgimento ed epoche successive1 punto
-
Trovato in Inghilterra un tesoro di rare monete sassoni, probabilmente nascosto a cavallo della battaglia di Hastings del 1066. https://www.fanpage.it/esteri/regno-unito-trovano-2-571-monete-dargento-col-metal-detector-valgono-oltre-5-milioni-di-euro/1 punto
-
Spero che anche @eracle62 dia il suo contributo sul n.6 e spero proprio di ritrovarlo qui sul forum, certi Numismatici di valore assoluto come lui, non si possono proprio perdere...1 punto
-
Questa la trovo una cosa molto interessante può scrivere chiunque? Grazie1 punto
-
Capitasse ad alcuno di lasciare la Calabria delle vacanze per ritornare, magari verso le Langhe Monregalesi, poco a Nord di Sapri potrebbe notare le mura merlate dell'antico borgo rivierasco di Policastro . Forse l'antica Pixunte, colonia mercantile della greca Reggio venuta in potere di Sibari verso il VII-VI sec. AC. , dopo romana col nome di Buxentum, in epoca alto-medioevale bizantina assume il nome di Policastro con il quale sarà poi dei Longobardi di Salerno, Normanna ed ancora Angioina ed Aragonese fino ad essere nel 1328 dei Grimaldi di Genova . Tuttora ben visibili importanti tratti delle fortificazioni di epoca medioevale, dall'epoca magno-greca invece forse solo la controversa leggenda 'Pixoes' su rarissimi stateri incusi di tipo sibarita attribuiti, per altro con incertezze, a Siri .1 punto
-
Indicativamente alla fine di quest'anno, sul sito della zecca, ormai quando le emissioni possano definirsi " ufficiali " grazie anche ai rumors che circolano in rete, ma la vera presentazione ufficiale avviene durante il World Money Fair di Berlino che si svolge a Febbraio 2020.1 punto
-
1 punto
-
Grazie e giusto dirlo ... io ringrazio, e lascio poi il passo ad altre discussioni, però prima devo ringraziare anche chi ha scritto se no il Gazzettino non ci sarebbe stato, chi ha fatto editing, chi lo legge, chi ci sostiene qui e in altri ambiti anche oltre la numismatica, e’ un sostegno ideale come e’ ideale il progetto in quanto tutto si basa su partecipazione e lavoro volontario e tutto in modo gratuito per gli altri, per la comunità, anche non solo numismatica, e quindi grazie in particolare per questo numero a @adolfos, @4mori, @tornese71, @Tm_NPZ, @talpa@King John@El Chupacabra1 punto
-
In base all'estrema usura di questo mezzo buqsha, si potrebbe restringere la coniazione al periodo 1911-21, ben poca cosa rispetto la data reale non visibile... ma meglio che niente. In questo arco di tempo la monetina fu molto utilizzata, praticamente quando ancora questo esiguo valore nominale poteva permettere l'acquisto di qualcosina. Difficilmente quelle coniate negli anni successivi possono presentare questa usura.1 punto
-
Abito in Germania, dove è pieno di turchi. Al posto di 1 euro ho ricevuto 1 lira turca che mi son tenuto per la collezione1 punto
-
Credo quella di San Marino: invecchiati o passati a miglior vita i Collezionisti anni '60, '70 e '80 mi sembra non ci sia stato grande ricambio.1 punto
-
Anche a mio parere la monetazione di Vitt.Em.III mantiene ancora oggi una grossa fascia di estimatori, anche se mi dicono che non c’è più l’interesse di una volta, ma vedo che le monete di questo periodo, soprattutto se in conservazioni alte, spuntano ancora prezzi notevoli. Prendiamo ad esempio il 5 lire del 1914, moneta che considero comune nonostante sia classificata R2, per acquistarla servono ancora parecchi euro. Un’altra monetazione che mi sembra trovi molti ammiratori, è quella Papale. È una monetazione che trovo veramente affascinante, soprattutto quella in rame, dove si possono ancora fare ottimi acquisti spendendo cifre relativamente basse. Poi come già detto da chi mi ha preceduto, anche le napoletane e il Regno delle due Sicilie hanno la loro bella schiera di estimatori. Per quanto riguarda le monete antiche (romane e greche) che mi affascinano da sempre, purtroppo devo constatare un aumento esponenziale dei falsi che invadono il mercato, questo deprime molto il mercato e disincentiva molto i collezionisti dal comprare. Da ultimo gli Euro, che vengono molto collezionati dai giovani agli inizi e non solo.1 punto
-
1553 senza ombra di dubbio Anno in cui a 83 anni (per l'epoca tantissimi) muore Lucrezia Borgia, figlia di Lorenzo il magnifico e moglie di Giovanni dalle bande nere. ...me lo ricordo anche perché una delle mie figlie si chiama proprio Lucrezia...1 punto
-
Ciao Papillon, I 2€ con la F sono evidentemente più di 15.000 (perchè corrispondenti alle 15.000 divisionali + quelli presenti a caso nei rotolini), a meno che qualcuno non trovi delle divisionali con all'interno monete di 2€ senza F: e allora si aprono altri scenari. Seconda certezza è che sono stati coniati meno 2€ senza F (in quanto, al loro numero ufficiale, pari a 300.000, vanno sottratti i 2€ con la F che erroneamente li sostituiscono all'interno dei rotolini): anche in questo caso il discorso resta valido a meno che qualcuno non trovi delle divisionali con all'interno monete di 2€ senza F...e allora si aprono altri scenari. I conti tornano nella misura in cui la zecca francese ha fatto degli evidenti pasticci come già avvenuto in passato: vedi quanto ho scritto nei precedenti post per info.1 punto
-
Abbiamo due utenti che ne hanno contate una 20ina con la F nei rispettivi rotolini, ed un altro che invece ha verificato la completa assenza di monete con la F in un altro. Se come detto, delle 600k monete destinate ai rotolini, il 35% è stato per errore coniato con la F, significa che ci sono 210k monete "sbagliate", ed ipotizzando che tutti i rotolini misti abbiano una 20ina di monete con la F, ci sono circa 10k rotolini misti su 12k totali e quindi solo 2k "normali" (e comunque non è possibile sapere con certezza quali rotolini siano misti e quali no se non aprendoli, perdendo quindi di fatto l'"esclusività"): alla fine chi paventava che fossero quelle senza la F le monete "rare", potrebbe non essere andato poi così lontano dalla verità. Certo è che 3 rotolini su 12k non sono un buon campione di riferimento1 punto
-
In realtà esiste un opuscolo, molto raro a trovarsi, che illustra le collezioni in maniera sintetica ma con belle foto aspettiamo l’opera maggiore1 punto
-
Stamattina mercatino. 5 Forint a 1 euro....non so se solo a me ma rovistare in cerca di monete nelle ciotole mi da un piacere immenso!!1 punto
-
Se quello che Lei ha scritto è vero consiglio vivamente a tutti gli utenti del forum di smettere di acquistare monete. D’altronde il commercio ha delle ragioni che il cuore non intende. Ragion per cui di fronte alla possibilità di guadagnare dei soldi noi commercianti siamo disposti a vendere qualsiasi cosa, incluse monete false Io onestamente sono un pochino stufo di frasi fatte e di luoghi comuni. Gli aurei non sono più difficili delle monete greche, che anzi sono molto più falsificate e con un grado di difficoltà molto maggiore. Sotto un profilo tecnico è molto più facile falsificare una moneta dell’800 di cui sappiamo tutto sul processo di produzione e il metallo impiegato che su una moneta antica !! Al suo post sull’ autenticità non ha risposto nessuno perché contiene nei cons una serie di argomentazioni oggettivamente sbagliate: i ritrovamenti singoli sono molto meno inconsueti di quanto Lei pensi. D’altronde se Lei conoscesse la monetazione aurea di Carausio e Alletto saprebbe che molti degli aurei conosciuti provengono da ritrovamenti singoli. Queste notizie ci sono arrivate anche grazie anche alla normativa inglese che fa si che i metal detectoristi dichiarino il luogo e le modalità del ritrovamento Le monete d’oro, a differenza di quelle di bronzo e argento non subiscono nessun tipo di corrosione del metallo e non sviluppano ossidazioni a meno che non vengano trovate nel mare. La moneta nella foto si presenta in maniera assolutamente non sospetta e non capisco perché sia un problema il suo stato di conservazione. Non comprendo poi a cosa faccia riferimento quando parla di mancanza di patina ? La moneta è stata pulita probabilmente con acido citrico e la lucentezza dei campi è assolutamente normale e la permanenza della moneta nel terreno certo non ne altera lo stato di conservazione. Solo chi ha una limitatissima conoscenza della monetazione romana può mettere in discussione l’autenticità di questa moneta. Io non pretendo che qualcuno accetti che la moneta è autentica perché lo dico io, ma se qualcuno esprime dei dubbi dovrebbe farlo portando delle motivazioni valide. Per favore smettiamola con questa cretinata che è quasi impossibile distinguere un aureo vero da uno falso.1 punto
-
Molto bella @Rocco68. Inserisco l'ultima piastra del 1857 aquile capovolte, legenda al dritto e rovescio con lettere sottili e taglio al dritto.1 punto
-
Me lo sono chiesto anche io, vero è che il dettaglio, per quanto araldicamente importante, è dimensionalmente "piccolo" e questo, unitamente al fatto che tali varianti sono meno facili da trovare (ne potrebbe essere stato coniato un numero minore di esemplari), potrebbe spiegare come mai sia sfuggito. Poi 30-40 anni fa non c'erano forum per confrontare in breve tempo numerosi esemplari... mi son dato questa risposta, chissà...1 punto
-
Buongiorno e buona domenica a tutti. Ottima idea, questa discussione, partecipo con la mia Piastra del1857 (Traina n°318), caratteri spessi al dritto e al rovescio, A sostituite da V rovesciate, probabilmente stesso conio di quella nella foto dello studio del Traina, ne parlammo in una discussione di alcuni anni fa.1 punto
-
Purtroppo le condizioni legali delle aziende sono sempre lunghe, perchè per definizione sono condizioni legali e devono coprire tutti gli scenari possibili, nel bene e nel male. Il capitolo 13 (forse tra i piu importanti in queste circostanze) però non è così lungo e tutt'altro che noioso. Personalmente lo trovo affascinante e merita una lettura anche per capire che azioni si possano intraprendere o meno in determinate circostanze. Una piccola nota che formalmente fa la differenza e merita di essere citata: PayPal sottolinea "NOTEVOLMENTE diverso dalla descrizione" (SNAD - Significantly not as described che è diverso da "not as described"). Ciò significa, nel caso pratico della numismatica, che se acquisto una moneta FDC e mi arriva una moneta SPL non vi è alcuna protezione acquisti - è diversa dalla descrizione ma non notevolmente diversa. Nel caso invece acquisti una FDC e mi arrivi una B, direi che il notevolmente è più che valido. Attenzione anche al fatto che se acquisto una moneta circolata/usata, normali segni di usura (come specificato al paragrafo 13.8) sono da considerarsi accettabili in quanto il bene è usato per definizione. Il tutto sempre fatto salvo a quanto dichiarato e descritto dal venditore! IMPORTANTISSIMO - Ultima nota e poi chiudo (basta parlar di lavoro che è il mio giorno off!) Il servizio clienti PayPal è lì per risolvere controversie tra le parti e stabilire chi sfortunatamente ha torto e, quindi, paga. E' altrettanto vero che lo stesso servizio clienti è anche lì per dare informazioni, prevenire la controversia, e dare qualche suggerimento utile. Nel dubbio leggete i termini e condizioni e cercate risposta sulla vostra tutela. Per casi più complessi o se l'importo in gioco è roba da non scherzare chiamate, chiedete, informatevi prima di fare l'acquisto per capire se potete essere protetti o meno. Un consulto non è mai negato, può essere utile ed è gratuito. E spesso evita poi spiacevoli conseguenze o lunghi contenziosi. Buon weekend a tutti!1 punto
-
Grazie Eros, vediamo se riusciamo a risvegliare la bella discussione con questo minuscolo tondello in argento del bel Gioacchino Napoleone Murat: Mezza Lira 1813 Perdonate le pessime foto, vi assicuro che dal vivo c'è da esserne molto fieri! E poterne ammirare ogni ricciolo nella capigliatura ?.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Salve........quest'oggi mettiamo un pò da parte le notizie sulla zecca e ritorniamo a identificare le sigle sulle Monete; riprendo quindi il periodo Vicereale, dove credo che alcune di esse non sono state ancora correttamente attribuite a questo o quel Maestro di Zecca e di Prova. Monetazione di Filippo II > qui devo dire che effettivamente notizie sui Maestri di zecca ve ne sono, non altrettante per quelli di Prova, sappiamo infatti che dal 1561 (ordine del 22 settembre) sulle monete di Napoli vengoono apposte anche le sigle dei Maestri di Prova, il primo è stato Vincenzo Porzio (sigla VP o PV in monogramma)....e poi ? si notano in questo periodo molte sigle accoppiate ai noti Maestri di Zecca come i Ravaschieri, de Leo e Fasulo, ma che fino ad oggi in alcuni volumi/cataloghi non sono riportate e mi riferisco alle sigle CI (tagliata) e la sigla G quest'ultima, sulle monete del 1596 e 1598. L'unico che riferisce di alcuni nominativi, oltre logicamente il ben noto Vincenzo Porzio, è il MIR ma per questi nominativi vi è l'assenza di date e chiaramente non si riesce bene a identificare, quindi la data della loro presenza in zecca ed il Corpus. Questa premessa per dire cosa...........tra le tante, che spero presto di arrivare ad una corretta attribuzione, ve nè una in particolare che a dir poco mi stà facendo ammattire. Filippo II - Carlino FIDEI/DEFEN/SOR - Pannuti e Riccio 39/d sigla G/CI (tagliata) - Collezione Privata. Tale moneta che gli autori ci hanno lasciato catalogato apparentemente sembra essere una delle tante monete con sigle di facile attribuzione.....ma è proprio così ? temo proprio di no e lo stò vivendo sulla mia pelle. Credo anche che la moneta effettivamente reca la sola sigla G (che peraltro è l'unica del periodo con la G) infatti non credo che gli autori si siamo sbagliati nel riportarla senza la R affiancata (ricordo GR - Germano Ravaschieri), se avessero avuto un minimo dubbio non l'avrebbero riportata, ma quello che più mi manda ai "matti" è anche l'abbinamento con la sigla CI . Magari anche loro che hanno dato meno importanza alle sigle piuttosto che alle varie forme degli Stemmi, non avuto modo di capire l'importanza di essa per la datazione di un Maestro di Zecca e/o di Prova, anche perchè non fu questo il loro obiettivo.........cosa devo pensare ? che l'inisore abbia dimenticato di incidere la R ? e poi la sigla CI. Mi auguro che con l'aiuto di qualche appassionato di monetazione vicereale e/o come me di sigle si riesca a capire cosa o meglio di chi sono quelle sigle su questo Carlino. Vi posto di segutio alcune pagine di ciò che ho trovato e studiato..............vi rendere subito conto che la confusione o meglio la VARIETA' regna e non poco.......e questo per una sola Moneta !! :help: :help: :help: :help: Un saluto1 punto
-
Ciao Galenus......ti riporto il Documento con il quale Carlo I dà in appalto la zecca a questi due Maestri: 1 Re Carlo dà in appalto la zecca di Castel Capuano di Napoli ad Angelo de Vito di Ravello e a Filippo Saladino di Messina per un anno dal primo di aprile di questo anno 1280 al 31 marzo del 1281, con l'obbligo di dover battere 10 mila once di oro in carlini e medaglie di carlini di oro, computandosi il loro lucro alla ragione di un tari e cinque grana di oro per ogni oncia di carlini di oro. Tra le condizioni vi è quella che i carlini di oro e le medaglie de' carlini debbono essere della tenuta “ profortionaliter cuius siint floreni auri et quilihet karolensis integre contincat de fino auro tarenos quatuor et grana decem et noiiem et tres ocfavas alferius grani et Medalea ipsortun Karolensiiim contineat de fino auro tarenos duos grana novem et undecim ex decimas alterius grani ita quod quatuor ipsorum karoìensiwn. vel octo medalee. contìneant tanto de auro fino quantum continent quinque floreni auri videìicet tarenos decem et novem, et grana decem et seppe”. Ed in fine ordina a quei zecchieri che tutta la luiova moneta a mano a mano che si conierà dovranno trasportarla al castello del Salvatore a mare, detto dell'Uovo, consegnandola a que' regi tesorieri. Archivio Storico Italiano - (Reg. Ang. 1270, B. n. 26, fot. 326 t.).1 punto
-
Ottimo Galenus, mi complimento per il tuo primo passettino, noto con piacere che anche tu ti stai appassionando a questi personaggi, e come non farlo, diciamola tutta, sono stati dei veri grandi Maestri che hanno diretto questa Officina Monetaria ineguagliabile in Italia e forse anche all'estero, come si possono mai trascurare; mi sembra giunta l'ora che vengono tutti e completamente rispolverati, anche perchè le monete senza il loro lavoro non esisterebbero ...........!! Ma c'è moltissima strada da percorrere fino ai Borbone. Un saluto da Pietro1 punto
-
Come accennato nei precedenti post la presenza dei salernitani (come Sergio Frezza, Angelo di Vito ecc. ecc.) e di napoletani (come i Gattola, Macedonio ecc.ecc.) nelle officine del conio dell’oro è spiegata dal fatto che entrambe le città, Salerno e Napoli, avevano la privativa della lavorazione dell’oro e dell’argento e che in queste stesse Officine avvenne il contatto con i lavoratori dell’oro e dell’argento fiorentini; questa fu la via maestra attraverso la quale la lavorazione dell’oro toscana penetrò nel Regno di Napoli, visto che i banchieri fiorentini nella collaborazione con gli Angioini avevano imposto propri operai. Ma chi erano…………… I mercanti e/o banchieri fiorentini, furono appaltatori all’avanguardia e anche le maestranze tecniche furono fra le più richieste, alcuni sovrani arrivavano al punto di inviare al governo fiorentino richieste specifiche per ricevere maestri di zecca ed altro personale destinato alla zecca. Interessante fu il rapporto fra la presenza di questi maestri di zecca e la politica monetaria degli Stati nei quali tali zecche erano comprese; essi infatti spesso sovrintendevano all’istituzione di nuove zecche, alla riforma organizzativa delle stesse, dei sistemi monetari e alle nuove emissioni di grande successo. Gli appaltatori, maestri particolari di zecca, la cui conduzione era regolata tipicamente da contratti stipulati oppure concessi in gestione per conto dell’amministrazione erano mercanti che solitamente fornivano anche il personale tecnico della zecca, compresi orefici e argentieri per saggiare i metalli. In tal senso è significativo il perchè i maestri fiorentini cominciarono ad essere attestati in varie zecche dell’Italia proprio quando queste iniziarono a coniare una nuova moneta d’oro, come proprio a Napoli quando nel 1278, la Zecca Napoletana dette avvio all’emissione del nuovo Carlino d’oro. Il maestro fiorentino che prese in appalto la zecca napoletana nel 1278, Francesco Formica, si impegnò come primo atto a stabilire la nuova sede della zecca nel Castel Capuano, l’odierno Castello dell’Ovo. Ma questo è solo il primo nominativo, uno dei tantissimi Maestri di Zecca (fiorentini, ravellesi, messinesi, napoletani) che diressero la zecca partenopea dal 1278.1 punto
-
Aspetta a stampare Galenus.........a te manderò una copia dell'intero lavoro, non appena sarà terminato, comprensivo di tutti i Nominativi dei Maestri di Zecca, di Prova e Incisori. ;)1 punto
-
Sotto il regno di Giovanna I sappiamo che la zecca funzionava nel nuovo edificio che fu sotto Roberto e che si erano spese ben oltre 70 once per ripararlo e per costruirvi dei nuovi locali. Per tutta l’attività legislativa Angioina, non si ebbero sbalzi notevoli, né vi fu la pretesa di introdurre innovazioni, ma piuttosto il desiderio di rispettare le norme vigenti e di assicurarne l’osservanza. Giovanna I, in un documento del 1346, confermava notevoli privilegi ai “Siclari” Napoletani, affermando che i medesimi erano già stati concessi ai “Siclari” di Brindisi dall’Imperatore Svevo e rinnovati dai suoi predecessori a quelli di Napoli; tali privilegi erano principalmente due: esenzione da ogni imposta e gravami, e foro speciale, cioè esenzione dai Tribunali ordinari e giurisdizione del solo Maestro di Zecca, e ciò sia quando detti operai effettivamente lavorassero nella Zecca, sia quando non vi lavorassero; privilegi questi che, se pur importanti, erano assai diffusi in quel tempo. Ai “Siclari” di Brindisi, lavoranti a Napoli nel 1343, Giovanna conferma anche l’esclusività della nomina ai soli figli legittimi dei lavoranti medesimi della regia Zecca, privilegio esteso, forse, anche alla zecca di Napoli. Nel Bollettino del Bovi si legge che sotto Giovanna I d’Angiò, nel 1343, la zecca partenopea fu affidata alle società dei Bardi (Filippo Rogerio), degli Acciaiuoli (Renato Giovanni) e dei Bonaccorsi (Matteo Villani). In un lavoro di Gennaro Maria Monti (BCNN fascicolo I e II anno 1925) si legge che nel 1344, il Cardinale Amerigo – Baiulo del Regno di Napoli per il Papa, durante il processo contro Giovanna I, dette in appalto la coniazione di 100.000 Carlini d’argento alle Società fiorentine dei Bardi, Bonaccorsi e Acciaiuoli, cioè anche dopo il capitombolo finanziario dei Bardi (1339) e poco prima del loro fallimento avvenuto nel 1345; le stesse banche avevano messo a capo il loro procuratore Filippo de Simone e che dopo di lui fu maestro di zecca Luigi de Baccosi di Lucca. Nel 1346 falliscono le famiglie dei Bardi, i Peruzzi e gli Acciaiuoli (Sambon) ed il credenziere Nicola Costagliola dirige la zecca per conto della Regia Corte (inizio del 1347). Il Banco o Compagnia dei Bardi era all’inizio del trecento una delle compagnie mercantili e finanziarie più potenti e ricche d’Europa. Tra la fine del duecento e i primi del trecento il Banco contava tra i 100 e i 120 impiegati e tra i suoi clienti si annoveravano i più brillanti e ricchi personaggi del tempo, inclusi Principi, Re e Cardinali. La fama dei Bardi, già notevole mentre la Compagnia era ancora in vita, crebbe ulteriormente nei libri di storia per via del suo fallimento nel 1346 dovuto soprattutto al mancato rimborso del debito della corona Inglese. Attorno al 1340 vivevano nella città e contado di Firenze più di 120 adulti maschi Bardi, tutti legati tra di loro da vincoli di parentela. Era una consorteria potente per numero e per ricchezza, forse la più potente e la più ricca, ed era in larghissima parte concentrata Oltr’Arno, dove ancor oggi si trova via de’ Bardi. Il fatto che i Bardi scegliessero di vivere vicini gli uni ali altri, in case contigue, sovente intercomunicanti, in una ben definita zona della città conferma l’elevato grado di coesione del gruppo. In più di un caso si vide che la contiguità delle dimore fu un fattore positivo che rafforzò notevolmente la consorteria quando questa si trovò a dover menare le mani; e ai Bardi i momenti e le occasioni di farlo non mancavano mai. Nel maggio del 1345 i Bardi ebbero uno scontro armato con i Peruzzi mentre quelli con i Buondelmonti non si contano. Gli anni “Venti” erano stati di eccezionale prosperità per questa famiglia, ma dopo il sole viene immancabilmente la pioggia. Agli inizi degli anni “Trenta” scoppiò una violenta crisi destinta a farsi di giorno in giorno sempre più acuta sino a raggiungere un’intensità mai conosciuta prima da allora. L’economia fiorentina ne fu letteralmente travolta; le compagnie fallirono, una dopo l’altra, e crollarono come castelli di carte. Saltarono gli Acciaiuoli, i Bonaccorsi, i Cocchi, gli Antellesi, i Corsini, i da Uzzano e i Perendoli. Dopo aver ostinatamente cercato di far fronte all’impossibile situazione, anche i due giganti crollarono: i Peruzzi nel 1343 ed i Bardi nel 1346. Grazie e alla prossima.1 punto
-
Questa sera inizio a riportare alcune notizie sulla Zecca di Napoli durante la dominazione Angioina e cioè da quando venne istituita: La zecca di Napoli, sino al 1325, fu esercitata nell’antica casa dei Fieschi, nella strada della Sellaria, appartenuta già al celebre Pier delle Vigne; nell’ottobre del 1325 avendo il procuratore del cardinale Luca Fieschi, davide Vogerio, fatto istanza perché fosse restituita al cardinale quella casa, la zecca e gli archivi furono trasportati in alcune case di Ettore Vulcano “ad portam Petruczoli”, presso la Chiesa di Santa Maria la Nuova. Nel marzo del 1333 re Roberto, avendo comprato per 700 once le case dei fratelli Adinolfo e Nicola Somma, presso la Chiesa di S. Agostino, vi stabilì la Zecca e l’Archivio, qui si tenne, d’allora innanzi, la zecca, sino agli ultimi tempi della monarchia delle Due Sicilie; quanto all’organizzazione della Zecca, essa restava quella dei secoli antecedenti, il cui ordinamento risaliva fino ai tempi di Federico II, da una parte i lavoratori detti Siclarii, Affilatores, Obererii monetarii (che formavano di fronte allo Stato una “Universitas” con cospicui privilegi), dall’altra, v’erano gli Ufficiali Regi ad essa preposti, cioè Notai Credenzieri, Ispettori delle Prove, Summatores, dipendenti dai Maestri di Zecca, cioè appaltatori che per contratto si obbligavano di fornire in un determinato tempo la quantità di moneta che il Governo richiedeva. Roberto d’Angiò non apportò alcuna innovazione al sistema monetario stabilito negli ultimi anni da Carlo II e negli ordini per il conio delle monete si riferisce sempre alle Norme con cui erano state coniate “de mandato recolende memorie divi avi nostri”; si legge infatti in documento del luglio 1317, riguardo alla coniazione dei Gigliati “et liga prediciorum carolenormn argenti sit de untiis undecim et sterlinos III argenti fini prò Ijualibet libra ponderis eorumdein et reliqtmm sii de here puro et quod qiiilihet carolenits argenteus sit insti et ordinati ponderis videlicet tareno-rmn quatuor et grana decem nec non quod carolenses ipsi.... argenti sint eiusdem tenute et lige sicut fuernnt carolenses.... argenti duduni cusi de mandato recolende memorie divi avi nostri Jerusalem et Sicilie regis illustris”. Ma sebbene i regi editti prescrivessero per i Gigliati lega e peso eguali a quelli di Carlo II, soltanto gli zecchieri, poco curandosi di quelle ingiunzioni, emisero moneta di scarsa lega e di peso sempre più scadente, sicché da gr. 3,93 il Gigliato fu ridotto man mano a gr. 3,80 con circa gr. 3,53 di fino e ancor meno. Le malversazioni nelle zecche del Regno erano già incominciate durante il governo di Carlo II, giacché le doviziose società di mercatanti e banchieri toscani che tennero l'appalto delle zecche, lo ebbero spesso in guarentigia di forti somme prestate al sovrano (Carlo II aveva abbandonato completamente agli appaltatori della zecca i diritti di Signoria sulla moneta) e profittarono delle difficoltà in cui trovaronsi Carlo II e Roberto di restituire quelle somme, per prendere una perniciosa ingerenza nell'amministrazione delle principali entrate del fisco. Richiamo nel doc. del 1317, perchè la moneta fosse veramente “insti et ordinati ponderis” è indizio assai significativo delle disoneste pratiche di quei zecchieri. Nel 1317, si ordinò di porre nel campo della moneta un simbolo distintivo che permettesse di determinare le responsabilità degli zecchieri e poiché sul finire del mese di dicembre del 1319, il popolo si mosse a tumulto a cagione delle malversazioni degli zecchieri e del triste stato in cui era ridotta la moneta d'argento, il governo si adoprò con buone promesse a calmare quel giusto risentimento, e furono dati ai giustizieri delle Provincie ordini severi per frenare la “rasio sive demolitio uiomtae”, assegnandosi il premio di 20 Augustali a coloro che denunciassero i falsificatori o tosatori dei Carlini; il 2 gennaio del 1320, il duca di Calabria, allora vicario generale del reame, decretò che in tutte le province del Regno fossero eletti quattro ufficiali incaricati di verificare il peso dei Carlini, prescrivendo che tutti quelli di peso inferiore, fossero ritirati dal commercio; nel settembre del 1321 fu fatto coniare un nuovo gigliato di miglior peso dell'antecedente e, perchè si potesse agevolmente distinguere il nuovo conio, vi si fece incidere, nel campo del diritto un giglio invece della ghianda, impressa sull'emissione del 1317-1319, in quell'occasione, furono fatti verificare i campioni dei pesi del Carlino, fissandosi il peso dell'acino col grano di frumento; i Carlini vecchi si calcolavano a ragione di 75 per oncia, siccome rilevasi da doc. del 1317, pubbl. dal Minieri Riccio (Studi sui fase. Atig., pag. 9). “Pecunia soluta est ad diversas rationes videlicet de carolrms iiliatis ad rationun 60 per unciam, de carolenis argenteis veteribus ad rationem jj per unciam”. Il conio dei Carlini fu continuato, sempre “conm aggiore attività”, e in un documento del 1326 leggiamo che si era dovuto aumentare il numero degli operai a cagione della gran copia di Gigliati che si coniavano nella zecca di Napoli; l'incremento della monetazione d'argento era dovuto al favore che godevano nell'Oriente latino i gigliati napoletani; il conio dei Robertini per l'Oriente divenne allora una vera speculazione. Le cose però non andavano meglio che nel 1318 e ne è indizio un documento del 10 giugno 1342, dal quale apprendiamo che, essendosi verificate nuove frodi, e trovandosi pesi scarsi, furono fatti eseguire nuovi campioni ponderali e spediti a tutti i giustizieri. (Arch. vol. XLI, n. 2346). (Fonte: Sambon RIN 1912)1 punto
-
Quest’oggi carissimi amici frequentatori, richiamo questa discussione per esporre di un argomento correlato alla figura di questi personaggi (Maestri di Zecca, di Prova e Incisori), non solo, come fino ad adesso trattato, in relazione alle sigle da loro apposte sulle Monete, ma….. e soprattutto riferendo di alcune notizie sull’Organizzazione della Zecca, luogo dove tali Ufficiali con le relative maestranza operavano, le funzioni da essi svolte all’interno della zecca stessa e come si è giunti nell’apporre tali sigle sulle monete. Nel fare ciò, logicamente mi sono avvalso di numerosi scritti e testi consultati, raccogliendo informazioni e cercando di essere il più conciso possibile. Credo, e semprechè non sbaglio, che di questo argomento non si sia mai parlato. Spero di farVi cosa gradita e soprattutto, se vi fa piacere, discutiamone. William R. Day Jr., Fiorentini e altri italiani appaltatori di zecche straniere 1200 - 1600: un progetto di ricerca; M. De Maio, Per la storia del battiloro solforano – Biblioteca Comunale Centro Studi di Storia Locale – Solfora (AV) 2007; C. Cipolla, Tre storie extra vaganti “Uomini Duri” – Bologna 1994; A. Sambon, Incisori dei coni della moneta Napoletana – Estratto RIN 1893; C. Prota, Maestri ed incisori della zecca Napoletana - Napoli1914; G.M. Monti, La zecca di Napoli sotto Giovanna I d’Angiò - Bollettino del Circolo Numismatico Napoletano, Fasc. I e II An. 1925; G.M. Monti, La zecca di Napoli sotto i Durazzeschi - Bollettino del Circolo Numismatico Napoletano, Fasc. I e II An. 1928; Sono stati consultati i seguenti siti: archiviodistao.firenze.it; rilievo.poliba.it; solofrastorica.it. Organizzazione della Zecca di Napoli Degli ufficiali che si occupassero della fabbricazione monetaria, detti inizialmente Ufficiali della Moneta e poi Maestri di Zecca, si hanno notizie a partire dalla metà del XIII secolo, il loro compito originario fu quello di sovrintendere alla importantissima operazione di controllo della matrice in acciaio con i simboli da imprimere, della coniazione della moneta garantendone la regolarità di peso e fattura. A questa prima funzione in breve si aggiunsero la vigilanza sulla circolazione del denaro e la giurisdizione sui reati connessi alla moneta, soprattutto la “falsificazione”. La lavorazione dei metalli fino alla realizzazione delle monete era un processo complicato e suddiviso in fasi ben distinte, ciascuna eseguita da operai diversi, alcuni dei quali altamente specializzati. Tra questi maestri vi erano ad esempio gli intagliatori dei coni e i monetieri, che compivano la fase finale e più delicata del lavoro, durante la quale sui tondelli grezzi era impresso il conio, a questi si aggiungevano altri operai esperti come i fonditori, i tagliatori, gli affilatori e gli incisori. Come il personale impiegatizio, le maestranze ricevevano un incarico a breve termine, in genere sei mesi e alcuni di essi, per l'importanza delle operazioni che eseguivano e l'alto livello di professionalità richiesto, godevano di prestigio e attenzioni particolari. Per evitare frodi, dal primo decennio del 1300 i Maestri di Zecca cominciarono a marcare le monete con un simbolo, uno stemma o apponevano delle lettere sulle monete che erano le iniziali del proprio nome o del cognome, anche garanzia per il popolo della bontà dei pezzi coniati, o/e per un controllo da parte dello Stato che fossero state prodotte secondo le disposizioni impartite. Dal 1317 invalse anche l'uso di annotare i contrassegni in un apposito registro sul quale venivano anche riportati i nomi dei maestri e dei notai, nonché le variazioni più significative sulle coniazioni. I notai eseguivano tutte le registrazioni necessarie all'ufficio: elenchi di impiegati e operai, redazione delle liberatorie al momento della riconsegna ai privati sotto forma di moneta del metallo portato alla Zecca per la coniazione, verbali, registrazioni contabili. Vi erano inoltre i cosiddetti saggiatori, approvatori o revisori che si occupavano di verificare fin nei minimi particolari la regolarità delle monete (peso, incisione e qualità della lega). L'elemento essenziale delle istruzioni impartite ad una Zecca consiste nelle disposizioni relative al peso ed al titolo; solo dal XIII secolo si sono conservati i registri delle Zecche, che ci permettono di conoscere alcuni elementi sulle emissioni, rispetto a quanto si può dedurre dalle monete stesse. Anche i nomi dei Maestri della Zecca Napoletana rimasero sconosciuti sino a che si riuscì a prendere in esame i dati dell'Archivio di Stato di Napoli; conoscendo il periodo in cui operavano, si attribuì a questa o a quella lettera e di conseguenza le relative monete, a Maestri o Incisori di cui quella lettera figurava come iniziale. Mancando però la data sulle monete di questo periodo e fino a Filippo II ( 1572 ), tali lettere comunque vanno considerate con cautela se utilizzate per la seriazione e datazione delle monete stesse; infatti non si conosce il periodo in cui un determinato conio con quella sigla apparve o fu abbandonato, né sempre la fine del mandato concesso ad un Maestro segna la cessazione dell'uso di quel conio. Vi riporto di seguito un passo di Michele Pannuti e Vincenzo Riccio (Rif. Le monete di Napoli - 1984) a proposito delle sigle dei Maestri di Zecca: sulle monete di Napoli, a partire dal Medio Evo, si osservano, nel campo del dritto e/o talora del rovescio, delle lettere; esse sono, in genere, iniziali di Maestri di Zecca, cioè direttori generali della monetazione, che apponevano tali lettere, a conferma della bontà delle emissioni avvenute sotto la loro gestione. Le prime lettere di zecchieri compaiono sulle monete di Napoli del XIV secolo, sotto Roberto d’Angiò (Robertini con la N gotica), Giovanna I da sola (Ducato d’oro con la B) e Giovanna e Ludovico di Taranto (Carlino sigla I - G e Denaro con la croce patente sigle A-U, N-U, N-A e I-U). Queste iniziali, sinora, non sono state decifrate; tale consuetudine fu ripresa sotto gli Aragonesi, a partire da Alfonso I , e perdurò fino ai Borbone. A Napoli, centro amministrativo, lavoravano presso la zecca, le nuove monete a partire dal 1278. La Zecca di Napoli fu istituita contestualmente alla riforma monetaria voluta da Carlo I d’Angiò che aveva trasferito nella nuova capitale, dalle officine di Brindisi il conio dell’oro insieme alle rispettive maestranze, e fu particolarmente curata da tutti i Re Angioini, che mantennero i privilegi favorendo l’autonomia dell’organismo, eliminando gradualmente le zecche periferiche del Regno. Diventò perciò una “Universitas”, una comunità auto gestita tanto da formare una vera e propria corporazione artigiana, forse l’unica esistente a Napoli, con notai, credenzieri, ispettori, con un tribunale speciale, che funzionava anche al di là dell’attività prettamente lavorativa, estendendosi a tutti i membri, operai e impiegati, anche quando questi non esercitavano più, e alle loro famiglie. L’istituto era retto da un Maestro di Zecca, con un ruolo particolarmente importante che trasformò questi appaltatori in governatori, impegnati per contratto a fornire la moneta richiesta; tale carica fu in mano ai toscani e a napoletani, che ebbero una grande incidenza nella gestione dell’attività. Tre documenti datati al 19 aprile 1278 mettono in risalto la strategia adottata nell’assegnazione degli incarichi; il primo atto proposto è relativo all’ufficiale responsabile all’assaggio; costui, nominato dalla Curia Regia, svolge la funzione di garante controllando che le proporzioni di metallo prezioso contenute nelle monete siano a norma di legge. Il Maestro di Zecca (Magister) è dunque il responsabile e il coordinatore di una èquipe di lavoro formata dai Siclari, Affilatores, Obereri (operai, monetieri e addetti al settore monetale); il compito principale dei maestri appaltatori è assicurare la battitura della qualità della moneta richiesta dalle disposizioni vigenti. Il lavoro di incisione, al contrario, interessa gli Incisores Cuneorum o Magister Cuneorum che avevano il compito specifico di incidere e quindi di realizzare i coni necessari per la battitura. Qui interessa sottolineare l’aspetto legato al conio e al rapporto della Zecca con gli orefici e con tutti coloro che avevano a che fare con la lavorazione dei metalli, che fu il fulcro intorno a cui girava tale istituzione. La zecca di Napoli accolse i lavoratori dell’oro di Salerno (Scalesi, Ravellesi e Solofrani), che venivano assunti insieme ai fiorentini, perché riuscivano ad ottenere lamine così sottili che al toccarle si polverizzavano, tanto che la loro bravura fu riconosciuta da una Prammatica, che li autorizzava a vendere essi soli a Napoli il loro prodotto. Tra i salernitani alla zecca di Napoli nel 1325 ci fu un notaio credenziere, Riccardo Cappasanta, e ci furono i lavoratori solofrani e quelli dell’area serino – montorese, i quali per essere assunti in queste officine dovevano avere rapporti con Salerno, perché attraverso questa strada avveniva l’assunzione. La presenza dei salernitani e di napoletani nelle officine del conio dell’oro si spiega dal fatto che entrambe le città, e solo esse (Salerno e Napoli) avevano la privativa della lavorazione dell’oro e dell’argento. In queste officine dunque avvenne il contatto con i lavoratori dell’oro e dell’argento fiorentini; questa fu la via maestra attraverso la quale la lavorazione dell’oro toscana penetrò nel Regno di Napoli, visto che i banchieri fiorentini nella collaborazione con gli Angioini avevano imposto propri operai. Il fatto che nella zecca di Napoli c’erano ben quattro fonditori solofrani, oltre a confermare l’antico legame di Solfora con Salerno anche per la lavorazione dell’oro, dà una chiara indicazione della genesi di quest’arte, che sarà una specificità solofrana. Ai lavoratori, Petrillo e Bartolomeo, detti di Solofra, e ai fratelli Gaudioso e Nicola de Feulo, tutti fondachieri se ne devono aggiungere altri che possono essere di S. Agata di Serino o della stessa Serino o anche di Monitoro. I fonditori di Solfora esprimono comunque una realtà importante e spiegano perché il Re, che aveva curato l’instaurarsi nella zona di questa attività che chiedeva molta maestria, si interessò a che questi operai specializzati si trasferissero alla Zecca di Napoli; anche lo studioso del periodo Angioino, Giovanni Maria Monti, nel prendere in considerazione questa nutrita presenza, sottolinea l’importanza di un tale nocciolo artigianale. Vale la pena ricordare che gli operai erano esentati da ogni tipo di imposta e gravame, dal giudizio presso i Tribunali ordinari, sia durante che fuori il periodo di lavoro, che i lavoranti erano assunti se erano figli legittimi e che i figli avevano diritto a succedere ai padri.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?