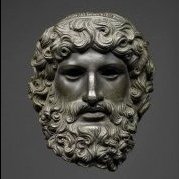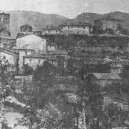Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 04/09/20 in tutte le aree
-
Buongiorno, vi segnalo i primi risultati di scavi archeologici compiuti a Gorizia e che hanno permesso di scoprire che l'insediamento umano iniziale nell'area cittadina risalgono alla protostoria (dato inedito). Gorizia, Corte Sant’ilario. Dalla protostoria alla necropoli medievale I secoli della Gorizia passata svelati dagli ultimi scavi di tutela Il prosieguo delle indagini archeologiche, nell’ambito dei lavori di riqualificazione di Corte S. Ilario da parte del Comune di Gorizia, ha restituito nuovi dati per la comprensione dell’edificio a pianta ottagonale e della zona cimiteriale posta a sud del Duomo, aprendo tuttavia ulteriori questioni storiche e rivelando inoltre, inaspettatamente, una inedita e del tutto inaspettata testimonianza di presenze di epoca protostorica per Gorizia, precedentemente attestate solo in via sporadica e occasionale. L’intervento archeologico è stato eseguito sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia (Paola Ventura) da parte di Arxe s.n.c. I dati più innovativi emersi dagli ultimi scavi riguardano la datazione del deposito archeologico su cui si trovano il cimitero e le strutture ad esso legate o di poco successive. Nel corpo di questo strato argilloso/sabbioso, determinato probabilmente dall’accumulo di fango e di detriti provenienti dalle pendici del colle del castello, è stata individuata una concentrazione di pezzi di arenaria scottata frammisti a frammenti ceramici riferibili ad almeno mezza dozzina di vasi, nessuno dei quali conservato integralmente. Questi rinvenimenti sono di particolare importanza perché i reperti sono databili al momento di passaggio tra l’età del Bronzo Medio e quella del Bronzo Recente, attorno al 1.400-1.300 a.C., e rappresentano quindi la prima attestazione localizzata di presenze così antiche a Gorizia. Un altro importantissimo aspetto evidenziato da queste ultime indagini riguarda la struttura ottagonale dell’edificio, già raffigurata su una planimetria del 1583, che aveva fatto ipotizzare una sua funzione battesimale; lo scavo, ora reso possibile dopo il dissequestro dell’area, ne ha rivelato l’intero perimetro in muratura, pur interrotto in più punti da recenti sottoservizi. Al suo interno, sul lato settentrionale, alcuni gradini in pietra addossati alla parete, garantivano l’accesso all’interno, che presentava un piano di calpestio semi-interrato rispetto a quello esterno, solo in parte finora messo in luce. Lo scavo del riempimento è ancora in corso, ma allo stato attuale sembra accertato un utilizzo dello spazio come ossuario, almeno nell’ultima fase; solo la prosecuzione delle indagini potrà chiarire ulteriormente questo aspetto. Tuttavia è già possibile affermare che la struttura si inserisce in una fase successiva al primo utilizzo del cimitero: infatti nella fascia immediatamente a nord, compresa fra l’edificio ottagonale ed il lato sud del Duomo, sono state rinvenute e scavate altre dieci sepolture, almeno due delle quali sembrano riferibili ad un’epoca più antica, a causa della maggiore profondità e della tecnica di esecuzione delle fosse. Sono stati perciò prelevati dei campioni di osso da queste due sepolture e altri due campioni dalle tombe più alte, e quindi ipoteticamente più recenti, per future analisi al radiocarbonio che potrebbero fornire indicazioni sulla durata d’uso del cimitero: sulla base delle fonti storiche viene ipotizzato un inizio già nel ‘400 (la presenza del Duomo è accertata infatti dalla fine del ‘200, forse sul luogo di una piccola cappella precedente), mentre il termine viene posto nella seconda metà del ‘700. Tratto da https://www.girofvg.com/a-gorizia-i-nuovi-scavi-mettono-in-luce-testimonianze-protostoriche-e-una-necropoli-medievale/ Ciao Illyricum4 punti
-
Ecco la seconda emissione di Marquardo del 1378 (?) - 1381 (Rif.: Passera-Zub 245; CNI VI, 6; Bernardi 58a). E' interessante l'iconografia di questo denaro. Sul dritto infatti c'è la lettara M gotica dell'iniziale del Patriarca con, sopra, due oggetti misteriosi. L'ipotesi più probabile, ma fino a prova contraria, è che sia un globo appoggiato su un cuscino. Questo è un esempio di quelle immagini che dovevano essere di immediata lettura per i contemporanei, ma risultano difficili da comprendere per noi. Sul rovescio una croce che abbiamo già visto in precedenza sui grossi tirolini composta da due croci patenti una grabìnde e una piccola. Arka Diligite iustitiam4 punti
-
Ciao a tutti. Volevo proporvi questa piastra, arrivatami dal Regno Unito, finalmente a casa!!! Condizioni accettabili , 27,08 grammi, taglio a treccia, 41 mm.3 punti
-
Ciao a tutti cari ragazzi, avvicinandoci ai momenti più cruciali della Settimana Santa, colgo l'occasione per porre i miei auguri per una Serena Pasqua a Voi e alle Vostre Famiglie. Con sentito affetto. Pasquale Annibale Carracci ( 1585 ) Il Battesimo di Cristo Bologna - Chiesa dei Santi Gregorio e Siro Annibale Carracci ( 1593 ) La Resurrezione di Cristo Parigi - Museo del Louvre3 punti
-
3 punti
-
Usciva nel settembre del 1970, un doppio album con un’orchestra sinfonica di 85 persone, sei musicisti rock, tre cori e Ian Gillan, la mitica voce dei Deep Purple nella parte del figlio di Dio. Jesus Christ Superstar, il musical dei musical, l’opera rock che «osò» raccontare la Passione di Cristo tra atmosfere hippies e chitarre elettriche. E pensare che all’inizio era «solo» un album che proprio quest’anno compie 50 anni.2 punti
-
Stabilire quali monete venissero utilizzate a Romagna nel 1374 è una chimera. Sicuramente possiamo dire che in quel periodo storico, indicativamente venivano utilizzate le monete che circolavano principalmente in tutta la Romagna (Ravenna e Rimini in primis) e nelle Marche (con particolare riguardo all'Anconetano). Quindi direi che si usavano Denari e grossi agontani e bolognini, i primi emessi indicativamente dalle zecche di Ancona, Ravenna e Rimini (quest'ultima in minor misura) nonchè i bolognini e le altre monete emesse dalla zecca di Bologna. PS: l'articolo suggeritoti da @Illyricum65 e che non riesci a scaricare, te lo posto io, sperando sia scaricabile. Zecche_clandestine_e_poteri_signorili_in.pdf2 punti
-
Continuando con le zecche piemontesi : Zecche Italiane - Tortona. Comune (1248-1322). Grosso maggiore. D/ Le sigle di Federico F R con due stelle ad otto punte sotto e omega sopra R/ Croce patente con due stelle a otto punte nei quarti alti. CNI 1. MIR 1026. AG. g. 1.51 mm. 23,06. RR. BB-SPL. Fondi lucenti La concessione di coniare moneta venne data da Federico II e si mantenne fino al 1322 quando il Comune passò sotto Roberto D'Angiò.2 punti
-
Il collage lo realizzò un preparatissimo utente che dal 2014 non si collega più... @JunoMoneta non sai quanto ci manchi! Vi invito a visitare questa vecchissima discussione, dove venne postato questo collage. La iniziai io nel 2011...2 punti
-
Buongiorno, oggi ci spostiamo su San Marino 100 Lire 1978 Trovo molto bella la moneta su entrambe le facce, stupenda rappresentazione del lavoro nei campi. Saluti Alberto2 punti
-
Solo 783 es. coniati TURCHIA REP. 500 LIRE 1979 mm.22 g.8 AU 917/1000 D/ TURKIYE CUMHURIYETI FAO KÖYLÜ KADININI KALKINDIRMA FAO (emissione per la FAO, Food and Agriculture Organization) EMANCIPAZIONE FEMMINILE NEI VILLAGGI – Busto a sinistra di Sposa in costume tipico. R/ stella e mezzaluna. 500 LIRA 1979 in ghirlanda di spighe e alloro.2 punti
-
2 punti
-
1930 Bulgaria 10 Leva 1930 1930 Finlandia 5 Markkaa2 punti
-
ciao @giuseppe ballauri , riguardo a questo pezzo @Rex Neap aveva postato questa foto esauriente circa le corone, sempre in questa discussione!!!!!!! Alcune sono veramente particolari.2 punti
-
:drinks: Direi proprio di sì! :drinks: Ora me lo stampo, lo incornicio e lo appendo in camera. Così la prossima volta che mi capita un pezzo interessante per questo tipo ho un valido specchietto visivo a cui fare riferimento. Ogni volta che vedo un rovescio di questa moneta vado nel pallone perché non so affidarmi ad un parametro "oggettivo" ed affidabile. Grazie! :pleasantry: Anch'io ho fatto lo stesso per le Corone che gentilmente ci hai postato, ma per gli amici della sezione, esperti e meno esperti, ho fatto una cosa in più; le ho raggruppate in un unico file PDF così da far notare che veramente la Monetazione Napoletana è secondo me unica al mondo. Per un nominale da 120 Grana con la sola data 1805 guardate quante differenze.......... :o e parliamo della sola Corona.2 punti
-
1 punto
-
Grazie mille, mi siete stati tutti utili per la mia ricerca, oltre che gentilissimi e disponibili. Vi abbraccio.1 punto
-
Bel pezzo. Il profilo c'è, la legenda leggibile....complimenti1 punto
-
All'epoca, sperando di non sbagliare perché non in tutte le località si usavano le stesse monete ed i vari tagli, esisteva la "Lira" come moneta convenzionale formata da 240 denari. Forse è meglio se ti faccio una tabellina fermandomi alle monete non auree: Lira = 240 denari Denaro Quattrino = 4 Denari Soldo = Bolognino = 12 Denari Grosso Agontano = 24 Denari (ma ne esistevano anche da 20 Denari) Giulio = Grosso Pontificio = 2 Grossi Agontani = 4 Soldi/Bolognini Mi fermo qui sperando ti sia di aiuto. Anche perché con le varie svalutazioni e l'aumento del costo dei metalli preziosi molti rapporti nel frattempo erano andati cambiando. Ma indicativamente.....1 punto
-
1 punto
-
Si Artur. Lo ricordo bene; io avevo offerto da casa .... va a sapere che c'erano due "marpioni" in sala che se lo contendevano a suon di rilanci ..... se non ricordo male io avevo offerto alla base o poco più, fatto sta che ha raggiunto tre volte tanto.1 punto
-
Caro Luciano ero triste anch'io quando l'ho comprato. L'avevo combattuto con un'altra persona in sala e alla fine l'ho spuntata, ma a che prezzo... Poi ti dimentichi le cose negative e ti godi la moneta... Arka Diligite iustitiam1 punto
-
....altro che.......questo da sempre. I didrammi rappresentano per il collezionista della serie ateniese un pezzo chiave e tra i più rari assieme all'inarrivabile decadramma, ai rarissimi aurei ateniesi ed ai nominali delle "wappenmunzen" di taglio dracma, didramma e tetradramma. Dovrebbe esserci tra l'altro nel Celator (vado a memoria) uno studio dei primi 90' dello stesso Salvesen, collezionista che ha venduto il proprio esemplarare tramite la Nac. Odisseo1 punto
-
1 punto
-
Buongiorno a tutti, che nessuno sia fesso è tutto da dimostrare... Il mondo ne è pieno, tanti pesci abboccano a certe aste che propongono prezzi folli, poi abbiamo il discorso delle divisionali, spazzatura che continua ad essere venduta come se fosse l'affare del secolo, ogni mese escono monete commemorative, l'adunata degli alpini, la brexit, la sterlina rock dei queen e chi più ne ha ne metta. Fare l'affare della vita è impossibile ma con una buona preparazione e tanta attenzione alle varie aste, non è detto che si possano ancora fare buoni acquisti. Saluti e buona quarantena. Silver1 punto
-
Ecco per me (che non li colleziono in modo sistematico ma ne raccolgo solo alcune tipologie) invece il prezzo è un po' altino nel senso che probabilmente non l'avrei comprato, invece ad una ventina di euro l'avrei preso tranquillamente. Pur essendo consapevole che il prezzo di 35€ ci sta, non è assolutamente campato in aria immedesimandomi nel vero collezionista come ambidestro. Saluti Simone1 punto
-
DE GREGE EPICURI In questi giorni in cui tutti riordiniamo le nostre collezioni, mi è capitato in mano questo Vittorino, che ha un gran bel ritratto ma un rovescio (come spesso succede) molto peggiore. Al rovescio INVICTUS, con figura maschile (lo stesso imperatore? Seconddo Sear è il Sole) verso sinistra. Al D la legenda è: IMP C VICTORINUS PF AUG. Pesa 2,4 g e misura 20 mm.1 punto
-
Credo che abbia ragione il Sear. Invictvs è uno degli appellativi del Sole. La figura rappresentata è ''in nudità eroica'' con solo un mantello svolazzante che si addice perfettamente a un dio, mentre vedo difficilmente un imperatore rappresentato nudo. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
1 punto
-
Patriarcato di Aquileia Marquardo di Randeck (1365-1381) Denaro (1365-1378) Argento Peso: 0,90 g Diametro: 18 mm D/ + MONETA (globetto) M(AR)QV(AR)DI (globetto) PATE (globetto) AQ (globetto), aquila ad ali spiegate con la testa rivolta a s. su morione R/ (globetto) S (globetto) hERMA - CORAS (crocetta forata), Busto frontale di Sant'Ermacora su scudo, ai lati M -A Rif.: Passera-Zub 232; CNI VI, 1; Bernardi 57a Questa è la prima emissione di Marquardo di Randeck. Sul dritto è rappresentato un morione (tipo di elmo) con un aquila ad ali spiegate e sul rovescio Sant'Ermacora sopra uno scudo e le iniziali del Patriarca. Sul dritto le lettere A e R sono in nesso in bello stile gotico. Marquardo fu uno dei più potenti Patriarchi. Originario della Svevia fu uno degli alleati di Genova, Ludovico di Ungheria e Francesco I da Carrara nella guerra di Chioggia contro Venezia. Probabilmente proprio in quet'epoca Venezia decise di intromettersi attivamente negli affari dei Patriarchi, perchè rappresentavano un pericolo per la stessa sopravvivenza della città lagunare. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
1 punto
-
Terminati i loro piani di guerra si salutarono e si divisero. Si reincontreranno circa 6 mesi dopo, sul teatro di guerra di Filippi, destinati a scontrarsi con i due giganti che dopo si sarebbero spartiti il mondo: il lussurioso Antonio e l'astuto Ottaviano. Ma questa è un'altra storia, e un'altra serie di monete ...1 punto
-
Spagna, re cattolici Ferdinando e Elisabetta 1474-1504 real zecca di Siviglia1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Ecco due immagini del volume di Cappellari La classificazione della rarità è uguale..1 punto
-
1 punto
-
DE GREGE EPICURI Sia le figure che le scritte hanno margini molto sfumati e arrotondati, non c'è nulla di "netto", anche se la moneta non sembra tanto usurata. Poi sul fondo vedo tutta una grana di mini-crateri.1 punto
-
Siccome ultimamente ho sentito varie volte questa domanda, vorrei dare una mia opinione: non esiste una regola aurea per stabilire il giusto prezzo di una moneta in quanto tale valore (potenzialmente) può cambiare in qualunque momento per un’infinità di motivazioni. Ad esempio, ci sono alcune categorie di monete che vanno più o meno di moda in un determinato periodo. Guardate, ad esempio, la svalutazione generale subita dalle lire della Repubblica. Viceversa, ultimamente, sono estremamente ricercate le alte conservazioni e anche monete ritenute comuni o poco rare spuntano aggiudicazioni impensabili fino a pochi anni fa. Anch’io ho il catalogo Gigante e posso assicurare che, in alcuni casi, le valutazioni dei FDC sono sottostimate rispetto al reale andamento del mercato. Quindi non è sempre vero che nei cataloghi i prezzi sono “gonfiati”... Quindi come fare? Come si capisce se si sta comprando ad un buon prezzo? Ci vuole, semplicemente, esperienza. Bisogna, innanzitutto, puntare ad una certa monetazione e studiarla, osservare l’andamento dei prezzi su eBay o, ancora meglio, le aggiudicazioni nelle aste e, infine, frequentare periodicamente i convegni e i mercatini. Questa è la base. Dovete avere pazienza nel fare acquisti e, soprattutto, sapere quello che si sta comprando. L’affare della vita o la botta di culo verranno forse un giorno ma bisogna essere preparati. Se, invece, volete comprare “alla cieca”, dovete assumervene i rischi...1 punto
-
Stai sereno, all'inizio capita a tutti di prendere qualche fregatura. Abbiamo questo strumento formidabile che è LaMoneta, per conoscere le monete. Frequenta il forum e vedrai che imparerai tantissimo. un saluto1 punto
-
Patriarcato di Aquileia Ludovico I della Torre (1359-1365) Denaro Argento Peso: 0,90 g Diametro: 19 mm D/ LVDOV - ICI (crocetta forata) PA (crocetta forata), il Patriarca seduto sul faldistorio benedice con la mano destra e con la sinistra regge la croce patriarcale R/ (crocetta forata) AQVI (crocetta forata) - LEGIA (crocetta forata), torre su bastoni gigliati e decussati, ai lati L - V Rif.: Passera-Zub 220; CNI VI, 6; Bernardi 55 Ecco l'altro denaro di Ludovico I della Torre, terzo patriarca di questa famiglia dopo Raimondo e Pagano. Il primo denaro fu postato in precedenza da @chievolan. Sul dritto è rappresentato il patriarca seduto sul faldistorio ornato da teste di leone. Sul rovescio vi è il simbolo della famiglia del Patriarca, ovvero una torre sopra i bastoni decussati. Forse non tutti sanno che i Della Torre furono signori di Milano prima di essere cacciati dai Visconti. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
vedi collegamento: https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/bollettino/a-stampa/monografie?p_p_id=Monografie_WAR_FSIA6_Numismatica10_INSTANCE_E7qY&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_Monografie_WAR_FSIA6_Numismatica10_INSTANCE_E7qY_actionName=bollettino&_Monografie_WAR_FSIA6_Numismatica10_INSTANCE_E7qY_id=32&_Monografie_WAR_FSIA6_Numismatica10_INSTANCE_E7qY_javax.portlet.action=invoke Mario1 punto
-
Un numismatico che consuma tabacco potrebbe trovarlo interessante1 punto
-
Noi occidentali, diamo un valore commerciale a tutto ciò che esiste....1 punto
-
Ciao Mario, credo che Caio Ottavio meriti un mi piace che dici? Se vuoi, puoi cliccare sul cuoricino che sta in fondo a destra del post.1 punto
-
1 punto
-
Credo che sia meglio guardare tra le tessere di piombo di epoca romana come già ipotizzato da @dux-sab del resto se osservi bene si intravede il metallo bianco tipico del colore del piombo.1 punto
-
Buon giorno Juno, con questo post mi farai andare fuori di testa (mi hai impicciato il cervello, stamattina); Questo è il caso emblematico del "detto" che nelle monete Napoletane il difficile sta proprio nel ricercare due monete uguali :o E questa è solo la corona figuriamoci il resto della Moneta :( Aspetta oggi che vado sotto l'ombrellone e vedrai che qualcosa di uguale te la trovo :angry:1 punto
-
Ragazzi...qui innanzi tutto bisogna :hi: almeno per quanto mi riguarda e fare i complimenti a Juno per come, sia in questo caso, che negli ultimi post espone i concetti e analizza gli argomenti che vengono sottoposti nella sezione; Complimenti Giuseppe. Fatta questa breve premessa, alla quale ci tenevo particolarmente, nel caso specifico della Piastra denominata "Ruota di Carro" dando un'occhiata al mio esemplare in collezione avrei notato che a differenza di quella di Fabrizio, nella quale la punta in alto dello Stemma s'infila nella corona, la mia resta brevemete distante. Avete notato casi simili ? Cioè esiste una differenza in ragione dello Stemma che in questa Piastra, per intenderci del tipo "drappeggio più ampio e ricco", può riscontrarsi tra le varie grandezze dello Stemma stesso ? (Grande, Medio, Piccolo) oppure è un caso isolato. Si può tentare di analizzarlo? Grazie1 punto
-
E' una cosa che mi sono sempre chiesto, da quando da piccolissimo entrai per la prima volta in un museo e vidi le pipe romane. Siccome il tabacco viene dal continente americano, i romani non potevano conoscerlo (fino a prova contraria). Insomma di cosa si facevano i nostri Avi??? :lol: :lol: :lol:1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?