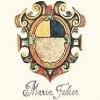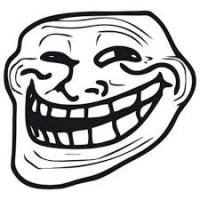Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 05/17/20 in tutte le aree
-
Con oggi sono due mesi che è partita questa discussione. Il risultato è notevole, siamo a 500 post, 7200 visite e tantissime monete illustrate. Per festeggiare ho pensato a questo scudo di Ludovico Manin (1789-1797). Rif.: Zub-Luciani 110.33. Arka Diligite iustitiam5 punti
-
Saranno tutte dello stesso diametro. 1816 con "punto" prima e rombo dopo la data.5 punti
-
Per gli appassionati di storia un interessante residuo della guerra fredda: due delle poche schede telefoniche emesse dall'Unione Sovietica prima di cessare di esistere: Per continuare la serie "paradisi della cartofilia dove le schede continuano ad essere usate ancora oggi (infilandole nei telefoni)", dopo il Vaticano abbiamo Cipro, con splendidi paesaggi naturali: e il Giappone nel suo tipico stile, con un personaggio di Angel Beats!, opera di animazione fantascientifico-surreale che parla dell'aldilà: Questa scheda testimonia anche il passaggio alla nuova banda magnetica corta.4 punti
-
Continuo con temi sociali. Croce Rossa Italiana e Telecom per la campagna Nazionale a favore delle vittime delle mine. Saluti Alberto4 punti
-
Buongiorno a tutti, @pietromoney la mia modesta 1816 con rombo dopo la data E niente dopo REX4 punti
-
Comunque esiste un posto dove si può ancora telefonare come ai tempi d'oro della cartofilia: il Vaticano. Agli apparecchi a moneta sono affiancati quelli a scheda, e ancora oggi vengono emesse le relative carte a chip (che dal 2014 hanno sostituito quelle a banda magnetica). L'esemplare qua sotto a destra del telefono è dell'anno scorso. E per completezza aggiungiamo anche un prototipo di nuova scheda vaticana realizzato nel 2010, prima che si decidesse di abbandonare il sistema Urmet a banda magnetica:4 punti
-
Facciamo un piccolo giochino...Pensate a una classica battaglia in stile giapponese tra due feudi nemici, come quelle che si vedono in alcuni film e serie TV. L'avete pensata? Beh...Scommetto che buona parte di voi ha sognato una battaglia con gli eserciti costituiti principalmente dai famosissimi guerrieri samurai, ma la realtà storica era ben diversa. Pertanto, in questa discussione analizzeremo un'ossatura "sconosciuta" degli eserciti giapponesi feudali: i fanti ashigaru. L'origine degli ashigaru Gli ashigaru, letteralmente "piedi leggeri", furono fanti impiegati nei conflitti del Giappone feudale dalla casta dei samurai. Qual è l'origine di questi fanti? Per rispondere a questa domanda bisogna dare uno sguardo alle origini dei samurai...Inizialmente i samurai servirono principalmente come arcieri a cavallo, tanto che i primi racconti non menzionano nemmeno le spade ed elogiano l'abilità con l'arco. La fanteria appiedata era costituita principalmente da agricoltori arruolati, non addestrati ed equipaggiati con i loro strumenti agricoli convertiti ad armi. Considerati dei non soldati, gli agricoltori arruolati non erano pagati e guadagnavano di razzie e bottini. Fu così che nacquero i primi nuclei di ashigaru. I contadini si resero presto conto che combattere le guerre poteva renderli più ricchi, e molti rinunciarono all'agricoltura per diventare fanti negli eserciti dei vari feudi. I primi racconti descrivono gli ashigaru come elementi pericolosi, mercenari, inaffidabili, ribelli e con un alto tasso di diserzione. È per questo motivo che gli ashigaru sono quasi sconosciuti, proprio perché gli scrittori giapponesi erano più interessati a scrivere storie sui samurai che ai mercenari contadini. Il culmine dello scempio fu il saccheggio e la distruzione di Miyako (l'odierna Kyoto) durante la guerra Ōnin (1467 - 1477). Nel periodo Sengoku (1467 - 1603) il modo di combattere cambiò dai numerosi duelli singoli al confronto tra formazioni disposte in ranghi. Pertanto, gli ashigaru diventarono la spina dorsale di molti eserciti feudali, trasformandosi a fanti semi - professionali ed equipaggiati. L'equipaggiamento degli ashigaru Come specificato precedentemente i primi ashigaru non avevano nessuna armatura e utilizzavano i vari strumenti agricoli come armi. Con l'inasprirsi delle guerre e il cambio del modo di combattere, i vari capi feudali iniziarono a equipaggiarli con armi migliori e armature economiche. Spesso erano armati con una lancia (yari) o un arco (yumi), ma molti portavano anche una spada (uchigatana) come arma da combattimento ravvicinato. Essenzialmente era una spada economica "usa e getta"; e la famosissima katana è un'evoluzione proprio di questa spada. Nel XVI secolo gli ashigaru furono equipaggiati anche con i tanegashima-teppō, un archibugio derivato da quelli portoghesi. Approfondiremo l'utilizzo delle armi da fuoco nella parte successiva. Per quanto riguarda l'armatura poteva consistere in un cappello conico (kasa), pettorali (dō), delle maniche rinforzate (kote), gambali (suneate) e cosciali (haidate). Il cappello conico poteva essere sostituito anche da un classico elmo giapponese (kabuto) o un cappuccio (tatami zukin). Nel periodo Sengoku la richiesta di armamenti aumentò a causa dei sempre più crescenti eserciti di ashigaru, aumentando così la produzione di elmi e armature semplici come la tatami. Inoltre, gli ashigaru, così come i samurai, portavano lungo la schiena un'asta con in cima uno stendardo chiamata sashimono, con lo scopo di facilitare l'identificazione durante la battaglia. Immagine da sinistra verso destra: cappello conico "kasa"; disegno recente di un gruppo di ashigaru; armatura di tipo "tatami" L'arrivo delle armi da fuoco I giapponesi utilizzavano armi da fuoco già da oltre due secoli, ma si trattava di rudimentali schioppi e cannoni derivati da modelli cinesi arcaici e superati. Come si arrivò a produrre un archibugio simile a quello portoghese? Devo dire che la storia è alquanto...bizzarra. Nel 1543 una nave cinese diretta verso l'isola di Okinawa con a bordo degli avventurieri e mercanti portoghesi fu costretta a ormeggiare nell'isola di Tanegashima a causa di una tempesta. La nave venne sequestrata e il signore dell'isola, Tanegashima Tokitaka, entrò in possesso di due archibugi. Capite le potenzialità di queste armi, Tokitaka affidò i due archibugi al suo armaiolo di fiducia, ma questo non riuscì a riprodurre il complesso scodellino dell'archibugio. Il problema si risolverà l'anno successivo, quando i portoghesi tornarono a Tanegashima portando un loro armaiolo che venne messo a servizio del daimyo dell'isola. Negli anni successivi la famiglia Tanegashima passò l'idea al potente clan Shimazu, ma in breve tempo anche altri clan si appropriarono dell'invenzione. La diffusione fu rapida e in soli 10 anni furono prodotti circa 300000 tanegashima-teppō. I samurai non disdegnarono l’uso degli archibugi, ma non si adattavano nel loro stile di combattimento. Per risolvere questo inconveniente i daimyō iniziarono a dotare i propri ashigaru con le nuove armi, anche perché richiedevano scarso addestramento per essere impiegati rispetto agli archi che servivano tanti anni di pratica. Il vantaggio degli archibugi fu decisivo durante la fine del periodo Sengoku. Un esempio è la battaglia di Nagashino (1575) dove i fucilieri ashigaru, appartenenti alla coalizione tra clan Oda e Tokugawa, vennero posizionati strategicamente da Oda Nobunaga e falciarono la temuta cavalleria del clan Takeda con colpi incessanti. Dopo la battaglia, il ruolo degli ashigaru negli eserciti venne riconosciuto e divennero un elemento essenziale pari ai samurai. I fucilieri ashigaru verranno utilizzati anche nelle invasioni della Corea nel 1592 e nel 1597, con un rapporto tra fucili e archi di 2:1 alla prima invasione e uno di 4:1 durante la seconda. Immagine da sinistra verso destra: stampa del periodo Edo con fucilieri ashigaru; stampa del periodo Edo che raffigura degli ashigaru indossare i "mino" sotto la pioggia. La fine degli ashigaru Con l'inizio dello shogunato Tokugawa (1603 -1868) l'arruolamento degli ashigaru iniziò subito a cadere in disuso. Sempre durante gli inizi del periodo Edo gli ashigaru rimanenti, oramai diventati professionisti, vennero considerati parte della classe samurai, nettamente più importante e prestigiosa, in alcuni feudi, mentre in altri rimasero tali. Così finì l'utilizzo dei "piedi leggeri", che da contadini mal equipaggiati e rozzi si trasformarono nel corso del tempo in fanti ben riforniti e disciplinati. Riprendo una bella frase finale su un sito storico straniero che rispecchia un po' tutta questa discussione: quando diciamo la parola samurai, non ci rendiamo conto che stiamo anche dicendo ashigaru. Spero che la discussione sia stata di vostro gradimento! Per qualsiasi dubbio o informazione scrivete pure! Alla prossima Xenon97 Gruppo di rievocatori vestito da ashigaru marciano in parata come parte della rievocazione della Battaglia di Sekigahara.3 punti
-
Non credo sia un problema del tondello ma dell'impronta. Tieni presente che il metallo veniva riscaldato portandolo a temperatura quasi di fusione, per cui il metallo andava a occupare tutti gli incavi del conio compreso tutti i difetti che esso presentava.3 punti
-
Questa monetina ci permette di aggiungere una nuova tessera nella costruzione di quell'enorme mosaico che è la monetazione sabauda. Come da titolo si tratta di un Viennese del II tipo del periodo di Carlo Il. La sua particolarità sta nelle sigle, TPP inedite sino ad ora su questa tipologia, che portano allo Zecchiere Pietro Paolo Porro che operava nella zecca di Torino. Nei primi anni di regno di Carlo Il la zecca di Torino era ancora appaltata a Giacomo Cassini, come sotto Filiberto Il, a cui subentrò appunto il Porro, probabilmente per meno di un anno, sostituito poi da Giacomo Dovetti. La coniazione di Pietro Porro fu probabilmente scarsa, visto la rarità delle monete che riportano le sue sigle, si possono trovare su uno scudo d'oro, due tipologie di testoni, tre grossi, parpagliole, quarti, forti ed ora si conoscono anche per i viennesi. Tutte queste tipologie con queste sigle sono abbastanza rare, come già detto, ma non conosco i rendiconti di battitura del periodo. Molti esemplari rintracciati del viennese presentano dei tondelli irregolari e, spesso, non permettono di leggere le sigle, in questo caso invece, sebbene il peso sia calante, 0,45 grammi, la moneta è bella larga da permettere la lettura di tutta la legenda.3 punti
-
Ricordo anche io quei gigliati, visti anche in qualche convegno. Erano tutti uguali, ma questo non somiglia per niente a quelli falsi. Cmq è sempre bene parlarne soprattutto se si hanno dei dubbi.3 punti
-
della serie mancava lei.. la sorella minore, per l'occasione ho sperimentato nuove soluzioni di illuminazione.. in particolare mi piacevano i risultati del dritto.. un mix di condizioni per cercare di combinare al meglio 3 fattori... 1 - rendere al meglio la tridimensionalità dei rilievi( visto che sono molto bassi); 2 - cercare di dare una illuminazione il più possibile uniforme.. per evitare antiestetiche zone d'ombra; 3- avere una illuminazione con l'intensità giusta per esaltare freschezza e brillantezza del metallo senza bruciature.. vi assicuro che combinare queste 3 cose insieme su questa moneta è una impresa veramente difficile per me. Dopo aver fatto la foto mi sono accorto che una parte bordo a destra non era sollevato abbastanza dal gommino, che appunto copre un po il bordo... allora ho cercato di ripetere la foto uguale,dopo averla sollevata un po... morale della favola non sono più riuscito a fare la stessa foto... come questa.. è proprio vero che questa moneta ha il fascino della maledizione ??3 punti
-
Posto un ducatello a cui tengo particolarmente pur essendo di qualità media, dovevo già presentarlo qualche tempo fa' quando Arka postò un magnifico scudo della croce sempre di Silvestro Valier poi però mi sono perso altrove... Come detto già più volte i ducatelli di alta qualità sono abbastanza ostici e difficili da reperire, ecco quindi che personalmente pur essendo costato un " tantin massa " lo comprai per la collezione. Io poi in tutta onestà non mi sento di considerarlo comune il Valier.3 punti
-
Buongiorno, posto di seguito due esemplari di anelli in pietra incisa che non possono non destare ammirazione circa la perizia degli artigiani che li crearono, al di là dei voli pindarici delle descrizioni scritte negli articoli (e in particolare, quella sul presunto anello di Caligola). NB: cliccare sul titolo per il reindirizzamento agli articoli. L'anello di Carvilio L'anello di Caligola Ciao Illyricum2 punti
-
buona sera a tutti. con questo 9 cavalli di Filippo IV, per stasera concludo.LA cosa abbastanza strana e' che manca la terza cifra che compone l'anno 16 9. Dovrebbe essere un 2 ma non c'e'.2 punti
-
2 punti
-
Buonasera, @mariarosaria, posto il mio 9 cavalli di Filippo IV 1626 con la quarta cifra quasi abrasa. @Rex Neap può essere utile a Mariarosaria per confronto? Saluti Alberto2 punti
-
Buonasera a tutti, anche io sono d'accordo con Lorenzo, @dareios it anzi aggiungerei che i campi sono la parte più alta (sporgente) del conio, e quindi è quella parte che in fase di coniazione spinge di più il tondello vergine. Spingendo di più nel tondello caldo diciamo che tende a "spianare" maggiormente eventuali imperfezioni (come i graffi di lima) rispetto ai capelli, che per esempio, sono la parte più alta delle moneta ma più bassa del conio. Spero di essere riuscito a esprimere chiaramente il mio pensiero.2 punti
-
Ti scrivo solo un ulteriore informazione: dal 1628..... quindi 28/29 e 30 i contrassegni dei coniatori sono sempre avanti busto...negli anni prima o a fine legenda a destra o sotto il busto. Buona serata anche a te.2 punti
-
No, Pietro non arriva neppure allo SPL ? Voglio impreziosire la tua discussione condividendo la mia INPANS, pochi pezzi conosciuti.2 punti
-
Buona Domenica Artur, è l'ultimo che ti resta del rotolino? Fantastico! saluti luciano2 punti
-
2 punti
-
2 punti
-
Sono monete da Mezzo Carlino, di Filippo III di Spagna; i primi due battuti all'inizio del suo regno, tra il il 1599-1606, Filippo è raffigurato giovanissimo, mentre il terzo, più adulto, tra il 1606 e il 1609. Quest'ultimo, non ha le sigle ed è più raro dei precedenti.2 punti
-
Ciao Beppe, certo che possiamo darci del Tu? Per tendenza intendo dire da circa 2 mesi a questa parte ovviamente, ma inserisco anche il mese prossimo, poiche' sto guardando varie aste in corso dove gia' tra le offerte presenti, questa "tendenza" diciamo , e' la stessa. La tesi iniziale era comunque che, a mio avviso, l'incremento di prezzi o valore ci sara' per le monete in altissima conservazioni, poiche' l'andamento del mercato era gia' quello....ora che momentaneamente vi e' un 'offerta praticamente nulla per via della mancanza di aste battute, e anche nei mesi prossimi sara' comunque inferiore al passato per via del Lockdown che ha impedito reperimento, sara' molto difficile poter soddisfare la domanda che era e (sempre a mio parere) rimarra' alta. Questo e' il discorso relativo alle alte conservazioni....ne consegue il fatto , a dimostrazione che il mercato numismatico al momento e' in salute, in mancanza o scarsa proposta di questo tipo di materiale, la gente ,comprando ugualmente , si trova a contendersi cio' che vi e' ora sul mercato , ossia le medio-basse conservazioni. Da qui il fatto che monete, che fino a dicembre scorso magari sarebbe state invendute a "X" perche' rappresentavano un mercato in discesa, ora non solo vanno vendute, ma realizzano addirittura molto piu' di "X". Poi ovviamente se guardiamo al futuro mercato tra 6-7 mesi o 1 anno e ragioniamo su pandemia finita, il mio pensiero rimane quello di sempre, ossia quello che avevo prima dell'inizio di questa situazione......monete in altissima conservazioni che saranno sempre piu' richieste e non perderanno di valore ed uno scostamento dai prezzi delle monete in medio-bassa che sara' sempre maggiore. Quindi si, anche io ritengo che cio' che stiamo vedendo ora per le medio-basse conservazioni sia solo una cosa temporanea , dovuta principalmente alla mancanza di alte conservazioni. Una volta che torneranno ad essere proposte, la "battaglia" tornera' ad essere su queste Ciao Roberto2 punti
-
Un evento importante per la nostra Telefonia : la Telecom subentra alla SIP , nella seconda scheda pubblicizza il servizio fax "Mosaico"2 punti
-
Buonasera e buon weekend. Di recente ho migliorato l'esemplare che avevo in collezione...è la prima volta che cambio una moneta per migliorarla con Modena ma quando l'ho vista non ho potuto dire di no. Questa è una delle poche tipologie collezionabili di questo duca, in mistura. Il dritto risulta di conio un po più stanco a mio avviso, alcune lettere della legenda sono ribattute come se ci fosse stato un doppio colpo in fase di coniazione ed il conio risulti leggermente traslato....qualche traccia di nero al bordo, ossidazione da ritrovamento in un muro di casa a mio modo di vedere. Il vero punto di forza però è il rovescio....un'aquila davvero ben impressa, completa e ben centrata ed un'argentatura completa. Cosa ne pensate? Grazie a tutti quelli che lasceranno un parere o un commento e un saluto a tutti. Marco2 punti
-
1 punto
-
Altra monetina presa a inizio 2020 e pagata 30 centesimi. 20 cent 1919 "esagono" Si notano anche alcuni dettagli del 20 cent del 1894/51 punto
-
Ciao a tutti..posto questa scheda a tema storico che fa riferimento alle 5 giornate di Milano che nel 1848 un'insurrezione armata si ribellò al dominio austriaco1 punto
-
1 punto
-
E' la 428a Magliocca ?!?!?! ?? R4 Complimenti @Rocco68 moneta rarissima. Riguardo allo stato di conservazione, per me arriva appena appena al BB ? Ovviamente scherzo. SPL pieno x me e dal vivo forse anche di più1 punto
-
https://www.sixbid-coin-archive.com/#/de/search?text=lira gritti spl 250 euro . C'è anche questa che riporto sotto finita a 100 euro piu diritti in qspl quindi sopra i 150 euro spedita SECONDA PARTE - MONETE DI ZECCHE ITALIANE Venezia Andrea Gritti, 1523-1538. Mocenigo o lira (sigla L.M), AR 6,50 g. Paolucci 5. q.Spl1 punto
-
Salve, Prima moneta, la seconda foto va capovolta, somiglia a questa https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-FIII/18 Ignoro il valore. Per la seconda moneta, non è il mio campo. Attendiamo pareri...1 punto
-
1 punto
-
Concordo con quanto detto da @Stilicho . In esergo dovrebbe esserci SMAQP o SMAQS. La S iniziale è ben visibile, la fine purtroppo no. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
Buona sera, In questi giorni con l'aiuto del catalogo "Varianti ed errori nelle monete della Repubblica Italiana 2002, 2003" mi sto divertendo a catalogare curiosità e piccoli difetti che ho trovato su alcune monete della Repubblica. Volevo portare alla vostra attenzione la moneta oggetto della discussione, 50 Lire 1992 che ritengo in conservazione BB. La monetina è stata coniata con conio abbastanza usurato. Al R/ si nota una impronta centrale evanescente e quindi manca la R di Repubblica. Al D/ stesso difetto e quindi manca il rombo sopra la firma dell'incisore. Come riportano alcuni cataloghi dal 1992 al 1995 la mancanza del rombo, parziale o totale è dovuta alla consunzione del conio. Cosa ne pensate di queste curiosità? Saluti miza1 punto
-
Bellissima e interessante discussione! Complimenti! Saluti e grazie di averla postata!1 punto
-
Per chi non avesse avuto l'opportunità di vederla... Direttamente dal Magliocca...1 punto
-
Bellissima discussione, e complimenti ad @acraf per gli approfondimenti a suo tempo condivisi. Mi chiedevo: non è che nel frattempo sono diventati un libro o un articolo? Credo che poche cose siano così interessanti e, allo stesso tempo, così prive di certezze, come la nascita della moneta.1 punto
-
@lorluke @gennydbmoney @pietromoney @gcs...ciao gente... Son contento le foto vi abbiano fatto cambiare idea e grazie per i complimenti. Io già dalle prime foto intuivo il potenziale della moneta in questione e quando alla fine è arrivata non sono rimasto deluso, delle volte ci vuole un pò di fortuna e un pò di occhio come scrive @gcs...la qualità delle foto del venditore è sempre stata scarsa e non era facile giudicare, un pò mi son buttato! Ho inserito in collezione una moneta che difficilmente cambierò....belli sti pezzi1 punto
-
Complimenti una monetina bella larga e centrata. Spesso le schiacciature sono proprio nelle aree fondamentali, tipo sulla sigla o il segno di zecca, ma questa a mio avviso non pregiudica molto la tipicità della moneta. Notavo il punto sullo scudo che avrà sicuramente un significato specifico, ma quello nel 3°cantone della croce è anch'esso voluto o è accidentale? La posizione mi sembra stranamente vicina al gambo.. di solito sono più centrati nel cantone1 punto
-
@Blakye Come detto sopra, sarebbe opportuno allegare una foto anche del dritto. Comunque, a me sembra di vedere una "C" a ore 9 (cerchietto rosso) e "..PVBLICAE" sul lato destro. Inoltre, a sinistra delle figura, si vede una sorta di fiocco o coccarda o piccola corona (cerchietto azzurro). Questi elementi mi farebbero propendere per una SECVRITAS REIPVBLICAE che e' stata emessa da Graziano, Valente, Valentiniano I e Valentiniano II. In esergo leggo una "A" e l'abbozzo di una lettera che potrebbe essere una "Q". Questi elementi mi fanno supporre la zecca di Aquileia. Proprio Aquileia ha emesso SECVRITAS REIPUBLICAE con quel fiocco/coccarda/corona in campo sinistro del rovescio. Allego un link esplicativo: https://www.tesorillo.com/aes/102/102i.htm Spero di non aver detto inesattezze. Ogni correzione/integrazione e' sempre ben accetta. Ciao. Stilicho1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
@tonycamp1978 grazie per i tuoi interventi, giuste osservazioni. I miei esami sono frutto esclusivo di curiosità. Mentre per l'oncia USA ho visto il formarsi della patina da quando non esisteva, per la moneta svedese non è stato possibile in quanto acquisita un paio di settimane fa. Di quest'ultima, per informazioni fornite dal venditore, posso dirti che è stata conservata in un monetiere per svariati anni. Lo studio che dici tu sarebbe molto interessante ma ci vuole molto tempo per verificare il variare della formazione della patina. I miei post volevano essere solo uno stimolo ad intraprendere studi un po' diversi da quelli esclusivamente numismatici, spero che qualche collezionista giovane lo faccia, basta avere un po' di curiosità e fare un piccolo investimento nella strumentazione.1 punto
-
Buonasera. Colleziono prevalentemente altro ma qualche monetina del regno incontra i miei gusti. Qualche anno fa ebbi modo di aggiungere questa in raccolta. Non è ancora stata postata in questa miscellanea, preferite tutti la "cinquantenario". Secondo me questa impronta non è da meno; in più ho l'impressione che questa tipologia sia più brillante rispetto alla precedente in analoga conservazione. È solo una mia impressione? Buona serata.1 punto
-
Guidati da Roberto d' Altavilla "il guiscardo" , entrano a Roma da porta S. Giovanni il 27 Maggio 1084, chiamati da papa Gregorio VII asserragliato in Castel Sant' Angelo per resistere al nemico di sempre, l'imperatore Enrico IV . Gregorio VII ha speso buona parte degli ultimi 10 anni nell'antagonismo con l'impero nella lotta per le investiture, con l'apparente vittoria ottenuta con l'umiliazione di Enrico IV a Canossa nei 3 giorni del 25 Gennaio 1077 . Enrico IV riesce a conservare l'impero, rafforza il suo potere e riprende l'offensiva contro il papa entrando in Roma il 21 Aprile 1083, portandovi l'antipapa Clemente III : ritornerà ancora in Roma l'anno seguente per esservi incoronato imperatore dall'antipapa il 31 Marzo 1084, con Gregorio VII assediato in Castel Sant'Angelo . L'arrivo dell'esercito del 'Guiscardo' allontana l'imperatore da Roma ma la città diventa preda dei Normanni che per giorni la saccheggiano infierendo sugli abitanti ribellatisi : un enorme incendio completerà le distruzioni al punto che buona parte della città sarà da allora a lungo disabitata . Gregorio VII seguirà, pressochè prigioniero, i Normanni che lasciano Roma e raggiungerà Salerno dove chiuderà la sua vita il 25 Maggio 1085 . Roberto il guiscardo, duca di Puglia e Calabria, ha battuto in Salerno rari follari in Ae, mentre in Roma, probabilmente circolavano ad esempio denari al nome di Leone IX con Enrico III .1 punto
-
Bisognerebbe postare il quesito nell'apposita sezione (exonumia), lì sicuramente sapranno rispondere alla tua domanda. Saluti1 punto
-
La legenda al rovescio, RE FRUMENTARIA RESTITUTA ("Ristabilita la coltura del grano"), ricorda le agevolazioni che questo pontefice concesse per la campagna romana. Questa moneta e anche l'analoga estremamente rara quadrupla, ricordano infatti tanto la diminuzione di un paolo che Alessandro VIII concesse per la macinatura di ciascun rubbio di grano, quanto il permesso che venne concesso agli agricoltori di esercitare il commercio del grano stesso. Questo è l'esemplare della mia collezione. Michele1 punto
-
I do not know similar uses in Italy, but in a famous 90s pop song the 100 lire coin was mentioned to indicate a betrayal with a paltry sum.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?