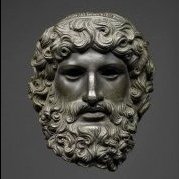Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 09/27/20 in tutte le aree
-
Buonasera a tutti, giornata piovosa, il pomeriggio sta trascorrendo immerso piacevolmente con monete e vassoi.. ? Per la Napoletana di oggi ho scelto uno dei miei Tornesi da 6 Cavalli Ferdinando IV millesimo 1789. Spulciando su Wikipedia ho trovato un interessante passaggio che credo possa interessare anche voi e magari spingere ad approfondire. ? Notiziario di Corte Notiziario di Citta'. Il Notiziario di Corte Notiziario di Città del Regno di Napoli è un vademecum tascabile, di cm 15x7,5, che contiene notizie utili sulla complessa e articolata organizzazione, politica ed amministrativa del Regno, nell'anno 1789 e sui rapporti con altri Stati. Descrizione del Notiziario Ricoperto di pelle marrone chiara, con impressioni in oro, sul piatto superiore e su quello inferiore porta lo stemma dei Borboni. Composto di 240 pagine, numerate da 7 a 240, è dotato di un frontespizio dove è rappresentata, di profilo e dentro una cornice ovale, la coppia regnante – Ferdinando IV di Napoli e Maria Carolina d'Asburgo-Lorena – con lo stemma borbonico. Sulla pagina a fronte, una incisione a tutta pagina – con il dio Nettuno, il Vesuvio e una sirena che sostiene un ovale col titolo Notiziario di Corte – introduce la prima parte di questo vademecum, almanacco dell'anno 1789. La datazione Anno 1789 si trova nella pagina seguente, ma è priva di luogo di stampa e di stampatore. Questo almanacco è stato pubblicato dal 1788 al 1790. La seconda parte è introdotta da una incisione simile, a tutta pagina, con la scritta Notiziario di Città. Questo vademecum rappresenta anche una curiosa somma di conoscenze, di vario genere, tipiche dell’epoca in cui fu pubblicato. Per averne una idea, basta questo passo, a p. 31: "Può considerarsi la terra come una sfera perfetta, senza un errore manifesto" Non sempre è chiaro il significato dei vari uffici, in cui era ripartita la gestione politica e amministrativa del Regno di Napoli e di certi termini arcaici sfugge il significato. Saluti Alberto3 punti
-
Buongiorno a tutti e buona domenica, oggi dalle mie parti il tempo non permette di stare all'aperto, ottima occasione per passare del tempo con le mie adorate monete. ? Posto Tornese con Tosone Filippo IV 1632 se vedo bene. Saluti Alberto3 punti
-
@Asclepia, ieri ti dicevo che il tuo amore per queste monete è contagioso, non scherzavo, proprio ieri a Capua oltre a toccarli con mano per la prima volta, mi sono subito innamorato di questo pezzetto. L'ho subito liberato dalla bustina dove era chiusa e soffriva. ? Complice anche la mia passione per i Cavallini Aragonesi ? Ecco il mio primo 2 grani Siciliani 1815 Saluti Alberto3 punti
-
Fermo restando che ogni intervento dovrebbe essere segnalato in fase di presentazione della moneta, nessuno considera il buco in quanto tale, nel senso che il foro è espressione del vissuto del manufatto e facente parte del suo corredo di informazioni al pari di una contromarca o di un graffito intenzionale, quindi la sua alienazione ha sminuito il "portato" numismatico e scientifico peculiare di quella moneta. Secondo me : operazione da condannare senza se e senza ma. Si tratta dell'ennesimo caso di snaturamento di un reperto, sacrificato sull'altare del profitto.2 punti
-
2 punti
-
Buonasera carissimi, diciamo che mi sono assentato per validi motivi... Separazione e perdita del lavoro in modo inenarrabile, sono dovuto ricorrere a 49 anni suonati agli avvocati, la prima volta in vita mia... Per quanto riguarda il lavoro ho ottenuto le mie rivincite e ora sono di nuovo in corsa, ma è stata dura.. Per quanto riguarda le donne ci sto lavorando... Diciamo che la numismatica è passata per un momentino in secondo piano.. mi sono ammazzato di sport per reggere lo stress, ha funzionato alla grande. Vi leggo comunque sempre ed ogni tanto osservo cosa propongono le aste online. Statemi bene tornerò presto. Silver2 punti
-
Ciao stessa moneta se osservate bene si vede il foro riparato, cambia leggermente colore il metallo apportato, logicamente le piccole diversità sono dovute alla successiva rifinitura e lucidatura, miracoli della saldatura con il laser e della mano dell'operatore. Silvio2 punti
-
Interessante articolo della Gabanelli sul Corriere.it: "Lingotti, elmi, monete. A chi appartengono i tesori sottomarini?" https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/tesori-sommersi-dove-sono-quanto-valgono-chi-appartengono/06b78fb4-fcdd-11ea-b4fe-6ee7d601be57-va.shtml2 punti
-
Salve a tutti! Dalla ciotola oggi solo due monetine a 50 cent l'una ma solo questa per me meritava anche di più: Gersh Etiopia 1903 (1895)2 punti
-
Buongiorno e buona domenica a tutti, Convegno di Capua terminato. ? Resta il bellissimo ricordo dell'esperienza fatta, degli amici incontrati e della cordialità e pazienza di ogni espositore, la disponibilità mostrata verso tutti anche verso chi è stato solo spettatore. Bellissime monete di ogni tipologia, molte le rarità e ottime le conservazioni proposte. Vi mostro la moneta Pescata in Ciotola per la quale non ho esitato nemmeno un secondo a prenderla, nonostante il rovescio fosse praticamente liscio, e il diritto un pelino messo meglio. Ma a mio avviso un ritratto inconfondibile e meraviglioso. 3 Grana Gioacchino Murat. ? Voi l'avreste lasciata? Saluti Alberto2 punti
-
Io proverei a cercare tra le monete emesse dalla lega tessala2 punti
-
Come prima cosa, mi sembra doveroso presentarvi la moneta in oggetto, si tratta di un 50 centavos coniato nel 1947 dalla zecca di San Francisco, prima emissione numismatica delle Filippine in seguito all'indipendenza ottenuta dagli USA nel 1946. La moneta presenta le medesime caratteristiche metriche delle monete coniate dagli USA durante il precedente periodo del Commonwealth delle Filippine, ovvero 10 grammi in argento '750, per 27,50 mm di diametro. La tiratura è limitata a 200.000 esemplari, teoricamente non emessi per la normale circolazione, anche se molti esemplari in realtà circolarono. - Al Diritto abbiamo il busto in uniforme del Generale volto a destra, che intervalla la scritta "Gen. Douglas MacArthur" disposta su due righe; sotto il collo la data oggetto di commemorazione "Oct 20 1944" e, tutto intorno, la dicitura DEFENDER AND LIBERATOR OF THE PHILIPPINES; - Al Rovescio troviamo, al centro, lo stemma nazionale delle Filippine con ai lati due rose, in alto l'indicazione dell'autorità emittente, in esergo il millesimo, il segno di zecca ed il valore; Aggiungo che venne contemporaneamente emesso anche il taglio da 1 Peso in argento, con il medesimo design. La cosa che mi ha sempre colpito di questa tipologia è il fatto che, una commemorazione di tale importanza, fu fatta con il Generale MacArthur ancora in vita e pienamente operativo, tanto che di lì a pochi anni, come vedremo, sarà tra i protagonisti della Guerra di Corea. I vostri commenti sono come sempre graditi..2 punti
-
Complimenti Alberto...io ho cominciato ad appassionarmi a questa monetazione partendo proprio dai 2 grani, è stato amore a prima vista per l'iconografia...il tuo è un 2 grani con al dritto la legenda "aperta" (tra il punto della data e la x di rex c'è spazio), ci sono pure con legenda chiusa, e di recente ne ho trovato uno ancora più spaziato in cui la punta del collo di Ferdinando entra praticamente nella legenda (lo posterò a tempo debito). Al rovescio il valore in lettere e cifre normali, c'è pure invece quello con il valore con lettere e cifre piccole...e poi come fa notare @demonetis, è ribattuto come capita spesso (è quasi più difficile trovarli non ribattuti) su una moneta austriaca da 6 kreutzer 1800...complimenti ancora per il tuo primo pezzetto...spero c'è ne saranno molti altri. Saluti2 punti
-
- TAGLIO : 2 commemorativo - STATO : Germania (Deutschland) - ANNO : 2017 - Data di Emissione : 3 febbraio - Scultore : // - Incisore : Frantisek Chochola - TEMA : Renania – Palatinato (Rheinland – Pfalz) serie «Stati federali» (Bundesländer) - Tiratura : 30.613.000 (Divisionale FDC: 31.000 / Divisionale FS: 27.000 / Folder FDC : 34.000 / Folder FS : 41.000) - Diametro: 25,75 mm - Peso: 8,50 gr - Spessore: 2,20 mm - Zecche: Berlino (A) ; Monaco (D) ; Stoccarda (F) ; Karlsruhe (G) ; Amburgo (J) - Zecca della moneta postata : Amburgo (J) La Porta Nigra è sicuramente la porta più grande e meglio conservata risalente all’epoca romana, situata al nord delle Alpi. Costruita in occasione della costruzione ad Augusta Treverorum (Treviri – in tedesco: Trier) fra il 170 ed il 180 d.C. , anche se per altri studiosi l’edificazione risalirebbe in una data compresa fra il 180 ed il 200 d.C. . La Porta Nigra è sita in una zona accanto al fiume Mosella, dove prima dei Romani viveva la tribù gallica dei Treveri della Gallia Belgica. Essa era la porta d’entrata nord della città, come la Porta Alba era al sud e la Porta Inclyta ad ovest. Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, la Porta Nigra divenne anche una chiesa, ed in essa visse come eremita il monaco Simeon. Essa servì come chiesa sino al 1802, quando, assieme ad altre chiese, venne chiusa per ordine di Napoleone Bonaparte. Dal 1986 fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. La Porta Nigra e la sua città (Trier) fanno parte di uno dei sedici stati federati tedeschi: la Rheinland – Pfalz. Questo stato, situato ad ovest e confinante con la Francia, venne istituito nel 1946 dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Faceva parte del Palatinato Renano, nato nel 1085 con Enrico II di Laach e decaduto nel 1803. Il suo capoluogo è Mainz ed ha poco più di 4 milioni di abitanti. La sua è una economia fiorente dove spiccano le industrie chimiche, farmaceutiche ed automobilistiche, nonché commercio, turismo, viticultura e agricoltura. I vini di questa terra sono molto rinomati, come rinomata è la "Deutsche Weinstraße" , ovvero “la strada tedesca del vino”, lunga 85 Km e dove in estate si tengono diverse feste legate appunto al vino. Le sue maggiori mete, siano esse città e non, sono principalmente: Mainz (Magonza), Trier (Treviri), Koblenz (Coblenza), il Castello di Eltz, Speyer (Spira) e i castelli della Valle del Reno.2 punti
-
Tutti ben sanno quanto diventano insopportabili le donne quando si mettono in testa delle cose e vogliono avere sempre ragione e non smettono fino a quando esausti, gli interpellati, fanno il segno di approvazione con uno sconsolato movimento della testa. Prokyrator_83 sul messaggio pagina 19 scrive di essere certo che il peso delle monete da 10 e 20 centesimi sia uguale a quelle emesse nello stesso periodo. La classica risposta di chi crede che non sia nessassario completare quello che va fatto e se proprio lo vuoi sapere prendi una tua moneta e pesatela. Se non corrisponde, anche di poco, va bene lo stesso. FFF nel messaggio pagina 16 scrive che le presentazioni gli sembrano ben fatte dimenticando che delle monete citate sono state presentate solo una faccia (che l’altro lato sia liscio?) rimarcando che manca il peso, segnalando che Prokyrator_83 la bilancia per pesare le monete ce l’ha. In natura, quando leggo e ascolto, nella mia testolina scatta un qualcosa che risolve l’interrogazione con rapidità. È la seconda parola che tutti i bambini dicono dopo la canonica “mamma”: perchè, perchè, perchè... ottenendo sempre la risposta. Signori, qui non stiamo parlando di identificazione ma di cosa dobbiamo identificare non avendo ricevuto neppure il minimo richiesto. Oltre alla foto, sulla prima pagina di ogni richiesta di identificazione sta scritto (e da compilare) peso, diametro, materiale presunto. È una richiesta ovvia e doverosa da fare. Chi non è in grado rinunci alla identificazione. Sicuramente ho peggiorato l’opinione che i lamonetiani hanno verso di me. Vi assicuro che non tutte le donne non sono così. Siate clementi. Purtoppo, per natura e preparazione alla vita, lavoro e affronto il tutto con le regole della Analisi e Sintesi. E le cose incomplete o imperfette vengono cestinate al volo, senza esitazione. Non so se nella numismatica funziona, nella vita sì.2 punti
-
Sul fondo di una kylix (530 A.C.) attribuita alla mano di Exekias, Dioniso è dipinto steso in una snella nave con lunghi tralci di vite attorno all'albero, in un mare con delfini . Il mito degli Elleni ci dice che Dioniso, in viaggio in nave, è rapito dai marinai, rivelatisi pirati : il dio trasforma l'albero della nave in vite e se stesso in leone e terrorizza i pirati creando anche mostri, forse immaginari . I pirati atterriti si gettano in mare ed il dio li trasforma in delfini, con una metamorfosi ben illustrata su un altro vaso etrusco, una hydria a figure nere del VI sec. A.C. . Forse per il ricordo dell'origine umana di quei mammiferi marini, i delfini sono spesso raffigurati anche nel loro legame con l'uomo, emblematico, ad esempio, nel mito di Falanto raccolto in mare da un delfino che lo porterà in salvo a terra facendolo cavalcare sul proprio dorso : considerato in epoca storica ecista dei Parteni, Spartani venuti in Italia per fondarvi Taranto, Falanto sul delfino diventa l'emblema cittadino di pressochè la totalità della monetazione tarantina .1 punto
-
E' da notare @gigetto13 che, come nei 2 dettagli da mosaici che ho postato, così come nel sarcofago, la figura sul delfino è alata e lo guida con le redini .1 punto
-
Ciao allobroge, avevo detto io a daniele8 nella Sezione identificazioni che poteva trattarsi di una moneta Savoia, ma dalle foto non capivo bene e indicativamente mi sembrava un Obolo di Carlo I, ora con queste foto , concordo con te.1 punto
-
1 punto
-
Molto piacevole e pur essendo particolarmente approfondito il tema, comunque alla portata di tutti. I trenta denari e alcune reliquie relative alla passione. Qualche ripetizione funzionale alla lettura per tutti Per chi ama la numismatica, la storia, ma anche semplicemente le curiosità1 punto
-
1 punto
-
Questa è una caratteristica comune delle monetazioni preunitarie. Varie zecche hanno una rosa di difetti di coniazione che spaziano da quelle sul tondello a quelle del conio. Non seguo pedissequamente questa coniazione, per cui mi limito ad un confronto da profano con le foto che ha postato il buon Michele per confronto. Il peso è molto calante e potrebbe essere un ottimo indicatore, ma non so se potrebbe rientrare nella regolare variabilità di peso di queste monete. Vediamo se interviene qualcuno che potrebbe aiutarci In ogni caso, per rispondere alla tua ultima domanda, l'acquisto di un falso coevo per me è sempre un ottimo acquisto.1 punto
-
Buona domenica a tutti gli appassionati di video relativi al mondo della numismatica. Quest'oggi vorrei mostrarvi un video del canale Passione Monete, in cui viene trattato il tema dei falsi numismatici. Per molti di noi potranno forse sembrare delle banalità ma credo che sia un video importante per chi non "mastica" la materia. Complimenti, quindi, al carissimo @rada per l'impegno dimostrato nel diffondere il Verbo del sapere numismatico (in questo video e non solo)! Buona visione1 punto
-
No, dai! non dire così!? Qui si discute pacatamente nel rispetto delle opinioni di tutti, nessuno escluso. Anche io, come te, ho fatto le mie considerazioni sul caso. Se qualcuno poi può aiutarci a risolvere l'arcano, ben venga, no? A me e' venuto in mente gpittini, ma sicuramente ci saranno anche altri. E' il bello del forum: il confronto. Buona domenica e a rileggerci. Stilicho1 punto
-
ANONIME - Aes Grave (289-225 a.C.) - Semisse - Pegaso a s.; sotto, lettera S - R/ Pegaso a d.; sotto, lettera S - (AE g. 159) RR Cr. 18/2; TV. 9; Syd. 16,52; Mont. 474 la V non è un segno di valore ma una contromarca di un cambiavalute. Il segno di valore è la S. Nessun coccodrillo ma solo pegaso1 punto
-
1 punto
-
Le monete appiccagnolate hanno anche loro i propri fan. MENO le monete con EX appiccagnolo che, probabilmente a ragion veduta, vengono viste come "ne carne, ne pesce".1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Buona sera amici...e grazie a tutti per l'apprezzamento...quelli che giustamente ha notato a gambe all'aria @Litra68 sono appunto grani che si distinguono per avere gli assi spostati... Solitamente i grani hanno tutti gli assi alla francese, io con quella mossa ho probabilmente confuso il buon @borbonik , è che altrimenti avrei dovuto capovolgere troppe monete...così quelle capovolte son grani con assi alla tedesca, di preciso i 2 grani 1814 con corona a sette punte, un grano del 14 (vedi foto), e i 5 grani del 1815 con sigle V.B. sfalsate (variante che ho scoperto da poco...) Qui posto la foto del grano del 1814 che non è in se una variante per particolari in legenda che è solo un pò più mossa del solito, o del ritratto o che, ma proprio perché si distingue da altri grani del 1814 per avere gli assi alla tedesca o a medaglia che dir si voglia. La monetina a mio parere è nata tribolata ma ha circolato quasi nulla, l'ho presa qualche tempo fa da un venditore di Bologna. Saluti1 punto
-
1 punto
-
@prokyrator_83 richiedi identificazioni e valore di monete di grande interesse numismatico e storico, mentre le tue presentazioni sono alquanto pessime sotto tutti i punti di vista. Se hai venduto o vendi un paio di monete che hai postato in passato ti compri una macchina fotografica migliore di quella che un professionista usa per lavorare, un calibro da far invidia a un meccanico, una bilancina così precisa da far arrossire un operatore di compro oro. Dai, non ci vuole tanto. mi sembri quel tale che ha una macchina bellissima senza il serbatoio per la benzina. Non vai da nessuna parte. Seguo le tue richieste e gli interventi dei lamonetiani con grande interesse. Se continui così mi sa che i tuoi post li salto a pie pari. E forse non sarò la sola. Ricorda che le monete hanno un dritto e un verso, un peso e se non c’è una ragione precisa se ne posta una alla volta. Fattene una ragione. Ora che ho finito di scrivere mi sono chiesta perchè ti ho fatto questa tiritera (termine vulgaris per dire che ti ho fatto una menata, termine vulgaris per dire che ti ho rimproverato). Alla fine se vuoi qualcosa da persone esperte e ben disposte a soddisfare le tue richeste sei tu che ti devi dare da fare. E se non lo fai chi ci rimette sei solo tu. A me, come vedi nel tondino in alto a sinistra di questa pagina, mi basta una carota da sgranocchiare per essere soddisfatta. Ciao. PM.1 punto
-
1 punto
-
Caro Allek comincio a capire quale puo’ essere la ragione nella distanza dei ns rispettivi punti di vista. lei credo non abbia molta pratica di aste ( questo tipo di aste beninteso). la sua descrizione e’ quella di un meccanismo che si svolge perfettamente inquadrato e indisturbato su dei binari stabiliti a priori ove non possono esistere ulteriori o diversi gradi di liberta’. la realta’ non e’ cosi e come ho - nell’effettivo svolgimento delle cose - la possibilità - a volte beninteso - di aggiudicarmi un lotto ad un prezzo anche molto inferiore alla stima se la partenza e’ bassa , cosi dall’altro lato ( venditore) non posso programmare con assoluta certezza i prezzi che faranno le mie monete ma solo quelli che io possa ritenere congrui con l’effettivo pericolo che non vengano aggiudicate. Il suo discorso funzionerebbe nel caso di un titolo quotato - beni perfettamente fungibili ove non vi sia differenziazione e l’incontro domsnda offera sul mercato telematico contribuisce alla formazione perfetta del prezzo per quel titolo in quel momento. cosa ben diversa sono le monete - che molti vorrebbero assimilare alla categoria di beni d’investimento ma il cui mercato - diversamente da quello dei titoli e’ altamente imperfetto perche un bene non e’ eguale all’altro . Non vi puo’ essere un valore equivalente di mercato . A giugno un ducato di Federico III d’aragona per Napoli e’ stato battuto a 6 volte il suo prezzo medio di realizzo. L’esemplare era eccellente e in quell’asta si sono scontrati due collezionisti che entrambi lo volevano a tutti i costi. In un’altra asta avrebbe fatto 1/5 di quella cifra o un esemplare leggermento meno bello avrebbe fatto ben meno della meta’. Qual’e’ allora il valore che l’offerente avrebbe dovuto stabilire? In assenza di competizione si sarebbe allineato sulla valutazione media o poco piu’ . Un offerente che avesse assistito a questa competizione invece pretendera’ che il livello di riserva sia notevolmente piu’ alto con il concreto rischio che la moneta resti al palo se non vi fosse la competizione descritta sopra. mi creda sono un economista e seguo per passione l’andamento del mercato delle aste e credo che non si possa parametrizzare senza fare delle grosse approssimazioni che porterebbero a degli errori marchiani. la vendita all’asta non potra’ mai essere equivalente ad altra scelta commerciale. Le esternalità sono infinite, mancando la fungibilità del bene. Appurato cio’ gli operatori dovrebbero, tuttavia, attenersi sempre ad un sano codice deontologico che purtroppo, nella pratica di mestiere e nel caso specifico delle aste, viene invece spesso piuttosto disatteso e il concetto che certi comportamenti non etici non destino riprovazione solo perche’ permessi dalla legge mi sconvolge e allontana dall’ambiente.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
AVresti potuto aggiungere, "come fanno praticamente tutti gli eshop, da quelli che vendono ciabatte a quelli che vendono elettrodomestici"1 punto
-
Buongiorno a tutti, Non so a voi ma a me il fatto di averle riunite dopo più di 170 anni è una cosa che mi piace assai1 punto
-
Ovvero, come far impazzire i collezionisti e fargli passare la voglia di questo tipo di prodotti (e di collezionare in generale)... ?1 punto
-
Buonasera Beppe, la tua Piastra 1840 è il tipo normale. Altra differenza nel dritto è la diversa dimensione dei numeri della data. Nella variante rara le cifre sono più grandi.1 punto
-
Che non vale per le monete degli Stati Uniti, dove viene considerato "dritto" il lato con la rappresentazione allegorica di Lady Liberty (o dei Presidenti), mentre il nome dell'autorità emittente è sempre dall'altro lato, il "rovescio". petronius1 punto
-
Gli stati preunitari Costituzione del Regno di Napoli del 1848 Il primo esempio in Italia di statuto costituzionale si ebbe a Palermo, quando il 19 luglio 1812 il Parlamento del Regno di Sicilia borbonico riunito in seduta straordinaria, promulgò la Costituzione siciliana del 1812, una carta sul modello inglese. La Costituzione prevedeva un parlamento bicamerale formato da una Camera dei comuni, composta da rappresentanti del popolo con carica elettiva, e una Camera dei Pari, costituita da ecclesiastici, militari ed aristocratici con carica vitalizia. Le due camere, convocate dal sovrano almeno una volta l'anno, detenevano il potere legislativo, ma il re deteneva potere di veto sulle leggi del parlamento. Fu soppressa di fatto nel dicembre 1816 con la nascita del Regno delle Due Sicilie. Nel 1848, con le rivoluzioni scoppiate durante la primavera dei popoli furono concessi dai sovrani di alcuni stati italiani alcuni statuti: quello napoletano, quelli del ducato di Parma e dello Stato della Chiesa, quello siciliano e, in Piemonte, quello Albertino. Lo statuto Napoletano, su ispirazione della Seconda Repubblica francese, prevedeva che il potere legislativo fosse condiviso tra re e Parlamento. In Sicilia, invece, si era formato un regno autonomo la cui Costituzione rendeva per la prima volta le due camere elettive mentre conferiva il potere esecutivo al re che lo esercitava per mezzo dei ministri responsabili, da lui nominati, che sottoscrivevano ogni suo ordine. Veniva riconosciuta la libertà di parola, di stampa nonché di insegnamento. Tale carta costituzionale era "rigida", in quanto per effettuare modifiche era necessaria una procedura aggravata che prevedeva il concorso di due terzi dei votanti presenti di ciascuna camera. Anche lo Statuto dello Stato della Chiesa conteneva norme simili alle altre carte coeve. Fatta salva la dichiarazione della religione cattolica come religione di Stato e il potere di censura ecclesiastica preventiva sulle pubblicazioni religiose, erano recepite le libertà fondamentali del cittadino: la magistratura era indipendente dal potere politico, i tribunali speciali erano aboliti, era garantita la tutela della libertà personale e l'inviolabilità della proprietà. Per la prima volta nello Stato della Chiesa, i laici erano ammessi sia nel ramo esecutivo che legislativo. L'iniziativa legislativa apparteneva ai ministri, che erano di nomina pontificia. Le leggi erano formate tramite un sistema bicamerale perfetto, costituito dall' "Alto Consiglio" e dal "Consiglio dei Deputati". I membri del primo erano nominati a vita dal pontefice, senza limitazione di numero, quelli del secondo erano eletti. Le leggi, dopo l'approvazione, dovevano essere controfirmate dal pontefice. Nell'esercizio delle loro funzioni i membri delle due Camere erano "inviolabili" e, se condannati, potevano essere arrestati solo con il consenso del Consiglio di appartenenza. Dall'Unità d'Italia alla 1° Guerra Mondiale Lo Statuto Albertino La continuità tra il Regno di Sardegna e quello d'Italia avvenne con l'estensione dello Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto di Savoia nel 1848, a tutti i territori del regno d'Italia progressivamente annessi al regno sabaudo nel corso delle guerre d'indipendenza. Lo stato italiano nacque, da un punto di vista istituzionale, con la legge 17 marzo 1861 n. 4671, che attribuisce a Vittorio Emanuele II, «re di Sardegna», e ai suoi successori, il titolo di «re d'Italia». È la nascita giuridica di uno Stato italiano ( anche se altri stati avevano già portato tale nome nel passato, dal regno longobardo per finire col regno napoleonico ). Lo Statuto Albertino rimase quindi in vigore quasi 100 anni quando entrò in vigore la Costituzione repubblicana. Lo Statuto Albertino fu simile alle altre costituzioni rivoluzionarie vigenti nel 1848 e rese l'Italia una monarchia costituzionale ereditaria secondo la legge salica, con concessioni di poteri al popolo su base rappresentativa. La sovranità apparteneva al Re il quale, da sovrano assoluto, si trasformava in principe costituzionale per sua esplicita volontà e concessione, limitandosi nei suoi poteri. Era una tipica costituzione ottriata, ossia concessa dal sovrano, e da un punto di vista giuridico si caratterizzava per la sua natura flessibile, ossia derogabile e integrabile in forza di un atto legislativo ordinario. Poco tempo dopo la sua entrata in vigore, proprio a causa della sua flessibilità, fu possibile portare l'Italia da una forma di monarchia costituzionale pura a quella di monarchia parlamentare, sul modo di operare tradizionale delle istituzioni inglesi. Lo statuto corrisponde a ciò che si definisce una "costituzione breve", limitandosi a enunciare i diritti e a individuare la forma di governo. Tra i diritti veniva riconosciuto il principio di uguaglianza, la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio, la libertà di stampa e la libertà di riunione. Il capo supremo dello Stato era il Re e la sua persona era "sacra ed inviolabile", i ministri rispondevano giuridicamente per gli atti regi. Il Re era tuttavia tenuto a rispettare le leggi ma non poteva essere oggetto di sanzioni penali. Egli esercitava il potere esecutivo attraverso i ministri, convocava le Camere, scioglieva quella dei Deputati e aveva il potere di sanzione delle leggi, istituto diverso dall'odierna promulgazione presidenziale, poiché il Re valutava nel merito e poteva respingerle. Inoltre, il Re nominava autonomamente il Consiglio dei ministri e il Parlamento si limitava al potere legislativo; la prassi applicativa, tuttavia, sempre più spesso voleva che il Consiglio dei ministri si rifiutasse di restare in carica quando non gradito alla camera elettiva, così che il re fosse considerato più quale rappresentante dell'unità statale che come capo dell'esecutivo. Il Parlamento era composto di due Camere: il Senato del Regno di nomina regia e vitalizia, e la Camera dei deputati, eletta su base censitaria e maschile. I progetti di legge potevano essere promossi dai Ministri, dai parlamentari e dal Re. Per diventare legge dovevano essere approvati nello stesso testo da entrambe le Camere e, in seguito, essere munite di sanzione regia. Per quanto riguardava il potere giudiziario, il Re nominava i giudici e aveva il potere di grazia. A garanzia del cittadino stava il rispetto del giudice naturale e il divieto del tribunale straordinario, la pubblicità delle udienze e dei dibattimenti. I giudici, dopo tre anni di esercizio, avevano garantita l'inamovibilità, mentre gli era negata l'interpretazione delle leggi con rilievo direttamente normativo. Il primo Parlamento dello Stato unitario, al principio del 1861, si compose con un suffragio elettorale ristretto al 2% della popolazione[21] (corrispondente a 600.000 cittadini) comprendendo ovvero solo i cittadini maschi con una data capacità contributiva; con la legge del 22 gennaio 1882, n. 999 il diritto di voto venne esteso anche a chi avesse la licenza scolastica elementare arrivando dunque a coinvolgere il 7% degli italiani ovvero circa 2.000.000 su di una popolazione di 28.452.000 cittadini. Con la legge del 30 giugno 1912 n. 666 la percentuale degli aventi diritto salì al 23% della popolazione allargando il suffragio a tutti i cittadini maschi che avessero compiuto 30 anni o che, pur minori di 30 anni ma maggiori di 21, avessero un reddito di almeno 19,20 lire, o la licenza elementare, oppure avessero prestato il servizio militare. Infine, al termine della prima guerra mondiale venne introdotto, grazie alla legge del 16 dicembre 1918, n. 1985, il suffragio universale maschile ai maggiori di 21 anni o chi avesse adempiuto al servizio militare. Benché l'articolo 1 proclamasse il cattolicesimo religione di Stato, le relazioni fra la Santa Sede e lo Stato furono praticamente interrotte tra il 1870 e il 1929, per via della "questione romana". Il Ventennio Fascista Il Gran Consiglio del Fascismo durante la seduta del 9 maggio 1936, in cui fu proclamato l'Impero. Al termine della prima guerra mondiale e con i conseguenti scompaginamenti, in Europa si assistette a una evoluzione del costituzionalismo che si concretizzò in diverse esperienze politiche come la Seconda Repubblica Spagnola o la Repubblica di Weimar. In Italia questo non accadde. Anche a causa della mancanza di rigidità dello Statuto, ritenuto irrevocabile nei principi ma modificabile tramite legge in molte delle sue proposizioni, con l'avvento del fascismo lo Stato fu deviato verso un regime autoritario dove le forme di libertà pubblica fin qui garantite vennero stravolte: le opposizioni vennero bloccate o eliminate, la Camera dei deputati fu abolita e sostituita dalla "Camera dei fasci e delle corporazioni", il diritto di voto fu cancellato; diritti, come quello di riunione e di libertà di stampa, furono piegati in garanzia dello Stato fascista, mentre il partito unico fascista non funzionò come mezzo di partecipazione, ma come strumento di intruppamento della società civile e di mobilitazione politica pilotata dall'alto. Il fascismo non si dotò mai di una propria costituzione e lo Statuto Albertino non venne mai formalmente abolito, sebbene le leggi e le azioni del governo dittatoriale lo privarono completamente nella sostanza. Alcuni sostengono che lo Statuto venne violato già con la nomina di Mussolini come primo ministro ottenuta con la forza in quanto, allora, era solo un rappresentante di una minoranza parlamentare. I rapporti con la Chiesa cattolica vennero invece ricomposti e regolati tramite i Patti Lateranensi del 1929, che ristabilirono ampie relazioni politico-diplomatiche tra la Santa Sede e lo Stato italiano. Il 25 luglio 1943 Benito Mussolini venne estromesso, e il re Vittorio Emanuele III nominò il maresciallo Pietro Badoglio per presiedere un governo che ripristinò in parte le libertà dello statuto; iniziò così il cosiddetto "regime transitorio", di cinque anni, che terminò con l'entrata in vigore della nuova Costituzione e le successive elezioni politiche dell'aprile 1948, le prime della storia repubblicana. Ricomparvero quindi i partiti antifascisti costretti alla clandestinità, riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale, decisi a modificare radicalmente le istituzioni con l'obiettivo di ripristinare lo Stato democratico. Con il progredire e il delinearsi della situazione, con i partiti antifascisti che iniziavano a entrare nel governo, non fu possibile al re riproporre uno Statuto Albertino eventualmente modificato, e la stessa monarchia, giudicata compromessa con il precedente regime, era messa in discussione. La divergenza, in clima ancora bellico, trovò una soluzione temporanea, una «tregua istituzionale», in cui si stabiliva la necessità di trasferire i poteri del re all'erede al trono ( per l'occasione, ci fu un proclama del re il 12 aprile 1944 ), il quale doveva assumere la carica provvisoria di "luogotenente del regno", mettendo temporaneamente da parte la questione istituzionale; quindi veniva decisa la convocazione di un'Assemblea Costituente incaricata di scrivere una nuova carta costituzionale, eletta a suffragio universale.1 punto
-
2 euro commemorativo 70 anno della costituzione italiana 1948 - 2018 Approvata dall'assemblea costituente il 22 dicembre 1947 entrò in vigore il primo Gennaio dell'anno successivo. Dopo la fine della 2 Guerra mondiale fu indetto un referendum che portava a scegliere tra la monarchia e la Repubblica, con il 54% dei voti fu scelta la seconda contemporaneamente al referendum i cittadini furono chiamati a scegliere l'assemblea costituente. A dominare furono 3 grandi partiti "democrazia Cristiana" "partito socialista" e "partito comunista italiano" Appena eletta l'assemblea nominò al suo interno una commissione composta da 75 membri, che a sua volta si divise in tre sezioni. "DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI" "ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO" "RAPPORTI ECONOMICI E SOCIALI". l'Obiettivo della commissione per detta di Giorgio la Pira era quello di distinguere la carta costituzionale italiana da quella di tipo Individualista alla occidentale e da quella statalista di tipo "hegeliano". Riferi la Pira che: """ si pensò di differenziarla nel principio che "per il pieno sviluppo della persona umana, a cui la nostra Costituzione doveva tendere, era necessario non soltanto affermare i diritti individuali, non soltanto affermare i diritti sociali, ma affermare anche l'esistenza dei diritti delle comunità intermedie che vanno dalla famiglia sino alla comunità internazionale""". La costituzione era composta da 139 Articoli e i relativi commi (5 articoli abrogati nel corso della storia) più 18 transitorie e finali, suddivisa in 4 sezioni 1)PRINCIPI FONDAMENTALI 2)DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 3)ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 4)DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Passando alla moneta nel rovescio vediamo il capo dello stato Enrico De Nicola nell'atto della firma della Costituzione il 27 Dicembre 1947 al suo fianco a sinistra Alcide de Gasperi (presidente del consiglio) e Umberto Terracini (presidente della costituente) in basso la famosa frase detta da De Nicola a De Gasperi poco prima della firma """L'ho letta attentamente possiamo firmarla CON SICURA COSCIENZA"" coniata in 4.000.000 di pezzi ricorda a tutti una famosa frase di Pertini "MEGLIO LA PEGGIORE DELLE DEMOCRAZIE CHE LA MIGLIORE DELLE DITTATURE" Inserire altri media1 punto
-
" Per te ari, per te semini, per te ugualmente mieti, infine questa fatica ti procurerà gioia " Proveniente dalle remote radici della millenaria cultura del Bel Paese, per la 1° emissione del 2016 si è scelto di commemorare colui che è stato ispiratore di molti drammaturghi, Shakespeare e Molière solo per citarne alcuni, nonché uno dei più importanti e prolifici autori dell'antichità latina, ovvero Tito Maccio Plauto nel 2200° Anniversario della sua Scomparsa. Per la sua rappresentazione è stato scelto un mosaico romano del I° Secolo A.C. raffigurante le maschere teatrali tragica e comica, in onore alla sua grande capacità artistica. Varie fonti antiche chiariscono che Plauto era nativo di Sàrsina, cittadina appenninica dell'Umbria romana ( oggi in Romagna ) il dato è confermato da un bisticcio allusivo in Mostellaria 769-70. Plauto, come del resto quasi tutti i letterati latini di età repubblicana su cui abbiamo notizia, non era dunque di origine romana: non apparteneva però, diversamente da Livio Andronico ed Ennio, a un'area culturale italica già sotto influenza e dominio greco. Si noti anche che Plauto era con certezza un cittadino libero, non uno schiavo o un liberto: la notizia che svolgesse lavori servili presso un mulino è un'invenzione biografica, basata su un'assimilazione tra Plauto e i servi bricconi delle sue commedie, che spesso vengono minacciati di questa destinazione. Il nome del poeta è fra i dati incerti. Gli antichi lo citano comunemente come Plautus, la forma romanizzata di un cognome umbro Plotus. Nelle edizioni moderne fino all'Ottocento figura il nome completo Marcus Accius Plautus. Questa forma è di per sé sospetta alla luce di considerazioni storiche: i tria nomina si usano per chi è dotato di cittadinanza romana, e non sappiamo se Plauto l'abbia mai avuta. Un antichissimo codice di Plauto, il Palinsesto Ambrosiano, rinvenuto agli inizi del XIX secolo dal cardinale Angelo Mai, portò migliore luce sulla questione. Il nome completo del poeta tramandato nel Palinsesto si presenta nella più attendibile versione Titus Maccius Plautus; da Maccius, per errore di divisione delle lettere, era uscito fuori il tradizionale M. Accius ( che sembrava credibile per influsso di L. Accius, il nome del celebre tragediografo ). D'altra parte, il nome Maccius si presta a interessanti deduzioni. Non si tratta certo di un vero nome gentilizio e del resto non c'è ragione che Plauto ne portasse uno; si tratta invece di una derivazione da Maccus, il nome di un personaggio tipico della farsa popolare italica, l'atellana. Questa originale derivazione deve avere un legame con la personalità e l'attività di Plauto. È dunque verosimile e attraente ipotesi che il poeta teatrale umbro Titus Plotus si fosse dotato a Roma di un nome di battaglia, che alludeva chiaramente al mondo della scena comica, e quindi conservasse nei “tre nomi” canonici la traccia libera e irregolare del suo mestiere di "commediante". La data di morte, il 184 a.C., è sicura; la data di nascita si ricava indirettamente da una notizia di Cicerone ( Cato maior 14,50 ), secondo cui Plauto scrisse da senex la sua commedia Pseudolus. Lo Pseudolus risulta rappresentato nel 191, e la senectus per i Romani cominciava a 60 anni. Probabile quindi una nascita fra il 255 e il 250 a.C. Le notizie che fissano la fioritura letteraria del poeta intorno al 200 quadrano bene con queste indicazioni. Dobbiamo immaginarci un'attività letteraria compresa fra il periodo della seconda guerra punica ( 218-201 a.C. ) e gli ultimi anni di vita del poeta: la Casina allude chiaramente alla repressione dei Baccanali del 186 a.C.. Plauto fu autore di enorme successo, immediato e postumo, e di grande prolificità. Inoltre il mondo della scena, per sua natura, conosce rifacimenti, interpolazioni, opere spurie. Sembra che nel corso del II secolo circolassero qualcosa come centotrenta commedie legate al nome di Plauto: non sappiamo quante fossero autentiche, ma la cosa era oggetto di viva discussione. Nello stesso periodo, verso la metà del II secolo, cominciò un'attività che possiamo definire editoriale, e che ha grande importanza per il destino del testo di Plauto. Di Plauto furono condotte vere "edizioni" ispirate ai criteri della filologia alessandrina. Benefici effetti di questa attività si risentono nei manoscritti pervenuti sino a noi: le commedie furono dotate di didascalie, di sigle dei personaggi; i versi scenici di Plauto furono impaginati da competenti, in modo che ne fosse riconoscibile la natura; e questo in un periodo che ancora aveva dirette e buone informazioni in materia. La fase critica nella trasmissione del corpus dell'opera plautina fu segnata dall'intervento di Varrone, il quale, nel De comoediis Plautinis, ritagliò nell'imponente corpus un certo numero di commedie ( ventuno, quelle giunte sino a noi ) sulla cui autenticità c'era generale consenso. Queste erano opere da Varrone accettate come totalmente e sicuramente genuine. Molte altre commedie - fra cui alcune che Varrone stesso riteneva plautine, ma che non aggregò al gruppo delle "ventuno" perché il giudizio era più oscillante - continuarono a essere rappresentate e lette in Roma antica. Noi ne abbiamo solo titoli, e brevissimi frammenti, citazioni di tradizione indiretta: questi testi andarono perduti nella tarda antichità, fra il III e il IV secolo d.C., mentre la scelta delle "ventuno" si perpetuava nella tradizione manoscritta, sino ad essere integralmente recuperata nel periodo umanistico. La cronologia delle singole commedie ha qualche punto fermo: lo Stichus fu messo in scena la prima volta nel 200, lo Pseudolus nel 191, e la Casina, come si è detto, presuppone avvenimenti del 186. Per il resto, alcune commedie presentano allusioni storiche che hanno suggerito ipotesi di datazione troppo sottili e controverse. Uno sguardo cursorio agli intrecci delle venti commedie pervenuteci integre ( la Vidularia, messa in ultima posizione da Varrone, fu oggetto di danneggiamenti nel corso della trasmissione manoscritta: ne abbiamo infatti solo frammenti ) è senz'altro opportuno, anche se può suggerire una prima impressione assai parziale e anche fuorviante. Per unanime riconoscimento, la grande forza di Plauto sta nel comico che nasce dalle singole situazioni, prese a sé una dopo l'altra, e dalla creatività verbale che ogni nuova situazione sa sprigionare. Ma solo una lettura diretta può restituire un'impressione adeguata di tutto ciò: e se l'arte comica di Plauto sfugge per sua natura a formule troppo chiuse, una maggiore sistematicità nasce proprio dalla considerazione degli intrecci, nelle loro più elementari linee costruttive. Prima delle commedie vere e proprie, nella trascrizione manoscritta c'è quasi sempre un argumentum, cioè una sintesi della vicenda. In alcuni casi sono presenti addirittura due argumenta, e in questo caso uno dei due è acrostico ( le lettere iniziali dei singoli versi formano il titolo della commedia stessa ). All'inizio delle commedie vi è un prologo, in cui un personaggio della vicenda, o una divinità, o un'entità astratta personificata presentano l'argomento che si sta per rappresentare. Nella commedia plautina è possibile distinguere, secondo una suddivisione già antica, i deverbia e i cantica, vale a dire le parti dialogate, con più attori che interloquiscono fra di loro, e le parti cantate, per lo più monologhi, ma a volte anche dialoghi tra due o addirittura tre personaggi. Nelle commedie di Plauto ricorre spesso lo schema dell'intrigo amoroso, con un giovane ( adulescens ) che si innamora di una ragazza. Il suo sogno d'amore incontra sempre dei problemi a tramutarsi in realtà a seconda della donna di cui si innamora: se è una cortigiana deve trovare i soldi per sposarla, se invece è onesta l'ostacolo è di tipo familiare. Un altro elemento strutturale di grande importanza nelle commedie di Plauto è il riconoscimento finale ( agnitio ), grazie al quale vicende ingarbugliate trovano la loro fortunosa soluzione e ragazze che compaiono in scena come cortigiane o schiave recuperano la loro libertà e trovano l'amore. La grande comicità generata dalle commedie di Plauto è prodotta da diversi fattori: un'oculata scelta del lessico, un sapiente utilizzo di espressioni e figure tratte dal quotidiano e una fantasiosa ricerca di situazioni che possano generare l'effetto comico. È grazie all'unione di queste trovate che si ha lo straordinario effetto dell'elemento comico che traspare da ogni gesto e da ogni parola dei personaggi. Questa uniforme presenza di comicità risulta più evidente in corrispondenza di situazioni ad alto contenuto comico. Infatti Plauto si serve di alcuni espedienti per ottenere maggior comicità, solitamente equivoci e scambi di persona. Plauto fa uso anche di espressioni buffe e goliardiche che i vari personaggi molto di frequente pronunciano; oppure usa riferimenti a temi consueti, luoghi comuni, anche tratti dalla vita quotidiana, come il pettegolezzo delle donne. Le commedie di Plauto sono delle rielaborazioni in latino di commedie greche. Tuttavia, questi testi plautini non seguono molto l'originale perché Plauto da una parte adotta il procedimento della contaminatio, per il quale mescola insieme due o più canovacci greci, dall'altra aggiunge alle matrici elleniche cospicui tratti riconducibili a forme teatrali italiche come il mimo e l'atellana. Plauto tuttavia continua a mantenere nella sua commedia elementi ellenici quali i luoghi e i nomi dei personaggi (le commedie della recensione varroniana sono tutte palliatae, cioè di ambientazione greca). Si può affermare che Plauto prende molto dai modelli greci ma grazie ai cambiamenti e alle aggiunte il suo lavoro non risulta né una traduzione né un'imitazione pedissequa. A questo contribuisce anche l'adozione di una lingua latina molto vivace e pittoresca, in cui fanno spesso bella mostra di sé numerosissimi neologismi. La cosa che distingue l'imitatore dal grande scrittore è la capacità di quest'ultimo di farci dimenticare, tramite le sue aggiunte e le sue rielaborazioni, il testo di partenza. Sul tema della contaminatio c'è un'altra importante nota, il fatto che nei prologhi del Trinummus ( verso 19 ) e dell'Asinaria ( verso 11 ) Plauto definisce la propria traduzione con l'espressione latina "vortere barbare" ( in italiano: "volgere dal greco in latino" ). Plauto utilizza il verbo latino vortere per indicare una trasformazione, un cambiamento di aspetto; si perviene necessariamente alla conclusione che Plauto non mirasse solamente a una traduzione linguistica ma anche letteraria. Il fatto poi che utilizzi l'avverbio barbare deriva dal fatto che essendo le sue fonti di ispirazione di origine greca, in latino erano rese con un notevole perdita di significato oltre che di artisticità, e dato che per i Greci tutto ciò che era straniero era chiamato barbarus, Plauto afferma che la propria traduzione è barbara.1 punto
-
Ti ho preparato questo bel regalino, dedicato a tutti gli amanti dei tondelli... 2 Euro Commemorativo "Anno Europeo del Patrimonio Culturale" Questa moneta viene emessa dallo Stato della Città del Vaticano il 01/06/2018 per commemorare il 2018 l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, iniziativa annunciata dall'Unione Europea nel 2017 e lanciata il 31/01/2018, a cui partecipano i 28 Stati Membri. Autore del soggetto Daniela Longo, incisore Claudia Momoni, in questa emissione viene rappresentato il "Gruppo Scultoreo del Laocoonte", scultura in marmo conservata nel Museo Pio-Clementino dei Musei Vaticani. E' stata emessa per un totale di 101.000 pezzi, di cui 76.000 in Folder FDC, 15.000 in Busta Filatelico Numismatica e 10.000 in Cofanetto Fondo Specchio. Anno Europeo del Patrimonio Culturale L'obiettivo dell'Anno europeo del patrimonio culturale è quello di incoraggiare il maggior numero di persone a scoprire e lasciarsi coinvolgere dal patrimonio culturale dell'Europa e rafforzare il senso di appartenenza a un comune spazio europeo. Il motto dell’anno è: "Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro". L’Anno vedrà svolgersi una serie di iniziative e di manifestazioni in tutta Europa per consentire ai cittadini di avvicinarsi e conoscere più a fondo il loro patrimonio culturale. Il patrimonio culturale plasma la nostra identità e la nostra vita quotidiana. Ci circonda nelle città e nei borghi d’Europa, quando siamo immersi nei paesaggi naturali o ci troviamo nei siti archeologici. Non si tratta soltanto di letteratura, arte e oggetti, ma anche dell'artigianato appreso dai nostri progenitori, delle storie che raccontiamo ai nostri figli, del cibo che gustiamo in compagnia e dei film che guardiamo per riconoscere noi stessi. Perché il Patrimonio Culturale ? Il patrimonio culturale ha un valore universale per ciascuno di noi, per le comunità e le società. È importante conservarlo e trasmetterlo alle generazioni future. Si può pensare al patrimonio come a "un qualcosa del passato" o di statico, ma in realtà si sviluppa attraverso il nostro modo di rapportarci ad esso. Per di più, il nostro patrimonio culturale ha un ruolo importante da svolgere nella costruzione del futuro dell’Europa. Questa è una delle ragioni per cui vogliamo raggiungere i giovani, in particolare durante l’Anno europeo. Il patrimonio culturale si presenta in varie forme: tangibile - ad esempio edifici, monumenti, artefatti, abbigliamento, opere d’arte, libri, macchine, città storiche, siti archeologici intangibile - pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, competenze, e i relativi strumenti, oggetti e spazi culturali, cui le persone attribuiscono valore. Ciò comprende la lingua e le tradizioni orali, le arti dello spettacolo, le pratiche sociali e l’artigianato tradizionale natural - paesaggi, flora e fauna digitale - risorse create in forma digitale (ad esempio opere d’arte digitali e animazione) o che sono state digitalizzate in modo da garantirne la conservazione (testi, immagini, video, registrazioni). Prendendoci cura del nostro patrimonio culturale, possiamo scoprire la nostra diversità e avviare un dialogo interculturale su ciò che abbiamo in comune. Quale modo migliore per arricchire le nostre vite se non interagendo con qualcosa di così fondamentale per la nostra identità? Il patrimonio culturale non dovrebbe essere lasciato al declino, al deterioramento e alla distruzione. Per questo motivo, nel 2018, cercheremo i modi per celebrarlo e conservarlo. Cosa accade nel 2018 ? L’Anno europeo appartiene a tutti, affinché ognuno possa sperimentare, apprezzare e godere del patrimonio culturale. Tutti sono invitati a partecipare alle migliaia di attività che si svolgeranno in tutta Europa per far sentire le persone più strettamente coinvolte con il patrimonio culturale. Ogni Stato membro ha nominato un coordinatore nazionale per attuare l’Anno e coordinare gli eventi e i progetti a livello locale, regionale e nazionale. Le principali parti interessate del settore culturale, come pure le organizzazioni della società civile, sono strettamente coinvolti nelle attività dell'Anno europeo. A livello europeo, tutte le istituzioni dell’Unione europea sono impegnati a rendere l’Anno un successo. La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, otre al Comitato europeo delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo organizzeranno eventi per celebrare l'Anno e inaugurare attività incentrate sul patrimonio culturale. Inoltre, l'UE finanzierà progetti a sostegno del patrimonio culturale. Un apposito invito a presentare progetti di cooperazione relativi all’Anno è stato pubblicato nell’ambito del programma "Europa creativa". Numerose altre opportunità saranno disponibili nel quadro dei programmi dell'UE Erasmus+, Europa per i cittadini, Orizzonte 2020 e altri ancora. Per far sì che i nostri sforzi lascino un’impronta oltre il 2018, la Commissione, in collaborazione con il Consiglio d’Europa, l’UNESCO e gli altri partner, gestirà dieci progetti a lungo termine. Questi comprenderanno le attività con le scuole, la ricerca su soluzioni innovative per riutilizzare gli edifici appartenenti al patrimonio culturale o per contrastare il traffico illecito di beni culturali. L’obiettivo è stimolare un cambiamento reale nel nostro modo di fruire, tutelare e promuovere il patrimonio culturale, facendo sì che l’Anno europeo crei benefici per i cittadini a lungo termine. Gruppo Scultoreo del Laocoonte Descrizione e Stile Il gruppo statuario raffigura la fine di Laocoonte e dei suoi due figli Antifante e Timbreo mentre sono stritolati da due serpenti marini, come narrato nel ciclo epico della guerra di Troia, ripreso successivamente nell'Eneide da Virgilio, in cui è descritto l'episodio della vendetta di Atena, che desiderava la vittoria degli Achèi, sul sacerdote troiano di Apollo, che cercò di opporsi all'ingresso del cavallo di Troia nella città. La sua posa è instabile perché nel tentativo di liberarsi dalla stretta dei serpenti Laocoonte richiama tutta la sua forza, manifestando con la più alta intensità drammatica la sua sofferenza fisica e spirituale. I suoi arti e il suo corpo assumono una posa pluridirezionale e in torsione, che si slancia nello spazio. L'espressione dolorosa del suo viso unita al contesto e la scena danno una resa psicologica caricata, quasi teatrale, come tipico delle opere del "barocco ellenistico". La resa del nudo mostra una consumata abilità, con l'enfatica torsione del busto che sottolinea lo sforzo e la tensione del protagonista. Il volto è tormentato da un'espressione pateticamente corrucciata. Il ritmo concitato si trasmette poi alle figure dei figli. La statua è composta da più parti distinte, mentre Plinio il Vecchio, in effetti, descrisse una scultura ricavata da un unico blocco marmoreo (ex uno lapide). Tale circostanza ha creato sempre molti dubbi di identificazione ed attribuzione. Storia Antica e Datazione Plinio raccontava di aver visto una statua del Laocoonte nella casa dell'imperatore Tito, attribuendola a tre scultori provenienti da Rodi: Agesandro, Atenodoro e Polidoro. Scrive Plinio: «Né poi è di molto la fama della maggior parte, opponendosi alla libertà di certuni fra le opere notevoli la quantità degli artisti, perché non uno riceve la gloria né diversi possono ugualmente essere citati, come nel Laoconte, che è nel palazzo dell'imperatore Tito, opera che è da anteporre a tutte le cose dell'arte sia per la pittura sia per la scultura. Da un solo blocco per decisione di comune accordo i sommi artisti Agesandro, Polidoro e Atenodoro di Rodi fecero lui e i figli e i mirabili intrecci dei serpenti.» (Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, XXXVI, 37) La tradizionale identificazione della statua dei Musei Vaticani con quella descritta da Plinio è ancora generalmente accettata, visto anche che la residenza privata di Tito si doveva trovare proprio sul colle Oppio, dove la statua venne poi ritrovata. Accettata è anche l'attribuzione ai tre artisti rodii, autori anche dei gruppi statuari con storie di Ulisse della grotta di Sperlonga. Varie date sono state proposte per questa statua, oscillanti tra metà del II secolo a.C. alla metà del I secolo d.C.; Bernard Andreae, in alcuni studi, ha ipotizzato che il Laocoonte sia una copia di un originale bronzeo ellenistico, come dimostrerebbero alcuni dati tecnici e stilistici. Sulla parte posteriore della statua si trova infatti del marmo lunense, non utilizzato prima della metà del I secolo a.C., inoltre alcuni dettagli rimandano inequivocabilmente alla fusione a cera persa: ad esempio il mantello che ricade sulla spalla del giovane a destra fino a toccargli il ginocchio deriva quasi certamente da un espediente tecnico necessario a costituire un passaggio per il metallo fuso. Si è ipotizzato che l'originale fosse stato creato a Pergamo, come suggeriscono alcuni confronti stilistici con opere della scuola locale: i pacifici rapporti tra la città dell'Asia minore e Roma erano infatti rafforzati dai miti legati a Troia, dai quali discendevano le leggende di fondazione di entrambe le città. Plinio comunque attesta la presenza a Roma della statua marmorea a metà del I secolo d.C. attribuendola a scultori attivi un secolo prima. Infatti alcune iscrizioni trovate a Lindos, sull'isola di Rodi fanno risalire la presenza a Roma di Agesandro e Atanodoro ad un periodo successivo al 42 a.C., ed in questo modo la data più probabile per la creazione del Laocoonte deve essere compresa tra il 40 ed il 20 a.C., per una ricca casa patrizia, o più probabilmente per una committenza imperiale (Augusto, Mecenate), anche se il Laocoonte sembra lontano dallo stile neoattico in auge nel periodo. Visto il luogo di ritrovamento è anche possibile che la statua sia appartenuta, per un periodo, a Nerone Il Ritrovamento La statua fu trovata il 14 gennaio del 1506 scavando in una vigna sul colle Oppio di proprietà di Felice de Fredis, nelle vicinanze della Domus Aurea di Nerone: l'epitaffio sulla tomba di Felice de Fredis in Santa Maria in Aracoeli ricorda l'avvenimento. Allo scavo, di grandezza stupefacente secondo le cronache dell'epoca, assistettero di persona, tra gli altri, lo scultore Michelangelo e l'architetto Giuliano da Sangallo. Questi era stato inviato dal papa a valutare il ritrovamento, secondo la testimonianza di Francesco, giovane figlio di Giuliano (che, ormai anziano, ricorda l'episodio in una lettera del 1567). Secondo questa testimonianza fu proprio Giuliano da Sangallo ad identificare i frammenti ancora parzialmente sepolti con la scultura citata da Plinio. Esistono comunque testimonianze coeve che danno la stessa identificazione della scultura appena rinvenuta. La Collocazione al Belvedere La statua fu acquistata subito dopo la scoperta dal papa Giulio II, che era un appassionato classicista, e fu sistemata, in posizione di rilievo, nel cortile ottagonale ("Cortile delle Statue") progettato da Bramante all'interno del complesso del Giardino del Belvedere proprio per accogliere la collezione papale di scultura antica. Tale allestimento è considerato l'atto fondativo dei Musei Vaticani. Da allora il Laocoonte, assieme all'Apollo del Belvedere, costituì il pezzo più importante della collezione, e fu oggetto dell'incessante successione di visite, anche notturne, da parte di curiosi, artisti e viaggiatori. Restauri ed Integrazioni Quando il gruppo scultoreo fu scoperto, benché in buono stato di conservazione, presentava il padre ed il figlio minore entrambi privi del braccio destro. Dopo un primo ripristino, forse eseguito da Baccio Bandinelli (che ne eseguì una delle prime copie, intorno al 1520, oggi agli Uffizi, per Leone X), del braccio del figlio minore e di alcune dita del figlio maggiore, artisti ed esperti discussero su come dovesse essere stata la parte mancante nella raffigurazione del sacerdote troiano. Nonostante alcuni indizi mostrassero che il braccio destro fosse, all'origine, piegato dietro la spalla di Laocoonte, prevalse l'opinione che ipotizzava il braccio esteso in fuori, in un gesto eroico e di forte dinamicità. L'integrazione fu eseguita, probabilmente in terracotta, da Montorsoli ed il restauro ebbe un successo duraturo tanto che Winckelmann, pur consapevole della diversa posizione originaria, si dichiarò favorevole al mantenimento del braccio teso. Intanto, tra il 1725 e il 1727, Agostino Cornacchini eseguì un restauro del gruppo scultoreo che versava in condizioni di degrado. Vennero sostituiti il braccio di terracotta del Laocoonte e quello in marmo del figlio, evidentemente rovinati con altri dall'identica posa. Nel 1906 l’archeologo tedesco Ludwig Pollak rinvenne fortuitamente il braccio destro originario di Laooconte, che si presentava piegato, come Michelangelo aveva immaginato: l’arto fu ricollocato alla spalla da Filippo Magi tra il 1957 ed il 1960, che rimosse tutte le integrazioni non originali, secondo i prìncipi del restauro moderno. Influenza Culturale La scoperta del Laocoonte ebbe enorme risonanza tra gli artisti e gli scultori ed influenzò significativamente l'arte rinascimentale italiana e nel secolo successivo la scultura barocca. Straordinaria fu infatti l'attenzione suscitata dalla statua, e se ne trova traccia nelle numerose lettere degli ambasciatori che la descrivono, nei disegni e nelle incisioni che subito dopo iniziarono a circolare per l'Europa. Il forte dinamismo e la plasticità eroica e tormentata del Laocoonte ispirò numerosi artisti, da Michelangelo a Tiziano, da El Greco ad Andrea del Sarto. Michelangelo ad esempio fu particolarmente impressionato dalla rilevante massa della statua e dal suo aspetto sensuale, in particolare nella rappresentazione delle figure maschili. Molti dei lavori di Michelangelo successivi alla scoperta, come il Tondo Doni, lo Schiavo ribelle e lo Schiavo morente, furono influenzati dal Laocoonte. Molti scultori si esercitarono sul gruppo scultoreo facendone calchi e copie anche a grandezza naturale. Il re di Francia insistette molto per avere la statua dal papa o almeno una sua copia. A tal fine, lo scultore fiorentino Baccio Bandinelli ricevette l'incarico dal cardinale Giulio de' Medici papa Clemente VII Medici, di farne una copia, oggi agli Uffizi. Il re di Francia, però, dovette accontentarsi di inviare, intorno al 1540, lo scultore Francesco Primaticcio a Roma per realizzare un calco al fine di ricavarne una copia in bronzo destinata a Fontainebleau. Un'altra copia si trova nel Gran Palazzo dei Cavalieri di Rodi a Rodi. Una copia in gesso, appartenuta al Mengs, si trova nell'Accademia di belle arti di Roma. Il fascino della scultura coinvolse per secoli artisti ed intellettuali come Gian Lorenzo Bernini, Orfeo Boselli, Winckelmann e Goethe, diventando il fulcro della riflessione settecentesca sulla scultura. La tragica mobilità di questa statua è uno dei temi del saggio Laokoön, di Lessing, uno dei primi classici di critica dell'arte. Buona Cultura a Tutti1 punto
-
Intervengo perchè al tempo degli studi sugli incisori ci accorgemmo che: una Piastra del 1788 con le sigle BP andava sicuramente riscontrata in quanto il Perger, Bernardo morì nel 1786.....e quindi ci poteva essere stato un errore di catalogazione...alla pari della moneta da 2 quattrini dei Reali Presidi del 1791 (e della quale si è operata una modifica nella catalogazione da BP a DP). @@gcs @@rhoss ...quindi a differenza degli altri anni del Gigante (addietro, per intenderci) è stata esclusa la 51a (per le sigle BP) e inserita sempre alla 51a la variante dei 3 gigli disposti a piramide; la 51b...poi, non ha nulla di particolare....ha la semplice lettera P incisa al dritto. Quindi ricapitolando troviamo le Piastre con DP (51), con DP e gigli a piramide (51a) e con sigla P (51b). Un saluto a tutti.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?





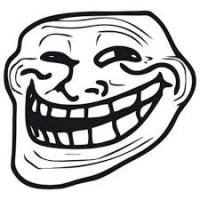








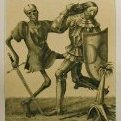
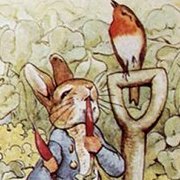





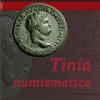

.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)