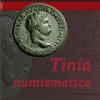Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 08/20/21 in tutte le aree
-
Ciao! 1 = si 2 = no 3 = ribadire a chi lo tira per la giacchetta che la sezione c'è ed è lecita nei termini del regolamento. Saluti Luciano5 punti
-
Sarebbe cinese la più antica zecca al mondo. Quella prodotta nell’antica fonderia di bronzo di Guanzhuang, rappresenterebbe la prima moneta metallica standardizzata al mondo: gli studiosi pensano che la zecca abbia iniziato a funzionare tra il 640 e il 550 a.C. Oltre all’edificio della fonderia, sono state rinvenute delle officine dove venivano prodotti manufatti in bronzo, ma anche in ceramica, giada e osso. Tutto questo dimostrerebbe che la città era un ricco centro artigianale. La struttura più importante, per volume e funzione, rimarrebbe la fonderia: la attorniano oltre 2000 fosse di tre metri di larghezza, nelle quali venivano accumulati gli scarti della produzione. Qui sono stati ritrovati degli strumenti impiegati durante le fusioni, come crogioli e mestoli. E, soprattuo, una coppia di monete a forma di vanga, insieme a 54 stampi di argilla. Tra i due esemplari, quello meglio conservato consiste in una vanga a punta che, in origine, doveva misurare più di cinque pollici di lunghezza (12,7 centimetri) e riporta tre linee parallele sulla superficie. I 54 nuclei di argilla, usati per la fusione delle monete in rame, stagno e piombo, dimostrano che l’intero processo di coniazione, compresa la produzione di stampi e la fusione delle monete, avveniva nella fonderia. https://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2021/08/scoperta-a-guanzhuang-la-piu-antica-zecca/?utm_source=Newsletter Artribune&utm_campaign=fc896dca36-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-fc896dca36-154214486&ct=t()&goal=0_dc515150dd-fc896dca36-154214486 petronius4 punti
-
Clemente XI (1700-1721), MEZZA PIASTRA (Munt 55), al R/ veduta del porto di Ripetta e del Tevere, con la via omonima e le chiese di S. Rocco e S. Girolamo degli Schiavoni: ai lati due figure sdraiate, figuranti il Tevere e l'Aniene Il porto di Ripetta (così chiamato per distinguerlo da quello di "Ripa Grande" accanto a Porta Portese, 1706), o Porto Clementino, era uno scalo fluviale di Roma situato lungo il Tevere. Nel XIV secolo, esisteva un piccolo porto rudimentale utilizzato per lo scarico di legname, carbone e vino. Solamente all'inizio del Settecento papa Clemente XI approvò il progetto per la realizzazione di un nuovo porto dall'aspetto monumentale, dotato di banchine, scalinate e piazzali. Il disegno fu affidato all'architetto Alessandro Specchi, che si avvalse della collaborazione di Carlo Fontana. L'opera, per la cui costruzione furono impiegati materiali di spoglio provenienti dal Colosseo, fu inaugurata il 16 agosto 1704. La costruzione, significativo esempio di architettura tardobarocca, era caratterizzata da due ampie scalinate curve, che collegavano le banchine al livello del piano stradale; al centro si apriva un emiciclo, dove era collocata una fontana per abbeverare gli animali da soma impiegati nel trasporto delle mercanzie. Ai lati dell'emiciclo si innalzavano due colonne, le quali furono utilizzate per indicare il livello raggiunto dalle alluvioni del Tevere. Un testo coevo così recitava: "Fatto costruire con saggia provvidenza da N.S. Clemente XI nel 1704 su le amene rive del Tevere per pubblico beneficio ed ornamento". Nel tempo il porto subì un rapido degrado, e fu infine demolito a seguito della costruzione dei "muraglioni" del Tevere, la cui necessità fu stabilita dopo la piena del 1870. La legenda LAETIFICAT CIVITATEM si traduce con "Rallegra la città". Ecco la moneta e a confronto due incisioni del 1754 e del 1760, ed infine una foto del 1865, pochi anni prima della sua scomparsa.4 punti
-
Ciao a tutti! Più volte si è detto che le monete papali, in particolare quelle di epoca barocca, costituiscano per la pregevolezza e la varietà delle incisioni, un vero e proprio documento vivo dell'epoca. Un aspetto particolare è costituito dalle rappresentazioni architettoniche di monumenti, piazze, edifici, che costellano molte monete pontificie e che, riportate su tondello dai grandi maestri incisori dell'epoca, possano essere considerate delle vere e proprie "foto metalliche" del passato. Apro questa discussione su un'idea di Fabrizio @ilnumismaticocon l'intento di presentare monete la cui iconografia possa essere confrontata con altri documenti d'epoca, in particolare stampe, litografie, dipinti e acqueforti per trovare un parallelismo tra quanto riportato in moneta e quanto riprodotto con i metodi più tradizionali del tempo. Scopriremo insieme come le monete siano davvero un'istantanea di ciò che è stato e che ora spesso non è più! Partiamo! Volendo parlare di monete papali e monumenti, non posso non partire se non dal più iconico e famoso monumento della cristianità: Innocenzo XI (1676-1689), PIASTRA (Munt 38): al R/ il prospetto della Basilica di San Pietro. Su questa meravigliosa piastra, opera di Giovanni Hamerani, si può ammirare la facciata della Basilica Vaticana eretta tra il 1607 e il 1614 da Carlo Maderno sotto il pontificato di Paolo V Borghese (1605-1621). La legenda PORTAE INFERI NON PREVALEBVNT (Le porte dell'inferno non prevarranno), fanno riferimento al fatto che Innocenzo XI fu animatore della "Lega Santa" che portò alla liberazione nel 1683 di Vienna, assediata dai Turchi. Il Papa, mettendo in moto tutta la diplomazia pontificia, cercò di promuovere una grande Lega contro la potenza musulmana, ma riuscì solo a concludere una lega tra Impero e Polonia e ad ottenere contributi in denaro dagli Stati italiani; anche i cardinali si quotarono per ingenti somme e fecero oblazioni perfino delle argenterie personali. Per la guerra ai Turchi, la Camera Apostolica durante il pontificato di Innocenzo XI, inviò all'Imperatore oltre 5 milioni di fiorini. Ecco la piastra e a confronto lo stesso prospetto in un acquaforte del 1724.3 punti
-
Adriano Publio Elio Traiano Adriano, noto come Adriano (in latino Publius Aelius Traianus Hadrianus, nato ad Italica il 24 gennaio 76 e morto a Baia il 10 luglio 138) è stato un imperatore romano della dinastia degli imperatori adottivi, regnò dal 117 fino alla sua morte. Successore di Traiano, fu uno dei "buoni imperatori" secondo lo storico Edward Gibbon. Colto e appassionato ammiratore della cultura greca, viaggiò per tutto l'impero e valorizzò le province. Fu attento a migliorare le condizioni dei militari. In Britannia costruì un vallo fortificato, il "Vallo di Adriano". Inaugurò una nuova strategia militare per l'Impero: all'espansione e alla conquista sostituì il consolidamento dei confini e della loro difesa. Mantenne le conquiste di Traiano, a parte la Mesopotamia che assegnò a un sovrano vassallo. Il suo governo fu caratterizzato da tolleranza, efficienza e splendore delle arti e della filosofia. Grazie alle ricchezze provenienti dalle conquiste, Adriano ordinò l'edificazione di molti edifici pubblici in Italia e nelle province, come terme, teatri, anfiteatri, strade e porti. Nella villa che fece costruire a Tivoli riprodusse i monumenti greci che amava di più e trasformò la sua dimora in museo. L'imperatore lasciò anche a Roma, con l'edificazione del Mausoleo, la Mole Adriana, e con la ricostruzione del Pantheon, distrutto da un incendio. [ ... continua dopo la scheda del sesterzio ... ] Valore nominale: Sesterzio Diametro: 33,50 mm circa Peso: 25,07 gr Dritto: IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG, busto laureato drappeggiato e corazzato a destra Rovescio: P M TR P COS III (Pontifex Maximus Tribunicia Potestate Consul tertium), Ceres in piedi rivolta a sinistra, tiene nella mano destra spighe grano e una lunga torcia nella mano sinistra, S - C in campo Zecca: Roma Officina: 3 Anno di coniazione: 121-122 Riferimento: RIC 610, Cohen 1075, BMC/RE 1244 Rarità: R1 Note: Bellissimo sesterzio, ogni volta che lo tengo in mano mi emoziono, lascio a voi i commenti. Ave! Quintus [ ... continua ... ] Sulla nascita di Adriano le fonti non concordano: alcune (come Elio Sparziano) sostengono che nacque a Roma, dove il padre stava svolgendo importanti funzioni pubbliche; altre (come Dione Cassio) che Adriano nacque a Italica, a 7 km da Siviglia, in Hispania Baetica. La sua famiglia era originaria della città picena di Hatria, l'attuale Atri, ma si insediò a Italica subito dopo la sua fondazione per opera di Scipione l'africano. Il padre, Publio Elio Adriano Afro, era imparentato con Traiano. La madre, Domizia Paolina, era originaria di Cadice. Adriano aveva una sorella maggiore (Elia Domizia Paolina), una nipote (Giulia Serviana Paolina) e un pronipote (Gneo Pedanio Fusco Salinatore). I suoi genitori morirono nell'85/86, quando Adriano aveva solo nove anni. Grazie al Corpus Inscriptionum Latinarum, sappiamo che Adriano ebbe una nutrice di nome Germana, una schiava di origini germaniche successivamente liberata che gli sopravvisse arrivando a morire a ottant'anni. Traiano, che non aveva avuto figli, divenne di fatto il tutore del giovane dopo la morte dei suoi genitori. Anche la moglie di Traiano, Plotina, lo aiutò notevolmente nel cursus honorum, trattandolo come proprio figlio. Inoltre sembra sia stata lei a spingerlo a sposare Vibia Sabina, anche lei parente di Traiano. Il matrimonio avvicinò ulteriormente il futuro imperatore alle stanze del potere, grazie anche agli ottimi rapporti intrattenuti con la suocera Matidia. Per il resto il matrimonio fu un fallimento. Dopo che l'imperatore Nerva ebbe nominato Traiano suo successore, presentandolo in Senato nel 97, la carriera di Adriano fu notevolmente agevolata. Le cariche accumulate nel cursus honorum del futuro imperatore furono numerosissime. Quando Nerva morì nel 98, Adriano si precipitò a informare personalmente Traiano. Fu anche arconte ad Atene per un breve periodo, e fu eletto ufficialmente come cittadino ateniese[3]. La sua carriera completa prima di diventare imperatore fu la seguente: decemviro stlitibus iudicandis seviro turmae equitum Romanorum praefectus urbi feriarum Latinarum tribunus militum con la Legio II Adiutrix piae Fidelis nel 95, in Pannonia inferiore tribunus militum con la Legio V Macedonica nel 96, in Mesia inferiore tribunus militum con la Legio XXII Primigenia nel 97, in Germania superiore; successivamente trasferito alla Legio I Minervia. questore (nel 101) ab Actis senatus tribunus plebis (nel 105) pretore (nel 106) Legatus legionis della Legio I Minerviae piae Fidelis (106, in Germania inferiore) Legatus Augusti pro praetore della provincia romana della Pannonia inferiore (107) console suffectus (108) septemviro epulonum (prima del 112) Sodales Augustales (prima del 112) arconte ad Atene (tra il 112/13) Legatus Augusti pro praetore in Siria (117) Al contrario del suo predecessore, Adriano non fu mai adottato ufficialmente, tramite la presentazione in Senato. Su questo punto l'Historia Augusta riporta diverse teorie, una delle quali fa discendere il suo avvento al potere da una presunta nomina di Traiano morente, molto probabilmente una messinscena organizzata da Plotina, che avrebbe orchestrato abilmente l'operazione, d'accordo con il prefetto del pretorio Attiano. La questione, in realtà, appare assai più complessa. Pare difficile che Adriano possa aver preso il ruolo di successore di Traiano per sola intercessione di Plotina e di alcuni suoi collaboratori. Alcuni conii monetali attesterebbero il titolo di Caesar per Adriano già in un periodo compreso tra il 114 e il 117. Sulla scia di tali dati l'adozione di Adriano apparirebbe meno offuscata da dubbi e una deliberata volontà di Traiano. Adriano, salito al trono, allontanò dai luoghi di potere gran parte del seguito e dell'amministrazione di Traiano, non senza ricorrere a metodi brutali (come nella repressione della congiura dei consolari), dei quali aveva fatto parte anche lui, compresi i vertici militari[5]. In ogni caso la ratifica da parte dell'esercito, che acclamò il nuovo imperatore, chiuse la questione. Il Senato, ricevuto un messaggio dal neoeletto, nel quale egli riferiva di non essersi potuto sottrarre alla volontà dell'esercito, si allineò a sua volta. Sia i militari sia i senatori trassero notevoli benefici dalla loro acquiescenza: i primi ricevettero il tradizionale donativo in misura più cospicua che in passato e anche i membri del Senato ebbero dei vantaggi. La fulmineità dell'ascesa al potere, accompagnata dall'eliminazione fisica dei principali potenziali dissidenti o concorrenti, portò a un insediamento rapido, seguito da un continuo rafforzamento che durò per tutto il ventennio in cui Adriano rimase al potere. L'opposizione al neo princeps era costituita da generali che, come lo stesso Adriano, avevano seguito Traiano nelle più importanti battaglie di ampliamento territoriale: tra questi Quieto, la cui morte provocò sommosse di ribellione in Mauretania. Adriano fu uno degli imperatori morti per cause naturali e non assassinati in una congiura. Anche la designazione del successore e il suo insediamento, dopo la morte di Adriano, non furono ostacolati. Un caposaldo della politica adrianea fu l'idea di ampliare, quando possibile, i livelli di tolleranza. Si fece promotore di una riforma legislativa per alleggerire la posizione degli schiavi, i quali si trovavano in situazioni disumane allorché si verificasse un crimine ai danni del dominus. Anche nei confronti dei cristiani mostrò maggiore tolleranza dei suoi predecessori. Ne rimane testimonianza, intorno all'anno 122, in un rescritto indirizzato a Gaio Minucio Fundano, proconsole della provincia d'Asia. In esso l'imperatore, a cui era stato richiesto come comportarsi nei confronti dei cristiani e delle accuse a loro rivolte, rispose di procedere nei loro confronti solo in ordine a notizie circostanziate emergenti da un procedimento giudiziario e non sulla base di accuse generiche. Un'altra riforma operata da Adriano fu quella dell'editto pretorio. Questo strumento normativo consisteva in un'esposizione di principi giuridici generali, che il magistrato enunciava al momento dell'insediamento. Con l'andar del tempo, questi principi costituirono un nucleo di norme consolidato (edictum vetus o tralaticium), al quale ogni pretore aggiungeva le fattispecie che intendeva tutelare. Tecnicamente la finalità dell'editto era quella di concedere tutela processuale anche a rapporti non previsti dallo ius civile. Con la riforma adrianea, che l'imperatore affidò al giurista romano Salvio Giuliano negli anni dal 130 al 134, l'editto venne codificato, fu approvato da un senatoconsulto e divenne perpetuo (edictum perpetuum). Sempre in campo giuridico, Adriano pose fine al sistema ideato da Augusto che, concedendo ad alcuni giuristi lo ius respondendi ex auctoritate principis, aveva consentito che il diritto si espandesse progressivamente attraverso l'opera creatrice di alcuni esperti scelti dall'imperatore stesso. Adriano sostituì al gruppo di giuristi isolati dello schema augusteo un consilium principis, che contribuì alla progressiva istituzionalizzazione di questa figura, togliendole l'indipendenza residuata. Nonostante avesse seguito personalmente più di una campagna militare (la più impegnativa quella dacica al seguito di Traiano), Adriano si dimostrò, oltre che esperto di cose militari, il che era prevedibile, anche un grande riformatore della pubblica amministrazione. Il suo intervento sulle strutture amministrative dell'impero fu profondo e radicale, dimostrando che era parte di un piano globale che l'imperatore andava applicando, a mano a mano, alla struttura dell'esercito, alla difesa dei confini, alla politica estera, alla politica economica. Adriano aveva una sua visione dell'impero e cercava di uniformare le singole parti al suo disegno. In luogo dei liberti cesarei diede spazio e importanza a nuovi funzionari provenienti dalla classe dei cavalieri. Essi erano preposti alle varie branche amministrative suddivise per materie: finanze, giustizia, patrimonio, contabilità generale e così via. Le carriere furono determinate, così come le retribuzioni, e la pubblica amministrazione divenne più stabile e meno soggetta ai cambiamenti connessi con l'avvicendarsi degli imperatori. Attento amministratore, Adriano pensò anche a tutelare nel migliore dei modi gli interessi dello Stato con l'istituzione dell'advocatus fisci, cioè una sorta di avvocatura dello Stato che si occupasse di difendere in giudizio gli interessi delle finanze pubbliche (fiscus). Va considerato che in epoca tardo-imperiale l'originaria bipartizione tra aerarium (la finanza pubblica di area senatoria) e fiscus (la finanza pubblica di competenza del princeps) era andata scomparendo per l'avvenuta unificazione delle due aree nelle mani dell'imperatore. Appena il suo potere fu sufficientemente consolidato, Adriano intraprese una serie di viaggi in tutto l'Impero (Gallia, Germania, Britannia, Spagna, Mauritania), per rendersi conto di persona delle esigenze e prendere i provvedimenti necessari per rendere il sistema difensivo efficiente. Nel 123 iniziò il lungo viaggio d'ispezione delle province orientali che lo impegnò per due anni. Nel 128 ispezionò la provincia d'Africa. Nell'anno seguente si recò di nuovo in Oriente. La sua filosofia risulta evidente dai suoi atti: il ritiro da territori indifendibili, il controllo dei confini basato su difese stanziali, la politica degli accordi con gli Stati cuscinetto che facevano da interposizione fra il territorio dell'impero e quello dei popoli confinanti. Durante il viaggio in Egitto nel 130 d.C., Adriano si recò a visitare i Colossi di Memnone. In età romana molti visitatori, richiamati da uno dei colossi di Memnone per il suo canto al sorgere del sole, erano soliti a lasciare incise sulle gambe della statua le loro osservazioni e le loro dediche. Anche gli accompagnatori di Adriano e dell'imperatrice Sabina fra il 20 e il 21 novembre del 130, lasciarono alcuni testi: Colossi di Memnone "quando in compagnia dell'imperatrice Sabina fui presso Memnone. Tu Memnone, che sei figlio dell'Aurora e del venerabile Titone e che sei assiso di fronte alla città di Zeus, o tu, Amenoth, re egizio, a quanto raccontano i sacerdoti esperti delle antiche leggende, ricevi il mio saluto e, cantando, accogli a tua volta favorevolmente la moglie venerabile dell'imperatore Adriano". In questi lunghi viaggi, nei quali praticamente percorse tutto l'impero, non si occupò solo di questioni legate alla difesa dei confini, ma anche di esigenze amministrative, edificazioni di edifici pubblici e, più in generale, di cercare di migliorare lo standard di vita delle province. Al contrario di altri imperatori, che governarono l'impero senza muoversi praticamente mai da Roma, Adriano scelse un metodo di conoscenza diretta, che poté attuare grazie al consolidamento della situazione interna: allontanarsi dalla sede del potere per periodi così prolungati presupponeva una certezza assoluta sulla tenuta del sistema. Un altro elemento era la curiosità propria del suo carattere e la propensione per i viaggi, che lo accompagnò tutta la vita. Amò la cultura, l'architettura e la scultura greca. Soggiornò molte volte ad Atene e in tutta la Grecia, attratto da quel mondo pieno di meraviglie artistiche, e le popolazioni locali innalzarono in suo onore molte statue. Il regno di Adriano fu caratterizzato da una generale pausa nelle operazioni militari. Egli abbandonò le conquiste di Traiano in Mesopotamia, considerandole indifendibili, a causa dell'immane sforzo logistico necessario per far giungere rifornimenti a quelle regioni e alla molto maggiore estensione del confine che sarebbe stato necessario difendere[6]. La politica di Adriano fu tesa a tracciare confini controllabili a costi sostenibili. Le frontiere più turbolente furono rinforzate con opere di fortificazione permanenti, la più famosa delle quali è il possente Vallo di Adriano in Gran Bretagna. Qui Adriano, dopo aver terminato la conquista del Nord dell'isola, fece costruire una lunga fortificazione per arginare i popoli della Caledonia. Anche la frontiera del Danubio fu rinforzata con strutture di varia natura. Il problema delle strutture difensive era strettamente connesso col territorio e col tipo di difesa che si voleva instaurare. Infatti strutture particolarmente pesanti e durature, oltre a richiedere tempi di realizzazione e costi ingentissimi, mal si adattavano a mutamenti strategici nelle linee difensive. Se un territorio era particolarmente soggetto a incursioni in un determinato periodo, una struttura leggera, formata da fossati, terrapieni e palizzate, poteva fornire una discreta tenuta, dando alle truppe di stanza nelle fortificazioni il tempo di intervenire. Diverso era il caso di incursioni in profondità o di vere e proprie invasioni, che richiedevano strutture molto più resistenti, le quali però, una volta edificate, diventavano definitive e non seguivano le evoluzioni politiche e strategiche del territorio. Molte regioni passavano da situazioni di occupazione vera e propria allo stato di protettorati, i cosiddetti "Stati clienti", il che modificava notevolmente le necessità difensive. Quando la politica del protettorato si consolidava, si mantenevano in loco le risorse strettamente necessarie, spostando le risorse liberate in zone più calde. Questo sistema, detto delle vexillationes, cioè di distaccamenti prelevati da una legione e comandati altrove, dette ottimi risultati conferendo un'elasticità di manovra notevole. Il sistema dei distaccamenti consentiva anche di non turbare gli equilibri regionali faticosamente raggiunti, perché non si spostava un'intera legione ma singoli reparti. Il che, con il consolidamento di una difesa sempre più stanziale e con i conseguenti legami che s'instauravano tra i legionari e gli abitanti locali, consentiva di mantenere il controllo del territorio, disponendo comunque di una massa di manovra da destinare a operazioni belliche ove fosse stato necessario. Per mantenere alto il morale delle truppe e non lasciarle impigrire, Adriano stabilì intensi turni di addestramento, ispezionando personalmente le truppe nel corso dei suoi continui viaggi. Poiché non era incline, già dai tempi delle campagne daciche, a distinguersi per lussi particolari, si spostava a cavallo e condivideva in tutto la vita rude dei legionari. Di questa attività rimane memoria nelle cosiddette Iscrizioni di Lambesi[7], che vennero erette dopo una permanenza dell'imperatore nel castrum omonimo, sede della Legio III Augusta di stanza in Numidia. Nel documento viene descritta una serie di esercitazioni molto complesse che la legione svolse con successo nell'anno 128, a dimostrazione della nuova dottrina difensiva di Adriano, che intendeva ottenere il massimo dell'efficienza militare anche in quadranti, come quello numidico, abbastanza pacifici. Da un punto di vista della struttura organizzativa non portò grandi innovazioni nell'esercito, salvo creare nuovi corpi (secondo alcuni rinforzare corpi già esistenti), basati su leva locale, denominati Numeri, al fine di dare un apporto alle truppe ausiliarie, i cosiddetti Auxilia. I motivi erano diversi, innanzitutto tecnici: si trattava di mettere in linea truppe molto specializzate, ad esempio lanciatori, o destinate a terreni particolari, o equipaggiate in modo non convenzionale (come alcuni corpi di cavalleria pesante). Inoltre i Numeri non fruivano come gli Auxilia del diritto di vedere arruolati stabilmente i loro figli nelle legioni e quindi contribuivano a mantenere gli organici in numero costante. I Numeri erano molto più vicini degli Auxilia ai gruppi etnici stanziati nei territori che si intendevano controllare e conservavano organizzazione e armamento loro propri. Il tutto a costi nettamente inferiori a quelli che si sostenevano per i legionari regolari, i quali, oltre a una paga di tutto rispetto, fruivano di donativi saltuari e di una liquidazione alla fine del servizio, spesso costituita dal diritto di proprietà di terreni. Il problema della Giudea si era manifestato in tutta la sua gravità fin dai tempi della prima rivolta, nel 66, quando le truppe di Cestio Gallo, governatore della Siria, furono duramente sconfitte con perdite rilevantissime (poco meno di seimila uomini, secondo Giuseppe Flavio) e la perdita delle insegne da parte della Legio XII Fulminata. Il tutto per opera di truppe che non si potevano tecnicamente definire all'altezza di quelle romane. Il che dimostra la fortissima motivazione dei combattenti Giudei e, in particolare degli Zeloti. La rivolta si protrasse fino alla distruzione di Gerusalemme del 70, per opera del generale Tito, figlio di Vespasiano, e alla caduta della fortezza di Masada avvenuta nel 73, conclusasi con la morte per suicidio di tutti i resistenti e dei membri delle loro famiglie.Nel 115, sotto Traiano alla rivolta divampata a Cirene, in Egitto e a Cipro si unirono anche i Giudei con effetti devastanti. Il problema era strutturale, dato che gli abitanti della Giudea rifiutavano decisamente la romanizzazione, sia per motivi nazionalistici sia, soprattutto, per motivi religiosi. Infatti, professando una religione monoteista che, in quanto tale, non prevedeva l'affiancamento di altre divinità come era avvenuto in tutte le province, l'integrazione diveniva completamente impossibile. Quando Adriano si trovò a dover affrontare la ricostruzione di Gerusalemme ripropose i moduli architettonici e urbanistici applicati in tutto l'impero, mentre la popolazione ebraica chiedeva una ricostruzione nella forma precedente alla distruzione del 70.A seguito della visita effettuata alle rovine della città nel 130 cominciò l'opera di ricostruzione permettendo inizialmente la ricostruzione di un Terzo Tempio, ma secondo la testimonianza del Midrash[8] quando gli venne riferito dai Samaritani che ciò sarebbe stato causa scatenante di continua sedizione, parve ricredersi. Di poco seguente, la scelta di far erigere, in luogo di quello ebraico (come accadeva in tutto il resto dell'impero) un tempio al dio romano Giove sul sito del Monte del Tempio[9], e altre costruzioni dedicate a varie divinità romane in tutta Gerusalemme, tra cui un grande tempio alla dea Venere[10]. Egli fece poi anche rinominare la città la quale divenne così Aelia Capitolina in onore di sé stesso e di Giove Capitolino, la principale divinità romana. Secondo Epifanio (De ponderibus et mensuris, cap. XIII-XVI.; ed. Migne, II. 259-264), Adriano nominò Aquila di Sinope - parente acquisito dello stesso imperatore - come "supervisore dei lavori di costruzione della città"[11]. Si dice anche che operò per mettere un grande foro, che avrebbe dovuto essere il centro d'incontro sociale primario della nuova città, all'incrocio delle strade principali del cardine e del decumano, oggi facente parte dell'area quadrata costituita dal Muristan. Presto i Giudei, che avevano sperato in tutt'altro, furono assai delusi dal constatare quanto stava accadendo alla loro terra sacra, cominciarono pertanto sempre più un'opera di opposizione. Quindi una causa della rivolta fu il nazionalismo degli abitanti della Giudea. Altra causa, secondo una tradizione basata sulla Historia Augusta, suggerisce che le tensioni siano via via cresciute fino a sfociare in uno scontro aperto quando Adriano volle abolire la circoncisione rituale della religione ebraica (il Brit milah)[12] che egli, da fine ellenista qual era, avrebbe interpretato come l'esser una pura e semplice mutilazione fisica[13]. Tuttavia su questo specifico punto la revisione moderna ha evidenziato che moltissimi popoli sotto il dominio romano, nell'area nordafricana e mediorientale, la praticavano senza divieti e che quindi appare singolare un divieto specifico; uno studioso, Peter Schäfer, ribadisce che non vi sono mai state prove per affermare una simile ipotesi proibizionista[14][15][16]. Nel 132 divampò la terza guerra giudaica, con i ribelli comandati da Simon Bar Kochba (Simone figlio della stella). Le perdite dei Romani furono tanto pesanti che nel rapporto di Adriano al Senato fu omessa l'abituale formula "Io e il mio esercito stiamo bene". Necessitò di ben 12 legioni per sopprimere la rivolta, ossia circa 5/6 di tutta la forza militare dell'Impero: fu la sola volta in cui il Senato rinuncia a trionfare il ritorno dell'Imperatore dopo una vittoria militare[17]. Nonostante le perdite subite, nel 135 Adriano riuscirà a distruggere la città fortificata di Bétar e soffocare la ribellione devastando la Giudea (580 000 ebrei rimasero uccisi, 1,5 milioni deportati al Mercato degli Schiavi di Adriano a Gaza, 50 città fortificate e 985 villaggi furono distrutti), Adriano tentò di sradicare l'Ebraismo considerandolo la causa delle continue ribellioni. Proibì di seguire la legge ebraica, di attenersi al calendario ebraico e mise a morte gli studiosi della Torah (il martirio). I "Rotoli sacri" delle scritture furono formalmente e solennemente bruciati sul Monte del Tempio. Nel tentativo di cancellare la memoria stessa della Giudea, rinominò la provincia Syria Palaestina (dal nome dei loro antichi nemici, i Filistei, dall'ebraico "Philistim" פְּלִשְׁתִּים che significa "invasori") e agli ebrei da quel momento in poi fu fatto divieto di entrare nella capitale riconsacrata al paganesimo. Più tardi si permise loro di piangere la loro umiliazione una volta all'anno a Tisha B'Av. Era evidente che l'impero non poteva permettersi di mantenere in vita un potenziale focolaio di ribellione in un'area così delicata, soprattutto in considerazione della presenza di comunità ebraiche in molti paesi al di fuori della Giudea derivante dalla diaspora avvenuta in seguito ai fatti del 70. Quando le fonti ebraiche parlano di Adriano è sempre con l'epitaffio "possano essere le sue ossa frantumate" (שחיק עצמות o שחיק טמיא, nell'equivalente aramaico), espressione mai usata neppure nei confronti di Vespasiano o del figlio Tito che avevano fatto distruggere il Secondo Tempio. Adriano morì nella sua residenza di Baia di edema polmonare, a 62 anni come il predecessore Traiano. Cassio Dione Cocceiano riporta in un brano della "Storia romana": «Dopo la morte di Adriano gli fu eretto un enorme monumento equestre che lo rappresentava su una quadriga. Era così grande che un uomo di alta statura avrebbe potuto camminare in un occhio dei cavalli, ma, a causa dell'altezza esagerata del basamento, i passanti avevano l'impressione che i cavalli ed Adriano fossero molto piccoli.» In realtà non è certo che il monumento funebre sia stato iniziato dopo la morte dell'imperatore e molto probabilmente fu iniziato da Adriano nel 135 e, dopo la morte, terminato dal successore, adottato ufficialmente prima di morire, Antonino Pio. La struttura fu, nei secoli, trasformata ripetutamente e oggi è uno dei monumenti più famosi di Roma: Castel Sant'Angelo, il quale è infatti anche denominato Mole Adriana. Esistono teorie secondo cui il sarcofago in porfido dell'imperatore (in particolare il coperchio) sia stato riutilizzato come vasca del fonte battesimale di San Pietro in Vaticano. (Fonte Wikipedia)3 punti
-
Ciao, sembrerebbe questa moneta afgana https://en.numista.com/catalogue/pieces73823.html3 punti
-
Buongiorno, condivido le pagine del catalogo riguardante ITALIE - REPUBLIQUE DE VENISE (Murano). L'Asta si è tenuta a Parigi il 21/04/1969. La commissione d'asta era pari al 16% sul prezzo di aggiudicazione. Tale percentuale poi si riduceva all'11,50% per il range di prezzo da 6.001 a 20.000 franchi francesi, per poi ulteriormente ridursi al 10% superata la soglia dei 20mila franchi. Trattasi di esemplari facenti parte di un tesoro rinvenuto nell'Abbazia di Sainté-Trinité de la "Luizerne" in Normandia nel 1968. Abbazia della Santissima Trinità di La Lucerne - Wikipedia ABBAZIA DI LUCERNA D'OUTREMER - Capolavoro architettonico del patrimonio normanno - Fondazione dell'abbazia di Lucerna d'Outremer - Architettura romanica medievale - Visita culturale dell'abbazia - Visita guidata con guida-docente - Cantiere e laboratorio di To l'Abbazia del patrimonio - Gita scolastica e divertente visita in famiglia - | Granville - Avranches - Mont Saint Michel - Manica - Normandia | (abbaye-lucerne.fr) Peccato che le riproduzioni fotografiche siano in b/n. Saluti, Domenico P.S.: Al seguente link trovate il testo completo, comprensivo dei prezzi di aggiudicazione. [Catalogue de vente. Trésor de l'Abbaye Sainte-Trinité de la Luzerne. Monnaies d'or] | Gallica (bnf.fr)2 punti
-
Clemente X (1670-1676), PIASTRA (Munt 20): al R/ il porto di Civitavecchia con l'arsenale in fondo a sinistra e la fortezza a destra; nel bacino un veliero e barchette. Il porto di Civitavecchia fu costruito per volere dell'imperatore Traiano intorno al 106 d.C.. Dopo la caduta dell'impero romano il porto di Civitavecchia assistette ad un susseguirsi di dominazioni e passaggi di mano, contesi tra il papato, varie potenze comunali e frequenti incursioni saracene. Nel XV secolo, dopo che la città fu rientrata definitivamente sotto il controllo papale, il porto di Civitavecchia riprese vigore e importanza. Fu dapprima costruita la Rocca, una fortificazione quadrangolare; poi nel 1508 Giulio II affidò al Bramante i lavori di costruzione del Forte Michelangelo, che sarebbe sorto su antiche rovine romane. Il forte venne completato nel 1537 grazie forse al contributo di Michelangelo. Nel 1608, sotto il papato di Paolo V, fu eretto un fanale (il Faro), sulla estremità meridionale dell'isola frangiflutti, alto ben 31 metri. Il 26 novembre del 1659 venne posta la prima pietra dell'arsenale disegnato dal Bernini, che per lungo tempo avrebbe coagulato buona parte dell'economia cittadina. Fu poi edificata la cinta muraria merlata opera di Pier Paolo Florian voluta da papa Urbano VIII nel 1630. Alcune di queste strutture sono andate distrutte a causa dei bombardamenti durante la seconda guerra mondiale. In particolare nel 1943 furono distrutti il Faro, l'Arsenale, il Forte del Bramante e la Rocca vecchia. La legenda VT ABVNDETIS MAGIS (Perchè abbiate più abbondanza), si riferisce all'arrivo a Civitavecchia a forti quantità di grano. Ecco la piastra e a confronto nell'ordine un dipinto del XVIII secolo, una xilografia del 1860 e una del 1891.2 punti
-
2 punti
-
Passati 5 giorni dalla caduta di Kabul, le informazioni che cominciano a trapelare da varie parti contribuiscono a chiarire la dinamica dei fatti. Da quanto ho avuto modo di leggere (e le fonti citate mi sono sembrate affidabili) gli Stati Uniti erano perfettamente consci che il sistema statale che avevano creato e foraggiato in 20 anni sarebbe caduto entro pochi mesi dal ritiro Americano. Questa evidenza pare spiegare il terribile cinismo (altro volto del pragmatismo) Americano che fin dai colloqui di Doha, lo scorso anno 2020, si è limitato a includere i rappresentati dei Talebani, escludendo del tutto, e quindi delegittimando del tutto, il governo ufficiale Afghano. Mi ha lasciato profondamente interdetto scoprire che la principale sorpresa di Biden sia stata constatare che il governo ufficiale Afghano fosse caduto in meno di una settimana, invece dei circa 3 mesi che gli USA avevano previsto. Detto in altre parole, gli Americani si aspettavano che l'esercito Afghano si facessero massacrare, nel migliore dei casi, per circa 3 mesi prima di soccombere comunque ai Talebani. Nei piani USA questo avrebbe permesso agli occidentali di andare via con comodo. Se queste erano le attese, credo che i militari Afghani abbiano fatto bene, se non benissimo, ad abbassare le armi. Hanno evitato, in base alla lettura USA che non gli dava la benché minima possibilità di vittoria, solo un'inutile massacro, il loro. Biden ha anche detto che la missione in Afghanistan non ha mai puntato a costruire un nuovo stato democratico ma solo per estirpare il terrorismo. Purtroppo all'opinione pubblica Italiana ed Europea per 20 anni era stata propinata la "supercazzola" della missione di pace per "esportare" un modello democratico di vita in Afghanistan. Sebbene io sia perfettamente conscio che i motivi reali delle guerre e delle occupazioni militari siano spesso diverse da quelli che vengono narrate all'opinione pubblica, da Italiano che ha pure pagato le tasse per finanziare tale missione mi sento vagamente preso per i fondelli, in quanto la missione militare poteva, se accettiamo la narrazione fatta proprio da Biden, concludersi nel 2011 con la morte di Osama Bin Laden. Diciamo che, probabilmente, Biden avrebbe potuto preparare un discorso migliore. Ciò detto, va' sicuramente riconosciuto a Biden un insolito pragmatismo e realismo nella sua comunicazione, capace di squarciare il velo di ipocrisia costruito dietro questa operazione militare e difeso strenuamente negli anni da varie amministrazioni occidentali. Meglio la triste verità che un velo melenso di ipocrisia. Gli americani, nei due secoli della loro storia, hanno alternato periodi di isolamento domestico a periodi di politica estera aggressiva. Non è escluso che nei prossimi anni se ne stiano buoni a casa loro. I cocci che hanno lasciato in Afghanistan, a ben vedere, li riguardano ma non in maniera eccessiva. Di fatto, col ritiro, gli USA ottengono 5 possibili obiettivi. 1) I talebani in Afghanistan possono diventare una mina vagante per la Cina, qualora si mettessero in testa di aiutare l'indipendentismo Uiguro. (I cinesi non sono scemi e credo gestiranno la situazione a loro vantaggio) 2) I talebani in Afghanistan possono essere una mina vagante anche per le repubbliche ex-societiche centro-asiatiche legate alla Russia. (ma nemmeno i Russi sono scemi, e infatti hanno cominciato da subito a rapportarsi col nuovo regime). 3) risparmiano un pozzo di soldi andando a concentrarsi su questioni geopolitiche più importanti e rinunciando all'influenza (irrealistica) sull'asia centrale. 4) L'Iran si ritroverebbe al confine di nord-est una nazione di cultura Wahabita, storicamente ostile e sarebbe invaso da profughi ingestibili che certamente farebbe fluire verso ovest. 5) Ulteriore destabilizzazione politica dell'UE. La politica estera Europea è certamente inesistente, ma già immagino da qui fino al 2022 ulteriori liti tra ungheresi e polacchi, tedeschi e Italiani, ecc. ecc. a causa della pressione dell'immigrazione dall'Afghanistan (ne arriveranno centinaia di migliaia). Un'UE forte non è utile per nessuno (tranne agli Europei che però paiono non capirlo). I profughi, probabilmente centinaia di migliaia che, giustamente, sognano una vita migliore di quella che potranno avere in Afghanistan, ancora una volta busseranno in Europa. Ma dov'è l'Europa in questo momento? Al momento mi risulta non pervenuta, come in tante altre occasioni.2 punti
-
Va bene, lo confesso: oltre all'album dei "rottami" (che poi, qualcuno dice che così rottami non sono), posseggo "l'abisso degli orrori", una sorta di caverna scavata nelle viscere della terra dove getto e nascondo tondelli deturpati ed orripilanti che voi umani non avete mai visto né potete immaginare. Sono monete quasi o del tutto irriconoscibili che utilizzo per esperimenti abominevoli che spesso portano alla loro definitiva distruzione...2 punti
-
Ho aggiunto al mio giudizio sulla tua moneta una considerazione sul deplorevole andazzo che riguarda non solo monete antiche. Nel tuo caso non è successo ma, ripeto, dei pseudo esperti, e ti assicuro che qui ce ne sono, si sentono in dovere di dire la loro anche se "non è il loro campo". Così facendo mettono la proverbiale zecca ( siamo un forum di numismatica e non abbiamo le pulci ma le zecche) del dubbio nel nuovo collezionista. Tanto per riderci su ho recuperato un poema epico postato da qualcuno molti anni fa : S'ode a destra uno strillo : ma è falsa a sinistra rispondono : è bbuona ! Poi nessuna opinione è prevalsa E s’inizia una gran maratona. C’è chi nota la bolla del fuso Chi ritien che sia solo sporcizia, un difetto causato dall’uso e s’invoca una bella perizia. Ora un altro s'avanza spiegando che si è fatta una gran confusione che da foto soltanto osservando non si può ricavarne opinione Per intanto si spargono accuse D’arroganza e di scarso saper Di postare le tesi più astruse E di imporre lo proprio voler. Ecco appare un drappello schierato; ecco un altro che incontro gli vien. E il discorso non più moderato Viene chiuso per fare del ben.2 punti
-
Lo è anche per me. Ho notato che se si condivide un acquisto o si mostra una moneta della collezione, prima o poi qualcuno solleva dei dubbi sull'autenticità. "Non è il mio campo ma......" Se non è il tuo campo astieniti dal dare giudizi. Abbiamo qui esperti in ogni campo, aspettiamo il loro di giudizio. Se poi si colleziona con il timore di comprare falsi, allora è meglio lasciare la numismatica e collezionare qualcos'altro.2 punti
-
Ecco l'ultimo della serie: 1735. Peccato per le piccole mancanze di patina, ma la perfezione è rara nel nostro campo...2 punti
-
Ferdinando IV, Piastra 1798 SICILIAR ET HIE REX senza punteggiatura, e al rovescio tre soli punti fra i rombi nella fascia della Corona Reale. Sapete se esiste uno studio che classifichi tutte le variazioni di conio di questo millesimo?2 punti
-
De gustibus... Eccoli estratti dal buio dell'antro oscuro. Inizio con una visione d'insieme della paginetta dove vi sono i superstiti dei 2 Centesimi di V.E.II. In realtà avevo 5 esemplari del 1867 T (3 sono stati regalati), vi era anche un 1862 N (regalato) e, praticamente, tanti 1867 M da farne un rotolino:1 punto
-
DE GREGE EPICURI Moneta certamente autentica. Il ritratto è davvero splendido, mentre anche qui il conio di martello è un po' scivolato, dando immagini un po' alterate alla testa della PIETAS ed alle lettere AVG.1 punto
-
Bellissimo sesterzio. Qualche riga Antinoo la meritava.1 punto
-
Cari amici numismatici italiani, Posso solo dire che sono entusiasta. Grazie mille per il grande interesse e le valutazioni e valutazioni molto utili da parte tua. Il fatto è che questa moneta è l'ultima moneta dei tesori e la data è particolarmente importante a causa del tempo di occultamento (terminus post quem). La precedente valutazione dei miei colleghi era dove il tuo stimato ghezzi60 (un ringraziamento speciale a te) un simbolo simile del XX. Serie negata. Bernocci ha datato la lama triangolare nel 1975, 516 al 1252 - 1421, il che metterebbe in discussione l'intera valutazione. Con il vomere 1326 2° semestre la datazione si adatta di nuovo. Sono felice di trasmettere ulteriori dati e la prima pagina. Distinti saluti Il tuo Pecoinius Posizione del timbro: 6:30 h Diametro 20,1 / 20,6 mm Peso: 3,53 g1 punto
-
Ciao,perfettamente d'accordo con te e se ricordi te l'ho detto anche in un altro post. Per quanto riguarda giudicare l'autenticità da una foto è difficile,e questo io lo specifico sempre, ma si tratta di un parere non vincolante che chiedo( non una perizia) . Non chiedo mai e non chiederò mai di darmi un parere sulla conservazione o sul valore della moneta,per me e sottolineo per me sono cose secondarie e prettamente soggettive. Poi se qualcuno vuole esprimere un giudizio estetico che lo faccia pure tranquillamente, sia esso positivo che negativo, la cosa non mi da per niente fastidio. Le monete che acquisto piacciono a me,poi si sa chi si contenta....... Grazie Alla prossima1 punto
-
Ciao Amici Murattiani, facciamo un passo indietro e parliamo ancora del conio che presenta la scritta "NAPO". Mi perdonerete se non posto delle monete della mia raccolta, bensì monete comparse in Aste negli ultimi 10 anni. Certamente Cristiano saprà decifrarle al meglio e sarei contento potessero essere utili per il suo studio. Le note principali sono nelle immagini, purtroppo la qualità delle stesse è scarsa ma sono ancora decifrabili. Saluti a Tutti, Beppe1 punto
-
1 punto
-
Per confronto allego il link di una simile https://www.wildwinds.com/coins/sear5/s3514.html#RIC_02601 punto
-
Devo dire che anche a me dà fastidio la frase: '' Non è il mio campo, ma non mi piace. '' Ribadisco che, se fossimo in presenza, nessuno direbbe una frase del genere. Ma siamo in un forum e questo è uno dei difetti che bisogna sopportare. Per fortuna i pregi sono molti di più. ? Per quanto riguarda la titubanza, è dovuta proprio al fatto che si giudica una foto e così il giudizio non può essere definitivo. Con le foto a tutti noi è capitato di sbagliare... Arka Diligite iustitiam1 punto
-
Sì, è falsa. È il solito falso da bancarella usato come "tappabuchi" dai collezionisti. La moneta autentica vale decine di migliaia di euro ed è impossibile che venga trovata per caso. Quando fu coniata, venne data ad importanti personalità del Regno. Chi l'ha acquistata, ha la documentazione della transazione e, di solito, conserva questa moneta in cassetta di sicurezza.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Bella banconota, visto cosi ti identifico con il Senatore Publio Aurelio Stazio investigatore per passione nell'antica Roma al tempo dell'imperatore Claudio1 punto
-
Tu li hai evocati! Io posseggo 4 album colmi di miniassegni (raccolti all'epoca e donatimi negli anni), ma questi non ho avuto il coraggio di metterli in collezione (né di buttarli: cuore tenero di collezionista): I Miniassegni zombi...1 punto
-
Trovare questi soldini perfetti è difficile, accontentiamoci di vedere bene la data!1 punto
-
Ciao Alain, è vero quello che dici... però in questa monetina la data è chiarissima.1 punto
-
DE GREGE EPICURI A me le foto non sembrano malfatte. Certo, la moneta ha qualcosa di sgradevole, nel senso che le lettere non sono belle nitide, ed i fondi sembrano un po' granulosi, ma forse è stata sottoposta, appunto, a forme aggressive di pulizia. Potrebbe comunque essere autentica. Quanto ai residui del codolo di fusione, tieni conto che i tondelli venivano preparati per fusione, prima di essere coniati.1 punto
-
Anche per me risolvere l’equazione di secondo grado (x-6)2=x+6, dove x è l’età di Franco, è la soluzione più immediata. Volendo trovare una strada alternativa si può considerare che, se poniamo y = x-6, la soluzione del problema richiede di trovare un intero il cui quadrato è uguale all’intero stesso più 12, ovvero y2= y +12. L’equazione in questione si può riscrivere come y(y-1)=12, da cui è immediato ottenere y=4 e, di conseguenza, x=10.1 punto
-
Ciao Giovanni e grazie per la tua analisi. L’enorme quantità di falsi di origine bulgara che sono stati messi sul mercato rendono praticamente dubbia l’autenticità della maggior parte delle monete con questa tipologia e la storia della mia dramma di cui dirò nella discussione «“Apollonie” di apollonia autentiche o false?» in cui l’avevo presentata ne è una prova. Saluti da apollonia1 punto
-
Non mi sembra una grande idea, allegare all'esterno, copia della fattura.1 punto
-
Innanzitutto prego. È un piacere. Veniva preposto DEUTSCH in contrapposizione al fatto che l'ÖSTERREICH, cioè l'Austria, o meglio ancora la corona dell'impero austriaco (senza la corona del Regno d'Ungheria), comprendesse in epoca asburgica territori di nazionalità tedesca, ceca, polacca, italiana e quant'altro. Con la preposizione di DEUTSCH ci si voleva così riferire alla sola Austria di nazionalità e lingua tedesca corrispondente grossomodo all'odierna Austria nata, come la Cecoslovacchia, dalle ceneri della monarchia asburgica.1 punto
-
Buongiorno a tutti e a tutte. Mi spiace smontare le vostre supposizioni (ne faccio anch'io a iosa ?) tuttavia, paradossalmente, è più probabile che sia la banconota meglio conservata a provenire dal fronte che non quella più martoriata. Potrei anche sbagliarmi, non sono un esperto, tuttavia la questione è la seguente. Le due banconote sono diverse per piccoli particolari di stampa, ma soprattutto per il fatto che la prima reca la sovrastampa DEUTSCHÖSTERREICH, la quale distingueva le banconote dell'impero austro-ungarico (senza sovrastampa) da quelle della neonata Repubblica d'Austria (con sovrastampa) alle prese con transizioni economico-politiche e inflazione e incertezze varie. Il disegno delle banconote austriache era lo stesso del disegno delle banconote austro-ungariche. Anche ragionando sul fatto che il neonato stato austriaco possa aver sovrastampato la contromarca su banconote austro-ungariche già in deposito, mi sembra improbabile che possa averlo fatto su banconote già pesantemente usurate dal fronte. Per questo ritengo improbabile la provenienza dal fronte della prima banconota. Lascio la parola a chi ne sa più di me.1 punto
-
Ho finito i like e quindi per ora mi limito ad un volgare "Azzzz" Io non ho ancora mai considerato di inserirla in collezione, ma chiedo tanto per sapere, se esistono varianti x questo millesimo? Complimenti ancora per la bellissima e rara moneta1 punto
-
In attesa di poter ammirare da sola la tua Piastra 1785, faccio un salto temporale di 17 anni, condividendo una delle Piastre più rare di Ferdinando IV : La 1802 La conservazione non è delle migliori, ma a me piace molto.1 punto
-
Buongiorno, posto questo dieci grani, per avere una vostra opinione. Il peso è di 26,2 gr, il taglio è liscio. Saluti1 punto
-
Come si versa la marca da bollo, in via telematica? Ci si deve recare presso l'Ufficio o il tutto avviene telematicamente? Ho voluto provare a vendere una moneta che non apprezzavo più su Catawiki; l'ho fatto più che altro per sfizio e noia dovute al lockdown, ma viste le complicazioni, d'ora in poi ricorrerò a case d'aste italiane. Alla fine l'acquirente francese, cui ho dovuto spiegare che le leggi francesi sono diverse da quelle italiane, si è detto comprensivo e ha detto di non preoccuparmi, che avrà pazienza e aspetterà, e nel frattempo di avvisare Catawiki di "non rompere".1 punto
-
Il mio punto di vista è che il valore delle monete non è quello dei vari cataloghi, listini ed aste varie. Non può esistere un valore prefissato di una moneta. Innanzitutto se il valore va commisurato al grado di conservazione allora ci dovrebbe essere un sistema che ci dia certezza del grado di conservazione da un punto di vista solo ed unicamente oggettivo, un sistema basato su parametri fissi ed inconfutabili, ma un sistema del genere non esiste. Poi il valore dovrebbe essere cristallizzato in un segmento temporale ben determinato, come succede con le quotazioni dei metalli preziosi, ma con la numismatica questo non è possibile. Inoltre anche l'area geografica in cui si vende la moneta molto spesso influenza il prezzo. Oltre l'area geografica, anche il tipo di vendita incide sul prezzo della moneta (asta pubblica, asta on-line, vendite tra privati sulle varie piattaforme di aste on-line, convegni, mercatini, acquisto direttamente dalle mani del collezionista che cede la propria collezione, acquisto dalle mani di un erede del collezionista, acquisto di una singola moneta o di pochi pezzi, acquisto di un grosso lotto di monete, ecc. ecc.) Poi ci sono periodi di benessere diffuso e periodi di crisi economica con conseguente ricaduta sui prezzi delle monete. Insomma, le variabili sono tantissime. Morale della favola: non esiste il valore della moneta; i cataloghi sono forse utili solo per orientarsi tra un minimo ed un massimo, ma non fanno il valore della moneta (anzi molto spesso sono pieni di imprecisioni e di valutazioni non veritiere). Solo l'esperienza ci dà l'illusione di aver pagato il giusto prezzo, ma comunque non ci può dare nessuna certezza.1 punto
-
Ringrazio Eliodoro per aver postato questo minimo. Affiancare poi i due nominali rende subito l'idea della differenza fra le due monete. Un quarto di grammo in cui è racchiusa tanta di quella storia sulle riforme dell’epoca. Nonostante la famosa riforma monetaria voluta da Carlo I d’Angiò, i denari circolanti continuavano ad avere un contenuto di fino molto basso al punto che il papa stesso intervenne presso i regnanti napoletani per riformare la monetazione in biglione. Sotto Carlo II d’Angiò, papa Martino IV, sui piani di San Martino, il 30 marzo 1283, chiese la coniazione di buona moneta: “permittimus, atque statuimus, quod de cosilio proborum et legalium virorum habentium huiusmodi rei peritia, cudi faciemus monetam bonae tenutae, pretii, et valoris, secundum quod statui praedictarum expedite. Pro qua expenda non fiat collecta, nec distributio, sed dabitur campsoribus, et aliis mercatoribus ea volenti bus sponte recipere, et praefata moneta erit perpetua, nec mutabitur aliquo tempore, sed in suo pretio et statuto obseruabitur”. Richiesta poi ribadita, nel 1285, da papa Onorio IV. Carlo II mantenne la promessa solo nel 1289 facendo coniare il denaro regale con la sua medalea. Il primo documento, ad oggi, che parla di queste monete risale al 15 marzo 1290. Testualmente: “cuduntur in regia sicla Neapolis et monetam parvam denariorum vocatam regalis que in eadem sicla cusa est et cudentur […] et pred[icta] parvam monetam denariorum qui dicuntur regales ad rationem de denariis XL seu medaliis LXXX denariorum ipsorum pro tar. auri uno ponderis supradicti”. Quindi a Napoli si batte una moneta chiamata regale, al cambio di 40 pezzi per tarì ed ovviamente la sua metà a 80 pezzi per tarì (le monete postate da Eliodoro). La lega era nettamente migliore a quella dei denari precedenti, composta da 1 oncia e 13 sterlini d’argento e 10 once e tre sterlini di rame. In realtà però i saggi effettuati dal Sambon rivelano una percentuale più bassa d’argento. Forse le intenzioni erano buone ma già nel 1292 il cambio prefissato non veniva più rispettato e per un tarì servivano 54 denari regali (o 108 medalee): “habebat filiationi tuae lictera nuper culmini nostro missa quod denarii qui sub iudicio per Curiam nostram pretio de quadraginta per tarenum in sicla nostra Neapolis de mandato nostro cuduntur, pro maiori parte repudiantur, et quod tenutam non habent eidem pretio competentem ad probam enim ignis, ut scribis, decrescunt in tertia parte valoris ipsius, quo sit, ut ex defectu tenute ipsos expendio oporteat una quinquaginta quatuor per tarenum”. Si cercherà successivamente di riformare nuovamente le emissioni in biglione stabilendo di coniare tre nuovi nominali: il denaro, il ½ denaro ed il ¼ di denaro (petitta) con un contenuto di fino che avrebbe permesso il cambio con il tarì rispettivamente con 20 denari (in pratica il denaro equivaleva al grano di conto), 40 medalee ed ottanta petitte: “ adhibitis egro fidelium et peritorum consiliis que fuerint adhibenda, protinus novam monetam de predicta tenuta turonensium de turonis in sicla predicta cudi facias sine mora in denariis, medaliis et petictis, sub forma, signis et descriptionibus subnotatis, quos quidem denarios karolenses parvos, medalias autem parvas medalias ad diferentiam karolensium et medaliarum aurum et argenti volumus nominari. Monetam vero predictam eius fieri volumus ponderis et valoris quod ex causa karolensis parvi viginti aut medalie parve quadraginta vel petitte octoginta per tarenum perpetuo communitus expendantur”. Di queste monete però non vi è traccia e presumibilmente non furono mai coniate. La conferma che le reali volontà del sovrano fossero diverse da quanto richiesto dall’autorità papale la troviamo nel 1299 con la nascita del denaro gherardino. Un nuovo tipo di denaro che si sarebbe dovuto scambiare per 80 pezzi a tarì ma che per il suo basso contenuto di fino veniva scambiato per 120 pezzi per tarì (E furono fatti per ispendersi per lo Regno li 6 de’ detti gherardini piccioli per 1 grano). Spero di essere riuscito a far comprendere quanto importante sia questa monetina e quanta storia si celi dietro di essa, scusandomi in anticipo per la mia prolissità.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Forse...a patto di trovare l'acquirente interessato e, secondo me, non è facile. Un commerciante le comprerebbe per rivenderle singolarmente, e dunque non solo non riconoscerebbe alcun valore supplementare, ma offrirebbe addirittura meno degli 8-10 euro l'una di cui parli (e che, francamente, mi sembrano troppi non solo per un commerciante, ma ammettiamo pure che...). Un collezionista...esiste qualcuno disposto a spendere, diciamo 1200 euro, per avere 100 banconote tutte uguali, e tutte ugualmente comuni? Poi, che se ne fa? a rivenderle una ad una, ci rimette, dovrebbe trovare qualcuno disposto a sua volta ad acquistarle in blocco, ma questo qualcuno, quanto potrebbe offrire in più? Le acquista per passione, per il piacere di possederle? dal mio punto di vista, non è certo il modo giusto di collezionare, si ritroverebbe con 100 pezzi uguali il cui unico motivo di interesse sarebbe nei numeri di serie consecutivi. Sarà che a me non interessano nemmeno le serie sostitutive, ma non riesco a capire come uno possa collezionare "numeri" piuttosto che "pezzi di storia", come sono, o dovrebbero essere, le banconote e le monete...e per la storia, di Galileo ne bastano al massimo tre, una per ogni diverso decreto e firme Quanto sopra, vale non solo per le Galileo, che potrebbero essere solo un esempio, ma per qualunque altro tipo di mazzette tu dovessi avere, comuni, meno comuni, o rare. Se sono comuni, vale quanto sopra, se sono rare, si parlerebbe di cifre che in pochi potrebbero sborsare (quanto costerebbe una mazzetta di 5.000 Repubbliche Marinare FDS? ma anche di Manzoni, o Leonardo) e dunque, dal punto di vista pratico, cambierebbe poco. Detto questo, che naturalmente è soltanto la mia opinione, e non pretende certo di valere come verità assoluta, ti dò anch'io il benvenuto nel forum1 punto
-
Se può interessare posto quanto da me scritto qualche tempo fa. I 3 carlini 1647 di Filippo IV, anzi il 15 grana 1647 di Filippo IV, scusate il carlino 1647 di Filippo IV Come si evince dal titolo non è tanto chiara l’attribuzione del nominale a questa moneta del regno di Napoli, ma procediamo con ordine. Siamo a Napoli, il Regno è sotto il dominio di Filippo IV, nella città partenope comanda Rodrigo Ponce de Leon Duca d’Arcos e siamo in un periodo abbastanza complicato e delicato. Il popolo è insoddisfatto, tasse, gabelle e povertà lo sfiancano, la tosatura delle monete ha raggiunto livelli esagerati e spesso è la stessa zecca partecipe delle frodi monetarie. Insomma ci sono tutti i presupposti perché qualche tempo dopo, un pescivendolo di nome Tommaso Aniello, detto Masaniello, si prenda la premura di guidare una rivolta (ma fu proprio lui???) che spodestò il viceré e che portò alla proclamazione della Repubblica Napoletana. Torniamo un po’ indietro, come detto siamo nel 1647, nella zecca si decide di coniare una nuova moneta che porterà la “firma” del Mastro di zecca provvisorio Giuseppe Maffei e del Mastro di prova Geronimo Pontecorvo (non vi è comunque la certezza che le sigle apposte sulla moneta siano le loro); Questa moneta riporterà al D/, come si è solito fare, il busto del re volto a destra con corona radiata con la legenda PHILLIPP∙IIII∙DEI∙GRA (o similare) ed al R/ la croce potenziata cantonata da fiamme con la legenda *IN HOC SIGNO VINCES 1647 . A mio avviso è proprio questo rovescio, simile ad altri nominali di Filippo IV a causare un po’ di confusione. In pratica, il Cagiati nella sua opera “Le monete del reame delle due Sicilie” riporta questa moneta indicandone un valore nominale di 15 grana, escludendo o più probabilmente non conoscendo, il 3 carlini che verrà poi riportato dal CNI. Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza. Partiamo dal 3 carlini, il CNI ne riporta tre esemplari entrambi appartenenti alla collezione reale: N°1103 (30 mm – 8,98 g) D/ …HILIPP•IIII•DEI•GR• ; Busto con corona radiata volta a d. con dietro le sigle GM/P e davanti N. R/ *IN HOC•SIG…O•VINCES•; Croce potenziata cantonata da fiamme. N°1104 (22 mm – 4,90 g) D/ PHILIPP•IIII•D•GRA• ; Busto con corona radiata volta a d. con dietro le sigle GM/P e davanti N. R/ *IN HOC•…..O•VINCES•; Croce potenziata cantonata da fiamme. Come si potrà notare in entrambi le descrizioni non viene indicata la data, in quanto si tratta di monete tosate e che quindi essa non è visibile, ma nonostante ciò vengono riportati come datati 1647 questo forse anche a causa del terzo esemplare riportato ed indicato come appartenente alla collezione Catemario. N° 1105 (19 mm – 2,97) D/PHILIPP•IIII•D•GRA ; Busto con corona radiata volta a d. con dietro le sigle GM/P e davanti N. R/ +IN HOC SIGNO VINCES 1647; Croce potenziata cantonata da fiamme. La prima cosa che salta all’occhio, nonostante che anche quest’ultimo esemplare sia definito tosato (peso e diametro ne sono un riscontro oggettivo), è come mai esso sia perfettamente leggibile? Non sarà per caso che invece ci troviamo di fronte al carlino del 1647 riportato dal P/R al n°44 (19 mm – 2,96 g) e catalogato dal dott. Giovanni Bovi nel Bollettino del Circolo Numismatico Napoletano 1965-66 n°122. Infatti questo carlino, anch’esso rarissimo, ha tutte le carte in regola per essere il tipo riportato nel CNI al n°1105. Visionando la Raccolta degli studi del dott. Giovanni Bovi, scorrendo la monetazione di Filippo IV, troviamo la seguente descrizione: N°122 (19 mm – 2,98 g) D/ PHILIPP•IIII•D•G•REX; Busto con corona radiata volta a d. con dietro le sigle GM/P e davanti N. R/ *IN….CES • 1647; Croce potenziata cantonata da fiamme. Ma la cosa più intrigante è che anche questo esemplare è indicato come appartenente alla collezione Catemario e se non fosse per la legenda verrebbe da dire che sia lo stesso esemplare, infatti diametro e peso sembrano corrispondere. Possibile che non si tratti di un qualche errore di trascrizione degli autori del CNI? Per me siamo di fronte alla stessa moneta. Tra l’altro questo carlino è identificabile anche per la differenza di disegno delle fiamme che si trovano nei quarti della croce al R/ che assomigliano in questa moneta a delle foglie. Ora facciamo un piccolo passo indietro, ricordate i numeri 1103 e 1104 del CNI, e che in entrambi la data non era visibile? Ebbene il P/R al n° 21 riporta un’esemplare da 3 carlini appartenente ad una collezione privata datato 1648, ed in questo caso la data è ben leggibile al R/ al termine della legenda, quindi è da supporre che il 3 carlini 1647 non sia mai stato coniato, ma esisterebbe solo quello datato 1648. Quindi ricapitolando, i nominali con la croce potenziata al R/, con le sigle GM/P dietro il busto sono due, il 3 carlini 1648 ed il carlino 1647 e che entrambe queste coniazioni sono di estrema rarità. Ma avevamo parlato anche di un 15 grana riportato dal Cagiati se non erro. Ebbene anche questa moneta, indicata come appartenente alla collezione dell’Erba è invece il carlino di cui sopra che l’autore all’epoca confuse per una variante della tipologia dal nominale di 15 grana . Con questo breve “sunto” voglio chiarire che non ho scoperto nulla di nuovo, in quanto, sia il Bovi prima che il Pannuti e Riccio dopo, avevano già compreso l’errore e nelle loro rispettive opere hanno riportato le giuste indicazioni. Io nel mio piccolo mi sono limitato a chiarire cosa c’era dietro questa piccola confusione di tipologie, dovuta probabilmente ad errori di trascrizioni e di fraintendimenti giustificabili dal fatto che chi ha scritto l’opera del CNI e lo stesso Memmo Cagiati, considerata l’epoca delle pubblicazioni (inizio del 1900) e la mole delle stesse senza avere la disponibilità di foto chiare, facili comunicazioni con i collaboratori, non hanno avuto certo il “lavoro facile” che noi possiamo avere oggi nell’era della tecnologia e di internet.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?















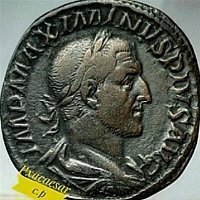
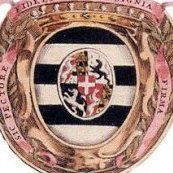











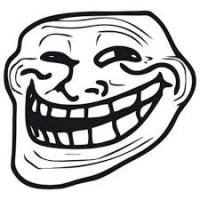


copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)