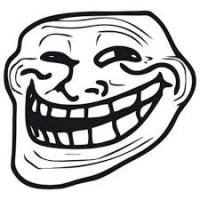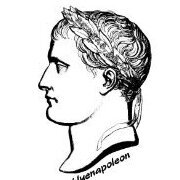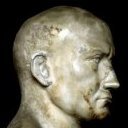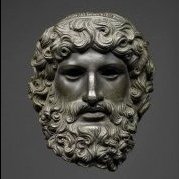Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 09/27/21 in tutte le aree
-
Buongiorno amici potevo aggiungerla alla discussione che ho aperto appunto su questa tipologia monetale, ma secondo me si meritava un post a se! Se lo merita per via della sua conservazione, del tipo con asterischi è la più bella che ho visto...sicuramente alcuni veterani della numismatica ne hanno viste di migliori e se qualcuno ha immagini di esemplari con questi simboli da postare li guardo molto volentieri ma questa è davvero un gioiellino senza contare la rarità, che come ho già scritto, nei manuali è sottostimata, da NC andrebbe passata almeno a R. Ecco le foto, molto graditi saranno i vostri commenti. Buon Lunedì amici. Come al solito nella variante con asterischi troviamo il rombetto dopo GRANA. Saluti ancora.9 punti
-
Complimenti. L’occasione ritengo sia utile per far evidenziare al Forum la presenza della testa del Leone (vedi particolare ingrandito allegato). Questo aspetto non viene rilevato dalla bibliografia consultata, a cominciare dal Manin, Jesurum, CNI, Werdnig, Paolucci, Gamberini di Scarfea, Manzoni, Dal Gian, Montenegro, Traina. Il riferimento appare nella descrizione di un esemplare simile apparso in asta Bolaffi nel dicembre 2020. Integro con la descrizione del Lotto 291 di cui all’Asta Bolaffi del 10-11/12/2020:4 punti
-
Salve, la moneta da 500 lire con data tagliata è un errore molto comune (nel 1988 sono più quelle con la data tagliata che quelle con la data integra). L'altra moneta è più interessante e presenta una foratura decentrata della corona esterna. L'errore è descritto in questa pagina (circa a metà): https://www.erroridiconiazione.com/t-4-errori-bimetallici/ Per la valutazione le ho scritto in privato. Saluti Andrea4 punti
-
Ho iniziato da qualche mese con le monete di Venezia e fissandomi con il Doge Michele Steno (1400 - 1413) e con un pò di fortuna ho completato, o quasi, la collezione di monete da lui emesse.- La monete sono: Grosso con le stelle, Mezzanino per VR e VI, Soldino con la stella dietro il Doge e come da indicazioni di Adelchi Benetton, nel suo nuovo libro, di tipo E, sotto classe C, massaro Marco Navager, Ducato, Denaro scodellato, Denaro per VR e VI, Tornesello (moneta per l'oltremare); le monete finirebbero qui ma intendo procedere completando con i vari soldini dei vari massari (sei in tutto).- Per me è storicamente interessante il Doge Michele Steno in quanto nel 1402 ha accorpato il colognese (Cologna Veneta e paesi limitrofi) a Venezia, e poi è stato il primo writer della storia ? A breve metterò anche le foto delle singole monete.-3 punti
-
Buonasera a tutti, la mia Napoletana di oggi, che sono riuscito finalmente a trovare. Tornese 1 Cavalli 6 del 1788 di Ferdinando IV. Mi accontento della conservazione che ritengo essere un apprezzabile Mb. ? Magliocca 330a Variante SICIL Saluti Alberto3 punti
-
Voglio far vedere questo ultimo arrivo in collezione, si tratta di un Cavallotto del 1618 di Carlo Emanuele I del IV o V tipo, se classificato con il mir o con il Cudazzo. Fra le più rare di questa tipologia monetale, ancor più raro è trovarli con la data perfettamente leggibile come in questo caso. Questo millesimo è considerato meno raro sui vari cataloghi rispetto all'anno successivo, ma ho avuto l'occasione di vedere più date del 1619 rispetto a quelle del 1618, quindi personalmente lo ritengo più difficile da rintracciare. Aggiungo che in questa tipologia la data è spesso fuori dal tondello e spesso si vede solo la parte superiore dell'ultima cifra non rendendo possibile capire se si tratta di un 8 oppure di un 9. Con questa moneta colgo l'occasione di scrivere qualcosa di più sui cavallotti, perché secondo me c'è un poco di confusione sui vari cataloghi... Consumata, ribattuta ma per fortuna con la data chiara e con un peso di 1,83 gr. ecco l'ultimo cavallo aggiunto al branco2 punti
-
Che ne pensate? Mi son sempre chiesto perché c’è il punto sotto la R in questi esemplari.2 punti
-
Buongiorno, Sarei felice di partecipare. Escluso per motivi anagrafici (?) dal dono numismatico, sono interessato al momento a tutto tranne al pranzo a causa di una concomitanza di appuntamenti. Non escludo però di riuscire a risolvere la sovrapposizione. Quindi magari vi tengo aggiornati. Curiosissimo di scoprire il Gazzettino e di introdurlo possibilmente nel mio Circolo di Morbegno (SO), saluto tutti, ringrazio gli organizzatori e metto in agenda l'appuntamento!2 punti
-
Condivido con piacere questo esemplare di ducato recentemente acquisito in Asta MÜNZEN GUT-LYNT GMBH - GUT-LYNT AUKTION 3 (LIVE ONLINE AUKTION) del 19/09/2021 Lotto 2016. Di seguito, la descrizione riportata dall’Asta nonché in allegato le relative foto con alcuni ingrandimenti. Francesco Loredan 1752-1762 Ducato o. J. (1752) Venedig Münzmeister Stefano Barbaro. Montenegro 2755. Dav. 1551. 22.58 g. Selten. Sehr schön-vorzüglich Buona serata, Domenico2 punti
-
Buonasera @VALTERI, Decisamente meno comuni dei didracmi, le dracme imeresi battute durante l’occupazione akragantina non sono meno affascinanti storicamente e non solo. Credo si possa ben dire che rappresentino un documento importantissimo, che testimonia la realizzazione ultima del lungo ed inarrestabile interesse di Akragas nel suo sviluppo verso la direttrice nord/tirrenica, nel periodo che va dalla tirannide di Falaride a quella di Terone, dal secondo quarto del VI secolo a.C. alla fine degli anni 70 del V secolo a.C. (anche se è da notare che la presenza nelle aree menzionate di seguito da parte di Akragas non si conclude con la tirannide Emmenide). Sappiamo dalle indagini di scavi archeologici che già poco dopo la sua fondazione da parte di Gela (580 a.C.), Akragas iniziò ad allargare la propria sfera di influenza nella valle dell’Imera meridionale (a discapito proprio della madrepatria) e che tale controllo fu esercitato all’incirca fino a metà del V secolo a.C. Ma anche lungo il corso del fiume Halikos Akragas muoveva a nord, verso Himera, tanto che l’intero territorio compreso tra i due corsi d’acqua ricadeva sotto il dominio della polis. Le ragioni di tale interesse erano essenzialmente tre: motivi di politica interna, commerciali/economici e di politica estera/espansionistica. In politica interna si voleva appagare ed acquisire sostenitori, guadagnare prestigio (ricordiamo, Falaride e Terone erano tiranni). Le ragioni economiche spaziavano invece dalla possibilità di intrattenere rapporti di scambio con l’entroterra indigeno alla possibilità di ottenere uno sbocco sul Tirreno, quindi ad aprirsi una via diretta al commercio con quelle popolazioni che abitavano ed effettuavano scambi nel mediterraneo nord occidentale, dall’Italia alla Spagna. La politica espansionistica di Akragas è un tema più articolato, difficile se non impossibile da riassumere in poche righe. Da un lato all’epoca di Falaride abbiamo la volontà di stabilizzare e consolidare i confini orientali (Gela) e quelli occidentali (Selinos), mirando al contempo ad “occupare” le zone interne indigene ed a contenere l’espansione punica nel nord ovest dell’isola (si pensi alle imprese del generale cartaginese Malco intorno alla metà del VI secolo a.C., ma abbiamo in merito poche notizie dato che “Cartago deleta est”). Dall’altro lato, una settantina di anni dopo, la politica di Terone è ancora tesa ad espandersi sulle stesse direttrici, ma l’alleanza politica prima e “di sangue” poi con Gelone gli garantirono la possibilità di occupare stabilmente Himera nel periodo in cui furono emesse le serie dette appunto di tipologia akragantina, nonché di infliggere la gravissima sconfitta all’esercito cartaginese di Amilcare nella battaglia di Himera del 480.2 punti
-
La mia passione numismatica è sbocciata meno di due anni fa e di iniziative di questo tipo, che aumentano e fomentano la mia voglia di numismatica solo a leggere il programma, ne ho viste veramente poche... quindi, nel mio piccolo, posso solo dire, GRAZIE! Iniziativa stupenda. Purtroppo per motivi logistici non mi sarà possibile partecipare, quindi ci provo : sarebbe potenzialmente possibile trasmettere il workshop in streaming? ? Capisco perfettamente che lo spirito dell'evento sia proprio quello di riportare le persone in presenza e quindi in caso di risposta negativa alla mia richiesta non potrei che essere d'accordo (anche se dispiaciuto) con gli organizzatori. Però magari una versione registrata e mandata in differita potrebbe essere un giusto compromesso.. Saluti!2 punti
-
Vorrei ora parlare un po' di Cavallotti. Come spesso succede su varie monete sabaude, anche su questa tipologia vi è un po' di confusione nei testi e nei cataloghi, anche negli ultimi. Tralasciando quelli del primo tipo del 1587 su cui c'è poco da dire, vorrei approfondire un po' il discorso per quanto riguarda le altre tipologie. Questi Cavallotti, o pezzi da tre Grossi, si iniziarono a coniare quasi un quarto di secolo dopo quelli del primo tipo e subirono una notevole svalutazione, i primi coniati ad una bontà di 3,1 denari, questi successivi ad una bontà di 2 denari fino ad arrivare a quelli del 1628 a 1,12 denari. Anche il peso diminuisce notevolmente, i primi tagliati a 82 pezzi al Marco e i seguenti a 96, 118 o 120 pezzi al Marco. Il Cudazzo sul suo nuovo testo inserisce un tipo nuovo di Cavallotto, sempre con la data 1587, classificandolo come secondo tipo, è comunque un primo tipo con una variante nella leggenda. L'altra tipologia, indicata sul Cudazzo al 751 del terzo tipo e sul Mir come secondo tipo, è quella con nulla ai lati dello scudo e una V fra le gambe del cavallo. Questa dovrebbe essere spostata, come periodo di coniazione, dopo l'altra tipologia, quella con i nodi ai lati dello scudo, perché le date segnalate del 1608 e del 1610 sono probabilmente degli errori di lettura o degli errori di coniazione e queste monete dovrebbero seguire l'ordinanza del dicembre 1618 per Vercelli come sono le due date, 1618 e 1619, che si possono trovare sui pezzi rintracciati. L'ordinanza per Vercelli del dicembre 1610 ha probabilmente portato la coniazione dei cavallotti con i nodi ai lati dello scudo con la scritta VERCEIL in esergo sotto al cavallo. L’altra tipologia, quella con i nodi, dovrebbe essere la prima che si è tornati a produrre, infatti si possono trovare date che vanno dal 1610 al 1616, è segnalato un esemplare datato 1619, ma potrebbe essere una errata lettura. Un'ordinanza successiva dell'ottobre 1628 ne fa riprendere la coniazione con una netta svalutazione come già detto. A Giugno 1630, causa peste, la zecca di Vercelli venne spostata a Santhià, dove dovevano essere coniati altri cavallotti, ma questo non è certo che abbia avuto luogo, anche se l'esemplare presente sul nostro catalogo datato 1630 potrebbe essere uno di questi. Infine esiste l'ultima tipologia coniata a Torino, quella con i rosoni ai lati dello scudo, con date 1618, 1619 e 1620, questa ultima data inedita inserita dal Cudazzo nella sua ultima pubblicazione, per questo tipo viene segnalata come zecca di produzione anche Vercelli, per un esemplare con una V fra le gambe del cavallo, ma il Traina segnala una errata lettura per questa moneta, essendo questa del tipo senza rosoni ai lati dello scudo. So che sono stato prolisso e forse poco chiaro, ma non è facile spiegare alcuni errori che si ripetono sempre in questa complicata monetazione sabauda, anche perché per le monete “grosse" e importanti c'e più interesse di chiarezza, mentre le monete "piccole" suscitano meno interesse… ma ho voluto provare a fare qualcosa che rimanga.2 punti
-
Nella mia vita ho collezionato un po' di tutto, sono partito dai francobolli e dalle banconote italiane e mondiali, poi ho girovagato tra monete di ogni epoca e territorio, infine ho scelto di dedicarmi in maniera quasi esclusiva ai libri di numismatica e storia monetaria... mi è mancato solo un ambito, le medaglie... fino adesso...qualche settimana fa ho avuto un colpo di fulmine per una bella medaglia papale di Paolo V e non ho resistito, eccomi quindi affetto da una nuova micidiale malattia, insieme alla libridine pure la medaglite, povere le mie tasche ?1 punto
-
DE GREGE EPICURI Il CCNM organizza la prima conferenza in presenza nella nuova sede di via Kramer 32, a Milano in Porta Venezia (al piano-terra in fondo al cortile a destra; citofono SEIDIPIU). La sede è raggiungibile con MM1 (fermate di Palestro o Porta Venezia),con i tram 5 e 9 e con gli autobus: 56,61,62,81,90 e 92. Inoltre coi treni S1,S5 ed S6. Si terrà martedì 19 ottobre alle 20.45; occorreranno green-pass e mascherina, e rispetto del distanziamento. Dopo mesi e mesi di video-conferenze, abbiamo pensato che fosse l'ora di vedersi anche di persona. In futuro forse saremo in grado di associare anche il video, ma per il momento abbiamo problemi tecnici. Il tema trattato dal prof. A.Cavagna è quello già proposto e poi rinviato lo scorso anno: "Un viaggio a Taranto nel 1911". Ernest Babelon, allora direttore del Cabinet des Médailles di Parigi, racconta che il 22 giugno 1911 a Borgo Nuovo di Taranto sarebbe venuto alla luce un grande ripostiglio di monete che, subito dopo la scoperta, venne diviso in tre lotti e immesso sul mercato antiquario. Un noto collezionista di origini greche, Michail Vlastos, riuscì ad acquistarne in breve tempo un primo lotto e, seguendo le vicissitudini dei restanti due, potè incorporare altre 100 monete nella sua collezione. L'ultima porzione (318 pezzi) venne invece dispersa in altre vendite. Sembra che il ripostiglio comprendesse un insieme apparentemente incongruo di emissioni da diverse aree mediterranee, accanto ad argento in lingotti ed in frammenti.1 punto
-
Ho voluto scrivere di quest'asta perché ho notato parecchie monete interessanti andate invendute e mi è parso strano.E' l'ultima ACM 20/21 Esempio alcuni Carlini molto particolari non ancora censiti (forse è stato questo il motivo) ed in alta conservazione. C'è un 1850 che ha sicuramente la Testa diversa ,altre teste e barbe diverse,anni particolari ribattuti su altri precedenti non recensiti,delle piastre sempre del periodo e non e parecchi tondelli del 600/700.......alcune anche se con prezzi alti sono andate via ma altre sono rimaste. Forse troppo alti i prezzi di partenza,se avessi potuto ne avrei prese un po ma almeno una l'ho presa e spero che in mano sia meglio della foto dell'asta. Un 1848 8 su 7 dovrebbe essere del 7° tipo ma sembra una via di mezzo fra il 6° e il 7°,forse un po caro ma visto che al momento non risulta recensito da nessuno e con la data a cavallo dei due tipi con la conservazione alta......... Al momento ho solo le foto dell'asta:1 punto
-
Salve sono Roberto il nipote del Cav. Uff. Walter Bisca. Se posso esservi utile1 punto
-
Annosa questione quella dei "30 pezzi d'argento", ma sempre affascinante. Parlando di sicli ho sempre ritenuto più probabile che i trenta pezzi d'argento fossero mezzi sicli piuttosto che sicli, in quanto il mezzo siclo era "il taglio" preciso della tassa del tempio, come riportato in Esodo 30:12-13 "Quando per il censimento farai la rassegna degli Israeliti, ciascuno di essi pagherà al Signore il riscatto della sua vita all'atto del censimento, perché non li colpisca un flagello in occasione del loro censimento. Chiunque verrà sottoposto al censimento, pagherà un mezzo siclo, computato secondo il siclo del santuario, il siclo di venti ghera. Questo mezzo siclo sarà un'offerta prelevata in onore del Signore."1 punto
-
Io penso che la coda fosse un punzone a parte, quindi se veniva poco impressa, come nel secondo dei tre casi che hai postato, non si vedeva. Oppure per fretta, era un dettaglio che si "saltava". Io ne ho una del 1858 con la coda che parte dalla schiena.1 punto
-
Ciao la cera microcristalina se applicata abbondantemente e non pulita fa quell'effetto. Esperienza personale. Silvio1 punto
-
Ricordo bene quello splendido ed interessantissimo incontro con la Prof.ssa Travaini, speo di poter replicare anche questa volta. Volevo comunque esprimere i miei complimenti a @dabbene per l'impegno nella divulgazione numismatica e per l'organizzazione di questo nuovo evento, che sia il primo di molti altri, per riuscire a rilanciare la numismatica in presenza e non solo in maniera virtuale, come purtroppo siamo stati costretti nel recente passato. ? ? ?1 punto
-
Ciao Beppe. Come sai non seguo Ferd II e qui qualcuno storcerà il naso ma non mi piace la sua monetazione...mi piace invece la dedizione con cui voi approfondite, scrutate e osservate maniacalmente le sue monete, cosa che io faccio con altre Detto questo ti dico la mia, da semplice "osservatore" : non è che quello che vedi come la minzione del leone non è altro che la quarta gamba mal impressa? La zampa staccata dal polpaccio leonino? Dico questo confrontando le foto da te postate. Se ho detto na strunz...ata perdonatemi ma mi andava di partecipare. Un caro saluto. Cristiano.1 punto
-
Ciao a tutti, ho scoperto che le 2 lire di Murat hanno avatar diversi oltre ai puntini. Mi scusi, ci sono due stampini per l'avatar di questa moneta d'argento? Uno grande, uno piccolo? Si prega di ignorare la scatola di plastica. Ho appena trovato questa differenza interessante. Cordiali saluti, MA Tianyi1 punto
-
1 punto
-
Concordo assolutamente. Il 3 grana è molto più ostico da trovare in buona conservazione rispetto al “grana 3” (e direi anche il 2 grana). Considerando la tipologia, dunque, il tuo esemplare è in uno stato di conservazione più che rispettoso e fai bene a ritenerti soddisfatto dell’acquisto fatto. Difficile trovare di meglio, e non solo da un punto di vista economico ma proprio come reperibilità sul mercato. Complimenti, quindi, per aver aggiunto un altro bel pezzo alla tua collezione di nominali in rame di Murat!1 punto
-
Buongiorno, @Asclepiabel capello il nostro Murat, complimenti, già dalle foto si vede un bel ritratto, e anche nella sua interezza è una moneta di tutto rispetto. Immagino che dal vivo ti Lustrerai gli occhi. ? Saluti Alberto1 punto
-
Forse anche su quest'altra pubblicazione, più recente, dovrebbe esserci:1 punto
-
1 punto
-
@Asclepia , le foto, secondo me non le rendono onore: dal vivo deve essere spettacolare! Complimenti per questa new entry!1 punto
-
Giulio S.V. 1521, Camerlengo Armellini, Roma. La Prima Moneta di Sede Vacante con i 2 Santi . Daniele1 punto
-
1 punto
-
Non conoscevo la filosofia di Stirner. Per come la descrivi qui brevemente la trovo molto interessante (e, oltretutto, realista). Comunque ben vengano tutte le proposte.1 punto
-
Ciao! L'armonia dei cittadini è la felicità della repubblica. Credo - ipotesi personalissima - che l'allegoria rappresentata debba intendere che la Repubblica (impersonata come in tante altre occasioni dalla donna assisa in trono e vestita con gli attributi rebubblicani di Venezia) si compiace che il popolo è felice; come rappresentare questa felicità? Circondando anonime bandiere (vedo due cuspidi delle quali una riporta in cima un globo, non credo veneziane perché mancanti del leone) di rami d'ulivo ( rappresentanti la pace) ed alla base il libro delle Leggi, alle quali tutti sono sottoposti. Di conseguenza penso che il globo sia un diverso modo di rappresentare il puntale che, questa volta, non è a punta. saluti luciano1 punto
-
E' possibile anche che non sia cera d'api ma un altro mix ceroso. Alcune volte questo tipo di trattamento viene fatto su monete che presentano zone di aggregati "salini" come quelli della foto (bianchi) che hanno attaccato e sono legati con la patina. La protezione con la cera impedisce all'acqua di attivare reazioni secondarie che possono corrodere la patina e farla "staccare" dal corpo della moneta. Infatti dalla foto si vede chiaramente che la cera è applicata su tutta la moneta , ma è rimasta amorfa e non lucida nelle zone dove ha "fatto presa" in maniera più consistente, ovvero nelle parti con residui di sedimento, tutta la zona a dx della figura stante e zona dei caratteri sul dritto (Faust......) per spiegarmi meglio.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Anche a me è successo di trovare monete in bronzo completamente incerate…doveva essere una pratica antica visto che la cera era frammista a sporcizia. Credo anch’io che si tratti di cera d’api, ed è insolubile sia in acetone puro che in trielina. Io l’ho rimossa con stuzzicadenti e tanta pazienza.1 punto
-
1 punto
-
Buonasera a tutti. Publica Filippo IV 1622 PVBL/ICA/°/COMMO/DITAS Ex Inasta 06 ottobre 2020 Collezione Litra Peso g. 13,26 Diametro 29,00mm CNI 154 Saluti Alberto1 punto
-
Stati Uniti, esseri umani presenti 23mila anni fa: trovate le impronte che riscrivono la storia Gli esseri umani erano presenti in America già 23mila anni fa: lo dimostrano alcune impronte di piedi appena scoperte in Nuovo Messico. Si tratta della più antica traccia della presenza umana nel continente e dimostra che qualcuno viveva lì già prima dell’ultima Era Glaciale. A fare questa scoperta sono stati i ricercatori della Bournemouth University, in collaborazione con lo US Geological Survey. Le impronte in questione sono state trovate all’interno del Parco Nazionale di White Sands, nel Nuovo Messico. Le impronte sono state lasciate nel fango morbido sul fondo di un lago, dove poi si sono solidificate e conservate per tutti questi millenni, intrappolando al loro interno anche semi di piante primitive. La cristallizzazione delle impronte - poi giunte fino a noi - è avvenuta anche grazie alla glaciazione del lago dovuta al periodo di intenso freddo. "Le nostre datazioni dei semi antichi sono molto precise e dimostrano una stratificazione dei semi appartenenti ad epoche storiche diverse all’interno di una stessa impronta – ha spiegato Kathleen Springer della US Geological Survey. – L’analisi al radiocarbonio ha permesso di datarle". Si tratta di una scoperta straordinaria. Finora, infatti, si è sempre pensato che gli insediamenti umani più antichi nel continente americano risalissero a circa 16mila anni fa. Gli archeologi ritenevano improbabile la presenza dell’uomo prima di questo periodo. La recente scoperta, invece, dice il contrario. Le impronte trovate sono di vario tipo: ci sono quelle umane, ma anche quelle di alcune specie animali come uccelli, mammut e lupi. Questo fa pensare a un’interazione fra esseri umani, animali e anche ambiente naturale. "Possiamo ipotizzare che i nostri antenati erano pragmatici, dediti alla caccia e all’adozione di strategie di sopravvivenza, ma ciò che vediamo attraverso queste impronte è un’attività di gioco che coinvolge individui di età diverse - ha spiegato il professore Matthew Bennett -. Un vero e proprio spaccato nella vita quotidiana dell’epoca". https://www.liberoquotidiano.it/news/scienze-tech/28815443/stati-uniti-esseri-umani-presenti-23mila-anni-fa-trovate-impronte-riscrivono-storia.html1 punto
-
1 punto
-
Taglio: 2 euro Nazione: Lituania Anno: 2020 Tiratura: 5.000.000 Condizioni: BB+ Città: Milano Note: NEWS!!!1 punto
-
1 punto
-
@Ledzeppelin81 Ciao Angelo, non conosco questa Medaglia, ma sicuramente non è antica. La sua composizione è quanto mai generica, non reca né date né scritte ma solo lo stemma dei Medici e il Giglio fiorentino : non è stata coniata per commemorare alcun evento specifico ma solo per ricordare Firenze, un gadget turistico o qualcosa del genere. Non è neppure una medaglia/omnibus, in quanto non reca alcuno spazio per incidervi date e nomi. Sulla datazione non è facile attribuirle una data precisa, potrebbe risalire anche a diversi anni addietro, ma sono certo che antica non è. Quanto al metallo impiegato, impossibile esprimersi guardando solo una fotografia : può trattarsi di una lega bianca, come l'alpacca, oppure di bronzo argentato ma fosse anche d'argento cambierebbe poco..... Non è un oggetto di cattivo gusto, va conservato. Buona serata.1 punto
-
Vi ricordo anche gli articoli del Gazzettino #8 in distribuzione gratuita il sabato 16 ottobre:1 punto
-
Lodevole l’iniziativa. Dispiace tremendamente che viene fatta in contemporanea al convegno di Venezia. Già pubblicato da un bel pezzo sul portale e già presente da qualche anno sempre al terzo sabato di ottobre Per l’ennesima volta non ci si riesce a coordinare…1 punto
-
Floriano Marco Annio Floriano (in latino Marcus Annius Florianus, nato a Terni nell'Agosto 232 e morto a Tarso nell'agosto 276) è stato un imperatore romano. Floriano nasce a Terni nel 232 ed era, probabilmente, il fratellastro di Tacito, fu da questi nominato prefetto del pretorio e, nel 276, si recò con l'imperatore in Asia Minore, per combattere i Goti. Dopo la vittoria sui Goti, Tacito intendeva tornare in Occidente, lasciando il controllo delle operazioni a Floriano, ma fu assassinato a Tyana nel giugno 276. Floriano si proclamò allora imperatore ottenendo il riconoscimento in Asia Minore e in Occidente; molto presto, però, gli si schierò contro Marco Aurelio Probo, il quale comandava l'esercito siriano o quello egiziano (o entrambi); allora Floriano smise di inseguire verso nord gli Eruli e portò l'esercito verso la Cilicia per affrontare Probo. Floriano aveva l'esercito più numeroso ma Probo era un comandante più capace e riuscì ad evitare l'ingaggio. Nell'agosto del 276 a Tarso (in Turchia), mentre i due eserciti si preparavano allo scontro decisivo, Floriano fu assassinato prima della battaglia da una spia. Aveva regnato per soli 88 giorni. Ricoprì un consolato, probabilmente nel 276. (Liberamente tratto da Wikipedia) Riporta l'Historia Augusta: "Costui era fratello germano di Tacito e si impadronì dell’impero dopo il fratello, non con l’autorizzazione del senato, ma di sua propria iniziativa, quasi che l’impero fosse ereditario, pur sapendo che Tacito aveva giurato in senato che, quando fosse arrivato in punto di morte, avrebbe lasciato l’impero non ai suoi figli, ma ad un qualche personaggio di valore. Tenne dunque l’impero per meno di due mesi e fu ucciso a Tarso dai soldati che avevano sentito la notizia dell’elezione a imperatore di Probo da parte di tutto l’esercito; dal canto suo Probo era tanto valente in campo militare, che il senato lo volle, i soldati lo elessero, e il popolo romano lo richiese a gran voce. Floriano cercò anche di imitare i costumi del fratello, non tuttavia sotto ogni aspetto. Ché il suo economo fratello gli rimproverava la prodigalità, e questa sua stessa brama di potere dimostra che egli era di ben diverso stampo da lui. Da una stessa famiglia, dunque, uscirono due principi, dei quali l’uno regnò sei mesi, l’altro appena due, come, in un certo modo, due interré fra Aureliano e Probo." (Historia Augusta, Tacito, 14, 1-5) Floriano (276-276) Valore nominale: Antoniniano Zecca: Cyzicus (Misia) Officina: Anno: Maggio-giugno 276 Diritto: . IMP FLORIANVS AVG (Imperator Florianus Augustus) . Busto radiato, drappeggiato e corazzato a destra visto di 3/4 davanti Rovescio: . CONCORDIA MILITVM (Concordia Militum) . La Vittoria a sinistra, tiene i mano un ramo di palma e porge una corona all'imperatore, a sinistra, che porta uno scettro Campo: Esergo: T Conservazione: Rarita': R1 Metallo: Billone Peso: 3.76 gr Diametro: 24.00 mm Riferimenti/Link: RIC V-I Cyzicus 116, Cohen 15 Note: Il migliore dei miei 2 concordia militum di Floriano. Floriano, uno dei cosiddetti "imperatori minori", regnò per soli 88 giorni senza avere il tempo (o la capacità) di lasciare grandi tracce di se se non con molte, belle, monete. Ogni commento su moneta e imperatore è il benvenuto. Ave! Quintus1 punto
-
Archeologia, scoperti i confini del regno di Micene narrati da Omero Conclusa le decima campagna di scavi nella necropoli della Trapezà di Eghion a cura degli archeologi dell’Università di Udine Una scoperta che potrebbe contribuire a disegnare i confini del regno di Micene nel Peloponneso della tarda età del bronzo, che risulterebbero parzialmente coincidenti proprio con quelli suggeriti da Omero nell’Iliade. Si tratta del rinvenimento di tre spade, di fogge caratteristiche delle produzioni micenee palaziali, databili nell’ambito del XIV secolo a.C., ovvero nel periodo di pieno fulgore dei palazzi micenei di Micene, Tirinto e Pilo. I manufatti sono stati messi in luce dagli archeologi dell’Università di Udine, coordinati da Elisabetta Borgna, nello scorso mese di agosto, durante la decima campagna annuale di scavo della necropoli della Trapezà di Eghion in Acaia, nel Peloponneso occidentale, dove il gruppo udinese collabora dal 2010 a un più ampio progetto del Ministero greco della cultura. Rinvenute durante l’indagine di una delle tombe apparentemente più semplici e modeste, le spade molto probabilmente erano appartenute ad altrettanti guerrieri residenti in una comunità situata sulle propaggini montane dell’Acaia orientale, da cui si controllavano il centro di Eghion, la pianura costiera e il mar di Corinto. Le scoperte di quest’anno si aggiungono a quella delle scorse campagne, quando l’indagine di un’altra tomba – la tomba 6, assai più ampia e profonda – ha portato alla luce ricchi corredi di ceramica e gioielli, nonché di un deposito di oggetti in bronzo che comprendeva una monumentale cuspide di lancia da parata, preliminarmente interpretata come dotazione di una figura particolare - un ufficiale, sovrintendente o governatore locale - legato all’autorità centrale di Micene. Lo scorso agosto gli archeologi hanno condotto inoltre indagini nell’antico villaggio individuato nel 2015 qualche centinaia di metri più a sud della necropoli. Fondato in età pre-micenea, verso l’inizio del II millennio a.C., l’abitato ebbe lunga durata. Quest’anno è stato riportato alla luce un imponente edificio con focolare centrale del tipo a “megaron”, caratteristico dell’architettura micenea. All’indagine sul campo presso la Trapezà, il gruppo di ricerca dell’Ateneo di Udine è invitato a collaborare dal direttore del museo di Eghion, Andreas Vordos, nell’ambito di un ampio progetto del Servizio Archeologico greco per il Ministero greco della cultura nell’area archeologica dell’antica città di Rhypes. Le campagne avviate nel 2010 e concentrate dal 2012 sui contesti funerari - un nucleo di tombe a camera scavate nella sabbia coesa del substrato di un pendio collinare - sono supportate, oltre che dall’Ateneo di Udine, dal Ministero italiano degli Affari esteri e dall’Institute for Aegean Prehistory di Philadelphia. Il valore storico della scoperta delle armi nella necropoli Il sistema politico-sociale ed economico dei regni micenei era rigidamente centralizzato e dunque certi beni strategici come le armi avevano circolazione controllata e accesso limitato. "Prodotte nelle officine centrali - spiega Elisabetta Borgna -, esse erano conservate nei magazzini palaziali ed erano per lo più distribuite all’occorrenza agli uomini chiamati alle armi o erano detenute da guerrieri e ufficiali con ruoli specifici nell’ambito dell’amministrazione palatina. È dunque raro che durante la piena età palaziale, ossia quando era più efficiente e rigoroso il sistema di controllo dei palazzi, nelle tombe, e in particolare in quelle appartenenti a necropoli periferiche, venissero deposte delle armi; quando avveniva, queste ultime erano certamente incaricate di esprimere indicazioni rilevanti sullo status e sul ruolo dei defunti". L’individuazione, dunque, di un gruppo di guerrieri micenei nella necropoli achea in corso di indagine è un fatto molto significativo per la ricostruzione storica dei confini politici del regno miceneo nella tarda età del bronzo. "Questa presenza – evidenzia Borgna – sembra costituire una conferma a quanto racconta Omero nel secondo libro dell’Iliade, quando, nel celebre Catalogo delle Navi, quantifica la potenza militare degli Achei impegnati nella spedizione a Troia elencando i comandanti e la provenienza dei contingenti. Il poeta greco riferisce che Agamennone in persona, re di Micene, avrebbe guidato da condottiero cento navi di guerrieri, reclutati, oltre che nei territori immediatamente circostanti al palazzo di Micene, in Argolide e Corinzia, anche nella periferica Eghialia, ossia la porzione orientale dell’Acaia intorno ad Eghion, sede di vari insediamenti di cui più tardi ci avrebbe parlato Pausania". In particolare, accennando a “coloro che abitavano intorno ad Eghion” "le parole di Omero – conclude Borgna - fanno riferimento a comunità in grado di fornire risorse in termini di seguito e forza militare per grandi iniziative come quella della leggendaria guerra di Troia che il poeta si apprestava a celebrare. Le tracce ora rinvenute di quei guerrieri micenei che nel vasto Peloponneso servirono la potente organizzazione militare dei palazzi rappresentano dunque forse il nucleo storico di una realtà trasposta in leggenda ed evocata dal racconto epico". Le indagini nel sito dell’antico villaggio Il megaron, a pianta rettangolare regolare, generalmente tripartito e con portico antistante, era un modello planimetrico-strutturale caratteristico dell’architettura micenea, e in particolare del nucleo dei palazzi in cui si svolgeva la vita di corte, che ospitava la sala del trono. Era caratterizzato dalla presenza di un grande focolare centrale, che, interpretando il passaggio dall’autorità familiare in sede domestica a quella pubblica nella sede cerimoniale e istituzionale, rappresentava, in veste monumentale, il simbolo del potere miceneo. L’edificio con impianto a “megaron” della Trapezà di Eghion – risalente agli inizi della civiltà micenea (XVII sec a.C. circa), e dunque precedente alla fondazione dei palazzi – può essere confrontato con alcune strutture coeve, interpretate in altri insediamenti come dimore di gruppi emergenti a livello locale. Il focolare era costruito su imponenti fondazioni in grosse pietre, era delimitato da grandi ciottoli e allestito con un’articolata serie di stesure di ghiaia e ciottoli su cui poggiavano piastre di argilla da cottura. "Una complessità – sottolinea Borgna - che sembra la premessa del fiorente sviluppo dei secoli successivi, così ben documentato dalla necropoli. Le dinamiche di crescita, evoluzione ed estensione dell’abitato e il rapporto tra questo e la vicina necropoli sono tra gli affascinanti aspetti ancora da chiarire". https://www.ilfriuli.it/articolo/tendenze/archeologia-scoperti-i-confini-del-regno-di-micene-narrati-da-omero/13/2516141 punto
-
I famosi 30 denari di Giuda sono appunto i sicli di tiro ... Anche se ci son pareri non sempre concordi alcuni dicono che tramite studi si risale a quei sicli altri dicono sia solo un'operazione commerciale ... Sicuramente non erano monete romane in quanto raffiguravano l'imperatore o gli Dei e in quanto monete pagane non potevano essere accettate per il tesoro del tempio ma doveva essere cambiate prima di versare la tassa al tempio1 punto
-
Sono d'accordo con te, le commemorative si potevano includere... La mia scelta è ricaduta sulle seguenti: 1° Posto: 2 Lire Spiga 2° Posto: 5 Lire Uva 3° Posto: 50 Lire Vulcano 1° Tipo1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?