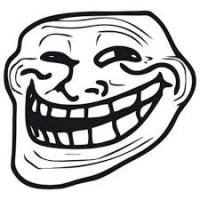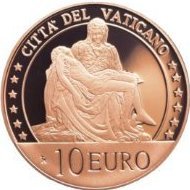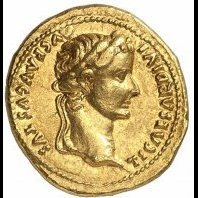Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 11/24/21 in tutte le aree
-
Buongiorno amici . Riporto su la discussione postando l'ultima arrivata in collezione Asclepia. Un tombino di quasi 31 grammi. Difetti al bordo e qualche debolezza ma in conservazione di tutto rispetto per la monetazione. Ho altri due 10 grani del 15 in collezione, entrambi con il punto dopo 10, questo esemplare ne è privo ( variante indicata anche nel Gigante mi sembra). Inoltre sempre confrontando noto che la coda della cornucopia che sfiora la G di Grani è più corta rispetto agli altri esemplari che ho in collezione (vedi foto del particolare). Ecco la moneta. Spero gradiate. Trovo i 10 grani tra i nominali più belli del periodo, la loro imponenza, il ritratto con corona radiata, il loro richiamo al classicismo li trovo irresistibili!! Saluti. Cristiano.6 punti
-
Buonasera a tutti! Mi sembrava d ' obbligo postar qui un nuovo arrivo,un' altra 34,questa volta , " torretta verticale". Saluti a tutti5 punti
-
Bellissima monetina, con un livello di conservazione veramente difficile da trovare. Il difetto sul bordo è peraltro piuttosto comune nelle monete di questo periodo e, come scrivi, dovuto all'operazione di fustellatura eseguita dopo la coniatura e quindi legato allo stato di zecca. Va fatto notare che lo stato di conservazione va sempre valutato dal verso, proprio perché, come conseguenza dell'operazione di fustellatura, il dritto risulta essere sempre concavo e quindi più protetto dalle ingiurie della circolazione, mentre il verso, convesso, è sempre il più usurato. Io ho un paio di mezzi bolognini con il verso quasi completamente liscio e il dritto con caratteri, seppur usurati, ancora perfettamente definiti. Ora la caccia è aperta per il sesino con ritratto!... ovviamente quello con il ritratto vòlto a destra... che quello rivolto a sinistra, fino a prova contraria, resta il frutto di un errore tipografico... ciao Mario4 punti
-
Un orrore serio, nel senso che la monetina non è stata deturpata per un motivo banale o per divertimento, ma per utilizzarla come pesetto da 1 grammo penso negli anni '10/'20, sono presenti vari punzoni di controllo.3 punti
-
Segnalo l'uscita del n. 120 di Monete Antiche Questo l'indice: Un cavaliere campano-sannita su un didramma di Neapolis. (Antonio Morello) [3-25] Il denario di L. Staius Murcus (RRC 510/1): un esemplare con aquila estense e alcuni aggiornamenti. (Alberto Campana) [26-32] Vita, sorte e monete di Marco Antonio. (Luca Arnaudo) [33-43] ANASTATICA, inserto di letteratura numismatica. Giuseppe Ruotolo, Scritti scelti di Numismatica. (a cura di Luca Lombardi) Dionysos nella monetazione antica. (Giuseppe Ruotolo)2 punti
-
Nel comune piemontese di Mergozzo, in località Montorfano si trova la piccola interessante chiesa romanica dedicata a S. Giovanni Battista, costruzione in blocchi di granito in unica navata con pianta a croce latina, realizzata verso il XI sec. Scavi archeologici nella ed attorno alla chiesa hanno portato alla luce resti di un preesistente complesso paleocristiano probabilmente del V-VI sec. e di una basilica a 3 absidi di epoca carolingia del VII-VIII sec. All' interno dell' attuale chiesa è conservata parte di un fonte battesimale del VI sec. ed all' esterno fondamenta del preesistente complesso basilicale, con sepolcreti di epoca romana ed altomedievale .2 punti
-
@Litra68 mi hai fatto venire voglia di postare le mie... In attesa dell'elenco tuo ?2 punti
-
Grazie @niko per i complimenti! @mariov60 quello che dici è assolutamente vero, infatti anche i dettagli del rovescio di questa moneta mi hanno sorpreso non poco! Per quanto riguarda il sesino con ritratto... è già in collezione!? Non ha la conservazione del Mezzo Bolognino, però è piacevole, sopratutto al rovescio mentre il dritto ha qualche difetto in più... e la foto non aiuta ad esaltarlo. Tra l'altro anche su questa monetina sembra presente traccia della fustellatura. Chissà che un giorno non salti veramente fuori anche quello con busto rivolto a sinistra... anche se anch'io sono propenso a credere che non esista. Cioso.2 punti
-
Gettone della Wisconsin Brewery di Ch. Bast a Milwaukee, nel Wisconsin. Su una faccia è raffigurato un barile di birra e sull’altra la stella con un boccale di birra all’interno come nell’insegna della Zoigl in Baviera. Il 1863 è uno degli anni della guerra civile che avvenne nel periodo tra il 1861 e il 1864, quando i cosiddetti gettoni della guerra civile furono coniati e distribuiti privatamente negli Stati Uniti per sopperire alla scarsità di centesimi emessi dal governo.2 punti
-
In 41 anni non mi è mai capitato. Tuttavia rimpiango i tempi, quando non c'era internet, che si andava al convegno e lì, sorpresa, trovavi un pezzo per la tua collezione. Emozione pura. Ora sfogli migliaia di pezzi, trovi quello che ti interessa, spesso devi attendere settimane per l'asta, poi, quando riesci a prenderlo, devi pagare, aspettare che te lo spediscano, aspettare ancora e quando ti arriva è ovvio che un po' di entusiasmo è sparito... Arka Diligite iustitiam2 punti
-
2 punti
-
2 punti
-
2 punti
-
Bene! Con ciò direi che abbiamo concluso tutta la parte relativa alla descrizione del quadro storico. Mi auguro di non avervi tediato troppo ma, personalmente, ritengo che la Storia sia un elemento fondamentale in numismatica. Senza conoscere la Storia, non credo si riesca ad apprezzare veramente le monete (o medaglie, come in questo caso) che collezioniamo. A me, comunque, ha fatto piacere scriverlo. Spero che a voi abbia fatto piacere leggerlo ? Veniamo ora, finalmente, alla tanto attesa medaglia. Al dritto troviamo la testa laureata di Napoleone rivolta verso destra. Alla base del collo notiamo la firma dell’incisore Andrieu. Al rovescio, invece, abbiamo un’elaborata rappresentazione in pieno stile neoclassico. Al centro della raffigurazione troviamo Ercole con pelle di leone e clava nella mano, colto nell’atto di sferrare il colpo fatale ad un gigante steso a terra che si ripara con uno scudo. A destra abbiamo la Vittoria alata con ramo di palma in mano e pronta ad incoronare con l’alloro il vincitore. In basso nell’esergo: Bataille de Wagram - VI Juillet MDCCCIX (6 luglio 1809), con firme di Galle e Denon. Si tratta di una medaglia discretamente rara, soprattutto in argento ed in alta conservazione. L’esemplare da me aggiudicato, che assicuro essere poco valorizzato dalle mie pessime qualità fotografiche, presenta al dritto una bella patina omogenea da vecchia collezione, mentre al rovescio ha mantenuto ancora una buona percentuale del lustro del metallo. Da apprezzare anche la quasi totale assenza di colpetti, segnetti sui campi e tacche, tutti elementi congeniti che purtroppo affliggono spesso le medaglie napoleoniche anche in alta conservazione. Credo di aver detto, bene o male, tutto quello che volevo scrivere su questa medaglia. Perciò, vi lascio ora alle foto, curioso di sentire qualche vostro commento (e sulla Storia di questo pezzo e sulla medaglia in sé). Grazie a tutti per l'attenzione.2 punti
-
1 punto
-
Buonasera a tutti, oggi voglio presentarvi una monetina della zecca di Modena, coniata sotto il duca Rinaldo d'Este nella prima parte del 1700. Si tratta di un Mezzo Bolognino, moneta classificata Non Comune, un nominale quindi non introvabile, ma che spesso lascia a desiderare in quanto a conservazione (come la maggior parte delle monete di Modena). In questo caso però vi presento la classica eccezione che conferma la regola! Ho infatti avuto la fortuna di trovare questo Mezzo Bolognino in conservazione nettamente superiore alla media, non parliamo di un FDC ma probabilmente ci avviciniamo allo Splendido. I rilievi sono ancora tutti intatti ed i fondi quasi completamente freschi, i capelli del duca presentano una leggerissima usura, mentre l'unica pecca è rappresentata dalla mancanza sul bordo del tondello, dovuta però alla fustellatrice, possiamo quindi definirlo un difetto di 'zecca'. Che cosa ne dite? Vi piace? Grazie per l'attenzione! Cioso.1 punto
-
Medaglia devozionale, bronzo/ottone, ovale orizzontale con piolini ad ore 3,6,9. - primo quarto del XVII sec.- D/ S. Agostino e S. Monica.- R/S. Nicola da Tolentino e S. Carlo Borromeo, in alto colomba (Spirito Santo), medaglietta rara.- Ciao Borgho1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Questa è la stadera bizantina più grande rivenuta in occidente ,serviva a pesare le merci sulle navi ,arrivava fino al quintale ,il suo "romano" ,così si chiamano i pesi cursori , pesa 10 kg e 500. N.b . Il tuo peso non è relativo a questa tipologia di pesa ma più probabilmente a una a doppio piatto.1 punto
-
1 punto
-
I presupposti per l'autenticità ci sono tutti. saluti TIBERIVS1 punto
-
Grazie per il messaggio Mariov, ti leggo sempre con piacere. Avrei una domanda: su un modulo del genere la concavità è accentuata/gioca un ruolo importante? N.1 punto
-
Avevamo fatto alcuni paragoni qui se ricordi: Diciamo che un operaio o un tirocinante odierno che guadagna 900 euro vuol dire che guadagna 30 Euro al giorno, magari però una volta al mese se appassionato potrebbe anche cedere alla tentazione di sacrificare i proventi di una giornata lavorativa per andare al teatro. Si vero, ma è oggi che la consideriamo una cosa normale, ma per i fabbisogni quotidiani di allora poteva essere considerato uno spreco enorme per un operaio.1 punto
-
1 punto
-
Quando si parla di potere di acquisto diventa difficile rapportarlo tra periodi così lontani. Post unificazione il salario di un operaio era dai 50 centesimi a poco di piú di una lira al giorno. Quindi, assumendo come corretta la rivalutazione, dai 2 ai 4 EUR al giorno. Oggi direi che saresti ampiamente sotto la soglia della povertà. Però immagino che il rapporto di costi tra i vari beni fosse molto diverso da oggi.1 punto
-
Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno letto ed apprezzato questo mio piccolo contributo, lasciando un commento positivo e/o un “mi piace”. Fa sempre piacere veder apprezzato un proprio lavoro, soprattutto quando per realizzarlo è stato necessario impiegare diverse ore di tempo tra scrittura, raccolta del materiale, ricerca delle immagini, ecc. Ovviamente, tutto ciò l’ho fatto esclusivamente per amore per la Storia, la numismatica e la loro divulgazione.1 punto
-
1 punto
-
Splendia medaglia, inquadrata nel contesto storico del tempo : da me che sono un appassionato di Storia, complimenti e saluti cordiali !1 punto
-
Beh, io manco lo stesso! ? Non so se mi ricorderò del termine dialettale, ma di certo non dimenticherò che il significato di cirri non è solo riferibile ad un genere di nuvole ?1 punto
-
Buongiorno a tutti, rispetto la tua decisione di come intendi classificare, però ciò non toglie che si continui con l'analisi e le ricerche. Osservavo la scritta X P E in entrambi gli esemplari, quello che mi colpisce : Carattere X diverso da P ed E, osservate rilievi dorso. Si potrebbe pensare ad una schiacciatura ? Ma poi solo lei? Potremmo pensare che non sia una X di Xilofono ma una Croce? Oppure un valore X 10? Moneta di Fantasia ? Copia ? Tessera ? Oppure una moneta non ancora avvistata ? Abbiamo fatto tante supposizioni, a me personalmente stuzzica ancora alla ricerca. Saluti Alberto1 punto
-
Da Byblos di Fenicia, su uno shekel in argento del 365-350 a.C., abbiamo una nave da battaglia con i marines in armi pronti allo sbarco . L' esemplare, di grande conservazione, passerà ad inizio Dicembre in asta Rauch 113 al n. 119 .1 punto
-
Le Rimesse venivano fatte in tre copie, una per la Banca emittente, una per il beneficiario e una per la Banca che doveva pagare il beneficiario. Essendo, noi italiani, un popolo migratore le rimesse che sono giunte a noi spaziano dall'America (nord e sud), Australia, Cina e, praticamente, tutti continenti. È ancora una collezione di nicchia, ma già su uno dei bellissimi libri di Franco Gavello ci sono moltissime foto e valutazioni dei gradi di rarità.1 punto
-
Mi permetto di segnalare il sito, con innumevoli chicche: https://www.complianceturin.it/ Buona serata piergi001 punto
-
Stessa descrizione ma un diverso valore da quello già presentato (1.000 dracme) Seconda guerra mondiale Occupazione italiana delle Isole Jonie - 500 dracme del 19411 punto
-
Purtroppo non conosco questa emissione. Il giglio accantonato alla croce mi fa pensare alle autorità che usavano questo simbolo, Francia in primis. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
Mollale, lasciale stare, falle sentire inutili....senza valore, disprezzale per il tempo ed i soldi che ti hanno "rubato", urlagli in faccia quello che pensi e quello che vuoi...poi chiudile con disprezzo dove non vorrebbero stare, con calma e delicatezza sussuragli " ci rivedremo.....a presto" sbattendogli il cassetto/porta in faccia.....e vattene. Prendi tempo sono periodi difficili, attendi tempi nuovi, il nuovo anno magari e poi...vedrai...strisceranno ai tuoi piedi ed alla fine le perdonerai e tornerai da loro. Prendi tempo, per te.1 punto
-
http://www.circolocastellani.org/numismatica-romana/index al link sopra è visibile la collezione di medagliette votive recentemente esposta a Fano da Circolo castellani.1 punto
-
Seconda guerra mondiale Campagna di Francia Banconota francese da 1.000 franchi in uso durante l'invasione nazista. La campagna di Francia inizia a maggio del 1940 con l'invasione tedesca del Belgio, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e con la successiva avanzata della Wehrmacht all'interno della Francia. Il 10 giugno del 1940 l'Italia dichiara guerra alla Francia, il 14 giugno Parigi venne occupata dalle truppe tedesche. Dopo quattro anni iniziò la campagna di liberazione della Francia dal regime nazista con lo sbarco in Normandia (giugno 1944). Il 7 maggio 1945 a Reims, in Francia, al quartier generale degli Alleati due alti ufficiali del comando supremo delle forze armate tedesche firmarono la resa incondizionata, entrambi furono condannati a morte al processo di Norimberga e giustiziati nel 1946. La Francia fu inclusa a pieno titolo tra le potenze vincitrici n virtù del costante sforzo militare antitedesco sostenuto. ps: al solito cliccare sopra le immagini per ingrandire.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Buona sera, allego un foglietto trovato in un vecchio libro in discarica probabilmente appartenuto ad un appassionato di numismatica, peccato che non ci fosse la moneta, diametro circa 25 mm., secondo voi era un grosso? Grazie1 punto
-
Bellissima panoramica di iconografiè e capolavori di incisioni..... Anche nella tipologia delle Sedi Vacanti, spesso monotone per le consuete "CHIAVI DECUSSATE SORMONTATE DAL PADIGLIONE" trova un posto questa discussione, e probabilmente una delle scene più suggestive rappresentate nei coni Vaticani: SEDE VACANTE 1590 Testone e Quadrupla (stesso conio) L'angelo che libera S.Pietro dalla gabbia, dipinto di Rafaello1 punto
-
L'epoca delle bellissime illustrazioni di edifici romani si chiuse con la mezza piastra di Benedetto XIV,in cui viene raffigurato l'ospedale S.Spirito in Sassia,nel Rione Borgo.Questo ospedale, ancora esistente e funzionante, fu costruito ,in queste forme,da Sisto IV ,verso la fine del Quattrocento, ma venne restaurato e potenziato proprio da Benedetto XIV. Successivamente a questa rarissima emissione,il compito di ricordare restauri o nuove edificazioni,passò all'arte della medaglia.1 punto
-
Nell’esaminare una moneta gli appassionati ed i professionisti del settore hanno un grande alleato l’INGRANDITORE. L’idea di creare un post su questo argomento è nata ascoltando alcuni commenti di collezionisti, quasi tutti riguardanti il potere di ingrandimento della lente usata, del tipo “la mia ingrandisce 30 volte!”, dicitura che si trova spesso sulle confezioni di lenti di produzione cinese o sul supporto che contiene la lente stessa, con l’obbiettivo di chiarire le idee su tale argomento. Ho volutamente usato il termine generico INGRANDITORE per indicare uno strumento che permetta l’ingrandimento dell’immagine di una moneta, in quanto abbiamo a nostra disposizione diversi tipi di questo strumento dai più semplici a quelli complessi. Il post sarà articolato in più parti (per una questione di peso delle immagini) e nel seguente modo: 1. I tipi di lenti 2. Le aberrazioni 3. Lenti semplici e composte 4. Luminosità della lente - Trattamento antiriflesso 5. Il potere d’ingrandimento 6. Il microscopio 7. Quale tipo di ingranditore usare in numismatica? 8. Quale lente acquistare? 1- I tipi di lenti Le tipologie di lenti ottiche sono due: divergenti o negative convergenti o positive. Le lenti negative rimpiccoliscono l’immagine e quindi per le nostre finalità si utilizzano le lenti positive. Le tipologie di lenti positive sono tre (fig. 1): · piano convessa (presenta un lato piano ed uno convesso); · convessa (presenta i due lati convessi, con diverse curvature, detta “asferica”); · biconvessa (presenta i due lati convessi, con una stessa curvatura). 2- Le aberrazioni Tutte le immagini che passano da un mezzo ottico meno denso (aria) ad un mezzo ottico più denso (vetro ottico, policarbonato ottico) subiscono delle alterazioni sia per quanto concerne la planarità dell’immagine, sia per quanto riguarda i colori -frange di colore ai bordi- (aberrazioni cromatiche). Se utilizzate una lente piano convessa per osservare un foglio a quadretti, potrete notare che l’immagine si presenta con i lati dei quadretti concavi (aberrazione a cuscino), mentre se utilizzate una lente convessa, i lati si presentano concavi (aberrazione a barilotto) -fig. 2-. Per evitare, parzialmente, queste alterazioni di planarità dell’immagine si deve utilizzare una lente, biconvessa, che, come abbiamo visto, presenta due diverse curvature dei suoi lati, detta “asferica”. 3- Lenti semplici e lenti complesse Le aberrazioni prese in esame nel punto precedente riguardano le lenti semplici (lente singola) ed allora per eliminare completamente queste alterazioni dell’immagine vengono realizzate le così dette “lenti complesse”. Le lenti complesse sono realizzate tramite l’accoppiamento di due lenti positive, generalmente due lenti piano convesse o due lenti biconvesse. (fig.3) fig.3 Queste lenti, dette “doppiette”, risolvono il problema della planarità, e vengono definite “aplanatiche”, ma non risolvono le aberrazioni cromatiche. Per eliminare queste ultime, è necessario interporre tra due lenti positive, una lente negativa, costituendo una “tripletta”, definita “aplanatica e acromatica”. (fig. 4). fig. 4 In commercio si trovano svariati tipi di lenti complesse, anche alcune che permettono di ottenere diverse tipologie di ingrandimento (fig. 5-5a). 4- Luminosità di una lente complessa - Trattamento antiriflesso L’assemblaggio di più lenti migliora la qualità dell’immagine dal punto di vista di planarità e cromaticità, ma diminuisce più o meno sensibilmente la luminosità della lente. La luminosità della lente è determinata dalla quantità di raggi luminosi che attraversano il complesso ottico ed è un fattore da valutare in funzione del suo utilizzo. Per ovviare a questo inconveniente i costruttori di lenti complesse, per alcuni prodotti, utilizzano dei trattamenti antiriflesso che fanno sì che possano passare il maggior numero di raggi luminosi possibili (fig. 6). Questo trattamento, che può essere “mono strato” o “multi strato” si può riconoscere osservando le lenti che presentano una leggera tonalità violetta (figg. 7-7a). Ovviamente le lenti che presentano queste caratteristiche hanno un costo decisamente superiore a quelle non trattate.1 punto
-
8- Quale lente acquistare? Spesso e volentieri quando è il momento di acquistare una lente di ingrandimento la soluzione più utilizzata è quella di andare sui vari siti web e acquistare quella più conveniente economicamente. Questa scelta porta ad avere, tranne alcune eccezioni, uno strumento che non risolve le problematiche, esposte in precedenza, con il rischio di crearci anche qualche problema alla viste se lo strumento è usato con frequenza. La nostra attività di analisti nel settore diamanti, prima di iniziare lo stesso percorso per le monete, ha sicuramente influito sulle scelte strumentali, ma sugli strumenti è sempre opportuno adottare il detto “chi più spende meglio spende”. Qui di seguito indico marche di lenti professionali, che come tali hanno costi abbastanza elevati, ma sia per la qualità ottica sia per quella costruttiva, sono strumenti che dureranno per tutta la vita, unitamente al alcune lenti più economiche che però hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione. Intanto iniziamo a dire che le lenti possono essere costruite sia in cristallo ottico sia in policarbonato ottico. Ambedue i materiali possono essere trattati con i processi antiriflesso. Le lenti in cristallo ottico, generalmente subiscono anche un trattamento antigraffio, cosa che non accade per quelle in policarbonato. Questo fa sì che le prime hanno un costo decisamente più elevato rispetto alle seconde. Due parole sulle lenti di produzione cinese di basso prezzo. Sono realizzate con vetro non ottico, quindi presentano molti difetti, dalle piccole bolle alle tensioni interne, e quindi veramente di scarsa qualità e l’utilizzo a lungo andare può creare qualche problema alla vista. Detto questo diamo un elenco delle lenti di qualità ed i relativi prezzi di mercato: Zeiss D 36 (fig.11): 3X+6X per avere 9X, aplanatica e acromatica 120-150€ Eschenbach 3+6=9 (fig.12): 3X+6X aplanatica e acromatica 190-210€ Bausch & Lomb (fg.13) 5X asferica in policarbonato ottico 20-30€ Bausch & Lomb (fig.14) 4X in cristallo ottico 20-30€ Per le 10X: Bausch & Lomb (fig.15) 10X tripletta aplanatica e acromatica 50-60€ Belomo (fig.16) 10X aplanatica 50-60€ Nikon (fig.17)10X aplanatica 80-90€ Zeiss D40 (fig.18): 10X aplanatica e acromatica 90-120€ Schneider (fig.19): 10X aplanatica e acromatica 180€ Per le cinesi posso consigliare due lenti munite di illuminatore LED, molto comode nei convegni, dove l’illuminazione è sempre problematica; non conoscendo la marca alleghiamo solo le foto. La prima (fig.20-20a) è una 4X diametro 35 mm che permette l’osservazione dell’intera superficie di una moneta anche di grande modulo. L’altra (fig.21) è una 10X di buona qualità con lenti in vetro ottico ed un illuminatore circolare molto utile. Costi: 2-8€ la prima, 30€ la seconda. In questo panorama, non voglio trascurare le lenti di produzione russa degli anni ’70-‘80, che sono manufatti di alta qualità ottica e ancora si possono reperire a prezzi molto contenuti. Qui di seguito alcune foto di questi prodotti (fig.22>26). Conclusioni Credo di aver fornito un quadro abbastanza completo delle caratteristiche degli ingranditori, comunque rimaniamo a disposizione per chi volesse ulteriori approfondimenti sull’argomento, o chi avesse difficoltà di reperimento. Grazie per l’attenzione1 punto
-
5- Il potere d’ingrandimento di una lente Argomento delizia e cruccio degli utilizzatori! Determinare con precisione il potere di ingrandimento (PI) di una lente, è cosa abbastanza difficoltosa, ma c’è un metodo che permette di avere un risultato apprezzabile, senza dover ricorrere a formule complesse. Misurate, in millimetri, la distanza di messa a fuoco che corrisponde alla “lunghezza focale” (LF) della lente che state utilizzando (fig. 8). Dividete 200 con la misura che avete verificato e otterrete il potere di ingrandimento (approssimativo) della vostra lente. Es.: LF=20 mm PI= 200/20= 10X; LF=50 mm PI= 200/50= 4X Da questi esempi si può capire che maggiore è il PI, minore è la LF, quindi quando leggete su una lente (spesso avviene su prodotti cinesi!) 30X o 40X, quanto dovrebbe essere la LF? Basta fare 200/30X=DF 6,666 mm o 200/40X=DF 5 mm, che significa che dovreste tenere la lente a una distanza di 6,5 mm o 5 mm dall’oggetto, cosa che manualmente è praticamente impossibile! Con le lenti manuali si possono raggiungere al massimo i 20X (LF= 10 mm) e bisogna fare un bell’allenamento per utilizzarle, anche perché presentano un campo visivo alquanto ridotto. 6- Il microscopio Il microscopio è un ingranditore complesso, costituito da un sistema di lenti che permette di arrivare anche ad altissimi ingrandimenti, mantenendo planarità e assenza di aberrazioni cromatiche. Ne esistono diverse tipologie in funzione degli esami che si devono eseguire. Per l’utilizzo in campo numismatico, sia per la verifica di genuinità di monete antiche sia per operazioni di restauro, il più indicato è il “microscopio stereoscopico”, che permette una visione tridimensionale della moneta. Di questo tipo ne esistono due versioni con diversi sistemi ottici (fig. 9) In alcuni casi è necessario utilizzare anche un altro tipo di microscopio, il “microscopio metallografico” che permette di esaminare la superfice del metallo eseguendo osservazioni specifiche ad alti ingrandimenti, con un sistema di illuminazione particolare come si può vedere dalle figg. 10 e 10a. 7- Quale tipo di ingranditore usare in numismatica? Girando per convegni, spesso, abbiamo notato che sia collezionisti che operatori, per verificare lo stato di conservazione di una moneta, spesso utilizzano lenti da 10X, che riteniamo non adeguate a tale scopo. Se teniamo conto che tali tipi di lenti vengono utilizzate come standard internazionale nel grading dei diamanti dove è necessario individuare i più piccoli difetti, va da sé che tale strumento non è adatto per il grading numismatico, pena incappare in un giudizio completamente sbagliato, valutando difetti del metallo che in realtà tali non sono. Per tale attività riteniamo che le lenti più adatte sono quelle con un potere d’ingrandimento 4-5X, che dovrebbe essere adottato come standard operativo, in maniera che tutti noi sapremmo vedere i difetti allo stesso modo. Tale potenza d’ingrandimento permette di stabilire la maggiore o minore visibilità di un difetto, permettendo allo stesso tempo la completa visione della moneta in esame. L’utilizzo di una lente 10X va riservata per l’esame dei particolari che permettono di stabilire la genuinità di una moneta quando non si ha a disposizione un microscopio. Per chi si dedica al restauro monetale, invece, è assolutamente necessario utilizzare il microscopio stereoscopico con un adeguato illuminatore. Fine seconda parte1 punto
-
Di fronte all'importanza della questione e a scanso di inutili equivoci o dietrologie, mi sono permesso di chiedere direttamente alla Bertolami tutte le informazioni. Ecco quanto mi hanno riferito. - Dopo essere venuta a conoscenza della collezione (di proprietà di una famiglia calabrese), la Bertolami ha provveduto ad organizzare la procedura di rito: venne spedita dai proprietari una raccomandata con ricevuta di ritorno alla Soprintendenza della Calabria, nella quale si informava la stessa dell'intenzione di spostare tale collezione a Palazzo Caetani Lovatelli al fine di una vendita pubblica all'asta. La soprintendenza dopo 60 giorni non ha risposto (silenzio assenso), quindi la collezione è stata portata a Roma, dove poi è stata fotografata, messa in sicurezza allarmata, adeguatamente protetta in cassetti di legno rivestiti di velluto, infine schedata. Sulla scheda pubblicata nel sito (e sul catalogo cartaceo) si troverà ogni moneta numerata (con riferimento puntale alla fotografia), e sono disponibili schede con peso, diametro, asse di conio e bibliografia di riferimento di ciascun esemplare. Di fatto quindi la collezione è in Italia (adesso a Roma in Palazzo Caetani Lovatelli), e per legge non può essere venduta fuori dai confini nazionali, né ulteriormente spostata senza prima avvisare la Soprintendenza competente. Tutta questa faccenda pertanto è stata concepita nel pieno rispetto della normativa vigente. - La riserva è alta (150.000 E) e attualmente in Italia solo un museo pubblico (diritto di prelazione da parte dello Stato) o una fondazione privata di un certo livello potrebbero permettersi un acquisto del genere. Tale riserva però si avvicina al valore dell'intero gruppo nel mercato internazionale (ca. 180.000 E). Si dovrebbe vedere alcuni esemplari dal vivo: per stile, conservazione e centratura, all'estero avrebbero comodamente raggiunto realizzi di 10-15.000 E cadauno. La Bertolami ha accettato l'affidamento ugualmente, con il rischio di avere una perdita garantita (costi di fotografia, lavorazione, catalogo, spedizione, pubblicità, etc...) al solo scopo di pubblicare tutte le monete, cosicchè da preservare il dato scientifico. In passato si era offerta di fare da tramite tra i proprietari e lo Stato: la Bertolami avrebbe finanziato in primis la pubblicazione di uno studio dedicato (tipo giornata di studi, con contributi di vari studiosi legati alla monetazione incusa magnogreca, seguita dalla stampa degli atti), e avrebbe fatto in modo che gli esemplari migliori e quelli inediti fossero donati alla Soprintendenza (a scelta della stessa, senza limite numerico), in cambio dello svincolo e della libera circolazione di quelli più comuni. Si trattava in effetti di una procedura innovativa e rivoluzionaria per l'Italia, che avrebbe preservato in futuro diversi contesti, e incrementato quel "sentire comune" che manca a molti nostri connazionali. La stessa procedura è adottata in Inghilterra dall'Arts Council in materia di ritrovamenti fortuiti: dopo lo studio e la pubblicazione i reperti monetali vengono messi in asta da Spink & Son, ed è provato che tale procedura nel 94% dei casi abbatte completamente la clandestinità. Ma la Bertolami ha trovato un muro non razionalmente giustificato da parte di una funzionaria... Beh, almeno ci ha provato. In ogni caso la coscienza resta pulita e serena, nella consapevolezza che il dato scientifico è preservato, fissato e definitivamente pubblicato. - Per quanto riguarda lo studio del ripostiglio (perchè di ripostiglio, inequivocabilmente, si tratta, almeno per buona parte), fu proposto di farlo studiare in anteprima ad una giovane collaboratrice esterna della Direzione generale Archeologia, che però non accettò per motivi di tempo. Ovviamente un membro della Bertolami aveva intenzione di pubblicare la collezione in futuro su qualche rivista scientifica dedicata (RIN o AIIN), con particolare attenzione alla questione legale italiana. In ogni caso esiste disponibilità a una collaborazione a più mani. In ogni modo ormai l'intero rispostiglio (fotografie e dati tecnici) è di dominio pubblico (manca solo il contesto di rinvenimento, del quale tuttavia non si sa nulla). Quindi adesso, grazie al lavoro spesso aprioristicamente sottovalutato di una casa d'aste italiana, questo patrimonio numismatico è finalmente di proprietà intellettuale della collettività, ergo chiunque può pubblicarlo scientificamente senza alcun limite. Devo ringraziare la Bertolami per avermi inviato queste informazioni, autorizzandomi a renderle pubbliche. Ovviamente si tratta di un argomento altamente interessante e delicato sul piano sia scientifico sia legale e potrebbe costituire un interessante precedente per trovare una soluzione al vecchio e irrisolto problema del materiale trovato in Italia ma completamente decontestualizzato. L'unica alternativa resta la completa clandestinità e fuoriuscita di monete delle quali magari conosciamo dopo la foto, ma nessuna altra informazione circa la sua associazione con altre monete trovate insieme, con perdita di tutte le informazioni di carattere scientifico, senza dimenticare che lo Stato resta comunque defraudato e senza nemmeno alcuna possibilità di scegliere con diritto di prelazione almeno gli esemplari che effettivamente e sigificativamente mancano nelle sue collezioni pubbliche.... Staremo a vedere.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?