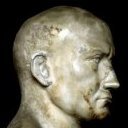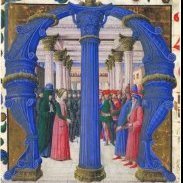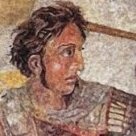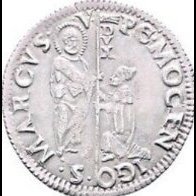Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 12/07/21 in tutte le aree
-
Ferdinando II 10 Tornesi 1840 Busto normale, Corona senza rigature e dicitura TORNESI stretta . Un caro saluto a tutti.6 punti
-
Per comprendere la Diana Ephesia e le sue relazioni con l’Artemide di Efeso credo si debba fare un passo indietro. Sappiamo che nel 356 a.C. il tempio arcaico andò nuovamente distrutto, questa volta a seguito dell’incendio perpetrato da Erostrato, secondo la tradizione nella stessa notte in cui nacque Alessandro Magno (Plut., Alex. 3, 5-6) il quale, come ci ricorda la tradizione, dopo la vittoria del Granico (334) visitò Efeso per offrire un contributo alla ricostruzione del tempio. Contributo che gli Efesini rifiutarono in modo alquanto “elegante” adducendo la motivazione secondo la quale “non spettava ad un dio ricostruire il tempio di un’altra divinità” (Strab. 14, 641). Alla realizzazione del nuovo Artemision, annoverato tra le sette meraviglie del mondo, di cui era la più imponente secondo Antipatro di Sidone (II-I sec. a.C.), parteciparono illustri artisti tra cui Skopas, che realizzò le sculture sulle colonne (Plin., NH 36, 95), e Prassitele, che secondo Strabone decorò l’altare. Sappiamo inoltre che il tempio godeva del diritto di asylia (Tac., Ann. 3, 61). Rilievo di un rocchio di colonna (columnae caelatae) del tempio tardo-classico, rinvenuto nei primi scavi ottocenteschi e conservato presso il British Museum di Londra (https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Artemide_(Efeso)#/media/File:Column_drum_Ephesus.JPG) A discapito del prestigio di cui il monumentale santuario dovette godere sin da tempi remotissimi, la statua di culto, fino almeno all’età ellenistica, sembrerebbe non proprio aderente ai canoni secondo i quali viene raffigurata sulle monete di età romana (dal II-I sec. a.C. e almeno fino a Gallieno) e sui medaglioni della provincia d'Asia di Claudio e di Adriano. In età romana si afferma infatti una nuova iconografia della divinità, cd. polymastos, che specie nel II sec. d.C. assumerà forme particolarmente barocche - come ben documentano le statue esposte nel museo di Selçuk postate - e che si caricherà di caratteri simbolici di particolare evidenza nella propaganda di Mitridate VI (88 a.C.). La diffusione dei culti orientali in età imperiale poi favorirà un’ampia circolazione di questa iconografia della dea (Diana Ephesia) in ampie porzioni dell’impero romano. Ma tornando all’immagine di culto primordiale, che si riteneva “caduta dal cielo”, sopravvissuta e custodita a discapito delle molteplici ricostruzioni del tempio, essa altro non era che uno xoanon, un cilindro di legno nero con parti aggiunte d'avorio e d'oro, rastremato in basso e con sembianze umane soltanto nella parte superiore del corpo. Lo avrebbe accertato autopticamente, in età neroniana, il governatore d’Asia Licinio Muciano secondo quanto riferito da Plinio (NH 16, 213): Maxime aeternam putant hebenum et cupressum cedrumque, claro de omnibus materiis iudicio in templo Ephesiae Dianae, utpote cum tota Asia extruente CXX annis peractum sit. convenit tectum eius esse e cedrinis trabibus. de simulacro ipso deae ambigitur. ceteri ex hebeno esse tradunt, Mucianus III cos. ex iis, qui proxime viso eo scripsere, vitigineum et numquam mutatum septies restituto templo…….[…..]. Che si trattasse di uno xoanon è peraltro suggerito dalla stessa fisionomia della statua anche in epoche più tarde, dove appare rigida e con parte posteriore liscia – simile alle mummie egizie - in quanto in origine era posizionata in senso verticale in modo da non poter cadere. Certo è che si trattava di un'immagine che rispondeva più ad esigenze cultuali che a preoccupazioni estetiche: l’immagine non brilla certamente per armonia scultorea ed è assente qualsiasi struttura plastica. Statuette in avorio rinvenute nel deposito di fondazione dell’Artemision di Efeso (da Akurgal, AJA 66/1962) Che gli elementi presenti sulla statua fossero seni, sacche scrotali di tori (forse ripieni di miele e offerti alla dea), uova di struzzo, ghiande o altro, essi simboleggiano in ogni caso una natura primordiale della dea riconducibile a quella della Gran Madre Cibele – che a sua volta ha origini remotissime e minoiche in particolare - signora della natura, della fertilità, degli animali (potnia theron), come documenta il corteggio di cervi, tori, leoni, grifoni, sfingi, api, sirene raffigurati nelle rigide squadrature dell’ependytes, che tuttavia sono creature originarie dell'Oriente e che rievocano i caratteri primordiali di una dea che, non dimentichiamolo, non è di origine greca e che “naturalizzava concetti più asiatici che greci” e che solo successivamente sarà assimilata dai Greci ad Artemide e, in progresso di tempo, alla Diana (Ephesia) dei Romani. Non a caso la tradizione pone il tempio di Diana sull’Aventino – divinità già venerata in epoca primordiale sul lago di Nemi come Diana Nemorensis - in stretta relazione con quello di Artemide ad Efeso. Al mondo della natura rimandano peraltro la collana con elementi fusiformi della dea da cui pendono ghiande e la ghirlanda di fiori e bacche. Le stesse protuberanze (seni?) non sono peculiari solo dell’Artemide efesia ma si ritrovano, ad esempio, quali elementi caratterizzanti del cd. Zeus di Labraunda. https://explore.psl.eu/fr/decouvrir/expositions-virtuelles/zeus-la-double-hache-le-sanctuaire-de-labraunda/les-cultes La stessa corona turrita che dà forma al polos, dettaglio che caratterizza una variante iconografia della statua di culto, costituisce un elemento non greco e simboleggia che la dea, come Cibele, sovrintendeva al benessere del suo popolo, così come le due Nikai spesso raffigurate sul pettorale. https://arachne.dainst.org/entity/1076312/image/5585618?fl=205 punti
-
Per le grandi transazioni sia in ambito internazionale che nazionale si usava ovunque ormai la carta, non solo banconote ma anche obbligazioni e buoni del tesoro, tuttavia l'uso di strumenti indiretti per il trasferimento di crediti risale già al medioevo, alle fiere di Champagne e allo sviluppo dei primi banchi in Italia e in Europa, trasportare grossi quantitativi di monete era problematico economicamente, pericoloso oltre che scomodo, ragion per cui si cercavano mezzi alternativi fin da quei secoli: compensazione dei debiti attraverso l'acquisto di merci e pagamento in moneta solo delle differenze, uso delle lettere di cambio con possibilità di girata e diffusione dei banchi con le loro filiali...ovviamente nel secondo ottocento con l'enorme sviluppo dell'economia e degli scambi tutto ciò raggiunse un progresso senza precedenti, enormi somme venivano scambiate in tempi molto rapidi da un capo all'altro del mondo, le monete auree e d'argento di maggior valore riposavano spesso nei caveau delle banche e la carta si muoveva al loro posto, naturalmente vi era anche circolazione effettiva delle monete per gli scambi più ridotti, quotidiani, l'uso della moneta d'oro e d'argento di grosso modulo divenne più consueto negli scambi grazie alla maggior produzione di questi metalli nel corso dell'ottocento, soprattutto l'oro, sempre piuttosto raro nei secoli passati, divenne molto più disponibile grazie alle scoperte di miniere in Siberia, Australia, California, Alaska e Sud Africa, questo permise la coniazione di un numero impressionante rispetto al passato di monete auree, anche di moduli prima assai inconsueti, però a circolare in maniera effettiva erano i pezzi intermedi, le sterline, i marenghi da 20 franchi e 20 lire, i pezzi da 10 e 20 marchi e da 20 e 10 corone... i massimi moduli erano molto più rari in circolazione, e non escluderei che anche nel loro caso vi fossero motivi di prestigio internazionale alla base della loro coniazione, evidentemente i tedeschi si accontentarono di un prestigio fatto di cose più concrete e meno appariscenti...5 punti
-
Il mio primo esemplare della Zecca di Trieste entrato in collezione. Trattasi di un esemplare da riferirsi al Vescovo Givardo (1199-1212): denaro con il nome GIVARDVS e tempietto, di cui posto due foto fatte da me (scusate il risultato!). Acquisito per le analogie con alcuni esemplari della Zecca di Aquileia in punto di tempietto e presenti in collezione. Saluti. Domenico4 punti
-
3 punti
-
3 punti
-
Non sono d'accordo. Anche se questa discussione andasse avanti per altri vent'anni sarebbe in ogni caso foriera di interessanti apporti conoscitivi. Tanto per fare un esempio sulla data di avvio della monetazione in Magna Grecia si discute da oltre mezzo secolo e non mi pare che le posizioni siano concordi (tutt'altro) né che si sia pervenuti a soluzioni certe. Punto secondo. Nessuno cerca di capovolgere in modo coatto l'attribuzione a Siracusa. Nel corso dei vari interventi sono emersi semplicemente alcuni elementi (tecnici, tipologici, ecc.) che appaiono piuttosto "atipici" nella produzione monetale siracusana e si è cercato di analizzarli ed eventualmente ricercare in via ipotetica familiarità con le emissioni di altri centri. Punto terzo. Anche se la moneta fosse stata emessa da Siracusa ad opera di maestranze non locali, la questione meriterebbe di essere approfondita più che essere liquidata sic et simpliciter perché "più logica". In particolare, se questa è la tua ipotesi (del tutto rispettabile), ti inviterei a collocare l'esemplare in esame all'interno della sequenza monetale siracusana proponendo un argomentato inquadramento cronologico ed un altrettanto commento esplicativo dei tipi visto che di siracusano hanno ben poco, tanto che non verranno più ripresi per motivi ignoti (e non necessariamente "politici" come tu affermi). Bisognerebbe infatti spiegare la valenza politica della personificazione di un fiume (presunto Alpheios) e dei due chicchi d'orzo e il motivo (sempre politico) per il quale restarono isolati nella coniazione della città. Punto quarto. La colonizzazione greca ha riguardato sia la Sicilia che la Magna Grecia ma non dimentichiamo che la maggiorparte delle colonie comincia ad emettere moneta in un periodo alquanto distante dalla data di fondazione. Siracusa ad esempio, tanto per restare in tema, viene fondata come Crotone alla fine dell'VIII secolo a.C. ma la monetazione prende avvio due secoli dopo quando ormai alcune tradizioni coloniali delle origini erano state ampiamente sedimentate ed autonomamente rielaborate. Per la moneta di Sibari ad esempio, che è ritenuta la più antica della Magna Grecia, pur essendo stati rilevati dei punti di contatto sia con l'elettro di Mileto sia con le più antiche serie di Corinto, essa resta comunque per caratteristiche tecniche e tipologiche il prodotto di maestranze greche locali che avevano raggiunto un altissimo livello nella lavorazione del metallo. Punto quinto. La moneta di Gela non costituisce un esempio calzante in quanto il toro andrprosopo, anche se di stile differente, è comunque tipo costante delle emissioni. Per Camarina è vero che l'esemplare postato resta un unicum però almeno un confronto lo trova con la moneta di Temesa con elmo/tripode tra due schinieri e leg. TEM, come fu peraltro ben evidenziato quasi quarant'anni fa dalla Caccamo Caltabiano che di recente ha attualizzato le considerazioni dell'epoca. Queste considerazioni, lungi dall'alimentare un "negazionismo", vogliono solo invitare ad una più attenta riflessione. E' probabile che il tetra con l'Alpheios (?) sia destinato a rimanere ancora per lungo tempo oggetto di ipotesi diverse ma ognuna di queste ipotesi deve essere argomentata in modo ampio e convincente.3 punti
-
Ciao Vedo solo ora questa richiesta. Si tratta di un sesino (??) ad imitazione della trillina di Milano per Carlo V. La moneta in oggetto è piuttosto controversa ma generalmente identificata, appunto come sesino (??) emesso dalla zecca di Correggio. di seguito lo screen shot della vendita 51 di Nomisma, lotto 1314. ciao Mario3 punti
-
buongiorno ho una domanda da porre che, pur riguardando la monetazione europea dell'800, e pertanto attinente alle discussioni "monete contemporanee estere", ricopre un aspetto più economico che numismatico, e quindi ritengo possa essere più generalista, e per questo ho scelto la sezione "piazzetta". Avessi sbagliato chiedo venia e non mi risentirò se verrà spostata. La questione riguarda le coniazioni europee auree dell'800: premetto che il mio interesse numismatico è incentrato solo su questo periodo (in particolare sul centenario che va dal congresso di Vienna alla fine della prima guerra mondiale). Questo per svariati motivi: finalmente la tecnologia permise la coniazione di monete ben fatte, il secolo in questione è stato ricchissimo di fermenti sociali, artistici e tecnologici (ormai tutti concordano sulla nascita nell'800 della cosiddetta seconda rivoluzione industriale), culturalmente mi sento ancora in grado di immedesimarmi in quel secolo, mentre fatico a farlo per periodi anteriori ed ho un certo fastidio per il secolo in cui sono nato, quando penso ai tanti errori che l'umanità ha commesso in quegli anni (ma questa non è più una questione numismatica, per cui sorvolo). Vengo al sodo: essendo l'800 il secolo per eccellenza del bimetallismo, pressochè ogni stato coniò grandi monete d'oro: i 100 franchi francesi, le 100 lire italiane. le 5 sterline inglesi e così via. Mi sono dilettato a conteggiare i quantitativi coniati dai vari paesi, e riporto qui i dati da me desunti: Francia 28,471 tonnellate d'oro in monete da 100 franchi Italia 9,923 tonnellate in monete da 80/100 lire Regno Unito 4,869 tonnellate in monete da 5 sterline Austria 1,929 tonnellate in monete da 100 corone non ho avuto il coraggio di fare gli stessi conteggi relativamente alle coniazioni USA di monete da 20 dollari: tale quantità essendo stata di gran lunga troppo superiore all'intera produzione europea, e allora mi sono fermato. Mi pare ragionevole pensare che la notevole produzione di tali monete fosse spiegata dall'esigenza di far fronte all'incrementato scambio di beni internazionale, non penso proprio che tale quantità venisse prodotta solo per questioni di immagine e di prestigio nazionale: ne sarebbero bastate molte meno (penso alle coniazioni post guerra mondiale di VEIII). E la Germania? La Germania, dopo la proclamazione dell'impero, visse uno sviluppo economico ed industriale senza pari: il reddito nazionale raddoppiava ogni 15 anni, la popolazione aveva smesso di emigrare alla ricerca di maggior benessere ed anzi la nazione soffriva la carenza di mano d'opera; "in pochi decenni la Germania avrebbe conquistato la superiorità in Europa" (da: Mario Silvestri "la decadenza dell'Europa occidentale"). Dirò di più, riportando uno scritto del maresciallo Foch (che non fu certo un estimatore della Germania): Dopo tanta prolusione la domanda numismatica la Germania quindi era ricca, se non ancora la più ricca d'Europa, era destinata ad esserlo a breve: perchè allora non coniò mai grosse monete auree? La sua moneta di maggiori dimensioni, il 20 marchi, era poco più grande del marengo (7,965 grammi contro 6,45) e con un marengo non si acquistavano certo grandi cose: secondo i coefficenti Istat 1 marengo dell'800 corrisponderebbe a circa 96 Euro attuali; mi rendo conto che questa conversione lascia il tempo che trova, diverse essendo le esigenze e i tenori di vita di allora confrontati con quelli di oggi, ma risulta comunque pacifico che acquistare una casa nell'800 tramite piccole monete non era agevole, bisognava mettersi a contarne centinaia! Direte che la spiegazione si trova nell'uso di banconote? Ma se si usavano banconote in Germania si sarebbero dovute usare anche altrove, no? E allora perchè coniare? E comunque la banconota dell'800 garantiva la conversione in oro, per cui siamo al punto di prima, l'oro serviva ancora e, se in quantità ragguardevoli, necessitava di monete di grosso taglio. Un'altra spiegazione potrebbe trovarsi nell'azione bismarckiana, che abbandonò la politica del libero scambio, barricandosi dietro una trincea protezionistica. "Se non abbiamo bisogno di inertfacciarci economicamente con l'estero, nemmeno abbiamo bisogno di grandi monete; per i consumi interni bastano le piccole." Non so, di politica economica ne so ben poco per darmi una risposta, ed è per questo che pubblico la mia curiosità, sperando di sentire opinioni più illuminate dei miei flebili tentativi di comprensione del fenomeno. Grazie2 punti
-
Nel mito degli Elleni, Iolao è figlio di Ificlo e re, in Tessaglia, della piccola città di Filace . Sposato da un giorno con Laodamia, figlia del re di Iolco, per onorare il giuramento reso assieme ai pretendenti ad Elena, raggiunge in Aulide l' esercito degli Achei e con questi conduce le sue 40 navi verso Troia . Approdati alla spiaggia di Troia, nessuno degli Achei sbarca poichè è noto un oracolo che profetizza che il primo di loro che metterà piede a terra sarà ucciso . Iolao balza per primo dalla propria nave e corre alla battaglia contro i Troiani, sarà ucciso forse da Ettore e la guerra di Troia potrà avere inizio : dal suo gesto, Iolao diviene 'il primo a saltare', ovvero Protesilao . Ade e Persefone concederanno a Protesilao di lasciare per un giorno gli Inferi per poter rivedere una ultima volta la sposa Laodamia . In epoca storica, Protesilao è eroe onorato ed oggetto di culto nella Tracia ed in Tessaglia dove, nella città di Filace, esisteva un antico santuario a lui dedicato . Circostanza poco comune nella monetazione greca, l' eroe Protesilao è raffigurato su rari tetradrammi di Skione che ne riportano la testa elmata con il suo nome inciso sulla cresta dell' elmo : Tebe di Tessaglia, vicina a Filace, si ritiene ne rappresenti, su emidrammi di epoca ellenistica, il momento della discesa in armi dalla nave .2 punti
-
Ciao ragazzi proseguendo nella carrellata di tentativi fotografici più o meno maldestri, Vi presento una rarità del Re Numismatico, il mitico Littore venti lire anno V, moneta già condivisa in passato, ma per la quale mi piace sottoporre oggi nuove immagini volte a una particolare valorizzazione della patina. Sono convinto come molti altri che di queste monete in giro ci siano più dei cento esemplari indicati nei cataloghi visto che compare frequentemente. Ma qui si tratta di apprezzarne la colorazione più che la conservazione e la rarità, che comunque hanno sempre il loro perché. Cari saluti2 punti
-
Bello e molto interessante, un non comune denario per Pompeo il grande , da zecca itinerante . Passerà a Gennaio in asta New York Sale LIV al n. 1712 punti
-
un tempo molti grandi collezionisti applicavano contromarche, nel caso della collezione d'Este oserei dire che accresce il valore storico della moneta piuttosto che deturparla..2 punti
-
Una gradevole, curiosa frazione, propone al rovescio la figurazione della ninfa Larissa che, seduta su una hydria, parrebbe scalciare una palla . Passerà ad inizio Gennaio in asta CNG Triton XXV al n. 177 .2 punti
-
@Ross14 la tua domanda mi ha spinto a rileggere tutto quello che ho sul periodo, visto che giustamente Marco Terenzio Varrone non poteva fare il proquestore al seguito delle armate di Pompeo, trovandosi da tutt’altra parte. Crawford glissa, preferendo concentrarsi sull’iconografia. Riporto invece il passaggio di D. Sear, dal ricco volume sulla monetazione imperatoriale, che attribuisce l’emissione ad un non meglio identificato figlio di Varrone medesimo, sul quale nulla ho trovato.2 punti
-
Buongiorno ragazzi! La mia napoletana di oggi… ultima arrivata ? Comune, comunissima… Ma mi piace comunque tanto!2 punti
-
2 punti
-
Ho fatto un altra foto e penso che tu abbia ragione, Silvio. La data sarebbe bene 1610!2 punti
-
Dico che a quel prezzo la prenderei subito subito? Non é una valutazione reale. Il catalogo che ho menzionato sopra la colloca a circa 200... Io mi sono fatto un elenco delle monete che incontro spesso nelle ciotole. Per queste monete scrivo se vi sono eventuali errori, varianti o curiosità, non si sa mai ?2 punti
-
Per condividere con gli appassionati anche di storia. Venezia - Pasquale Cicogna (1585-1595) Medaglia 1593 realizzata per la costruzione del forte di Palmanova - Voltolina 691 - AE - gr. 20,87 - Ø mm 45 Grading/Status: BB https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME35D/1211 punto
-
Buonasera a tutti, si inizia a respirare aria di festa, ma non una festa normale, la festa delle feste , il Santo Natale. Inevitabilmente vengono in mente i regali da fare, quelli che si piacerebbe ricevere. I ricordi dei Natali passati di quanto si era bambini. Ecco proprio ispirato da questo clima festoso, nonostante la pandemia, ho deciso di dare seguito a ciò che pensavo da tempo. Una nuova discussione, non troppo impegnativa, alla portata di tutti, senza distinzione di età e di gusti collezionistici. Leggo spesso discussioni dove esordiamo dicendo di avere trovato la tale moneta nel cassetto del nonno.? Allora mi sono chiesto...cosa mi sarebbe piaciuto trovare nel cassetto del Nonno. Io sarei stato felicissimo di trovare un bel Fiorino d'oro. Ne ho preso uno in prestito dal Web , da una vecchia asta Pandolfini del maggio 2019. FIRENZE COSIMO III DE’ MEDICI (1670-1723) FIORINO D’ORO 1719 Au gr. 3,48 Giglio e San Giovanni CNI 87 Gal. VI, 6 MIR 325/5 Pucci 118 Se vi fa piacere , scrivete cosa vi piacerebbe trovare nel Cassetto del Nonno. Saluti Alberto1 punto
-
Ecco l’esemplare in oggetto che presenta un peso di grammi 3,761. Provenienza : Asta NAC 108 (Ex collezioni De Lazara e Gavazzi). Alcune brevi info sul Doge (da https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Molin? Francesco Molin (Venezia, 21 aprile 1575 – Venezia, 27 febbraio 1655) fu il 99º doge della Repubblica di Venezia e rimase in carica fino alla morte. Venne eletto il 20 gennaio 1646. Durante tutto l'arco di tempo del suo dogado proseguì la guerra contro i Turchi per il possesso dell'isola di Creta (proseguita sino al 1669) e fu necessario reperire nuovi fondi "vendendo" l'accesso al patriziato veneto in cambio di 130.000 ducati a persona per poter sopportare le spese di guerra. Il doge che resse con incredibile capacità lo stato sino quasi alla fine dei suoi giorni, alla fine soccombette alla calcolosi, e morì attorno alle 13 del 27 febbraio 1655 (l'ora è stata riportata dallo storico Andrea Da Mosto). Le malelingue fecero notare che gran parte del “merito” della dipartita fu l'eccesso di vino, di cui il doge era noto bevitore tanto che, scherzosamente, la gente diceva di lui, usando il suo cognome: «L'è un Mulino, non da vento, non da acqua, ma da vino!» Saluti. Domenico1 punto
-
Che bomba @Oppiano, congratulazioni! E buon inizio di collezione col filone triestino!!!1 punto
-
Buonasera a tutti, mi piacciono molto gli 8 Tornesi di Ferdinando IV. Ne posto ripropongo uno che sta lentamente patinando....spero Sigle R.C. piccole se non sbaglio. Saluti Alberto1 punto
-
1 punto
-
Ciao! Qualche rilievo in meno rispetto alla precedente, ma tutto sommato più omogenea nella consunzione. saluti luciano1 punto
-
DE GREGE EPICURI Autentico anche per me. La "dextrarum iunctio" per Nerva è uno dei rovesci più comuni.1 punto
-
Mi permetto di modificare il titolo della discussione per darle la giusta importanza in seguito alla riattribuzione allo Steno.1 punto
-
A me non viene in mente nessuna assonanza con termini in italiano corrente! ? Seri certo che non sia stata proferita da un ubriacone? ? (si scherza ovviamente). Dico bravo fin d'ora a chi l'azzeccherà.1 punto
-
Buonasera a tutti, Mi piace il tuo 8 Tornesi, un po meno perché spatinato. Spero si scurisca con il tempo.1 punto
-
Googlando ho trovato questo: La contromarca “aquiletta” — Este Project Buona serata da Stilicho1 punto
-
@talpa la ringrazio per il contributo che dà per soddisfare la mia curiosità. Solo per amore del confronto, e non certo per polemica, mi permetta però di esporre le mie considerazioni, non sempre in accordo con quanto lei ha scritto. Lei scrive: Per le grandi transazioni sia in ambito internazionale che nazionale si usava ovunque ormai la carta Leggo in un libro del Cipolla quanto segue: sempre il Cipolla scrive, stavolta relativamente al tardo '400: " Buona parte dell'argento estratto dalle nuove miniere del Tirolo calò in Italia in cambio delle molte merci che l'Italia forniva allora al mercato tedesco .... è documentato che Milano e Venezia furono i due più importanti mercati per l'argento in Italia" Non so come fosse il rapporto metallo-carta nel resto d'Europa, ma non vedo perchè l'Italia dovesse comportarsi diversamente dagli altri stati; e nemmeno ritengo che la moneta metallica usata fosse solo di piccolo taglio (è chiaro che, dal prestinaio, non si andasse a far la spesa con una moneta da 100 lire, ma mi pare ragionevole pensare che tale moneta, per acquisti più impegnativi, fosse usata). Quanto invece succedeva nel '400 mi fa supporre che più di compravendita si trattasse di baratto: in ogni caso è evidente che di metallo si tratta, non di carta. i massimi moduli erano molto più rari in circolazione Sono d'accordo, la moneta da 100 lire veniva usata più raramente delle altre, ma non credo fosse così impegnativa per l'uso: teniamo conto che l'oro nell'800 valeva, in proporzione, molto meno di oggi (nell'800 il rapporto argento/oro era di 1/15, oggi è di 1/80) e che una moneta da 100 lire non rappresentava un capitale, ma solo un importo importante (se accettiamo come valido il potere d'acquisto del marengo pari a 96 Euro, 100 lire equivarrebbero a meno di 500 Euro. Non facciamoci confondere dal valore attuale di tale moneta, oggi pari al triplo del valore su ipotizzato) Veniamo all'impiego delle grandi monete d'oro per questioni di prestigio nazionale: Carlo Felice, nella prima parte del secolo, ha fatto coniare ben 232.700 monete da 80 lire (le 100 lire, come lei ben sa, non erano ancora in uso): non è un numero eccessivo di monete, se coniate solo per il prestigio di un piccolo (e povero) stato? Consideriamo la Francia: in un secolo ha coniato circa 883.000 monete da 100 franchi: anche in questo caso considero assolutamente sproporzionato il numero, se rapportato ad un impiego della moneta per il prestigio. Quindi, riassumendo, resto dell'opinione che le monete di grosso calibro avessero un impiego (ancorchè limitato) quali strumenti di pagamento; . resto quindi con la curiosità tedesca Grazie ancora e saluti gino1 punto
-
Almeno avevate avuto un cenere da cui partire, immagina con cendere?. comunque ho sentito entrambi.1 punto
-
Arrivata anche a me: mi hanno assegnato la 20€ Cu FS, avendo acquistato (seppur in seconda battuta, poiché non me l'avevano assegnata all'inizio) la 10€ dell'anno scorso, ottimo1 punto
-
Arrivata email per emissioni del 6/12 MONETA AUREA EURO 200 – 2021 3.498,00 MONETA 10 EURO AG E AU (FS) - 2021 89,00 MONETA 10 EURO AG E AU (FS) - 2021 - STRAORDINARIA 89,00 MONETA 5 EURO AG E AU (FS) - 2021 75,00 MONETA 20 EURO RAME (FS) - 2021 46,00 Totale, per chi acquista tutto: 3.805€ Buon Natale!1 punto
-
Buongiorno a tutti, ho trovato questo, come confronto: NERVA, 96-98 d.C., DENARIO, Emissione: 96 d.C., Zecca di Roma, Rif. bibl. R.I.C., 3; Cohen, 25/Fr.2; Metallo: AR, gr. 2,98, (MR7962), Diam.: mm. 17,92, mBB, (R) A prima vista, l'esemplare postato, a me, sembra genuino; piccole le deviazioni nei dati ponderali e diametro. Sentiamo anche ulteriori pareri. Cordiali saluti, M1 punto
-
Santino Zilli Varianti errori e curiosita' della Repubblica Italiana quarta edizione 2021-20221 punto
-
a mio avviso è una imitativa di fine V sec o molto più probabilmente di inizio VI secolo mi sembra di tratto orientale, ma questa è una sensazione da esperienza e difficilmente definibile il dritto ha comunque i tratti orientali e potrebbe imitare una moneta orientale al rovescio il 60/70% della moneta rappresenta il "fuoritondello" dell'immagine del rovescio, che poi non per forza doveva avere un senso, si vede quella che potrebbe essere una A di tipo bizantino (che appare sulle monete da Marciano in poi in oriente) ... che possa essere una imitazione dell'AE4 con la A al rovescio è una pura illazione perché questa A occupa una parte minima del potenziale tondello originario saluti Alain1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Esatto! La prossima volta devo scegliere una parola dal dialetto paesano dimenticato da tutti....ma adesso non me la ricordo...beh sogneró qualche mio bisnonno e prenderò appunti.? Ora tocca a te @vwgolf ...divertiamoci un po' con la nuova parola??1 punto
-
Non saprei dirti con certezza, potrebbe essere. Vedo tracce di altro all'esterno del perlinato, ma non ci sono elementi certi per identificare la moneta ospite1 punto
-
Credo si tratti di un 1663 anche se probabilmente è stato usato per errore un 8 finale. Ti posto una moneta analoga passata in asta. D'altra parte un 8 maravedis 1668 non risulterebbe da nessuna parte. https://aureocalico.bidinside.com/it/lot/38212/1663-felipe-iv-m-madrid-s-8-/1 punto
-
Appena riesco ti allego una immagine del mir con la pagina in cui è indicata la tua moneta... Ora sono fuori casa1 punto
-
Ciao bella e interessante discussione, io propendo per teoria dei testicoli, e concordo con @Adelchi66 sul fatto che ci sia stata un'interpretazione religiosa cristiana, è anche da capire. Ho visto più volte da vicino le statue di Artemide conservate al museo di Selcuk che ospita i reperti di Efeso, e penso siano servite da modello per le copie, e osservando bene oltre alla forma anche come sono posizionate, non portano a pensare a dei seni, poi la vera interpretazione penso che la sapessero solo i sacerdoti e gli scultori dell'epoca. Se non vi dispiace vi posto alcune foto delle suddette statue, ho ridotto il formato. Silvio1 punto
-
Condivido la mia Piastra del 1852 " modello base" come direbbe @motoreavapore1 punto
-
....ma siamo sicuri che li abbiano comprati , veramente? O magari è stato fatto un escamotage per fare credere ciò? Queste non sono monete/bancone ma semplici gadget, forse hanno meno valore delle banconote del monopoli o di qualche altro gioco di società! Magari si possono considerare per fare degli scherzi a Carnevale: tipo mi puoi cambiare questa banconota...... Mi viene in mente la storiella di due falsari che hanno stampato delle banconote da 12 Euro (inizialmente era di 12.000 Lire, ma per i più giovani la si è aggiornata in Euro) perché 2€ erano di spese. Ma poi si sono accorti che era impossibile spacciarle in città ed hanno deciso di andare per paesini, dove credevano che le persone fossero meno sospettose o diffidenti. Iniziano subito con una signora âgeé chiedendogli se avesse da cambiare una banconota da 12 € e lei prontamente risponde domandando: "Preferisce 3 banconote da 4 € o 2 da 6 € ?".1 punto
-
Piastra 1858, lettere grosse al dritto, sottili nel rovescio. Taglio inciso al rovescio. Peso grammi 27,51 Riferimenti: Pagani manca, D'Incerti manca, Magliocca pag. 348 in nota : " ....in alcuni rari esemplari della moneta datata 1858 (aquile rovesciate) , si osservano conii (al rovescio) , nei quali le lettere della legenda sono completamente prive dei punti di abbreviazione . " Numero Collezione 492,1 punto
-
Azzarderei un mezzanino a nome del doge Michele Steno per Verona, qualità del fino minore mi sembra per tale coniazione e anche lo stile potrebbe essere compatibile.1 punto
-
Adelchi Benetton Il soldino veneziano e i suoi massari da Andrea Dandolo ad Agostino Barbarigo Torino 20211 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?