Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 03/22/22 in tutte le aree
-
E’ con molto piacere che vi comunico la pubblicazione del corpus riguardante i dioboli tarantini dal titolo “The diobol of Tarentum”. Il volume contiene ben 283 diverse tipologie con relative varianti, coprendo l’intero arco di produzione di queste emissioni, aggiornando tutte le pubblicazioni ad oggi conosciute e riunendole in un unico corpus. All'interno le immagini originali provenienti da case d'asta e dalle più importanti collezioni museali al mondo. Un ricordo speciale al compianto Dott. Giuseppe Tafuri (Arthas), tanto affezionato a questo forum, che ha fortemente contribuito alla realizzazione dell’opera. In allegato copertina, alcune pagine e presentazione del Dott. Giuseppe Sarcinelli, responsabile tecnico del Laboratorio di Studio e Documentazione Informatizzata delle Evidenze Numismatiche presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e curatore della collana Magna Graecia Coins. Presentazione The diobols of Tarentum.pdf Prefazione.pdf6 punti
-
Buonasera. Condivido la mia piastra 1815, di certo non eccezionale come stato di conservazione. Anche le foto, con zone d'ombra, non sono il massimo. Al dritto, la legenda presenta due rombi in verticale dopo la "D" e la data non è seguita dal punto. Se ricordo bene, ho letto da qualche parte che potrebbero costituire delle particolarità, ma no ho trovato conferma a tutto ciò né sul Gigante, né sul M.I.R., né sul Magliocca. Spero proprio che qualche esperto collezionista possa chiarirmi come stanno realmente le cose. Ringrazio fin da ora. Saluti3 punti
-
Salve a tutti, ho il piacere di sottoporre una mia opinione. Penso che la Piastra di Ferdinando IV del 1795 (non comune) possa avere una variante degna di nota. Ne posseggo due. Una ha le foglie di lauro, al Rovescio, alla destra del nominale, diverse dalla maggioranza di quelle che ho visto sulla rete. Sono più grandi e con una disposizione diversa. Ho trovato sul web pochissimi esemplari con queste foglie larghe, ma c'è sempre qualche differenza con quella che posseggo; ma una caratteristica comune delle Piastre del 1795 con la presunta variante è la forma del 5 della data; quelle, a mio avviso, più comuni, hanno il 5 come le Piastre del 1785. La riterrei una variante interessante, visto che non si tratta della tipica differenza sulla punteggiatura, ma naturalmente di una disegno decisamente diverso di un elemento che caratterizza questa affascinante moneta. Posto la foto del mio esemplare e 2 immagini di confronto, dove al numero 1 sono illustrati i particolari della mia moneta con la presunta variante, dal 2 all'8 esemplari con foglia piccola e più comuni, il 9 e 10 sono esemplari con foglia larga, seppur con qualche differenza rispetto a quella in mio possesso. Non so se in qualche manuale autorevole delle monete napoletane viene citata questa variante. In caso, chiedo perdono per l'ignoranza che dovrò colmare con l'acquisto di qualche buon manuale, del quale sento di non poterne fare a meno a lungo. Grazie per le vostre osservazioni3 punti
-
Carissimi, intervengo a distanza di tempo per colmare alcune piccole lacune del primo post. La gestione del tesoretto è tipicamente britannica. Il British Museum ha trattenuto una parte del ritrovamento (si tratta in particolare di monete di Costantino I Cesare con rovescio raro). La restante parte suddivisa tra gli scopritori (che l'hanno immessa sul mercato in parte restaurata e in parte "nature") e il proprietario del fondo. Il mio esemplare è giunto accompagnato da una lettera di presentazione dell'hoard, il dettaglio delle monete ritrovate e il numero di inventario assegnatole dal British Museum. Lettera e lettura assai gradite. Come giustamente osservato da @Stilicho, il mio esemplare conserva ancora resti di argentatura ed è in coservazione superiore alla media. RIC alla mano, vi sono due riferimenti per questa emissione di Costantino I cesare senza segni nei campi: RIC VI Londinium 88b e 89b, in virtù della presenza o meno del drappeggio sulla corazza. In realtà questa classificazione è stata ampiamente corretta nel Cloke&Toone, dal momento che con queste medesimo dritto e rovescio (leggende FL VAL CONSTANTINVS NOB C e GENIO POP ROM, PLN in esergo) vi sono due distinte emissioni battute con caratteristiche di metrologiche ben diverse. Una prima emissione è stata coniata tra il maggio e il novembre del 307 secondo uno standard di 1/42 di libbra romana, quindi circa 7,68gr, e corrisponde a Cloke&Toone 5.01.008 e 5.01.009, sempre a seconda che vi sia o meno il drappeggio. La seconda emissione è stata, invece, coniata tra novembre e dicembre del 307 secondo uno standard di 1/48 di libbra romana, quindi circa 6,72 gr (e un flan di diametro ridotto), corrispondente a C&T 5.03.003 e 5.03.004. Il mio esemplare pesa 7,57 gr, pertanto appartiene alla prima emissione. Qui di seguito in un confronto con un esemplare dell'emissione leggermente più tarda.... le differenze di modulo (e di stile) sono evidenti.2 punti
-
Fra i precedenti possessori figura la Comery collection, giá salita agli "altari" di questo forum se non ricordo male2 punti
-
Penso che di tavoli ce ne saranno diversi ma non riesco ad esserti più preciso. Noi ci saremo solo il sabato.2 punti
-
Sostanzialmente concordo con @Cremuzio. Il tema del fanciullo che cavalca il delfino è piuttosto enigmatico e le letture possono essere molteplici, si va dall'identificazione con Eros/Cupido ed al possibile simbolo di passaggio all'età adulta fino al "semplice" intento decorativo. Sul denario della Lucretia il legame con Eros/Cupido lo si potrebbe labilmente rintracciare vedendo nel delfino il "messaggero d'amore" che scovò Anfitrite. La teoria del Crawford che vede nel rovescio Palemone non mi ha mai convinto troppo. Abbiamo poi il medesimo rovescio anche su un denario della Cordia dove il binomio Venere/Cupido parrebbe più solido... ergo... per associarlo a Verticordia lo stesso Cordio Rufo dava per certo che l'iconografia utilizzata dal suo predecessore ritraesse Cupido. https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-G34/3 In tal senso quindi il riferimento "marino" o "marinaresco" potrebbe richiamare a Gaio Lucrezio Gallo... ma è un'ipotesi sicuramente discutibile.2 punti
-
Quest'oggi vi presento il mio primo importante acquisto del 2022. Un bel Follis di Costantino I Cesare coniato a Londinium. Ciò che mi rende orgoglioso di questa acquisizione è la sua provenienza. La moneta proviene, infatti, da quello che è stato chiamato "Rauceby hoard", che è stato trovato da due metal detectorist appena fuori dalla città romana di Ancaster, nel Regno Unito, nel luglio 2017. Il tesoro è stato segnalato nell'ambito del Portable Antiquities Scheme (PAS) e inviato al British Museum. Nel 2019 il tesoretto è stato dichiarato Treasure Trove e solo successivamente riportato dalla stampa quando è stato dichiarato il più grande tesoretto di tipo trovato nel Regno Unito. Il tesoretto consisteva di 3.099 nummi tetrarchici datati dal 294 al 307 d.C., molti in condizioni prossime al fior di conio. In ordine cronologico, le ultime monete nel tesoretto erano di Costantino come Cesare (nessuna come Augusto) risalenti al 307 d.C., tra cui un Costantino PRINCIPI IVVENTVTIS e una rara moneta ROMAE AETER di Massimiano. La maggior parte delle monete proveniva dalla Gallia (875 Londra, 1459 Treviri, 468 Lione), Italia (226), Cartagine (24) e un piccolo numero da zecche orientali. Sono presenti anche 19 imitazioni barbariche Poiché il tesoretto è stato dichiarato Treasure Trove, il British Museum ha ottenuto il diritto di prelazione e ha scelto di trattenere 375 monete, per le quali gli scopritori sono stati pagati. Le monete rimanenti sono state restituite ai detectorist all'inizio del 2021 per essere divise tra loro (700 ciascuno) e il proprietario terriero (1400). Uno dei cercatori, Rob Jones, ha pulito la sua parte di monete e ha iniziato a venderle su eBay. Rob aveva cercato il tesoretto per tre anni prima di trovarlo nel 2017. In precedenza aveva trovato un paio di monete tetrarchiche in ottime condizioni e sospettava che ce ne sarebbero state altre, quindi dal 2014 al 2017 ha trovato altre 8 monete simili, prima della scoperta definitiva nel luglio 2017. Le monete sono state ritrovate in condizioni notevoli, non fuse in unico blocco e con minimi depositi superficiali. Le monete sono state rimosse dal contenitore, che è stato lasciato in situ, e segnalate al PAS, che ha chiesto che il vaso/buco fosse riempito per un successivo scavo che è avvenuto circa due settimane dopo. Il tesoretto è stato evidentemente interrato con grande cura E' stata scavata una fossa ovale, rivestita di pietra, quindi è stato collocato il contenitore che è stato poi ulteriormente coperto di pietre.1 punto
-
Buonasera a tutti, Martedì 5 Aprile 2022 alle 20:45, il Centro Culturale Numismatico Milanese è lieto di annunciare una conferenza tenuta dalla P.ssa C. Perassi sul tema: Dalle immagini degli dei ai ritratti degli uomini: una rivoluzione iconografica nella monetazione antica. La conferenza presenta una panoramica dei temi figurativi della monetazione greca, con l’obiettivo di identificare il momento di passaggio dalle tradizionali immagini divine alla raffigurazione di un uomo vivente. Saranno analizzate dapprima le emissioni di elettro coniate in Asia Minore, la monetazione bimetallica dei re persiani, dei satrapi occidentali e dei re macedoni Alessandro I e Filippo II. Una indagine approfondita sarà riservata alla produzione di Alessandro III e dei suoi successori, alla ricerca della prima autorappresentazione dell’autorità emittente totalmente ‘umana’, ossia libera da quegli attributi divini (egida, corna o pelli di animali), che conferivano al ritratto una connotazione sovrumana. Essendo un evento di rilievo comunicheremo a breve maggiori dettagli per la partecipazione Buona serata a tutti1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Si tratta di una riproduzione. Lo scudo di Luigi XIV re di Francia e di Navarra è in argento 917/1000. Nel 1645 ne furono coniati 641.600, hanno un Ø di 38,5 mm. e pesano 27,31 g.; hanno bordo liscio con R/ ruotato di 180° rispetto al D/. Moneta abbastanza rara, viene valutata attorno i 500,00 € (quella autentica).1 punto
-
Ciao @Shyneon , a farmi venire quasi un infarto ? anziché battere il cuore è stato dopo tanti anni trovare in vendita questa piccola moneta in rame Napoletana e fare l'impossibile per poterla mettere in Collezione. Monete come questa che unisce rarità e conservazione eccezionale per la tipologia non si trovano facilmente. Ci sono riuscito . Un caro saluto a tutti. Rocco.1 punto
-
1 punto
-
Stavolta ho offerto 48€ in chiusura, per andare sul sicuro: l'asta si è chiusa con la seconda offerta a 38,20€, quindi alla fine me l'ha assegnata a 38,70€ Dopo la delusione della divisionale andorrana, ci voleva una botta di fortuna1 punto
-
pur non essendo il "mio" periodo, ne avevo parlato con l'editore, che è un amico, e so che dietro c'è stato un lavoro incredibile di raccolta, che ha coinvolto un impressionante numero di musei. quindi rinnovo qua pubblicamente i miei complimenti per questa opera a tutti coloro che hanno partecipato Alain1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Mah... Visti i prezzi dell'asta Aurora personalmente non mi azzardo a fare stime di ducati e zecchini... Arka Diligite iustitiam P.S. Scherzo ovviamente... O no?1 punto
-
1 punto
-
Buongiorno, riprendo da un sito FB un interessante testo sulla ricorrenza della giornata di oggi e il suo riflesso nella monetazione provinciale. Accadde oggi: Il 22 marzo avveniva la processione dell'Arbor intrat ("Entra l'albero"), celebrante la morte di Attis. Quel giorno si tagliava il pino, simbolo del dio, se ne fasciava il tronco con sacre bende di lana rossa, lo si ornava di viole e strumenti musicali e sulla sua sommità si ponevano le effigi del dio giovanetto. L'albero veniva portato dai "dendrofori" fino al tempio di Cibele (Grande Madre), dove avveniva la commemorazione funebre di Attis. Attis è il paredro di Cibele, il servitore autoeviratosi, che guida il carro della dea. Il centro principale del suo culto era Pessinunte, nella Frigia, da cui attraverso la Lidia passò approssimativamente nel VII secolo a.C. nelle colonie greche dell'Asia Minore e successivamente nel continente, da cui fu esportato a Roma nel 204 a.C. Nella Roma antica ad Attis erano dedicate un ciclo di festività che si tenevano fra il 15 e il 28 marzo, e che celebravano la morte e la rinascita del dio. Tra queste vi erano il Sanguem, celebrato dai Galli e l'Hilaria. Tracce di questi culti, che presero il nome di Attideia, sono presenti anche in colonie greco-romane (ad esempio quella di Egnazia in Puglia). Collegato con il culto di Cibele è il mito che la vede legata al dio Attis. Le varianti di questo mito sono molteplici. Una leggenda narra che Zeus fosse innamorato di Cibele e cercasse - invano - di unirsi alla dea. In una notte di incubi angosciosi, mentre Zeus la sognava ardentemente, il suo seme schizzò sulla pietra generando l'ermafrodito Agdistis. Questi era malvagio e violento e con continue prepotenze oltraggiò tutti gli dei. Dioniso, perciò, giunto all'esasperazione, volle vendicarsi e architettò ai suoi danni uno scherzo atroce: gli portò in dono del vino e lo accompagnò a bere in cima a un grande albero di melograno, finché Agdistis si addormentò ubriaco in bilico su un ramo. Con una cordicella Dioniso gli legò i genitali al ramo e, sceso in terra, scosse l'albero con tutta la sua forza. Nel brusco risveglio il malcapitato precipitò, strappandosi di netto i genitali: così Agdistis morì dissanguato, mentre il suo sangue bagnava il melograno e lo faceva rifiorire rigoglioso e carico di succosi frutti. La ninfa del Sangario, il fiume che scorreva nelle vicinanze, sfiorò con la sua pelle uno di quei frutti e rimase incinta di un dio: fu così generato Attis il bello, il grande amore di Cibele. Costei suonava la lira in onore di Attis e lo teneva perennemente occupato in voluttuosi amplessi. Ma, ingrato e irriconoscente, Attis volle abbandonare quelle gioie e fuggì per vagare sulla terra alla ricerca di un'altra donna. Cibele sapeva bene che nessuna infedeltà di Attis sarebbe potuta sfuggire alla sua vista onnipotente e lo sorvegliava dall'alto sul suo carro trainato da leoni. Colse così Attis mentre giaceva spensieratamente con una donna terrena, convinto che le fronde di un alto pino fossero sufficienti a nascondere il suo tradimento. Vistosi scoperto, Attis fu assalito da un rimorso tormentoso e implacabile, finché all'ombra del pino si uccise. Fonte WP. Medallion I. THRACE, Anchialus. Gordian III. AD 238-244. Æ Medallion (36mm, 29.54 g, 2h). Laureate, draped, and cuirassed bust right / Cybele, veiled and wearing mural crown, enthroned left, holding phiale, and resting arm on tympanon; below throne, lion seated left; to left, Attis, wearing Phrygian cap, standing facing, head right, holding pedum and raising hand; pine tree in background. AMNG II 623 (same rev. die as illustration); Mouchmov 2927 (same dies as illustration); Varbanov 633 (same dies as illustration). Good VF, earthen and green patina. Very rare. Provenance: Classical Numismatic Group, Inc. Mail Bid Sale 82 of 16.09.2009, lot: 823. Deriving from the Phrygian goddess Matar Kubileya, or “Mountain-Mother”, Cybele was a manifestation of the Great Mother, an ancient deity who embodied the Earth’s fertility, the rugged mountains and deep recesses, and wild animals. Her association with untamed and unrestrained nature is similar to Dionysos, and Cybele is often depicted with a lion (or biga drawn by lions), and a tympanon, or drum, used to drive her male devotees into a state of ecstasy, resulting in self castration. To varying degrees, the attributes of Cybele were adopted by the Greeks and Romans in their own fertility goddesses. Beginning in the late sixth century BC, however, the Greeks adopted the worship of Cybele herself and in 210 BC, during the height of the Second Punic War (218-201 BC), the cult was introduced to the Romans when an archaic xoanon of the goddess was brought to the capital from Pessinos in Phrygia where Cybele was venerated along with the hermaphroditic deity, Agdistis, as well as Attis. While the annual Roman festival held in honor of Cybele each April, the Ludi Megalenses, represented a greatly sanitized veneration of the goddess, the presence of the other two associated deities reveals a somewhat more ancient, complex, and violent myth. According to Pausanias (7.17.5), Attis was the son of Nana, the daughter of the local river-god, Sangarios. To conceive the child, Nana impregnated herself with the fruit of an almond-tree that had grown out of the severed male genitals of Agdistis, a local hermaphroditic deity. After the baby’s birth, she abandoned it, and it was reared by a he-goat. When Attis grew to maturity, he attracted the attention of the local king, who wished to betroth his daughter to the boy. It was either the goddess Agdistis, now female only, or Cybele, who at this point became infatuated with Attis; in both versions, each goddess appeared in her transcendent power at the moment that the marriage-song was being sung (Arnobius, Adversus Gentes, 9.5.4). Attis went mad and died by castrating himself, a practice which the male worshippers of Cybele, known as korybantes or galli, would continue to practice. In repentance for causing the death of Attis, the goddess ensured that the boy’s body would remain incorruptable and he was buried at the foot of a Phrygian mountain, which came to be known as Agdistis. A Lydian version of this myth, derived from that of Phrygia and also noted by Pausanias, relates that when Attis introduced the cult of the Mother Goddess, known now as Cybele, to the Lydians, Zeus, in a jealous rage, sent a boar to plague the land. While hunting it, Attis was gored by the boar and died. This version may have been created later to provide an etiology for the refusal of the Gauls in that region to eat pork. Medallion II. Roman Provincial. Gordian III. Æ Medallion of Anchialus, Thrace. AD 238-244. AVT K M ANT ΓOPΔIANOC AVΓ, laureate, draped and cuirassed bust right / OVΛΠIANΩN AΓXIAΛEΩN, Cybele, veiled and wearing mural crown, enthroned left, holding phiale, and resting arm on tympanon; below throne, lion seated left; to left, Attis, wearing Phrygian cap, standing facing, head right, holding pedum and raising hand; pine tree in background. AMNG II 623 (same rev. die); Mouchmov 2927 (same dies); Varbanov 633 (same dies). 31.53g, 35mm, 12h. Good Very Fine; heavily tooled. Very Rare. From a private UK collection. Provenance: Roma Numismatics Limited E-Sale 66 date 09.01.2020, lot: 772. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=557106318114672&id=100014459260167 Ciao Illyricum1 punto
-
Ciao carissimo, perfettamente originale, molto simile alla mia. Complimenti per la moneta Alla prossima, ti auguro una buona giornata, M1 punto
-
Qualche elemento in più su questa moneta: http://www.moneteromane.info/corrisp/c412/c412.html Dupondio/Asse, Adriano e Roma ricca e trionfante Saluti. Giulio De Florio1 punto
-
1 punto
-
Buonasera,puoi provare qui... https://auctions.nomismaweb.com/it/sitem/2760/manuale-delle-monete-di-napoli-1674-1860/1 punto
-
1 punto
-
Ciao, è un sesterzio di Alessandro Severo come già detto con al rovescio la raffigurazione della Spes. Il busto non mi sembra drappeggiato(RIC 648b)Posto moneta della stessa tipologia? ANTONIO1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Buongiorno , non penso che questa somiglianza : moneta romana - 'calderone di Gundestrup' , possa essere interpretata se non in modo "universale" ; per quanto riguarda la moneta romana il Dio del mare Nettuno e una sua creatura il delfino , che meglio si adatta alla simbiosi con l' uomo . Circa il "calderone di Gundestrup" composto di tredici pannelli d' argento di cui uno e' quello sopra rappresentato , la presenza di tanti animali terrestri e di uno marino , lo rende difficilmente interpretabile , forse non una rappresentazione generale di diverse culture e religioni , un Panteon in miniatura , da qui forse deriva , oltre alla forma , l' appellativo datogli di "calderone" . Circa la figura del delfino : http://www.euromedi.org/diariodocumento.asp?titolo=3241 punto
-
E’ ancora presente nelle emissioni di Valeriano e del figlio Gallieno. Poi a seguito dell’ennesima riforma scompare. Per cercare altri esemplari sono andato a “sfogliare virtualmente” il catalogo online della American Numismatic Society: http://numismatics.org/ocre/results?q=authority_facet%3A"Valeriano" AND denomination_facet%3A"Dupondio"&lang=it&start=0 Che però ha un difetto: è basata sul RIC quando il testo di riferimento per il periodo è il Goebl! Accedo comunque al sito ANS di cui sopra dal quale trovo indicazione di un RIC 258 di Gallieno (dupondio VOTIS DECENNALIBVS del 253 d.C.) proposto come dupondio: Radiato, 23 mm 9.06 g Laureato, 24 mm 9.54 g Laureato, 24 mm 9.17 g Quindi secondo ANS abbiamo anche in Gallieno evidenza di pesi calanti rispetto al dupondio e ritratto radiato in un caso dei tre proposti. Anche qui… dupondio leggerino, asse “cicciotto” (e perché radiato?) o sesterzio molto sottopeso? Confrontiamo con il Goebl (non senza aver prima ringraziato @grigioviola per la consulenza) : Esistono serie costituite da sesterzi – dupondio (radiato) - asse come quella sopra. Regno congiunto Valeriano-Gallieno, zecca di Roma, emissione I, Goebl 253/254. Quindi abbiamo quello che Goebl indica come ultimo dupondio. Gallieno, regno da solo, IMP GALLIENVS PF AVG/VOTIS DECENNALIBVS emesso a Roma, VII emissione (262 d.C.) di cui abbiamo la serie completa dei tre nominali bronzei: che equivale al RIC 258 di ANS ma ci dimostra che esiste tutta la serie completa. Per quanto concerne poi Mariniana (in riferimento alla discussione di cui in apertura) abbiamo questo schema delle emissioni : Segnate come 1-5 perché non collocabili con precisione in una emissione, quindi finestra temporale ampia 253/259 d.C. E come noterete, il Goebl (che qualcosa ne sapeva) segnala antoniniani, sesterzi e assi a nome suo ma NON DUPONDI. Se torniamo all’ANS, troviamo infine un dupondio di Salonina con crescente (257-8 d.C.) https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1931-0712-2 Peso: 14,97 g che rientrerebbe con il limite temporale (262) proposto dal Goebl per i dupondi.1 punto
-
1 punto
-
In altra discussione si è parlato dell'incendio perpetrato dalle truppe tedesche in ritirata da Napoli dei documenti custoditi nell'archivio con il conseguente ed immane danno del nostro patrimonio storico culturale. Negli anni, a partire da Riccardo Filangieri, c'è stato il tentativo di raccogliere ciò che in precedenza era stato pubblicato per ricostruire quanto irrimediabilmente perso. Un grande lavoro ora disponibile online unitamente anche a qualche documento aragonese. Una base di partenza essenziale per lo studio della monetazione angioina. https://www.accademiapontaniana.it/pubblicazioni/ Anni fa fui frequentatore assiduo della biblioteca Giustino Fortunato di Roma per consultarli. Averli ora online è una vera fortuna. Buona lettura.1 punto
-
1 punto
-
Questa tipologia di errore è stata riscontrata in tutte le monetazioni mondiali e nelle varie epoche. Normalmente deriva dal fatto che per portare i tondelli di vari tagli alla pressa monetaria vengono usati gli stessi "contenitori" (cassoni, cesti, secchi, etc. a seconda dell'epoca e dall'operatività di ogni singola Zecca). Pertanto, può/poteva accadere (ovviamente raramente) che un tondello di una precedente operazione di coniazione rimanga dentro il "contenitore" (es. perchè si è impigliato) dove vengono/venivano riversati i tondelli di un'altra moneta. Oppure la "contaminazione" tra i due tondelli poteva avvenire all'interno della società esterna che produceva i tondelli e quindi arriva/arrivava già in Zecca una partita di tondelli "contaminata" con qualche tondello di un'altra denominazione. Ad esempio i tondelli in acmonital venivano prodotti a Cogne e li nelle fasi di produzione o di spostamento poteva esserci una "contaminazione" tra monete di tagli diversi. Caratteristica essenziale è che il tondello "sbagliato" deve essere di un diametro inferiore rispetto alla moneta che si intendeva coniare ("moneta corretta"), in quanto un tondello di diametro maggiore non sarebbe entrato nei tubi di alimentazione dei tondelli che erano parametrati con il diametro della "moneta corretta". Pertanto, una moneta da una lira impero non poteva essere coniata (spontaneamente) su un tondello delle due lire impero. L'inverso invece ovviamente si, come nel caso di specie. Inoltre, il tondello sbagliato deve appartenere ad una moneta che veniva coniata dalla Zecca nello stesso periodo in cui veniva coniata la moneta "corretta". Sebbene non si possa escludere a priori l'intervento dell'uomo nella generazione di questi errori, è anche vero che gli stessi possono sicuramente verificarsi anche spontaneamente e, come detto, errori di questo tipo si sono riscontrati in tutte le zecche mondiali e in varie epoche.1 punto
-
Buonasera a tutti. Servirebbero più foto per valutarla meglio e da più angolazioni. Da quel che si può intuire la moneta è veramente molto bella. Io azzarderei qFDC. Difficile trovarla perfetta. Ottimo esemplare. Complimenti1 punto
-
Peccato quei segnetti per me anche sta trova il qfdc e lo SPL+/qfdc Comunque gran bella moneta1 punto
-
Mi scuso per l'incoveniente di prima, allego nuovamente l'interessante articolo recentemente pubblicato dalla seguente testata giornalistica locale sul clamoroso furto avvenuto negli anni '70 presso il Medagliere del Museo Archeologico di Gela: https://www.letterag.online/lg-rubriche/archeologia-e-storia-del-territorio-gelese/vite-complicate-dei-medaglieri-il-furto-di-monete-al-museo-di-gela-e-il-loro-parziale-recupero/?fbclid=IwAR36tPt9YxS9aHUfdMEqmsJTWvfDhPHlmXjR1d_Dkjbil8pl_L9xQw_4-Gs1 punto
-
DE GREGE EPICURI Lo studio delle iconografie e dei loro mutamenti nel tempo non è l'unica "specializzazione" di Claudia Perassi. Un altro suo tema prediletto è l'uso della moneta come gioiello, su montature particolari (es. braccialetti costituiti da numerosi aurei) o associata a spille o gioielli di altro tipo; ed anche i depositi votivi di monete, sia in epoca antica (grotte sacre, fontane...) che medievale (fondazioni di chiese e cappelle). Infine, si è occupata di monete frazionate, in particolare attraverso un importante convegno organizzato presso l'Università Cattolica.1 punto
-
Questa recentissima entrata in collezione è una buona candidata a “moneta batticuore”, anche se è in ottima compagnia. ?. Non ce ne sono tante in giro di questa qualità con questo millesimo…?1 punto
-
E' una storia che ho già raccontato, ma mi piace ripeterla... Era una domenica di settembre di molti, troppi, anni fa. La mia ragazza collezionava cartoline d'epoca e mi chiese di accompagnarla ad Asolo dove c'era un mercatino dell'antiquariato. Mentre lei guardava le sue cose, io cominciai a spulciare quello che c'era sul banco. Mi attirò una moneta ''antica''. La data era 1893. Quasi cento anni, pensai... Chiesi il prezzo. 1000 lire disse il commerciante. Gliele diedi. Era un 10 centesimi di Umberto I. Molto malmesso e ora non mi darebbero i 50 centesimi che spesi. Ma fu l'inizio di una passione che dura da più di quarant'anni e che mi ha tolto per sempre la noia. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
1 punto
-
Brevi note sulle monete suberate di Velia tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C. Alla memoria di Giuseppe (Arthas), numismatico e caro amico, sono dedicate queste brevi note sulla monetazione di Velia che sintetizzano uno scambio di opinioni sul tema foriero, in questa come in altre occasioni di confronto, di nuovi e stimolanti apporti conoscitivi nel consueto clima conviviale che non di rado stemperava la “ponderosità” di alcune tematiche. Il contributo si inserisce in un filone di ricerca sulle monetazioni dell’Italia meridionale a cui lo studioso ha dedicato una porzione rilevante della sua produzione scientifica, sorretta da rigore metodologico e acutezza di analisi, come documentano monografie e contributi di dettaglio che hanno fornito un notevole apporto alla ricostruzione di aspetti specifici di singole monetazioni, indagate in una dimensione più ampia che dall’ambito prettamente numismatico si dilata al contesto storico e archeologico. * * * Tra la fine dell’età agatoclea e gli eventi pirrici, periodo grosso modo corrispondente ai periodi VII (305/4-293/90 a.C.), VIII (293/90-280 a.C.) e IX (290-280/75 a.C.) della classificazione Williams (The silver coinage of Velia, London 1992), la monetazione di Velia si caratterizza per un rilevante ampliamento del volume di produzione delle coniazioni argentee, fenomeno che, come ha ben evidenziato Burnett, non appare isolato in Magna Grecia, trovando riscontro nella seconda metà del IV secolo sia sul versante ionio che su quello tirrenico (Neapolis, Metaponto, Crotone, Taranto, Thurii, Heraklea; v. A. Burnett, La documentazione numismatica, in Tramonto della Magna Grecia, ACT XLIV – Taranto 2004, Taranto 2005, 162 s.). All’intensificazione del gettito monetale velino si aggiunge un netto incremento dei simboli (palma, delfino, cicala, spiga, caduceo, pentagramma, triskleles, ecc.) che si dislocano senza soluzione di continuità all’interno dei vari segmenti produttivi ricostruiti da Williams con probabile funzione di segno di controllo più che di riferimento a precise vicende storiche. Si tratta di aspetti di una certa rilevanza che segnano una cesura con il precedente assetto monetario e per i quali i fattori chiamati in causa sono molteplici: arruolamento dei mercenari - e, quindi, aumentate esigenze finanziarie in relazione alle spese di guerra e al mantenimento dell’esercito - , acquisto e/o rifornimento di merci, riscossione di tributi ma anche spese per la monumentalizzazione della città richieste da un ampio programma di riorganizzazione dell’assetto urbanistico che in questo periodo investe l’abitato, gli edifici sacri e gli spazi pubblici, le fortificazioni, ecc. Altro aspetto interessante e per certi versi complementare, ma cui è stata rivolta scarsa attenzione negli studi, è rappresentato dalla pressoché concomitante produzione di un cospicuo numero di monete suberate (o presunte tali). Molte di esse figurano già nel catalogo di Williams (contrassegnate dal segno +) ma a trent’anni dalla sua edizione (1992) il mercato antiquario ha notevolmente contribuito ad implementare la documentazione nota fornendo nuovi ed interessanti apporti. Si tratta di 16 pezzi inquadrabili – tranne per la serie 406 - all’interno di emissioni per le quali già Williams aveva rilevato un discreto numero di suberati e che quindi ampliano e confermano un quadro sostanzialmente noto. Di seguito una tabella riassuntiva (con suddivisione degli ess. in periodi, sezioni e serie secondo il catalogo di Williams e con il relativo riferimento alle tavole fotografiche, riportate in calce): Periodi Sezioni Serie Peso (in gr.) Provenienza Tav VII 69 406 6,20 RN, 4, 2013, 25 1 408 5,61 RN, 12, 2014, 37 2 71 423 6,79 Künker, 347-9, 2021, 599 3 72 440 7,34 CNG, 489, 2021, 17 4 6,76 Artemide, 24, 2021, 8 5 74 469 7,26 NAC AG, 46, 2008, 805 6 5,57 Rauch, 80, 2007, 19 7 75 489 7,39 CNG, 294, 2013, 2 8 VIII 80 539 7,15 Kölner, 115, 2021, 19 9 6,21 The NY Sale, 5, 2003, 23 10 6,98 Agora Auc., 65, 2017, 5 11 6,81 CNG, 294, 2013, 3 12 IX 82 584 5,97 Auc. GmbH, 20, 2013, 4 13 6,70 CNG, Triton XV, 2012, 1033 14 6,36 Rauch, 107, 2018, 51 15 6,51 Apollo Numismatics 161 punto
-
Grazie Dracma, soprattutto per aver ricordato un ragazzo che se ne è andato troppo presto e che rimarrà sempre nei nostri cuori.1 punto
-
Agora Auctions 65, 2017, 5 Lucania, Velia. Ca. 300-270 B.C. AR fourrée stater (22.99 mm, 6.98 g, 6 h). cf. Williams 527ff. 11 CNG 294, 2013, 3 LUCANIA, Velia. Circa 280 BC. Fourrée Nomos (20mm, 6.81 g, 7h). Williams +539.1–9; From the Robert and Julius Diez Collection. Ex Gustav Philipsen Collection (Part I, J. Hirsch XV, 28 May 1906), lot 723. 12 Auctiones GmbH, 20, 2013, 4 Velia plated AR Didrachm, c. 290-280/275 BC Velia, Lucania. AR Fourrée Didrachm (21 mm, 5.97 g), c. 290-280/275 BC. 13 CNG Triton XV, 2012, 1033 LUCANIA, Velia. Circa 280 BC. AR Nomos (20mm, 6.70 g, 12h). Williams +584.2b (this coin). From the Deyo Collection. Ex Freeman & Sear 8 (5 February 2003), lot 28 (inorrectly citing Williams 564); Ars Classica XIV (2 July 1929), lot 54; Ars Classica XIII (27 June 1928), lot 138. Williams lists this coin in a category “Plated or Probably Plated.” However, his use of “probably” is apropos here, as a specific gravity test verifies that this coin has an appropriate silver content, and is not plated. 14 Rauch, 107, 2018, 51 LUCANIA - Velia (Hyele, Elea) Nomos/Didrachme (6,36 g), ca. 280 v. Chr. Stellenweise leichte Hornsilberauflagen, kleiner Stempelfehler im Rv. s.sch.-vzgl. – 15 Apollo Numismatics https://www.vcoins.com/es/stores/apollo_numismatics/12/product/lucania_velia_fourree_didrachm_nomos_stater__athenalion_and_stag/47492/Default.aspx Lucania, Velia: fourrée didrachm, 290-275 BC, 6.51gm, 23.3mm. Williams 584 (O:289/R:407); SNG ANS 1398. aEF, scratches on lion’s body. As noted above, the same dies used to strike our specimen also were used to strike specimen 584 in Williams, an officially minted coin (given the physical characteristics of specimen 584 evident in the plate photo, it is difficult to believe that it is a fourrée that escaped detection by Williams). It is interesting that immediately after specimen 584 in his catalog, Williams lists many fourrée specimens which he labels +584,1 through +584,24, all of which are of the same identical type as 584 and of very similar style in most cases. There is a possible historical scenario that is consistent with the above facts. If forgers were able to obtain a pair of official dies (O:289 and R:407 by William’s designation), they might have used them first to strike fourrée (including our specimen) and then used them as guides for engraving subsequent dies which they then used to strike more fourrée such as William’s examples +584,1 through +584,24. 161 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?





















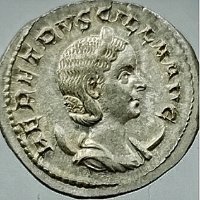




copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)






