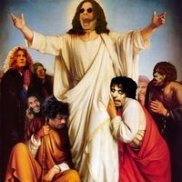Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 03/24/22 in tutte le aree
-
Ciao a tutti, risulterei aggiudicatario ( Asta ancora non conclusa), all'Asta Antium n. 10, di questo lotticino di denari tornesi. Ovviamente, stiamo parlando di bassissima conservazione, però la seconda moneta sembrerebbe una contraffazione del denaro tornese di Campobasso Presenta, infatti, la legenda DE CLARENCIA al diritto- CAMPIbASSI al rovescio, classificata nella categoria D da Ruotolo e dal MIR al n. 372 con rarità R3, moneta che non ritrovo nè nella collezione del British ne in quella di Vittorio Emanuele III ( mi riservo, però di ricontrollare) La prima moneta me la devo vedere dal vivo, sembrerebbe Filippo di Savoia. Terminato l'acquisto, all'arrivo me le studio meglio, per confermare o meno queste sensazioni. Saluti Eliodoro5 punti
-
Questo contributo propone una sintesi organica e talora ampliata delle maggiori discussioni sulla moneta sibarita (v. l’elenco riportato in calce), che proprio su questo forum hanno trovato terreno fertile di confronto e dibattito, in particolare a seguito dell’edizione del corpus (ad oggi privo di tavole) a firma di E. Spagnoli, La prima moneta in Magna Grecia: il caso di Sibari, Diogene ed., Pomigliano D’Arco 2013 (v. in proposito la recensione di T. Lucchelli, Nuove prospettive nella ricerca sulla moneta della Magna Grecia. Due libri recenti sulle zecche di Sibari e Reggio, “RIN”, 117, 2016, 265-7). Nell’impossibilità di affrontare, per ragioni di tempo e spazio, tutte le problematiche emerse dalla lettura del volume, ci si limita ad enucleare solo alcune delle principali tematiche discusse nei vari interventi, rinunciando alla disamina di proposte alternative di classificazione e inquadramento cronologico ventilate da studi più o meno recenti, in particolare: F. Barritta – B. Carroccio, Ritmi di coniazione e storia: elementi per una riconsiderazione della monetazione incusa a Sybaris e nel suo “impero”, “NAC”, XXXV, 2006, 53-81. Id., Considerazioni sulla monetazione sibarita, Tricase 2013. B. Carroccio, Monetazioni incuse, Pitagorismo e aristocrazie indigene: appunti per una ridefinizione del problema, in G. De Sensi Sestito-S. Mancuso (edd.), Enotri e Brettii in Magna Grecia. Modi e forme di interazione culturale, II, Soveria Mannelli 2017, 77-107. Il volume costituisce l’edizione a stampa della tesi di dottorato (E. Spagnoli, Tra economia e società: la moneta di Sibari, Università di Napoli “Federico II”, 2009) e condensa le pluriennali ricerche dell’A. sulla monetazione sibarita: La documentazione, in Sibari e la Sibaritide, ACT XXXII (Taranto-Sibari 1992), Napoli 1994, 612-631 (contributo scritto di concerto, ma a firma disgiunta, con A. Stazio autore nello stesso volume del testo su La monetazione, 597-631). Aspetti della tesaurizzazione monetale di Sambiase (IGCH 1872 – CH II. 8, in G. De Sensi Sestito (ed.), Tra l’Amato e il Savuto. Ricerche storico-topografiche sul territorio lametino nell’antichità, II, Soveria Mannelli 1999, 185-94. Ripostiglio di Sambiase, in E. Spagnoli – M. Taliercio Mensitieri, Ripostigli dalla piana lametina, Soveria Mannelli 2004, 9-47. Cultura materiale a Sibari: officine e maestranze, “AIIN”, 52, 2006, 281-8. La moneta di Sibari: struttura e metrologia, in N. Holmes (ed.), Proceedings of the XIVth INC (Glasgow 2009), I, Glasgow 2011, 405-16. Si aggiunge il più recente studio sulle emissioni con tipo sibarita: E. Spagnoli, La moneta come base documentale per una riflessione sul ruolo politico dei centri indigeni della Calabria in età tardo arcaica. Le emissioni con tipo sibarita, in L. Cicala-M. Pacciarelli (edd.), Centri fortificati indigeni della Calabria dalla protostoria all’età ellenistica (Atti del Convegno Internazionale-Napoli 2014), Paestum 2017, 199-222. Il testo risulta di agevole lettura benché l’assenza del necessario repertorio illustrativo e di un elenco delle provenienze (rimandato dall’A. ad un successivo volume, ad oggi non pubblicato) costituiscano un grave limite alla sua utilizzazione, impedendo di cogliere sul piano visivo le pur interessanti considerazioni dell’A. sulla evoluzione stilistica del tipo e sulle sue varianti iconografiche, oltre che, naturalmente, su talune peculiarità epigrafiche a cui viene conferito particolare rilievo nella seriazione delle emissioni. Benché si ignorino le motivazioni di tale scelta editoriale, non esplicitate dall’A., essa appare tuttavia singolare e per certi versi poco condivisibile soprattutto in considerazione dell’oramai ampio gap cronologico dalla prima edizione del volume (2013). Non poche difficoltà presenta inoltre la lettura (e decodificazione) dei graffiti (p. 307, fig. 3) e dei grafici in b/n per la resa del tutto inefficace (v. ad ess. pp. 309-10, 314, 316-7). Dopo un capitolo introduttivo che delinea il quadro storico e archeologico della colonia achea e lo stato degli studi numismatici nel panorama più ampio della monetazione incusa della Magna Grecia (Cap. I: La colonia achea e la sua moneta. Il quadro storico, archeologico e numismatico: lo stato degli studi, 23-78), l’A. presenta un catalogo costituito da 1105 monete strutturato per sequenza di coni (Cap. II: Le emissioni monetali: la sequenza dei conii, 79-171) con l’individuazione di 408 coppie di conii (307 di D/ e 360 di R/) distribuite su tre diversi nominali (stateri, dracme e oboli). Più di recente è stata opportunamente segnalata anche la presenza di emioboli (v. infra) che, seppur di esigua consistenza e privi del dato di provenienza, rappresentano una documentazione significativa che integra la fascia bassa dei valori coniati (L. Lazzarini, Prime note su emioboli arcaici inediti di Sibari, Crotone e Metaponto, “NAC”, 46, 2017, 19-29). La documentazione esaminata comprende le emissioni databili entro il 510 a.C. escludendo, pertanto, sia le monete riferite alle varie rifondazioni di Sibari (su cui v. il contributo in appendice) sia le emissioni che adottano il tipo sibarita, pubblicate in altra sede editoriale (v. supra). Dall’analisi scaturisce un’articolazione delle emissioni in tre fasi produttive (A, B, C) al loro interno distinte per peculiarità epigrafiche (classi epigrafiche) e/o tipologiche e stilistiche (v. Tabella 1). Il tipo, unico per statere, dracma e per il D/ dell’obolo (R/ MV) è rappresentato dal toro retrospiciente, in rilievo al D/ e incuso al R/. Sul piano strutturale la sequenza risulta discontinua per la debole concatenazione dei conii, con alta percentuale di coppie isolate. Tabella 1 (da Spagnoli, p. 305)4 punti
-
Ciao a Tutti, Posto una moneta che è bruttina, ossidata e molto vissuta. Il 5 Tornesi 1827 di Francesco I°. In questo caso però è raretta. Si tratta della Variante HIERVSAL – globetto sotto il busto. Eccola e, mi raccomando non storcete il naso, poverina è passata in molte tasche! Moneta già censita dal D'Incerti: E dal Magliocca al n. 475e: Sulla Rarità in effetti ci sarebbe da discutere, in quanto il Gigante (n. 16a – Pag. 579 ) la considera solo R. Vi invito a condividere i vostri esemplari di questa moneta, anche quelle senza varianti e ad esprimere le vostre opinioni. Ho svolto un lavoro di revisione a questo proposito, e se a qualche amico interessa, posterò il risultati nel mio prossimo intervento. Grazie e Buona Serata, Beppe4 punti
-
4 punti
-
Claudio II "il Gotico" Marco Aurelio Flavio Valerio Claudio meglio conosciuto come Claudio II "il Gotico" (in latino Marcus Aurelius Flavius Valerius Claudius, nato a Sirmia il 10 maggio 213 o 214 e morto a Sirmium nel luglio 270) è stato un imperatore romano dal settembre/ottobre del 268 alla sua morte, ovvero un solo anno e nove mesi, periodo troppo breve per poter porre in atto efficaci riforme in campo militare, finanziario e sociale. Di stirpe illirica fu il primo di un gruppo di imperatori che durante il III secolo cercarono di risolvere i gravi problemi dell'impero. Gli ottimi rapporti che ebbe con il senato di Roma, grato per l'eliminazione di Gallieno, si manifestarono anche dopo la morte di Claudio con l'elezione ad Augusto del fratello Quintillo. Portò a termine la guerra con i Goti, meritandosi il titolo di Gothicus Maximus . [continua...] Claudio II "il Gotico" (213/214 - 270) Valore nominale: Antoniniano Zecca: Milan (Milano) Officina: 3a Anno: Settembre 268 - gennaio 269 Diritto: . IMP CLAVDIVS P F AVG (Imperator Claudius Pius Felix Augustus) . Busto radiato, drappeggiato e corazzato a destra visto di 3/4 dietro Rovescio: . FELI-C T-ENPO (Felicitas Temporum) . La Felicitas in piedi di fronte a sinistra, con caduceo nella mano destra e scettro nella sinistra. Campo: Esergo: T Conservazione: Rarita': Metallo: Billone Peso: 3.34 gr Diametro: 17.50 mm Riferimenti/Link: RIC 145, Cohen 77 Note: Il migliore dei mie monete di Claudio il Gallico e probabilmente anche la più bella che abbia visto. Ben centrata, ben conservata ma, soprattutto, con uno stupendo ritratto. Claudio il gotico, un grande imperatore che cercò di risollevare le sorti di Roma... ma visse troppo poco per raggiungere il suo scopo, regnò per soli 21 mesi. Di seguito la continuazione della sua biografia liberamente tratta dalla Wiki. Ogni commento su moneta e imperatore è il benvenuto. Ave! Quintus [continua...] Nacque probabilmente in Sirmia da famiglia illustre nel 213 o 214, che la Historia Augusta mette in relazione con la Gens Flavia (di Vespasiano, Tito e Domiziano). Aurelio Vittore sostiene che molti credevano fosse figlio di Gordiano II, il quale, ancora adolescente, venne iniziato da una donna matura in vista dell'imminente matrimonio. Vi sarebbe anche un accenno di parentela con il futuro imperatore Marco Aurelio Probo. La Historia Augusta racconta che quando era ancora un giovane soldato: "[Claudio] si mise in mostra in una gara tra i più forti lottatori, durante uno spettacolo che si teneva nell'accampamento in onore di Marte. Egli adiratosi con chi lo aveva afferrato non per la cintura, ma per i genitali, gli fece cadere con un sol pugno tutti i denti. Questo gesto gli fu perdonato, poiché si era vendicato per l'offesa ricevuta al proprio pudore." (Historia Augusta, Divus Claudius, 13.6-7) Si racconta che durante questo episodio fosse presente lo stesso imperatore Decio (che regnò dal 249 al 251), il quale lo lodò pubblicamente per il valore e il pudore, tanto da donargli armillae (bracciali) e torques (collari), ma lo invitò anche a ritirarsi dalle competizioni militari, temendo che potesse compiere altri atti troppo violenti per le regole della lotta. Sembra si sia distinto per le sue capacità militari, poco dopo (attorno al 250), come tribunus militum, durante il periodo delle invasioni dei Goti. In questa circostanza venne inviato dallo stesso Decio presso il passo delle Termopili, a protezione del Peloponneso, ottenendo dal governatore dell'Acaia, duecento soldati della Dardania, cento cavalieri catafratti, sessanta cavalieri, sessanta arcieri cretesi e mille reclute ben armate. Era ancora tribuno militare sotto l'imperatore Valeriano (tra il 253 ed il 258) della legio V Martia, dislocata a quel tempo nella provincia di Siria, come ci tramanda la Historia Augusta. Valeriano dispose, quindi, che fossero corrisposti a Claudio: "...uno stipendium di 3.000 moggi di grano, 6.000 di orzo, 2.000 libbre di lardo, 3.500 sestari di vino invecchiato, 150 di olio di prima qualità, 600 di olio di seconda scelta, 20 moggi di sale, 150 libbre di cera, una giusta quantità di fieno, paglia, aceto, legumi, ortaggi, 300 pelli per le tende, sei muli all'anno, come pure tre cavalli, dieci cammelle, nove mule, 50 libbre all'anno di argento lavorato e 150 aurei (filippi in questo caso) con impresso il viso di Valeriano e, quale dono di Capodanno, altri 47 aurei (filippi) e 160 trienti. A ciò si aggiungano anfore, bicchieri e pentole per undici libbre. Due tuniche militari rosse e due mantelli militari all'anno, due fibbie d'argento dorato, un anello con due gemme del peso di un'oncia, un bracciale di sette once, una collana da una libbra, un elmo dorato, due scudi ornati d'oro e una corazza da restituire. Due lance erculiane, due giavellotti corti, due falci, quattro falci da fieno. Un cuoco ed un mulattiere con l'obbligo di restituirli. Due belle schiave di guerra. Una veste bianca di misto seta, ornata di porpora di Gerba, una tunica di porpora di Mauretania. Un segretario e uno schiavo addetto alla mensa, da restituire. Due paia di coperte di Cipro, due camicie bianche, una toga, un laticlavio, tutti da restituire. Due cacciatori personali, un carpentiere, un addetto al pretorio (alloggio personale), un portatore d'acqua, un pescatore ed un pasticcere. Mille libbre di legna al giorno, qualora se ne trovi, altrimenti di meno ed in misura di quanto possibile a seconda del luogo; quattro palate di legna secca al giorno. Un responsabile del bagno, compresa la legna per il bagno, altrimenti si laverà nei bagni pubblici." (Historia Augusta, Divus Claudius, 14.3-13) Valeriano aggiunse, quindi, alla fine: "Ho deciso di assegnare tutti questi particolari vantaggi [a Claudio], come se trattassi non di un tribuno, ma di un generale, poiché è un uomo tale che bisognerebbe assegnargli ancora di più [di quello che già gli ho concesso]." (Historia Augusta, Divus Claudius, 14.15) In effetti il trattamento sembrerebbe riservato a un dux ducenarius, vale a dire a un ufficiale con uno stipendium base pari a 200.000 sesterzi annui. Dopo questo incarico, divenne governatore dell'Illyricum (dux totius Illyrici), che comprendeva, già dal tempo di Valeriano, un comando militare che sovrintendeva a tutti gli eserciti delle province romane della Tracia, delle due Mesie, della Dalmazia, delle due Pannonie e delle tre Dacie: "[...] gli ho assegnato uno stipendium pari a quello del prefetto d'Egitto, un corredo di vestiario pari a quello del proconsole d'Africa, tanto argento quanto ne percepisce il sovrintendente alle miniere dell'Illyricum (curator Illyrici metallarius), un numero di addetti al suo servizio pari a quello che destino a me stesso [Valeriano] quando mi reco in ogni città, perché sia evidente a tutti quale sia la considerazione in cui tengo quell'uomo [Claudio]." (Historia Augusta, Divus Claudius, 15.4) Sempre dalla Historia Augusta si sa che ebbe un ottimo rapporto con l'allora governatore della Mesia (non è noto se superiore o inferiore), Regaliano, al quale indirizzò una lettera, nella quale lo ringraziava per la riconquista di alcune regioni dell'Illirico (Mesia superiore), grazie anche al successo ottenuto nella battaglia combattuta presso Scupi. Tale episodio potrebbe riferirsi agli anni 258-259. Qui esercitò il suo prestigioso comando, che sembra fosse il più importante dopo quello dell'imperatore stesso, per dieci anni a protezione del limes danubiano, contro l'ormai devastante pressione dei Goti (dal 258 al 268 circa). Un'altra indicazione presente in una lettera trascritta dalla Historia Augusta, indirizzata da Gallieno a un certo Venusto, vede Claudio in Dacia, quando sul trono vi era ancora probabilmente Valeriano, e non era ancora scomparso Cornelio Salonino (in un periodo ipotizzabile tra il 258 e il 260). Dopo il 258 potrebbe, inoltre, aver ricoperto il suo primo consolato. Nel corso del 267, Gallieno, grazie all'appoggio di Aureolo (magister equitum) e alla perizia militare del suo magister militum, Claudio, combatté con successo le armate galliche secessioniste di Postumo. Quando forse la vittoria finale era vicina, tanto da ipotizzare una riunificazione dell'impero delle Gallie al potere centrale di Roma, con la fine del 267 e gli inizi del 268 una nuova e immensa invasione da parte dei Goti (unitamente a i Peucini, agli Eruli e a numerosi altri popoli) prese corpo dalla foce del fiume Tyras (presso l'omonima città), dando inizio al più sorprendente e devastante assalto di questo III secolo, che sconvolse le coste e l'entroterra delle province romane di Asia Minore, Tracia e Acaia affacciate sul Ponto Eusino e sul Mare Egeo. "E così le diverse tribù della Scizia, come i Peucini, i Grutungi, gli Ostrogoti, i Tervingi, i Visigoti, i Gepidi, i Celti e gli Eruli, attirati dalla speranza di fare bottino, giunsero sul suolo romano e qui operarono grandi devastazioni, mentre Claudio era impegnato in altre azioni [contro gli Alemanni] [...]. Furono messi in campo trecentoventimila armati dalle diverse popolazioni [...] oltre a disporre di duemila navi (seimila secondo Zosimo), vale a dire un numero doppio di quello utilizzato dai Greci [...] quando intrapresero la conquista delle città d'Asia [la guerra di Troia]." (Historia Augusta, Divus Claudius, 6.2-8.1) E mentre i Goti impegnavano lo stesso imperatore Gallieno in Tracia e Illirico, una nuova orda di Alemanni riusciva a penetrare nell'Italia settentrionale attraverso il passo del Brennero (nel 268), approfittando dell'assenza dell'esercito imperiale, impegnato a fronteggiare sia la devastante invasione dei Goti in Mesia, Acaia, Macedonia, Ponto e Asia, sia l'usurpatore Aureolo che, prima fu battuto presso Pontirolo sull'Adda (pons Aureoli), poi si fortificò a Mediolanum (Milano). Gallieno, tornato a Mediolanum, si apprestò ad assediare Aureolo che qui si era rinchiuso, con la speranza di ricevere aiuto da parte di Postumo. Ma Aureolo, che aveva ormai perduto ogni speranza, fece spargere voci nel campo dell'imperatore, che inneggiavano contro Gallieno. Alcuni comandanti, stanchi dell'imperatore, ordirono una congiura e dissero al principe che Aureolo aveva tentato una sortita facendolo uscire dalla sua tenda. Gallieno fu ucciso a tradimento dal comandante della cavalleria dalmata Ceronio o Cecropio, in un agguato, insieme al fratello Publio Licinio Valeriano. Alla congiura pare non fosse estraneo il suo successore, Claudio, anche se non partecipò direttamente alla riunione. "E poiché né Eracliano, né Marciano potevano sopportare una condotta tanto dissoluta da parte di Gallieno, si accordarono per pianificare chi tra loro due avesse assunto l'impero. [...] Di fatto venne però scelto Claudio, [...] uomo Optimus fra tutti, che non partecipò alla riunione, ma che godeva presso tutti di una tale riverenza, considerazione, da apparire giustamente degno dell'impero, come si poté poi comprovare in seguito." (Historia Augusta, Gallieni duo, 14.1-2) Altri storici (anche coevi) affermano che Gallieno morì in conseguenza di una brutta ferita riportata durante lo svolgersi dell'assedio. Tra gli organizzatori c'era il suo prefetto del pretorio Aurelio Eracliano e Marciano. Alla notizia della sua morte (avvenuta nel settembre/ottobre del 268), i suoi familiari furono assassinati. Morì così a cinquant'anni, dopo tre lustri di regno e fu divinizzato per volere del suo successore Claudio II, che nel frattempo era stato proclamato imperatore dalle truppe, decisione ratificata poco dopo dal Senato. "[...] indossate le toghe i senatori si recarono al tempio di Apollo Palatino, e dopo aver dato lettura del messaggio dell'imperatore Claudio, vennero levate allo stesso le seguenti acclamazioni: “Claudio Augusto gli dei ti proteggano” ripetuto sessanta volte, [...] “Claudio Augusto, tu fratello, tu padre, tu amico, tu buon senatore, tu vero principe” (ripetuto ottanta volte), “Claudio Augusto, difendici tu da Aureolo... dai Palmireni... da Zenobia... da Vittoria... da Tetrico”." (Historia Augusta, Divus Claudius, 4.2-4.) Aurelio Vittore, infine, sostiene che Gallieno sul letto di morte designò quale suo successore Claudio, che si trovava a Ticinum e al quale furono inviati gli indumenti imperiali attraverso Gallonio Basilio. Costrinse poco dopo il senato di Roma a deificare Gallieno. Vi è da aggiungere che Claudio appariva come il generale più esperto e il più vicino consigliere del precedente imperatore. Claudio, una volta acclamato imperatore, ottenne la resa di Aureolo, il quale, una volta consegnatosi venne messo a morte e ucciso da Aureliano, contro il parere dello stesso Claudio. Dopo aver affidato ad Aureliano la conduzione della guerra contro i barbari della Meotide (Eruli e Goti), oltre al comando generale della cavalleria "mobile" (magister equitum), come testimonia la stessa Historia Augusta: "Flavio Claudio saluta il suo Aureliano. La nostra repubblica si aspetta da te, come al solito, di contribuire con la tua opera: accostati a ciò. Voglio che i soldati siano sotto il tuo comando [...]. Bisogna attaccare i Goti e cacciarli dalla Tracia. Molti di quelli che infatti tu combattesti e che fuggirono, vessano l'Haemimontus e l'Europa. Affido a te il comando di tutti gli eserciti di Tracia, dell'Illirico e dell'intera frontiera. Svela a noi la tua solita virtù. Sarà al tuo fianco mio fratello Quintillo, quando potrà raggiungerti. Io sono impegnato in altre faccende, affido il comando supremo della guerra alle tue virtù." (Historia Augusta, Divus Aurelianus, 17.1-4) Si recò, in primis, a Roma per omaggiare il senato romano e ottenere la ratifica del titolo di Augustus (conferitogli in precedenza dalle armate settentrionali), oltre ad ottenere il consolato per l'anno successivo e la deificazione di Gallieno. Claudio non volle commettere l'errore del suo predecessore, Massimino Trace (235-238), il quale, una volta dopo aver ottenuto la porpora imperiale, non aveva mai messo piede nella capitale e aveva preferito trascorrere il suo regno lungo i confini settentrionali, senza mai omaggiare il senato romano. La sua assenza, se gli assicurò il sostegno del Senato, provocò nondimeno lo sfondamento del limes danubiano da parte dei barbari, tanto da costringerlo di lì a poco a far ritorno nel nord dell'Italia (inizi del 269), dove costrinse gli Alemanni a interrompere le loro scorrerie e a trattare il loro ritiro dal suolo italico. Il mancato accordo costrinse Claudio a combatterli. Egli, infatti, riportò la vittoria decisiva agli inizi di novembre, nella battaglia del lago Benaco (il lago di Garda) che, come racconta Aurelio Vittore, permise la loro definitiva cacciata dall'Italia settentrionale con gravissime perdite. Si racconta che più della metà dei barbari perì nel corso della battaglia (forse addirittura 50.000). Per questo successo ottenne il titolo di Germanicus Maximus. Narra la Historia Augusta che verso la fine del 268, l'usurpatore Leliano (probabilmente governatore della Germania superiore), si era ribellato nell'Impero delle Gallie a Postumo, il quale lo aveva assediato a Mogontiacum, suo quartier generale e dove trasferì anche la sua zecca personale. Sembra però che al termine dell'assedio, sia Leliano sia Postumo siano rimasti uccisi. Postumo venne ucciso dai suoi soldati poiché non aveva concesso il saccheggio della città renana. Questi scontri destarono forte preoccupazione in Claudio, che preferì ritardare la sua partenza per il fronte balcanico, preferendo però osservare gli eventi da lontano, senza dover intervenire direttamente. "Molte città della Gallia e anche molte fortezze che Postumo aveva costruito in territorio barbarico [oltre il fiume Reno] nel corso di sette anni e che, dopo la sua morte, erano state distrutte e incendiate durante un'improvvisa incursione dei Germani [si trattava o dei Franchi o degli Alemanni, al principio del 269], [Leliano] le ricostruì riportandole al precedente stato." (Historia Augusta, Triginta tyranni, 4.) Claudio, in seguito, operò una scelta strategica di non poco conto: preferì intervenire lungo il fronte balcanico contro i Goti, piuttosto che cercare lo scontro "fratricida" contro le forze secessioniste dell'Impero delle Gallie. Affidò, quindi, al fratello Quintillo il comando delle armate dell'Italia settentrionale, a guardia del fronte occidentale, e partì per il limes danubiano, ricongiungendosi con Aureliano e Marciano. Frattanto a Postumo e Leliano succedette Vittorino (verso la fine del 268 o gli inizi del 269). Quest'ultimo venne riconosciuto dalle province di Gallia e Britannia, ma non da quella della Hispania, che tornarono sotto il dominio dell'impero "centrale". Subito dopo (nel 269), un certo Giulio Placidiano, vir perfectissimus e praefectus vigilum, venne inviato nella Gallia Narbonensis dall'imperatore Claudio a occupare i territori sottratti all'impero "centrale". Placidiano riuscì probabilmente a riconquistare la parte orientale della Narbonensis, controllando la bassa valle del Rodano, nello stesso periodo in cui le truppe renane dell'Impero delle Gallie di Vittorino marciavano su Augustodunum per sedare una rivolta, scoppiata forse in coincidenza con l'arrivo di Placidiano. Vittorino, alla fine, riuscì a impedire che la città ribelle di Augustodunum Haeduorum (Autun), che aveva richiesto l'intervento militare di Claudio, ritornasse anch'essa all'impero "centrale". Assediò, infatti, la città per sette mesi, prima di conquistarla e saccheggiarla (estate 270). Claudio, impegnato com'era nella guerra contro i Goti, suo obbiettivo prioritario, non poté fare altro che assistere all'inutile secessione di parte della Gallia Narbonense, senza poter intervenire direttamente. Egli cercò nei pochi anni di regno di risolvere la difficile situazione interna e contemporaneamente fronteggiò con energia le gravi invasioni barbariche, affrontando con successo diverse popolazioni che si erano riversate entro i confini dell'Impero in grandi battaglie campali. Dopo gli Alemanni, fu la volta di Goti (tra cui Grutungi, Ostrogoti, Tervingi e Visigoti), Peucini, Eruli e Gepidi, che stavano devastando l'Acaia e le coste del Mar Mediterraneo. La Historia Augusta cita una lettera che Claudio avrebbe inviato al Senato romano nella quale dava indicazione del numero dei barbari: "Claudio imperatore al senato e al popolo romano. O senatori ascoltate e rimanete sbalorditi, per ciò che è la verità. Trecentoventimila barbari sono penetrati in armi in territorio romano. Se riuscirò a vincerli, ricompensatemi sulla base dei miei meriti. Se non ci riuscirò, sappiate che mi sono sforzato di combatterli, dopo il regno di Gallieno. La Repubblica è stremata. [...] Non rimangono ormai più scudi, né spade, né pila. La Gallia e la Spagna sono nelle mani di Tetrico, mentre gli arcieri sono sotto il controllo di Zenobia. Qualunque cosa riusciremo a fare, sarà già abbastanza grande." (Historia Augusta, Divus Claudius, 7.2-5) Agli inizi del 269, dopo che per alcuni mesi i Goti erano stati tenuti a bada dalle armate romane di Marciano, Claudio riuscì a raggiungere il teatro degli scontri e a riportare una vittoria decisiva su queste genti nella battaglia di Naisso, dove si racconta che persero la vita ben cinquantamila barbari, mentre pochi poterono far ritorno oltre il Danubio. E così il senato di Roma gli tributò, per i successi ottenuti insieme a Marciano, una statua, oltre al consolato. I Germani erano arrivati nel cuore della Mesia percorrendo la strada che da Tessalonica conduce a Scupi e poi verso nord, dopo aver devastato i territori attorno a Pelagonia (l'attuale Bitola). I sopravvissuti alla battaglia di Naisso, proteggendosi con i carri, si diressero in Macedonia. Durante la lunga marcia sulla via del ritorno, molti dei barbari morirono insieme alle loro bestie, oppressi dalla fame; altri furono uccisi in un nuovo scontro con la cavalleria romana degli "equites Delmatae", la riserva strategica mobile appena istituita da Gallieno. La marcia dei Goti proseguì in direzione orientale verso il monte Hemaus. Tuttavia i barbari, seppure circondati dalle legioni, riuscirono a procurare non poche perdite alla fanteria romana, che fu salvata solo grazie all'intervento della cavalleria affidata ad Aureliano, alleviando la sconfitta. Contemporaneamente le altre orde di Goti, che si erano riversate l'anno precedente (nel 268) nel Mare Egeo e nel Mediterraneo orientale e avevano compiuto azioni di pirateria, furono respinte definitivamente dopo una serie di scontri dall'accorrente prefetto d'Egitto, Tenagino Probo, nelle acque di fronte alle isole di Cipro, Creta e Rodi. La Historia Augusta, riferendosi a un discorso di Claudio gli fa pronunciare queste parole: "Abbiamo distrutto trecentoventimila Goti e abbiamo affondato duemila navi. I fiumi sono ricoperti degli scudi del nemico, tutte le spiagge sono ricoperte di spade e lance. I campi neppure più si vedono nascosti dalle ossa, non esiste alcuna strada libera, numerosi carri sono stati abbandonati. Abbiamo catturato tante donne, che i nostri soldati vincitori ne possono tenere per sé due o tre a testa." (Historia Augusta, Divus Claudius, 8.4-8.6) In sintesi il principale teatro della guerra gotica furono le province romane delle due Mesie e della Tracia. Vennero combattute numerose battaglie nei pressi di Marcianopoli, di Bisanzio e di Tessalonica (presa d'assalto dai barbari in assenza di Claudio). Ovunque si combatté sotto il comando di Claudio, le truppe romane ottennero la vittoria sui Goti. Vennero catturati molti barbari, tra cui numerose donne nobili dei barbari, e le province romane si riempirono di servi e agricoltori della coalizione dei Goti, trasformando questi ultimi in coloni del territorio di frontiera. Alla fine della guerra, Claudio aveva così procurato alla Repubblica romana, sicurezza e abbondanti ricchezze. In seguito a questi eventi Claudio, che era riuscito a ricacciare oltre il Danubio quell'immensa orda barbarica, poté fregiarsi dell'appellativo di "Gothicus maximus" e le monete coniate quell'anno ne celebrarono la "Victoria gothica". Dei barbari superstiti, una parte fu colpita da una terribile pestilenza, un'altra entrò a far parte dell'esercito romano, e un'ultima si fermò a coltivare le terre ricevute lungo i confini imperiali. Vi è da aggiungere che, in questo periodo, le forze militari romane presenti in Dacia erano ormai allo stremo. Evidentemente quando Aureliano gli subentrò nell'impero (estate del 270), la situazione nella provincia d'oltre Danubio era ormai irrimediabilmente compromessa e prossima all'abbandono definitivo, come accadde tra il 271 e il 274. Mentre Claudio era impegnato nelle guerre di confine contro i Goti, Zenobia, regina dei Palmireni, dopo la morte del marito Odenato, prese sulle spalle il manto imperiale. Successivamente inviò due suoi generali, Settimio Zabdas e Timagene, a conquistare la provincia romana d'Egitto (nel 269/270), importante granaio imperiale. Alla fine Timagene riuscì a uccidere in un agguato il prefetto d'Egitto, Tenagino Probo e le armate palmirene di Zabdas ottennero la vittoria, mentre tutti gli Egiziani facevano atto di sottomissione a Zenobia di Palmira, giurandole fedeltà e riconoscendola come Regina d'Egitto. Con l'inizio del 270, vide la fine della guerra gotica. Infatti i Goti superstiti, che erano confluiti nella regione dell'Haemimontus, furono decimati da fame e pestilenza, senza che Claudio decidesse di intervenire per dar loro il colpo di grazia. E così mentre l'imperatore era ancora impegnato nelle regioni del basso Danubio, forse in una campagna contro i Vandali, una nuova invasione di Iutungi tornò a procurare ingenti danni più ad occidente, in Rezia e Norico. Claudio, costretto a intervenire con grande prontezza, affidò il comando balcanico ad Aureliano, mentre egli stesso si dirigeva a Sirmium (Sremska Mitrovica in Voivodina), suo quartier generale (estate del 270), da dove poteva meglio controllare e operare contro i barbari. Poco dopo tuttavia morì, in seguito a una nuova epidemia di peste scoppiata tra le file del suo esercito (luglio/agosto). La sua morte venne interpretata, in modo assai retorico, come sommo sacrificio dell'imperatore per salvare l'impero stesso (res publica), come sembra fosse stato predetto dagli Oracoli sibillini. Non si può tuttavia escludere che l'imperatore sia stato avvelenato per ordine di qualche rivale. La sua morte fu una disgrazia per l'impero romano che aveva finalmente trovato un uomo capace di accontentare tutti: senato, esercito e popolo. "In suo onore, tutto il Senato dispose che fosse collocato nella curia romana un clipeus d'oro (uno scudo), sul quale si riconosce la sua immagine in un busto in rilievo. A lui, il popolo romano eresse a proprie spese sul Campidoglio, davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo, una statua d'oro alta dieci piedi. In suo onore, per volontà di tutto il mondo, fu posta sui rostri [nel foro romano] una colonna palmata, sopra la quale venne posta una statua d'argento del peso di 1.500 libbre." (Historia Augusta, Divus Claudius, 3.3-4) E mentre Claudio moriva, il fratello Quintillo, uomo di elevate virtù, secondo quanto ci racconta la Historia Augusta, assunse l'impero conferitogli per consenso unanime, non per diritto di eredità, ma per merito delle sue doti. Pochi giorni più tardi veniva ucciso o, più probabilmente, si tolse la vita ad Aquileia, lasciando che fosse Aureliano a ereditarne l'impero.3 punti
-
A proposito del cosiddetto tradimento della NATO nei confronti della Russia, stai dimenticando un piccolo dettaglio, e anche se questi « patti » verbali sono esistiti (Da quando trattati internazionali che coinvolgono diversi paesi possono essere assimilati a chiacchierate tra due « gentiluomini »?) sono anteriori alla dissoluzione del patto di Varsavia (luglio 1991) e i paesi dell’est facevano ancora parte del blocco sovietico. Poi (non so se ti ricordi questo dettaglio?) si sono emancipati e hanno acquistato il diritto di tutti i paesi riconosciuti internazionalmente all’autodeterminazione, a scegliere liberamente il proprio destino, e proteggere i propri confini. Puoi anche non essere d’accordo con la loro scelta, ma per loro significava integrare la NATO, ed era lecito, a meno di considerarli ancora e per sempre vassalli del ex URSS. «Considerando la situazione del nuovo mondo », non credo che se ne pentano. Hai una memoria selettiva. Si potrebbe anche parlare del documento firmato dai russi nel 1997, l’ «atto fondatore Nato/Russia », nel quale si impegnavano con i « partner » della Nato a garantire uno spazio di pace e di sicurezza nella zona euro-atlantica e l’integrità territoriale di tutti gli stati. I trattati, al pari dei patti verbali, sono validi finché non vengono rispettati da uno dei firmatari. Per quanto riguarda la presunta illegittimità dell’attuale parlamento ucraino, bisogna ricordare la dichiarazione all’ottobre 2012 del Ministro degli Esteri russo, riconoscendo che le elezioni si erano svolte “pacificamente, senza alcun eccesso e in linea con gli standard generalmente accettati” e che “hanno confermato l’impegno dell’Ucraina teso alla democrazia e allo stato di diritto”. Ma quando questo parlamento decide la destituzione di Ianukovič, presidente sotto l’ombrello di Mosca, non è più legittimo per farlo?3 punti
-
Come si fa a "mettere all'indice" la letteratura russa e che diavolo centra il cosmonauta ? Ormai non mi stupisco più, rimando a "Allegro ma non troppo", un libro di Carlo M. Cipolla. Le leggi fondamentali della stupidità umana Prima Legge Fondamentale: sempre e inevitabilmente ognuno di noi sottovaluta il numero di individui stupidi in circolazione. Seconda Legge Fondamentale: la probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della persona stessa. Terza (e aurea) Legge Fondamentale: una persona stupida è una persona che causa un danno a un'altra persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita. Quarta Legge Fondamentale: le persone non stupide sottovalutano sempre il potenziale nocivo delle persone stupide. In particolare, i non stupidi dimenticano costantemente che in qualsiasi momento e luogo, e in qualunque circostanza, trattare e/o associarsi con individui stupidi si dimostra infallibilmente un costosissimo errore. Quinta Legge Fondamentale: la persona stupida è il tipo di persona più pericoloso che esista.3 punti
-
Eccoci.. buongiorno a tutti. Come da accordi, vi invio le foto dei manifesti che apparvero nelle varie banche, avvisando il fuori corso per alcune banconote. Queste sono fotocopie tratte direttamente dagli originali. Gli originali li aveva Giulianini.3 punti
-
Segue il link ad un interessante studio di @King John su uno statere inquadrabile in epoca posteriore al 510 che integra ed amplia il quadro della monetazione sibarita fin qui proposto. https://www.academia.edu/38342474/F_De_Luca_Lo_statere_della_rifondazione_in_Il_Gazzettino_di_Quelli_del_Cordusio_Milano_Gennaio_2019_pagg_47_542 punti
-
Come si fa a mettere da parte e ignorare : 1) Governo e parlamento italiani 2) Idem UE 3) Bidon , Pelosi & Co. 4) TV e Giornali "mainstream"2 punti
-
Scarto di Zecca. Confrontato con esemplari coniati in modo corretto. Nell'ultima immagine l'ho sovrapposto su un Grano simile.2 punti
-
Buongiorno a tutti. Riccardo, in attesa di una risposta di Andrea , per la Napoletana di oggi resto in tema di errori di zecca con questo pezzo veramente particolare e unico: Grano Cavalli 1793.2 punti
-
Vediamo cosa scomparirà in Europa nel prossimo futuro. Prima di Putin e della Russia.1 punto
-
Ciao. Dovrebbe semplicemente trattarsi della moneta spicciola di rame, per lo più toscana e pontifica, circolante nei Reali Presidi. Non si fa riferimento a valute o nominali precisi ma, come ben sappiamo da altri documenti d'archivio, di monetine consunte, deformate o fuori corso ormai da sostituire delle quali si ordinò il ritiro «per rimediare alli sconcerti che si sperimentano nei Regj Presidj di Toscana, per cagione di quei quattrinelli informi che ivi correvano per monete» (Bovi, BCNN 1972). Ancora il Bovi (sempre BCNN 1972 ripreso anche a pag. 28 del mio libro) citò documenti dove a Napoli si ragionava che «per sostituirsi alli aboliti quatrinelli dovesse farsi una nuova moneta tutta particolare per quei regi Presidi...». In pratica qui quadrinelli è sinomino di spiccioli non napoletani!1 punto
-
Il processo di Norimberga è stato fatto da chi la guerra l'ha vinta. Non sono convintissimo che la Russia riesca a vincerla questa guerra.1 punto
-
1 punto
-
Ciao Aristarco, penso che sarà l'unica soluzione. Comunque (ultima spiaggia ?) ho scritto alla Casa de Moneta... Chissà... magari fuori e-shop qualcosa vendono. In caso di risposta affermativa vi farò sapere.1 punto
-
un denario di L. Minucius https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-G272/11 punto
-
Posto questa interessante tessera mercantile da classificare. 3,84 gr. Quartarolo toscano?1 punto
-
Più facile provare i crimini. Hai notato come ora in Europa stanno combattendo contro tutto il russo? Cultura, musica, balletto? Due esempi. Ai gatti russi proibito di essere alle mostre. Il miglior scacchista russo è stato escluso dalla competizione. Mi sembrava che i proprietari di animali domestici fossero le persone più gentili. Ho visto l'appello del proprietario di un gatto russo a cui non era permesso competere. Chiede di radere al suolo l'intera Europa con le bombe. La catena logica è chiara. Un po' più di stupidità da parte dell'Europa e Putin avrà le mani libere e il popolo russo lo benedirà per ogni atto. L'Europa si sta scavando un buco.1 punto
-
1 punto
-
Mi sembra che già il 14 Marzo alla mia "osservazione" #336 @Brios ha risposto in modo affermativo #3381 punto
-
Un po'di ottimismo: non dovremo più scervellarci per la transizione ecologica.... adesso si può inquinare tranquillamente come se non ci fosse un domani....1 punto
-
1 punto
-
Simile: FIRENZE (Sec. XIV) TESSERA - Famiglia Gherardini ?- D/Entro cerchio perlinato la lettera J con intorno 18 bisanti R/Monogramma G B (o J) inframezzato dalla croce, intorno 22 bisanti - Ae - Simile Vanni 1931 punto
-
Peccato per la mancanza ma questo denaro tornese è un vero e proprio documento storico. Che Nicola di Monforte abbia battuto denari tornesi è cosa risaputa, come è cosa nota che nessuno li voleva... "Lo conte de Campobasso già ha facto instantia de andarsene et così Jacomo Galiota et Jacopuzo da Montagano, perché non hanno portato altra moneta che tornesi novi, li quali esso Conte per forza faceva spendere in le terre sue et qua non ne possono alcuno, per il che già se è fuggito una grande parte della fanteria che menò con sé esso conte" Ma la città, terminata la congiura dei Baroni, fu perdonata per aver coniato tornesi: “a la dicta università generale et singulare persona, citatini et abitanti de essa tera, et presentim a ciascuno de ipsi, quali in tempo et sub dominio de lo excellente signor conte Cola de Campobasso sono stati soi officiali, presentim tempore presentis guerre, tenore presentis capituli concedere venia indulgentia, ita quod presens capitulum sit eis et unicuique ipsorum plenissimum et autenticum indultum et plenissima remissio de omni et singulo delicto, maleficio, crimine et omicidio, etiam de crimine lese maiestatis, in primo, secundo sive tertio capite, per ipsi o alcuno de ipsi commissi, consentuti et partecipati, et similiter de le false monete et denari, quovismodo per ipsi prenominati facti, cugnati et expesi, non obstante quod de tornensibus alias factis penes aliquos adhunc quantitatis aliqua reperiatur et forte in futurum reperiretur” Fatta questa doverosa premessa la moneta sub judice rappresenta, a mio avviso, un qualcosa che va oltre la semplice imitazione del denaro tornese. Il Conte di Campobasso ha coniato moneta a suo nome. Era ribelle al re... perchè quindi far coniare una moneta che riporti da un lato il riferimento alla città molisana e dall'altro un palese riferimento ad una zecca della Grecia Franca? Io sono dell'idea che prima della congiura il governatore degli Abruzzi Cola di Monforte, già facesse battere moneta. Facendo contraffazioni di denari tornesi della Grecia Franca. Una volta ribellatosi al re continuò con la coniazione ma uscì allo scoperto facendo battere monete a suo nome con particolare riferimento alla città di Campobasso. Questo esemplare quindi, a mio avviso, rientra in un periodo di passaggio tra il periodo di contraffazione e quello di imitazione. Una sorta di mule creato con un nuovo conio "imitativo" abbinato ad un vecchio conio "di contraffazione". Ovviamente ipotesi scaturite dopo una pesante giornata lavorativa... ? Moneta molto rara. Aggiungo un passaggio nell'asta Numismatica Picena nr. 1 lotto 131 ed un altro esemplare nell'asta Negrini nr. 32. Complimenti Eliodoro per l'ennesimo pezzo inserito in collezione. Sei quasi riuscito a svegliare il prolisso fedafa che è in me... ma di fronte a queste particolari monete non so contenermi.1 punto
-
La mia contromarca odierna: MARINO GRIMANI (1595-1605) SESINO CON CONTROMARCA LEONE - D/Croce pisana - Contromarca circolare "Leone" R/Il leone di San Marco -Mi - CNI T.XX,101 punto
-
Il libro di Fukuyama è stato citato più volte e probabilmente vale la pena leggerlo. Il riassunto che si fa della tesi di questo testo, ossia che la democrazia liberale e il capitalismo avrebbero spinto verso una situazione mondiale di benessere economico e di tranquillità mi è sempre sembrato una mezza sciocchezza (il libero mercato lasciato a se stesso alla lunga crea distorsioni e oligopoli, e la tendenza alla concentrazione del potere in poche mani). Ma senza una lettura seria del testo di Fukuyama non posso entrare nel merito delle argomentazioni fatte. Per cui posso solo attendere l'estate per avere abbastanza tempo da leggerlo. Aprendo una breve parentesi, ho sempre pensato che la dialettica fra classi diverse (quella che si chiamava lotta di classe) generalmente porta ad una sintesi tra interessi opposti che finisce per essere congeniale sia allo sviluppo economico che al benessere della società. Tra l'altro la situazione Russa è (a mio modestissimo avviso naturalmente) proprio una delle conseguenze delle aberrazioni estreme del capitalismo. Dopo la fine dell'URSS il capitale accumulato da generazioni di Russi è finito nelle mani di pochi che lo hanno gestito creando una democrazia autoritaria. Un buona parte della ricchezza Russa si trova all'estero. In presenza di forti ingiustizie sociali purtroppo torna di moda la vecchia favola del nazionalismo, che rappresenta una valida valvola di sfogo per le masse depauperate. La crisi Ucraina e il panslavismo sono tra le conseguenze del nazionalismo Russo.1 punto
-
In effetti le uniche due aste sulla baia tedesca sono a 56€ entrambe a 5 giorni dalla chiusura. Sulla baia italiana invece simo a livelli assurdi, anche ben oltre i 100€1 punto
-
E' sicuramente selvatico manca solo la prima parte della parola1 punto
-
Aggiornamento sul 1 cent 1988 con /R 1989: Da una ricerca fatta su 3 siti americani che sono Varietyvista.com- Lincoln forum- e Error-Ref.com è saltato fuori che i gradi di rarità che i 3 attribuiscono sono difformi. Quel che è certo è che abbiamo 7 varianti per la zecca P e 11 varianti per la zecca D quelli della zecca D sono più rari rispetto alla zecca P poichè sono stati più veloci nell'accorgersi del fatto e ritirare le monete prima della zecca P, pertanto nei ritrovamenti abbiamo una incidenza di 3 a 1 per la zecca P nonostante abbia meno varianti rispetto alla zecca di D. nel caso oggetto del topic che è la zecca P queste sono le indicazioni di rarità: Varietyvista.com : EXTRA RARE( per entrambe) Error-Ref.com : SCARCE( sarebbe il nostro NC) per P e RARE per D Lincoln forum : Rare per P and EXTRA RARE per D poichè di solito la verità sta nel mezzo e dato che il Lincoln Forum parla e studia solo di quello tendo a credere che la rarità del mio 1 cent sia RARE . per conoscenza @miza @petronius arbiter visto che vi siete interessati e vi ringrazio. Saluti.1 punto
-
Fase B La fase B, in assoluto la più abbondante (56,12%), include 695 ess. che documentano tre distinti tagli nominali: stateri, dracme e oboli (tavv. 4-6), tratti complessivamente da 229 coppie di coni (149 per gli stateri, 46 per le dracme e 34 per gli oboli). Elemento peculiare di questo segmento produttivo è la posizione dell’etnico (VM), che sugli stateri (tav. 4) e sulle dracme (tav. 5) è posto in esergo e non nel campo in alto come nella fase precedente. Gli oboli, invece, associano al consueto toro del D/, le lettere MV entro quattro globetti al R/ (tav. 6). 4-UBS 53, 2002, 13 (= Spagnoli 102.a) 5- Künker, 82, 2011, 57 ( = Spagnoli 1013.a) 6- Peus 376, 2003, 118 (= Spagnoli 2002.a) In alcuni casi (non rilevati dalla Spagnoli) l’esecuzione grafica della legenda risulta incerta: RN 1, 2018, 23 (coll. privata) All’interno di questa fase produttiva (classe epigrafica E) si collocano due stateri tratti dagli stessi conii (tav. 7.1-2) con l’etnico in forma eccezionalmente allungata (MVBAPITAM) e due dracme, caratterizzate dalla legenda VM in esergo al D/ e MV in alto al R/ (tav. 8; https://www.lamoneta.it/topic/181338-statere-di-sibari-con-etnico-completo/#comment-2025132; https://www.lamoneta.it/topic/169285-subaritas/#comment-1905089). 7.1-Berlin, SM 18215968 (dal ripostiglio di Cittanova 1879, IGCH 1889 = Spagnoli 111.a) 7.2-RN 18, 2019, 406 (ex BFA 44, 2018, 46 ex coll. Monegasque) 8-Paris, BNF, Luynes 556 ( = Spagnoli 1006.b) E’ stata altresì rilevata (https://www.lamoneta.it/topic/174785-varianti-epigrafiche-sibarite/#comment-1960434) la presenza di uno statere caratterizzato da una rara variante grafica della legenda: BFA – ACR 64, 2019, 95 (ex BFA 32, 2016, 110)1 punto
-
Riccione ha 2 piani del palazzo del turismo con numismatica e filatelia, Bologna ha almeno il doppio degli espositori ad occhio.1 punto
-
1 punto
-
Mi piacerebbe molto in effetti,capire cosa è successo a questi tondelli,sentir il parere di @andrea78ts sarebbe bello?1 punto
-
Sono 5 si imposta un sistema di 2 equazioni con 2 incognite x = 10 - Y : 3x = 10 + Y ; dove x e il numero di monete nel sacchetto e y è la differenza . risolvendo si ottiene 51 punto
-
1 punto
-
La colpa non è sempre degli altri mai la nostra: quindi se tuo figlio minorenne e senza patente ti chiede le chiavi della macchina è colpa solo sua se gliele dai..... Mi sembra che il discorso non fila proprio per logica!1 punto
-
Buonasera e grazie per il tuo apprezzamento! Il tema Wildman è molto presente nella mitologia germanica. "Le tipiche monete di Wildman mostrano una bestia gigantesca, solitamente pelosa e muscolosa, che indossa un perizoma di foglie, con solo le mani e i piedi privi di pelo. La creatura è spesso vista afferrare il tronco di un albero, a volte con una città o una foresta sullo sfondo. L'immagine è stata influenzata dalla tradizione pagana nella regione della montagna Harz in Germania, dove l'uomo selvaggio appare nel folklore e in altre forme d'arte, non esclusivamente sulla moneta. Harz (nella zona di Braunschweig) era un'importante regione produttrice di argento e le immagini sono un riferimento alla città mineraria Wildemann e alla leggenda della sua fondazione. Secondo la storia, nel 1529, i minatori inviati alla ricerca di nuovi giacimenti di minerali scoprirono un uomo selvaggio che viveva con una donna selvaggia. Lo catturarono, ma morì a causa delle ferite riportate. Secondo quanto riferito, grandi giacimenti di minerale d'argento furono scoperti dove aveva vissuto'. Personalmente ho solo un taler Wildman, ma di Erfurt!1 punto
-
Grazie mille! Le grandi monete d'argento sono davvero interessanti, soprattutto quelle del XVI-XVIII secolo! Ho altro sulla mia pagina insta se sei interessato a controllare: passionforcrowns1 punto
-
Grazie all'intuizione dell'ottimo @gpittini sono riuscito a risalire a questi dati : Grazie ancora.1 punto
-
Nelle Piastre del 1815 si conosce quel conio di rovescio con "punto" dopo ET , ma avendone un esemplare in collezione, per me è un semplice esubero di metallo.1 punto
-
1 punto
-
Come conio per il diritto è unico, abbinato a due diversi rovesci. Il conio del diritto ha ragione, @giuseppe ballauri, è uguale per tutte e 3 le piastre.1 punto
-
Ciao, Beppe Mi sembra che tutto ciò che tu hai esposto corrisponda alla realtà delle cose. Ho notato anche io che il doppio rombo dopo la “D” è sempre abbinato alla mancanza del rombo dopo la data. Mi sembra anche che la variante compaia solo relativamente al millesimo 1815. Per quanto riguarda il numero di conii interessati, invece, mi sembra siano due. Il mio esemplare corrisponde a quello con alla base il numero 335 pubblicato da Raffaele; l’altro, sempre pubblicato da Raffaele, mi pare diverso. Il rombo dopo “Infans” ,infatti,ha una posizione differente nei due conii, così come sono differenti vari altri particolari. Per il resto, la tua analisi risulta credibile ed utilissima, anche se i dati,naturalmente,necessitano di conferme. Grazie1 punto
-
1 punto
-
Buonasera, Tornese da 6 Cavalli 1792 con forte decentratura di conio. Errore di coniazione che sarebbe piaciuto tanto ad @andrea78ts. ?1 punto
-
Complimenti agli autori e alla edizioni D' Andrea che pubblica sempre libri di notevole interesse numismatico1 punto
-
 Nel 2019 ho pubblicato insieme ad Malcor A. L. e Trinchese A. la nuova lettura dell'epigrafe di LAC e nel prossimo incontro, probabilmente a Procida, darò dei riferimenti abbastanza precisi sulla datazione dell' epigrafe e carriera di Castus. Sono stati trovati altri reperti relativi alla gens Artoria (di cui ho scritto) in Britannia.1 punto
Nel 2019 ho pubblicato insieme ad Malcor A. L. e Trinchese A. la nuova lettura dell'epigrafe di LAC e nel prossimo incontro, probabilmente a Procida, darò dei riferimenti abbastanza precisi sulla datazione dell' epigrafe e carriera di Castus. Sono stati trovati altri reperti relativi alla gens Artoria (di cui ho scritto) in Britannia.1 punto -
E’ ancora presente nelle emissioni di Valeriano e del figlio Gallieno. Poi a seguito dell’ennesima riforma scompare. Per cercare altri esemplari sono andato a “sfogliare virtualmente” il catalogo online della American Numismatic Society: http://numismatics.org/ocre/results?q=authority_facet%3A"Valeriano" AND denomination_facet%3A"Dupondio"&lang=it&start=0 Che però ha un difetto: è basata sul RIC quando il testo di riferimento per il periodo è il Goebl! Accedo comunque al sito ANS di cui sopra dal quale trovo indicazione di un RIC 258 di Gallieno (dupondio VOTIS DECENNALIBVS del 253 d.C.) proposto come dupondio: Radiato, 23 mm 9.06 g Laureato, 24 mm 9.54 g Laureato, 24 mm 9.17 g Quindi secondo ANS abbiamo anche in Gallieno evidenza di pesi calanti rispetto al dupondio e ritratto radiato in un caso dei tre proposti. Anche qui… dupondio leggerino, asse “cicciotto” (e perché radiato?) o sesterzio molto sottopeso? Confrontiamo con il Goebl (non senza aver prima ringraziato @grigioviola per la consulenza) : Esistono serie costituite da sesterzi – dupondio (radiato) - asse come quella sopra. Regno congiunto Valeriano-Gallieno, zecca di Roma, emissione I, Goebl 253/254. Quindi abbiamo quello che Goebl indica come ultimo dupondio. Gallieno, regno da solo, IMP GALLIENVS PF AVG/VOTIS DECENNALIBVS emesso a Roma, VII emissione (262 d.C.) di cui abbiamo la serie completa dei tre nominali bronzei: che equivale al RIC 258 di ANS ma ci dimostra che esiste tutta la serie completa. Per quanto concerne poi Mariniana (in riferimento alla discussione di cui in apertura) abbiamo questo schema delle emissioni : Segnate come 1-5 perché non collocabili con precisione in una emissione, quindi finestra temporale ampia 253/259 d.C. E come noterete, il Goebl (che qualcosa ne sapeva) segnala antoniniani, sesterzi e assi a nome suo ma NON DUPONDI. Se torniamo all’ANS, troviamo infine un dupondio di Salonina con crescente (257-8 d.C.) https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1931-0712-2 Peso: 14,97 g che rientrerebbe con il limite temporale (262) proposto dal Goebl per i dupondi.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?






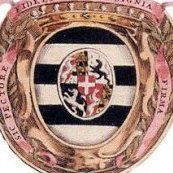

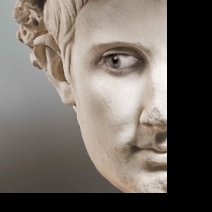





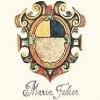


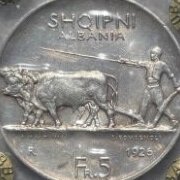
copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)