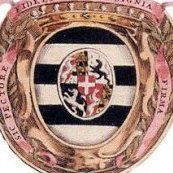Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 05/09/22 in tutte le aree
-
In realtà il punto di vista di Cipolla sulle svalutazioni tende ad una visione articolata e complessa, lontana dai manicheismi di giusto o sbagliato in senso assoluto, in ciò tende ad agganciarsi al dibattito sul tema degli alzamenti e diminuzioni monetarie iniziato già a partire dalla metà del settecento con i vari Broggia, Pompeo Neri, Galiani... anche in altre sue opere come "il fiorino e il quattrino", "La moneta a Firenze nel cinquecento", "Storia economica dell'Europa preindustriale" il tema della svalutazione è al centro del discorso, a suo modo di vedere le cause della svalutazione e dei mutamenti di valore delle monete possono essere diversi e non sempre da giudicare in maniera negativa, in alcuni casi sono necessari per adeguare il valore delle monete emesse a quello dei metalli realmente operante sul mercato, onde evitare la fuoriuscita più o meno catastrofica delle monete non allineate con i valori di mercato, un esempio a tal proposito, inerente gli effetti negativi di una politica monetaria troppo rigida e volta alla stabilità a qualunque costo, è quello narrato nel suo volume sulla moneta a Firenze nel cinquecento, dove la visione di assoluto rigore del duca Cosimo sul mantenimento di alti valori della moneta grossa finì per arrecare danni cospicui con la sparizione dalla circolazione delle monete più pregiate... nell'opera il fiorino e il quattrino invece si concentra proprio sul tema della svalutazione della moneta piccola opposta alla stabilità di quella grossa, anche li il discorso è articolato e legato al contesto politico della Firenze di quel tempo, governata da elites mercantili e agenti una politica monetaria favorevole agli interessi del grande commercio, dove servivano monete grosse e stabili, piuttosto che le monete piccole, fiduciarie, utili solo nel commercio ordinario, al minuto... la politica monetaria non è mai neutrale, serve sempre interessi legati alle fazioni che di volta in volta si alternano al comando... Sul tema consiglierei un volume di un altro grande maestro di storia economica e monetaria, Marcello de Cecco, " Moneta e impero", in cui si approfondisce la dinamica del come la scelta del sistema a base aurea di gold standard obbediva a precisi interessi di potere sia sul piano internazionale che interno...4 punti
-
Buongiorno, la presentazione che Vi propongo è un piccolo lavoro incentrato sulla Britannia e i suoi riflessi nella monetazione imperiale romana. Non è definitiva (alcune monete sono difficili da reperire come immagine) ma ritengo di aver raccolto un discreto catalogo tematico. Buona lettura! Britannia Romana: le emissioni numismatiche imperiali nel periodo tra Claudio e ai Severi. PROLOGO: L’esistenza della Britannia era nota alle popolazioni mediterranee fin dall’antichità classica grazie alle rotte commerciali di greci e cartaginesi finalizzate al reperimento di minerali ricchi di stagno di cui l’isola britannica era ricca. Le imbarcazioni, una volta superate le Colonne d’Ercole (Stretto di Gibilterra), costeggiavano le coste atlantiche spagnole e francesi e raggiungevano la Manica. Per i Greci le isole britanniche infatti avevano assunto il nome di Cassiteridi (Κασσίτερος / Kassiteros = isole dello stagno) e vari geografi greci ne diedero descrizioni perlopiù vaghe o riportate. Le prime citazioni nei testi latini riferite all’isola britannica risalgono al De bello Gallico di Giulio Cesare dove è riportato che durante la campagna gallica le popolazioni isolane fornivano appoggio alle tribù galliche continentali contro i Romani. E’ tuttavia verosimile ritenere che le motivazioni che spinsero Cesare ad invadere la Britannia fossero molteplici e tra queste la ricerca di fama e gloria personale e la possibilità di ottenere magari ulteriori richezze. Cesare condusse a scopo intimidatorio due spedizioni sull’isola, una con forze militari contenute (quasi una sorta di esplorazione) nel 55 a.C. e una seconda l’anno seguente con l’impiego di ben 5 legioni, 2000 cavalieri e 800 navi da guerra e da carico. In quest’ultima, dopo una prima vittoria romana i Britanni attaccarono il campo romano; il contrattacco portò i Romani ad avanzare nei territori britannici, conquistando anche un oppidum locale. Alla luce della malparata, il principe britanno Cassivellauno comandante della coalizione fu costretto a mediare la pace con Giulio Cesare, raggiunta con l’aiuto di alcuni capitribù filo-romani. Fu stipulato il pagamento di un tributo annuale e la consegna di ostaggi; oltre a ciò fu sancito che le tribù britanniche alleate di Roma non venissero attaccate dalla fazione anti-romana pena un intervento militare da parte di Roma. Stabilito ciò, Cesare rientrò in Gallia: l’isola britannica era entrata nella sfera d’influenza romana pur senza alcuna reale conquista territoriale ma mediante la creazione di una serie di clientele e di rapporti diplomatici e commerciali. Questo sistema resse per un po’ di tempo, con l’invio di ambasciatori tra le due parti e il rafforzamento degli scambi commerciali: Ottaviano pianificò più invasioni mai messe in pratica e lo stesso accadde per Caligola (40 d.C.). LE CAMPAGNE MILITARI ROMANE Parte 1 – da Claudio a Commodo 43 d.C. – La conquista romana della Britannia Nel tempo le frizioni ed i contrasti tra tribù britanniche si acuirono anche con appelli all’intervento militare di Roma da parte di principi tribali alleati; le richieste d’intervento rimasero inascoltate dagli Imperatori romani fino a che queste divennero il comodo casus belli per Claudio. Questi, desideroso di celebrare la propria gloria con una conquista militare prestigiosa (si trattava pur sempre di una terra lontana e poco conosciuta ma la cui conquista era sfuggita a vari suoi famosi predecessori) accolse l’esortazione all’intervento militare romano posta da Verica, principe britannico della tribù degli Atrebati, già alleati di Giulio Cesare, deposto ed espulso da Caratacus, capotribù dei Catuvellauni. Il grosso dell’esercito romano costituito un contingente militare composto da quattro rodate legioni (II Augusta, IX Hispania, XIV Gemina e XX Valeria Victrix) affiancate da circa 20.000 truppe ausiliarie batave sbarcò nelle coste meridionali dell’isola al comando di Aulus Platius (Alio Plauzio) e di altri comandanti tra i quali Titus Flavius Vespasianus, il futuro imperatore. Le truppe romane sconfissero i Britanni guidati da Caratacus e dal fratello Togodumnus (Togodumno) nei pressi dei fiumi Medway e Tamigi, conquistarono la capitale cateuvellauna Camulodunum (Colchester) ed imposero il dominio romano nel sud dell’isola britannica. Per avanzamenti successivi nei successivi quattro anni di conflitto Roma potè vantare la conquista di tutta la Britannia meridionale esclusi i territori dell’attuale Galles che vennero acquisiti successivamente con varie campagne militari (nel periodo 60 - 78 d.C.).3 punti
-
Sarà mica la prima banconota fimata da Lagarde in persona? Puoi per favore controllarne le dimensioni? Appunto! ? ===== Credo inoltre che sia una comune banconota, null'altro. Servus Njk3 punti
-
Buona sera Daniele. Quantificare il valore di una banconota, così come per le monete, è una questione molto specifica: voglio dire che dipende non solo dalla rarità della tipologia in genere ma molta parte la gioca la specifica conservazione della singola banconota. Per esempio, se guardi un catalogo vedrai che molte tipologie hanno diversi decreti e che ogni decreto ha valori diversi a seconda che la specifica banconota si trovi in conservazione MB, BB, SPL o FdS. Quindi non basta avere un riferimento di massima per la rarità della tipologia/decreto ma bisogna saper valutare approssimativamente la conservazione. In pratica, ogni banconota/moneta è unica e in buona parte fa storia a sé. Non solo, ma come per il mercato azionario, anche il mercato numismatico segue delle tendenze, in certi periodi al rialzo in altri al ribasso. Il catalogo, invece, per sua natura non rileva i movimenti di mercato, è come se fosse una istantanea del mercato al momento della sua redazione. Per giunta, molto spesso, i prezzi di catalogo risultano gonfiati. Come fare allora? Il mio approccio è quello di stimare una media delle aste vendute recentemente e per fare questo io guardo su internet. Notare che ho detto "aste VENDUTE", non quelle in vendita e non ancora acquistate. Questo perché un venditore può chiedere il prezzo che vuole ma non è detto che lo ottenga. Quando la domanda di un certo prezzo incontra l'offerta di quel prezzo, allora quella cifra è una buona indicazione del reale valore di mercato IN QUEL DATO MOMENTO. Naturalmente, può capitare che un venditore fortunato abbia incontrato un collezionista molto desideroso di comprare quel particolare pezzo, o viceversa che un fortunato acquirente sia incappato in un venditore sprovveduto che vendeva sotto il prezzo di mercato. Per questa ragione è opportuno considerare più compravendite chiuse e stimarne la media. Puoi andare su ebay, digitare nella finestra di ricerca la tipologia che ti interessa e ricordarti di spuntare l'opzione "oggetti venduti" a sinistra: ti si aprirà una pagina di aste chiuse con i vari prezzi di vendita effettivamente PAGATI. Osserva bene il decreto e lo stato di conservazione delle singole banconote, aggiungi le spese di spedizione e avrai una panoramica aggiornata del valore di mercato x quel decreto/tipologia. Personalmente uso i cataloghi per la preziosissima disamina storica e per avere una lista completa dei decreti e delle tipologie, ma tendo a non dare troppa importanza alle indicazioni di prezzo, che spesso sono davvero fuorvianti. Perdona la lungaggine ma questo è un argomento molto complesso che ho cercato di semplificare per come ho potuto.2 punti
-
Ma come cacchio è che tutti trovano banconote, lingotti d'oro, pepite, diamanti in cassetti/cantine/soffitte mentre io trovo solo polvere, scarafaggi, scolopendre e topi morti ?? Mannaggia come è brutta l'invidia!! ? Bel ritrovamento! ?2 punti
-
Il tutto rientra nella normalità, come le banconote da 5 euro Draghi e/o Lagarde 2013 e le banconote da 10 euro Draghi e/o Lagarde 2014. esempio: Personalmente queste banconote le spendo solamente2 punti
-
Proseguo con il 1858. Riferimenti: D'Incerti 340 Pagani 376 Magliocca 715 NC Peso grammi 15,442 punti
-
grazie per la risposta, sono ben felice del tono amichevole, pure io sono un buontempone, ma di quelli grossi, sono felice di essere in mezzo a voi. ?2 punti
-
Ciao Mas benvenuto! se avessi davvero trovato una eurobanconota del 2015 firmata dalla Lagarde 4 anni prima che diventasse governatrice della BCE avresti fatto davvero un bel colpo. In realtà probabilmente è il modello di quella 20€ che è stato introdotto nel 2015 e man mano che i vari capi della bce si susseguono la firma cambia. Buona continuazione! (perdonami il tono, in questa sezione siamo un po’ tutti amiconi e ci prendiamo spesso e volentieri in giro)2 punti
-
2 punti
-
MONETAZIONE TEMATICA DI COMMODO (180-192 d.C.) Commodo. Æ sestertius ( 19.27 g, 30 mm, 12 h). Zecca di Roma. Emesso nel 184 d.C. M COMMODVS ANTONINVS AVG PIVS, testa laureata a destra / BRITT PM TR P VIIII IMP VII COS IIII PP Britannia stante verso sinistra reggente spada curva e corona (o patera), S C tra i campi. S. RIC III 437; Banti 20. (www.cngcoins.com) Commodo. Æ sestertius ( 27.47 g, 30 mm, 12 h). Zecca di Roma. Emesso nel 184 d.C. M COMMODVS ANTONINVS AVG PIVS BRIT, testa laureata a destra / PM T R P X IMP VII COS VIII P P Vittoria seduta verso destra su alcuni scudi,incide su uno scudo appoggiato sul ginocchio. VICT BRIT in esergo, S C tra i campi. S. RIC III 440; Banti 484; Cohen 945. (www.cngcoins.com) Commodo. Æ sestertius ( 26.43 g, 30 mm, 1 h). Zecca di Roma. Emesso nel 185 d.C. M COMMODVS ANTONINVS AVG PIVS BRIT, testa laureata a destra / PM T R P X IMP VII COS VIII P P Vittoria seduta verso destra, inscrive con uno stilo su uno scudo appoggiato sul ginocchio. VICT BRIT in esergo, S C tra i campi. S. RIC III 452; Banti 485. (www.cngcoins.com) Monete emesse da Commodo in commemorazione della vittoriosa campagna britannica condotta da Ulpio Marcello. A partire dal 184 d.C. aggiunge il titolo di Britannicus Maximus (BRIT) alla legenda del dritto.2 punti
-
La prima tipologia di conio, antecedente al 1671, con un Carlo II molto giovane. Senza data.2 punti
-
Ho memoria che all'inizio, 2002, quando uscì l'euro, apparvero, stranamente, banconote da 5 euro che erano tagliate "male", nel senso che erano sfalsate, cioè, la misura della banconota era giusta, ma una banconota riportava un pezzo della banconota successiva: per cui capitava che una banconota avesse due numeri di serie e , fatalità, erano con la X cioè Germania. Poi in fiera Verona ho saputo e visto, che la Germania distribuiva, va a capire perchè, dei fogli interi delle banconote da 5 euro, per cui ognuno poteva tagliarle come meglio gli piaceva, creando così le variabili volute. Coincidenza, anche queste stranezze sono con X. E' un caso o in Germania hanno più libertà di stampa?2 punti
-
Trovata! Spero... Dinaro algerino https://en.numista.com/catalogue/pieces2457.html2 punti
-
2 punti
-
2 punti
-
Catalogo degli esemplari (in ordine di peso decrescente): 1) SNG Davis, I/2, 44 (gr. 13,16) 2) BFA 113, 2022, 178 (gr. 10,10) 3) Collezione privata (per gentile concessione del collezionista: gr. 9,36) 4) BFA 59, 2018, 158 (gr. 9,22) 5) Künker 94, 2004, 233 (gr. 9,15) 6) Meepzorp's Ancient Coins (posted November 2015: gr. https://www.forumancientcoins.com/meepzorp/gi_brut_skyl_vibo.htm 7) BFA 68, 2019, 96 (gr. 8,70) 8 ) Paris, BNF, 1988.128 (gr. 8,70) 9) CNG 130, 2006, 87 (coll T. Hardy: gr. 8,64) 10) CNG-Triton V, 2002, 193 (gr. 8,62) 11) Paris, BNF, Chandon de Briailles 16 (gr. 8,54) 12) CNG 60, 2002, 176 (ex Semenzato, 29.11.1980, 199: gr. 8,42) 13) Peus 410, 2013, 33 (gr. 8,30) 14) SNG ANS 3, 800 (gr. 8,27) 15) Nomos AG-Obolos 6, 2016, 191 (coll. in Ticino: gr. 8,20) 16) Numismatique L. Brousseau (gr. 8,12) 17) Paris, BNF, Luynes 816bis (gr. 8,08) 18) SNG Kikpe, 134 (gr. 8,07) 19) Coll. P. Guillard, 7341 (www.ogn-numismatique.com/article.asp?langue=fr&article=7341: gr. 8,00) 20) CNG 367, 2016, 33 (ex E.L. Owen Ltd., Ancient Greek Coins, Coll. L, 3858 ex Virzì, 1907: gr. 7,93) 21) RN 25, 2016, 15 (ex LAC 54, 2016, 15 ex RN 7, 2014 ex coll. Bussey: gr. 7,90) 22) RN 69, 2020, 227 (coll. Amilcare: gr. 7,90) 23) Nomos-Obolos Web A. 13, 2019, 167 (gr. 7,82) 24) RN 91, 2021, 69 (coll. Z.P., Austria: gr. 7,79) 25) SNG Australia, 1221 (gr. 7,73) 26) Peus 421, 2017, 1030 (gr. 7,66) 27) RN 47, 2018, 50 (“coll. of a Scientist”. Ex InAsta 37, 2010, 22: gr. 7,53) 28) Lanz 138, 2007, 80 (gr. 7,41) 29) SNG Cop., 1992 (gr. 7,37) 30) SNG X, Morcom 878 (ex Leu 6, 1973, 48 ex Virzì 457: gr. 7,34) 31) RN 47, 2018, 49 (“coll. of a Scientist”: gr. 7,15) 32) Artemide LVI, 2021, 58 (gr. 6,90) 33) Künker 318, 2019, 290 (ex Savoca 10, 2016, 26: gr. 6,89) 34) Dr. R. Fischer, 167, 2019, 4 (ex 165, 2018, 8 ex 164, 2018, 2 ex 162, 2018, 13 ex 157, 2017, 1: gr. 6,82) 35) RN 17, 2015, 54 (ex RN 12, 2014, 78 ex coll. F. James: gr. 6,77) 36) Tintinna, 9.7.2020, 16 (gr. 6,70) 37) Gorny & Mosch 237, 2016, 1087 (ex Artemide XLI, 2014, 61: gr. 6,60) 38) Chaponnière & Firmenich SA 9, 2017, 23 (ex Naville XII, 1926, 655: gr. 6,54) 39) CNG 294, 2013, 18 (coll. R. e J. Diez. Ex coll. G. Philipsen: Hirsch XV, 1906, 877: gr. 6,49) 40) Peus 392, 2007, 4178 (gr. 6,44) 41) SNG Catanzaro II, 731 (gr. 6,43) 42) Artemide XLVII, 2017, 54 (gr. 6,31) 43) BFA 32, 2016, 142 (gr. 6,26) 44) BFA 83, 2020, 152 (gr. 6,22) 45) RN, 2014, 35 (coll. J. Swithenbank: gr. 6,19) 46) CNG 146, 2006, 18 (coll. Garth R. Drewry. Ex Coin Galleries, 1988, 179: gr. 6,19) 47) Gorny & Mosch 224, 2014, 40 (ex NAC 8, 1995, 442) 48) BFA 8, 2014, 64 (gr. 6,10) 49) Peus 407/8, 2012, 140 (coll. P. Hammerich: Peus 355, 1998, 31: gr. 5,97) 50) SNG Kikpe, 133 (gr. 5,95) 51) Paris, BNF, FG 2055 (gr. 5,81) 52) CNG 327, 2014, 309 (“Continental collection”: gr. 5,65) 53) SNG Cop., 1993 (gr. 5,54) 54) Paris, BN, FG 2054 (gr. 5,26) 55) Peus 371, 2002, 68 (gr. 5,13) 56) Hirsch 348, 2019, 136 (ex coll. R.P., 1997) 57) Coll. Virzì 458 58) Coll. Virzì 4592 punti
-
Da sempre ho una smisurata passione per i pezzi da un reale di Carlo II della zecca di Cagliari... Ma, per alcune date, è molto difficile trovare esemplari on line... Ed anche fisici... Chiederei il vostro aiuto per poter apprezzare gli esemplari che avete in collezione e magari analizzarne l' evoluzione stilistica.. P.S.: qualcuno possiede il 1691? Ed i maltagliati 1671-73?1 punto
-
Ciao a tutti! Posto qui uno dei due tipi di reale del 1671, diciamo il tipo più arcaico!1 punto
-
Lo schifo di periodo continua, ma anche per questo è importante festeggiare questo giorno. Auguri a tutti.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Entrambe false. Sono cosi' orrende e divertenti allo stesso modo. Basta leggere e vedere i lavori di Arslan e Pautasso per rendersi conto che sono carnevalate.1 punto
-
Sarò molto probabilmente presente anch'io per il gazzettino a cui sta volta ho contribuito! Purtroppo temo di non riuscire per il pranzo, per un prossimo incontro volentieri!1 punto
-
1 punto
-
Buongiorno, R-29 Bisognerebbe partire con foto migliori, altrimenti è impossibile esaminare le immagini. Anche migliorandole, io non riesco a vedervi nulla di decifrabile. Al recto mi sembra di intravvedere un a testa, volta a sinistra, e alcune lettere in alto sulla destra. Al verso, al centro forse c'era saldato un anello e in tal caso si tratterebbe di un bottone ma io ne dubito : per me resta "nacht und nebel" , mi spiace. Saluti.1 punto
-
Numismatica Ars Classica > Auction 132 Auction date: 30 May 2022 Lot number: 366 Price realized: This lot is for sale in an upcoming auction Lot description: Cilicia. Pharnabazus, 380-375 Stater, Tarsus circa 380-375, AR 10.38 g. bltrz in Aramaic characters Baaltars seated l., holding eagle-tipped sceptre in r. hand; in l. field, ankh. Rev. frnbz – hlk in Aramaic characters Bearded bust of warrior l. wearing crested helmet decorated with palmette on bowl. Moysey, Issue 2, 39-41. SNG von Aulock 5931. SNG Berry 1288. Rare. Surface somewhat porous, otherwise extremely fine Estimate: 3500 CHF1 punto
-
MONETAZIONE TEMATICA DI ANTONINO PIO (138-161 d.C.) (NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE) Antonino Pio. AV Aureus. Zecca di Roma. Emesso nel 143 d.C.. ? ANTONINVS AVG PIVS PP TR P COS III, testa laureata a destra / IMPER-A-TOR II, Vittoria stante su un globo rivolta a sinistra reggente corona e palma. S C e BRI-TAN tra i campi. RIC III 113; Cohen 113. R. Aureo commemorante le conquiste di Q. Lollius Urbicus. Il riferimento a IMPERATOR omaggia Antonino Pio come condottiero dell’esercito. Va segnalato che comunque in realtà il suo coinvolgimento fu limitato e non direttamente in loco: infatti non fu insignito del titolo di BRITANNICVS. Antonino Pio. Æ sestertius. (31 mm, 22.99 g, 5 h). Zecca di Roma. Emesso nel 143-144 d.C. ANTONINVS AVG PI-VS P P TR P COS III, testa laureata a destra / IMPERA-T-OR II, Vittoria alata e drappeggiata, stante verso sinistra su un globo, reggente una corona con il braccio destro steso e ramo di palma retto con il sinistro. BRI-TAN e S- C nei campi. R. RIC III 719; Strack 928; Banti 45; SCBC 643; BMCRE 1614. (www.cngcoins.com) Sesterzio chiaramente richiamante l’iconografia dell’aureo di cui al RIC 113. Antonino Pio. AV Aureus. Zecca di Roma. Emesso nel 143 d.C.. ? ANTONINVS AVG PIVS PP TR P COS III, testa laureata a destra / IMPERA-TOR II, Vittoria stante rivolta a destra reggente trofeo. RIC III 109a; Calicò 1548. Aura Numismatika Praha, auction 57, 6 dicembre 2014. (https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=928&lot=359) Antonino Pio. Æ sestertius. (33 mm, 23.17 g, 1 h). Zecca di Roma. Emesso nel 143-144 d.C. ANTONINVS AVG PI-VS P P TR P COS III, busto laureato e drappeggiato a destra / IMPERA-TOR II, Vittoria che vola verso destra reggente un trionfo con le due mani. S- C nei campi. C. RIC III 717 b; Banti 179, SCBC 643. (www.cngcoins.com) Seppure in assenza di un chiaro riferimento alla Britannia è verosimile ritenere che la Vittoria cui fa riferimento la moneta sia quella ottenuta contro le popolazioni settentrionali della Britannia. Antonino Pio. Æ as. (11.74 g, 12 h). Zecca di Roma. Emesso nel 143-144 d.C. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III, busto laureato e drappeggiato a destra / IMPERA-TOR II, Vittoria che avanzante verso sinistra regge unoscudo che reca inciso BRI-TAN. S- C nei campi. S. RIC III 732; Strack 939; BMCRE 1623 var. (obv. legend break); Cohen 442. (www.cngcoins.com) Antonino Pio. Æ sestertius ( 20.08 g, 12 h). Zecca di Roma. Emesso nel 143-144 d.C. ANTONINVS AVG PI-VS P P TR P COS III, testa laureata a destra / BRITA-N-NIA, S • C in esergo, Britannia seduta verso sinistra su cumulo di rocce, reggente signum nella destra e lancia nella mano sinistra, appoggiata su uno scudo posto su un elmo. R2. RIC III 742; Strack 825; Banti 44; BMCRE 1637; Mazzini 116. (www.cngcoins.com) Antonino Pio. Æ sestertius. Zecca di Roma. Emesso nel 143-144 d.C. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III, testa laureata a destra / IMPERATOR II, Britannia elmata seduta verso sinistra piede destro appoggiato su pietre(?), reggente lancia e braccio sinistro appoggiata su uno scudo. BRI – TAN trai campi, S C in esergo. R2. RIC III 743; Cohen 115. Ex Gorny & Mosch, Auction 185, lotto 258, 8 marzo 2010 (http://www.acsearch.info/search.html?id=749094) Antonino Pio. Æ sestertius (27.15 g). Zecca di Roma. Emesso nel 143-144 d.C. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III, testa laureata a destra / IMPERATOR II, Britannia a testa scoperta seduta verso sinistra su globo reggente stendardo nella mano destra e nella sinistra la lancia; gomito sinistro appoggiato sul globo. Sotto il globo, onde. S C nei campi. R3. RIC III 744, BMC 1640. Ex Numismatica Ars Classica, Auction Q, lotto 1869, 6 aprile 2006. (http://www.acsearch.info/search.html?id=288797) Antonino Pio. Æ sestertius ( 24,83 g, 33 mm). Zecca di Roma. Emesso nel 143-144 d.C. ANTONINVS AVG PI-VS P P TR P COS III, testa laureata a destra / BRITA-N-NIA, S • C in esergo, Britannia seduta verso sinistra su cumulo di rocce, reggente signum nella destra e lancia nella mano sinistra, appoggiata su uno scudo posto su un elmo. R2. RIC III 745; Strack 926; BMCRE pg. 264, † var. (no cuirass); Cohen 119. (www.cngcoins.com) Due emissioni bronzee che celebrano la repressione della rivolta del 154-155 d.C. Antonino Pio. Æ dupondius ( 10,96 g, 24 mm). Zecca di Roma. Emesso nel 154-155 d.C. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVIII, testa radiata verso destra / BRITANNIA COS IIII, S C in esergo, Britannia seduta verso sinistra su cumulo di rocce, testa appoggiata alla mano destra; scudo e vexillum (?) sullo sfondo. S. RIC III 930; Cohen 118. (www.cngcoins.com) Antonino Pio. Æ as ( 11,26 g, 23 mm, 5 h). Zecca di Roma. Emesso nel 154-155 d.C. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVIII, testa radiata verso destra / BRITANNIA COS IIII, S C in esergo, Britannia seduta verso sinistra su cumulo di rocce, testa appoggiata alla mano destra; scudo e vexillum (?) sullo sfondo. S. RIC III 934; Strack 1102; SCBC 646; BMCRE 1971.(www.cngcoins.com) Asse simile al precedente dupondio RIC 930. Molti esemplari risultano esser stati coniati senza troppa cura su tondelli non adeguati. Ne sono stati rinvenuti in quantità significative nei siti romano-britannici, tra tutti a Coventina’s Well presso il forte di Carrawburgh sul Vallo di Adriano e pertanto è stato proposto che si tratti di una emissione dovuta ad una zecca militare presente in Britannia. Lo stile è abbastanza ortodosso e potrebbe indicare, in caso di conferma dell’ipotesi di cui sopra, che i conii siano stati inviati appositamente da Roma per la produzione locale. Antonino Pio. Æ sestertius ( 20,82 g, 31 mm, 12 h). Zecca di Roma. Emesso nel 140-144 d.C. ANTONINVS AVG PI-VS P P TR P COS III, testa laureata a destra / Vittoria che guida una quadriga verso destra reggente le redini. VICTORIAAVG, S C su due righe, in esergo. S. RIC III 653; Banti 508; Cohen 1082. (www.cngcoins.com) Sebbene non presenti alcun riferimento stretto alla Britannia il periodo di emissione ha fatto formulare agli studiosi l’ipotesi che l’esemplare sia quella riferibile alla vittoriosa campagna britannica di Quintus Lollius Urbicus.1 punto
-
Per me dalla foto è senza dubbio Spl/Fdc però come si sa bisognerebbe vederla dal vivo1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Per la new entry Provo con un 50 fils iracheno anni '30 https://en.numista.com/catalogue/pieces8606.html1 punto
-
Giocano sull'ignoranza della gente. Ecco perché ai russi non fa ne caldo ne freddo i sequestri degli yacht: sono pieni di centesimini.....1 punto
-
DE GREGE EPICURI E' uscito un volume su Tesoro di Como, consultabile e scaricabile dal sito: http://www.numismaticadellostato.it Tutte le schede delle monete, con foto, sono consultabili da qui: https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/patrimonio/vetrine/como/visita?codMuseo=171 punto
-
Buonasera a tutti, @sdy82 io non saprei risponderti, ne ho solo uno del 57 in collezione , non ho la possibilità di fare un vero confronto. Ma credo che se viene riportato in alcuni manuali ci siano degli elementi a corredo, al momento non posso consultare testi per verificarlo. Vediamo se altri utenti siano più di aiuto. Intanto posto il mio se può essere utile. Anche se di scarsa conservazione. Saluti Alberto1 punto
-
@Philippus IX questo è uno dei miei 89 che molto ricorda il profilo del tuo reale1 punto
-
Complimenti a tutti per queste bellissime Piastre. Ecco la mia '44. Mi scuso per la qualità delle foto. Al D, notavo una diversa inclinazione del busto, rispetto alle altre '44: punta del busto quasi sul millesimo.1 punto
-
Salve a tutti! Complimenti @Ashcoltami, hai intrapreso un percorso molto interessante, per diversi anni l'impresa diventerà abbastanza impegnativa a causa della grande rarità di tali esemplari. Vorrei postare il realino che preferisco per la capigliatura perfettamente geometrica di Carlo II e per l'anno 1892 che in realtà è 1692. Alcuni dati ponderali, peso: 2,1 g, diametro: 1,8 cm. Buona domenica1 punto
-
1 punto
-
Buona Domenica e Auguri a tutte le Mamme, Posto la mia Piastra del 1844. Buona Giornata.1 punto
-
Posto il mio, in attesa di altri contributi, ma è ben più tardo. Buona giornata, N.1 punto
-
Salve, segnalo : COELITVM SANCTORVM IMAGINES NVMMI REFERABANT Effigi di santi e immagini sacre sulla moneta tra Medioevo ed età moderna L’opera analizza la raffigurazione dei santi e delle immagini sacre sulle monete; i contributi presenti sono i seguenti: Michele Asolati, San Michele (?) prima di San Michele: una rappresentazione arcangiolesca sulla monetazione dei Gepidi (VI secolo d.C.) Domenico Luciano Moretti, La raffigurazione dell’Arcangelo Michele nella monetazione Medievale Raffaele Iula, Devozione e potere nel Mezzogiorno medievale: il caso di San Nicola secondo la documentazione numismatica Valerio Moneta, I Santi e la loro iconografia sulle monete italiane di età medievale Andrea Saccocci, Un Santo Signorile: San Prosdocimo e la costruzione del “mito” dei Signori da Carrara Lucio Taraborelli, Il Santo Pontefice sui bolognini della zecca di Guardiagrele Marcello Mignozzi, Ecce Agnus Dei: simbolo, dono, amuleto e sigillo. Gli spazi del sacro nella Puglia medievale e l’iconografia monetaria come pegno del vincolo tra il Papato e i D’Angiò Cristina Crisafulli, Santità di genere: rappresentazioni di Sante nella monetazione italiana Alberto D’Andrea, La raffigurazione dell’Annunciazione sulle monete fiorentine Giovanni Gorini, Conclusioni https://www.edizionidandrea.com/1 punto
-
Gens Mettia La Gens Mettia era una Famiglia plebea ma di antica origine , il primo Mettio conosciuto fu Mettius Fuffetius , dittatore di Alba Longa al tempo del re di Roma Tullo Ostilio , tra i due re venne stabilito di far combattere tre Orazi e tre Curiazi per stabilire chi tra Roma e Alba Longa dovesse vincere la guerra e quindi sopravvivere . Un altro Mettio conoscito fu Mettius Geminus cavaliere di Tusculum al tempo della guerra contro Roma nel 340 a.C. , infine Marco Mettio al tempo di Cesare di cui fu luogotenente e ambasciatore presso Ariovisto in Gallia , che emise monete tutte rare e molto rare . Pochi membri di questa Gens si sono presentati nella storia e nessuno ha raggiunto le cariche più alte dello Stato romano sotto la Repubblica . Diversi Mettii salirono alla ribalta in epoca imperiale con almeno tre che ottennero il consolato tra la fine del primo e l' inizio del secondo secolo . Il Dizionario di Biografia e Mitologia Greca e Romana descrive Mettius come "un antico nome italico" , in uso sia tra i Sabini che tra i Latini . Si conoscono monete in Quinari , Sesterzi e Denari Quinario , al D/ : testa di Giunone Sospita a destra ornata con pelle di capra , dietro un serpente , al R/ : Vittoria su biga al galoppo a destra Sesterzio , al D/ : testa diademata di Venere a destra , al R/ : M. METTI , giovane andante a destra che da’ da mangiare ad un serpente Denario , al D/ : CAESAR DICT. QUART. , testa laureata di Giulio Cesare a destra , dietro il Lituus , al R/ : M. METTIUS , Giunone Sospita su biga al galoppo a destra lancia un giavellotto e tiene uno scudo Denario , al D/ : CAESAR IMP , testa laureata di Giulio Cesare a destra , dietro simpulum e lituus al R/ : M. METTIUS , Venere girata a sinistra tiene uno scettro e una Vittoria e si appoggia ad uno scudo . Di quest' ultimo Denario esistono varianti con diverse lettere nel campo del rovescio , un’ altra variante reca scritto CAESAR IMPER. al dritto Foto in ordine di moneta , del Sesterzio esiste disegno del D/R nel babelon , qui solo il rovescio Fonte : Cesare , wikipedia , babelon1 punto
-
Tra Magna Grecia e Sicilia: il caso di Skylletion Molteplici sono i casi di monete rinvenute nell’Italia meridionale per le quali il centro di emissione e la peculiare tipologia restano di controversa definizione. L’assenza di solidi elementi di ancoraggio e di puntuali confronti impediscono infatti sia di definire a pieno gli aspetti squisitamente numismatici sia generano non poche difficoltà sul piano della valutazione cronologica e dell’inquadramento storico. Exempli gratia un esemplare (unicum) con testa di Sileno/due chicchi di grano entro quadrato incuso e iscr. ΣVΡΑ(?), oggetto di studi abbastanza recenti e a cui particolare attenzione è stata dedicata proprio all’interno del forum: https://www.lamoneta.it/topic/202880-le-prime-di-siracusa/ Un ulteriore caso di studio, non meno dibattuto, è rappresentato da una serie ben nota su base bibliografica dalla fine del XIX secolo, se non prima, il cui computo degli esemplari si è implementato in progresso di tempo valicando ampiamente le 50 unità. Si tratta di monete in bronzo anepigrafi con moduli compresi tra 22 e 17 mm caratterizzate dai seguenti tipi (fig. 1) : D/Testa maschile a s. con elmo conico (pileus?) talora laureato. R/ Scylla a s. con braccio d. proteso e remo nella s. 1 - Künker 318, 2019, 290 (ex Savoca N. 10, 2016, 26) Sul piano ponderale i valori risultano compresi tra gr. 13,16 e 5,13 benché numerosi valori degradati (anche in modo intensivo) derivano in massima parte dal notevole grado di usura dei pezzi, che in ogni caso registrano un complessivo addensamento delle frequenze nella fascia compresa tra a gr. 7,30 e 7,20 circa. Interpretazione Per il carattere anepigrafo e la peculiare tipologia le monete in oggetto, buona parte delle quali riconiate su litre dionigiane del tipo testa di Athena/ippocampo (fig. 2), appaiono nella storia degli studi numismatici alquanto dibattute. 2 - CNG-Triton V, 2002, 193 SICILY, Mercenaries? Circa 344-336 BC. Æ Litra (8.62 gm). Male head left, wearing pileus / Skylla left, holding club over left arm. SNG ANS 800 (Skylletium in Bruttium); Calciati III pg. 319, 1; SNG Copenhagen 1992 (Skylletium); SNG Morcom 878; Laffaille -; Virzi 457 (Skylletium). Near VF, brown patina. Appears to be overstruck on a Syracusan litra, Athena/Hippocamp (Calciati II pg. 87, 42), with a trace of the hippocamp's tail visible on the pileus. Often attributed to Skylletium in Bruttium on the basis of the Skylla on the reverse, this type has been found in excavations in Locri and in north-central Sicily, and as is the case with this coin, is often times overstruck on a Syracusan litra. Una breve messa a punto della questione in J. Morcom, “Some South Italian Questions”, in S. Mani Hurter-C. Arnold-Biucchi curr., Pour Denyse. Divertissements Numismatiques, Bern 2000, 161-3; M.H. Hansen – Th.H. Nielsen curr., An Inventory of Archaic and Classical Poleis, s.v. Skylletion, 258. Generico risulta invece l’inquadramento di Rutter (HN, p. 192, n. 2565). L’attribuzione è stata negli studi numismatici alquanto controversa e l’emissione riferita a centri diversi: a) Cuma (Head, HN, 37) b) Skylletion/Scolacium (odierna Roccelletta di Borgia, CZ: Sambon 1870, 358 e pl. XXIV, 37; Garrucci 1885, 161, tav. CXIII, 25. V. in proposito M. Govers Hopman, Scylla: Myth, Metaphor, Paradox, Cambridge 2012, 146). c) Sicilia (Calciati) d) Settore meridionale della Calabria (phrourion di Scylla: Castrizio) a-b) Tralasciando l’ipotesi dell’attribuzione a Cuma, ormai definitivamente abbandonata, uno dei principali elementi addotti a favore della localizzazione del centro di emissione nella greca Skylletion, risiede nell’interpretazione dell’immagine del rovescio (Scylla) come “tipo parlante”, allusivo al nome di un centro ben noto alle fonti letterarie. Esse, tuttavia, prospettano localizzazioni differenti: città della Sicilia (Steph. Byz. s.v. Skylletion fr. 320 Lasserre; Lycophr., Alex., 852-5); territorio gravitante in orbita crotoniate fondato dall’ateniese Menesteo e collegato ai nostoi (Strab. VI 1, 10 C 261. Cfr. Plin., NH III, 95; Solin. II, 10) o da Ulisse che nella tradizione post-virgiliana (Serv. ad Aen. III, 553: navifragum Scylaceum) vi avrebbe fatto naufragio, una testimonianza che forse evidenzia la pericolosità e l’insidia dei venti che dovette essere sperimentata anche dai Romani all’altezza del golfo di Scillezio. Ai dati forniti dalla tradizione letteraria si aggiungono quelli delle esplorazioni archeologiche condotte nel secolo scorso, a seguito delle quali Skylletion venne identificata con Roccelletta di Borgia (CZ), benché l’originario assetto urbanistico della colonia greca appaia non più visibile in quanto del tutto obliterato dalle strutture di epoca romana. Per l’età greca la documentazione restituita risulta scarsa e desultoria e limitata a materiale ceramico attico a figure nere databile nella seconda metà del VI secolo a.C. e a più tardi frammenti a figure rosse di età ellenistica. Sulla base di un passo purtroppo corrotto della citata Alessandra di Licofrone (852-5) che restituisce una supposta menzione di Athena Skyletria, è stato ipotizzato nell’area un culto Athena Skyllatia che secondo alcuni studiosi troverebbe un possibile ancoraggio nella denominazione assunta dal centro in età imperiale (Scolacium Minervium. Si veda R. Spadea cur., Da Skylletion a Scolacium. Il parco archeologico della Roccelletta, Roma-Reggio Calabria 1989) Si tratta in ogni caso di rinvenimenti che concorrono a valorizzare sul piano topografico la posizione strategica del sito, la cui fondazione, forse un originario epineion alla foce del Corace, dovette rientrare in quel processo di espansione della chora crotoniate in atto forse già alla fine del VII secolo a.C. Dal versante ionico attraverso l’istmo scilletico Crotone mirava infatti al controllo e alo sfruttamento delle principali arterie di comunicazione che attraverso le aree interne della regione lametina consentivano un immediato sbocco verso l’area tirrenica, come ben documentano la conquista di Temesa alla fine del VI secolo – centro gravitante fino al 510 in orbita sibarita - e la fondazione di poco successiva - inizi V sec. - di Terina (od. S. Eufemia Vetere. Per una messa a punto della questione v. anche G. Genovese, I santuari rurali nella Calabria greca, Roma 1999, 94 ss.). Per Freeman (History of Sicily, IV, Oxford 1894, 203), che cita Cassiodoro, si tratterebbe di Roccella del Vescovo soprattutto alla luce dei numerosi rinvenimenti dall’area e dagli scavi di Locri (P. Visonà, The Coinage of Skylletion: an archaeological note, “SM” 40/1990, 91-3; N.K. Rutter, Campanian Coinages 475-380 B.C., Edinbourgh 1979, 41). c) Per un’emissione ascrivibile e non meglio identificati mercenari prodotta forse nel comparto centro-settentionale della Sicilia, a Scillezio, propende invece Calciati (CNS 3, 319), che riconosce nel tipo del D/, così come nelle serie di Entella e, forse di Mitistrato, il riferimento ad una divinità guerriera (Mamers?) che veicolerebbe (e suggellerebbe) il collegamento con il mercenariato. d) Castrizio (La monetazione mercenariale in Sicilia. Strategie economiche e territoriali fra Dione e Timoleonte, Soveria Mannelli 2000, 58-9; Id., Quattro serie monetali di oppida autonomi nel Bruttium meridionale, “Quad. Arch. Mess.”, 7, 1992, 44-7) accoglie l’ipotesi di un’emissione mercenariale - come già prospettato da Calciati (CNS, 3, 319) – ma ne individua il centro di emissione nel settore meridionale della Calabria in età dionigiana, un periodo storico segnato dal sorgere di numerose roccaforti militari in mano a ex mercenari dionigiani, secondo modalità ben note e sperimentate già in ambito siceliota. Tali phrouria sarebbero stati infatti promossi dallo stesso Dionisio I, che avrebbe elargito ai mercenari terre al posto del tradizionale misthos, facendo dell’emissione monetale uno strumento di controllo e gestione dei suoi territori, per la maggior parte oppida brettii (tra cui forse Hyporon, Noukria, Mystia), sorti in un periodo - dall’età dei Dionisii all’arrivo di Timoleonte - denso di eventi traumatici e destabilizzanti. La distruzione di Rhegion, il ridimensionamento della sua chora ad opera di Dionisio I (387-6 a.C.) e la successiva ricostruzione della città con il nome di Phoibia da parte Dionisio II (358 a.C.), segnarono infatti un drastico mutamento dell’assetto socio-politico della Calabria meridionale, determinando ampi vuoti di potere che favorirono il nascere di nuovi centri abitati oppure l’insediamento da parte di mercenari italici di territori già occupati dagli indigeni. Si trattava di arroccamenti militari a cui, evidentemente, era stato concesso il diritto di battere moneta ma sempre in posizione subordinata all’egemonia siracusana. Sulla base di queste osservazioni, Castrizio assegna le monete con t. maschile/Scylla non a Skylletion bensì a Skyllaion, la rupe all’ingresso dello stretto di Messina e precedentemente annessa al territorio reggino, già fortificata da Anaxilas (Strabo VI 1,5), e forse sede di un presidio di mercenari di Dionisio I di Siracusa dal 386 a.C. Sul piano tipologico Castrizio, sulla scia di Manganaro (Dai mikrà kermata al chalkrokratos kassiteros in Sicilia nel V sec. a.C., “JNG”, 34, 1984, 22 e nt. 39), identifica la testa maschile del D/ con Odisseo a motivo del pileo, il classico copricapo del viandante, rilevando come proprio alla rupe scillaica fossero associate le vicende mitiche legate ai viaggi dell’eroe. In questa direzione sembrerebbero ricondurre anche i dati di circolazione. Nello specifico, rinvenimenti di monete da contesti noti si registrano nelle seguenti località (i dati sono tratti da G. Gargano, Una moneta di Methana da Castellace? Nuove ipotesi su una zecca ME- in Italia meridionale, “SNR”, 87, 2008, p. 32 a cui si rimanda per una più ampia bibliografia): area di Skylletion/Scolacium (2 ess.) versante ionico della Calabria (numerosi ess.) Palmi, loc. Donna Canfora (1 es.) territorio locrese (7 ess., dei quali uno dal ripostiglio rinvenuto nel 1986 in località Marasà in associazione con tre stateri AR acarnani, un hemilitron di Agatocle e 1 AE illeggibile) Monasterace marina (antica Caulonia): 1 es. da una collezione privata di provenienza locale Le presenze monetali di “Skylletion” risultano pertanto non particolarmente cospicue nel Bruttium mentre una considerevole quantità di esemplari è stata rinvenuta nella zona centro-settentrionale della Sicilia (E. Arslan, La moneta, in R. Spadea cur., Da Skylletion a Scolacium, cit., 189-91; S. Garraffo, La monetazione dell’età dionigiana: contromarche e riconiazioni, in La monetazione dell’età dionigiana, Atti VII Conv. CISN-Napoli 1983, Roma 1993, 229 con bil. prec.). Si impone pertanto un’attenta riflessione sulla possibilità di localizzare la zecca nell’area brettia dello Stretto, benché incerta appare l’ipotesi di una sua collocazione presso Scillato, ai piedi delle Madonie occidentali (V. Cammarata, Da Dionisio a Timoleonte. Problemi di numismatica della Sicilia antica, Modica 1984, 120 su cui v. G. Manganaro, in “Gnomon”, 60, 1988, 456). Se invece il centro dovesse ubicarsi in Sicilia, la presenza di numerario di Skylletion a Locri costituirebbe un aspetto non secondario, considerata la cospicua quantità di bronzo siceliota rinvenuto nella città magno-greca (M. Taliercio Mensitieri, Problemi monetari di Hipponion e delle città della Brettia tra IV e III sec. a.C., in M.L. Napolitano cur., Crotone e la sua storia tra IV e III sec. a.C., Napoli 1993, 169 con bibl. prec.). Alla luce della documentazione disponibile la questione dell’esatta localizzazione ed interpretazione di queste monete resta tuttavia ancora dibattuta. Allo stato attuale della documentazione si può solo osservare che l’assenza dell’etnico, le opzioni tipologiche (testa maschile pileata), la compattezza della serie e le frequenti riconiazioni su litre dionigiane costituiscono indizi che sembrerebbero ben descrivere i caratteri di un’emissione connessa a pratiche mercenariali. Link alle principali discussioni su Skylletion: https://www.lamoneta.it/topic/177785-skylletium-e-la-sua-moneta/ https://www.lamoneta.it/topic/117212-una-misteriosa-emissione-mercenariale/ https://www.lamoneta.it/topic/142882-le-pi%C3%B9-belle-rappresentazioni-di-guerrieri/?do=findComment&comment=19385361 punto
-
Piú la vedo e piú penso che quel ciuffo ( e la capigliatura) è proprio diverso.1 punto
-
Raffaele, non si tratta solo del "taglio" del collo ma, proprio di proporzioni ed indagini comparative con le altre 20 piastre del primo e del secondo tipo della mia collezione... ho sovrapposto tutte le teste con questa e nessuna presenta una simile fronte (che cambia le proporzioni della testa) e soprattutto, nessuna ha un collo cosi' stretto...1 punto
-
1 punto
-
Dello stesso articolo di Adrien Arles trovate qui una versione in inglese http://a.arles.free....g processes.pdf, che spiega non solo il processo di bianchitura (o bianchimento), ma anche come ad esempio le analisi XRF siano utili per capire le tecniche usate per la produzione in base ai dati qualitativi raccolti. Mostra inoltre come i tondelli bianchiti (o imbiancati, o "biancati" come ho letto ieri in un registro della zecca genovese del 1427) da questi studiosi sperimentalmente abbiano rivelato un arricchimento superficiale dell'argento tra 10 e 20 micron mentre i tondelli da scavo analizzati hanno mostrato un arricchimento superficiale dell'argento più corrosione fino a 100 micron (...!). Vi allego in successione le tre immagini a colori tratte dal contributo in oggetto : a) processo di bianchitura (guardate cosa succede alla struttura metallica); b) arricchimento superficiale in argento nel campione sperimentale; c) arricchimento superficiale in argento nel campione da scavo archeologico. Di nuovo un saluto MB1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?








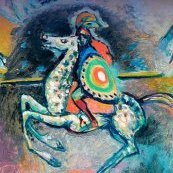


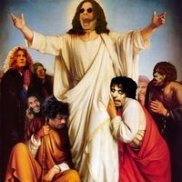
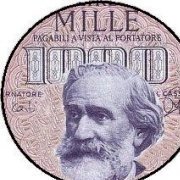




.thumb.jpg.a87f7e406a193e3cfac913a3792527b7.jpg)