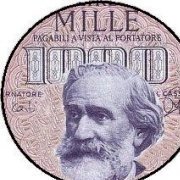Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 12/09/22 in tutte le aree
-
Continuiamo ad alimentare la discussione con ulteriori esemplari. In questo caso, trattasi del Lotto 8 dell’asta Varesi 80 del 9-10/11/2022 acquisito in collezione: AQUILEIA BERTOLDO DI MERANIA (1218-1251) Denaro (1218-1251) D/ Il Patriarca in trono con lunga croce e libro R/ Aquila ad ali spiegate sovrastante un edificio MIR 11 CNI 11/17 Bernardi 15 Ag g 1,22 mm 21 • Bella patina di monetiere SPL6 punti
-
Secondo me, i problemi posti da tale studio sono due, ben diversi: Fornisce qualche indizio scientifico sulla possibilità che questi medaglioni di Sponsiano siano antichi? Qualora si rivelino autentici, basterebbe per fare di questo Sponsiano un personaggio storico? Per la prima domanda, bisogna considerare l’insieme delle monete del gruppo, perché: Sono tutte fuse e condividono caratteristiche di stile, di metrologia, di tipologie molto inusuali, che si tratti di monete imperiali o di imitazioni « barbariche » o di falsi moderni. Due o tre di queste tipologie si ritrovano assieme in diversi musei, (Glasgow, Vienna, Gotha, Parigi, Sibiù in Romania) forse in seguito alla disperzione di questo gruppo iniziale « trovato » in Transilvania, fra cui Heraeus, numismatico e direttore delle collezioni imperiali, avrebbe acquistato dal ministro delle finanze Von Palm un esemplare di ogni tipo, 8 monete in tutto, conosciute da una nota manoscritta l’anno stesso del presunto ricovero(1713). @Caio Ottavio: Non so dove hai visto che nella fattispecie si sono accaniti gli studiosi più moderni? Dopo la condanna di Cohen, Mattingly, più prudente, descrive le monete « strange barbarous coins » e parla ancora di un « unsolved mistery », ma poi i numismatici moderni hanno praticamente chiuso il caso. Ecco la risposta all’utente di Cointalk del dottore Klaus Vondrovec, conservatore del Münzkabinett di Vienna : « in effetti, due monete (di Sponsiano) fanno parte della nostra collezione. Purtroppo non ho immagini, nonostante il fatto che esistono da più secoli, queste monete sono decisamente falsi moderni ». (Cited from: https://www.cointalk.com/threads/the-legend-of-sponsianus.364019/) Questa condanna riguarda le 10 monete (dai tipi 2 a 5) del gruppo iniziale, relegati nel reparto dei falsi del Museum di Vienna. Richard Abdy (B.M), Jérôme Mairat (Ashmolean museum), Mary Beard (storica, Cambridge) hanno emesso più o meno lo stesso parere. Affermazione seguita da quasi tutti i numismatici senza troppa fatica, ma che si rivela, trattandosi di Cohen, basata sulla mera osservazione di un calco e un esemplare d’argento ormai sparito. Sorprendentemente, a contraddire la sentenza innappellabile della non autenticità di queste monete è … lo stesso Cohen, che elenca il Filippo come « fabrique barbare », descrivendo tra l’altro il dritto con testa elmata di Filippo, quando si tratta ovviamente di una testa di Roma copiata dai dritti di denari repubblicani. Un altro esemplare del tipo 4 dell’articolo è stato messo all’aste nel 2013 da Kunker, senza che sia fatto il legame con il « ripostiglio » trovato in Transilvania. Anche per lui, un pedigree risalente all’asta Otto Helbing 1926. https://www.acsearch.info/search.html?id=1520268 Valeva comunque la pena di riaprire la discussione, e per andare avanti, proporre un’analisi scientifica delle monete disponibili. Se Paul Pearson, geologo di formazione, non è un numismatico, la sua analisi fatta con tecnologie moderne di archeometria che ragionevolmente si suppone da lui controllate, non può essere trascurata. Nessuna prova decisiva, ma un fascio di indizi (tracce d’usura non meccanica, incrostazioni di terra nelle zone compatibili con un interramento a lungo ) che fa che non si può più affermare come Cohen e i seguenti che si tratta di grossolani falsi moderni. Ulteriori ricerche sarebbero utilissimi, ad esempio le misure di elementi traccie (palladio e platinio) che consentono di precisare l’origine geografica dell’oro. Un’altra tecnica (ma costosa e invasiva) permette di datare l’ultima fusione subita dall’oro analizzato: https://journals.openedition.org/archeosciences/2017?fbclid=IwAR0kt4GNJUzZpOx54GGYryeHvDpHFEbV5v9Z8yunRrTeiC7nvQSz1S8npbs Più fattibile, si potrebbe ribaltare il ragionamento: Esaminare false monete per cercare se la tecnica di incrostazioni artificiali è già stata usata altrove dai falsari del XVIII sec. In ogni modo, tutto indica una fabbricazione in modalità degradata (monete tutte (?)fuse, con una sola impronta conosciuta per ognuno dei tipi dritto e rovescio, oro poco raffinato, disegni rozzi ispirati a denari repubblicani o antoniniani, legende errate, pesi incompatibili con una circolazione officiale) L’ipotesi emessa (la parte più discutibile dell’articolo) è che queste monete fossero destinate al pagamento dei soldati di alto rango, sotto il regno di Gallieno. Assediato da invasioni barbariche, e senza comunicazioni con il resto dell’impero, un dux chiamato Sponsianus si sarebbe attribuito l’imperium. IMP(erator) ma nessun AVG(ustus) sulla moneta, a meno di cercarlo un po’ nascosto sul rovescio (C A/VG, Caius Augurinus interpretato come Caesar Augustus). Sappiamo che la Dacia romana è nuovamente minacciata da ogni parte sotto Gallieno, che iniziò un primo ritiro, con un distaccamento di truppe e di popolazioni al sud del Danubio. Non si sa esattamente quante legioni o vexillationes rimangono ancora stazionate, ma Eutropio e l’autore della Storia Augusta attribuiscono ad Aureliano l’abbandono definitivo della Dacia attorno al 271/272. Pearson ipotizza nel frattempo una forma di secessionismo forzato, e per mancanza di scalptores (la monetazione di bronzo della zecca Dacica smette dopo 257) l’impiego di artigiani gioiellieri che lavoravano l’oro fuso estratto delle miniere daciche. Una costruzione che secondo me rientra più nell’ambito della fantastoria e che potrebbe screditare anche la parte scientifica dello studio presso gli esperti numismatici o storici. Sarebbe spiacevole. Affermare la storicità di uno Sponsiano imperatore andrebbe ben oltre il contesto di questo studio, e il suo titolo - Authenticating coins of the « Roman emperor » Sponsian - è fuorviante, anche se ci sono le virgolette. Se un altro esemplare fosse rimesso in luce, e in contesto diverso, sarebbe tutt’altra cosa. Testis unus testis nullus. Innanzitutto un usurpatore qualsiasi si sforza di seguire (con più o meno successo) le caratteristiche della monetazione ufficiale. Per il Filippo e il Gordiano, se il modulo è inusuale, la tipologia è coerente (PRINCIPI IVVENTVTIS e MARTEM PROPVGNATOREM), perché per Sponsiano scegliere un rovescio repubblicano? Inoltre, in un ambito romano, il fatto di non trovare un artigiano capace di ritrascrivere legende in latino coretto pare molto strano. E se tutte le monete fossero autentiche tranne gli Sponsiani? È poco probabile, ma non si può trascurare la differenza del tenore di rame, molto più alto per lo Sponsiano del Hunterian Museum che per le tre monete di Filippo e di Gordiano analizzate. Allora imitazioni barbariche dalla datazione incerta, forse posteriori al tempo di Gallieno? SPONSIANI sarebbe una scelta fantasiosa o una stringa di lettere producendo casualmente un raro nome romano. Speriamo che il dibattito si prolunghi tra esperti e ricercatori di buona fede. Sarebbe un eccellente risultato da porre all’attivo dello studio di Pearson, che non si merita né il disprezzo né la frenesia mediatica che ha scatenato.5 punti
-
Per memoria rimetto qua i 6 tipi del « gruppo iniziale »: gli esemplari del Gordiano (Glasgow, Parigi, Vienna)3 punti
-
Dopo le lacrime di papa Francesco, la preghiera di questo gattino è l'episodio che in questi giorni mi ha particolarmente toccato. apollonia2 punti
-
Buonasera a tutti, @Oppiano non sono pratico della monetazione di Filippo III , ma la butto li, quella che tu ipotizzi essere un oliva secondo me e' una foglia e fa parte del ramo solo che risulta staccata probabilmente per un difetto di conio. Mentre i presunti semini per me sono gli steli che partono dalle spighe di grano. Magari , anzi sicuramente non e' come la penso io, ma volevo esternarlo, vediamo se ci sono piu' validi interventi. Saluti Alberto2 punti
-
Grazie ancora. Penso che, prima di acquistarla, a questo punto sia meglio farla vedere direttamente. Per fortuna ho questa possibilità. In mano fa un bell'effetto: forse troppo.2 punti
-
I sestini di Giovanna e Carlo possono presentare varianti di punteggiatura,di stile nella corona e nella croce ma i le raffigurazioni del dritto e del rovescio sono quelle,quindi i casi sono due,o il tuo è un sestino dove non si vedono bene al dritto le iniziali I.C. coronate oppure è un'altra moneta simile ai sestini di cui si discute in questa discussione,ma in tal caso non è di Giovanna e Carlo, perché (al momento)non esistono sestini, sempre di Giovanna e Carlo,di tipo diverso... Spero di essere stato chiaro...2 punti
-
faccio notare che per forma e dimensione siete stati portati a crederlo un "nummo AE4" ... nonostante il peso un po' eccedente, ma vicino a molte di Marciano ... questo non è un caso ... proprio nella prima parte del VI secolo il "nummo AE4" sparisce in oriente , sostituito di fatto dal pentanummo.... che ci racconta qualcosa sul "valore dell'AE4".... ho scritto una cosa un po' lunga sul valore dell'AE4 ... è uscita a gennaio 2022 e tra poco grazie all'OK di D'Andrea, lo metterò su academia.... se la cosa vi stimola curiosità....leggerete qualcosa di interessante....una ipotesi, ma che credo abbia basi abbastanza solide2 punti
-
Sì, questo può avvenire in pratica. Ma non è così pacifico; se fosse pacifico nessuno, dico nessuno (a parte poche eccezioni), potrebbe detenere legittimamente reperti archeologici. Chi, infatti, può dimostrare che la propria moneta sia stata scoperta prima dell’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909? Del resto devo ancora vedere un attestato di libera circolazione che rispetti completamente il disposto di cui all'art. 64 citato; e in tale attestato (non certificato) nessun commerciante e nessuna casa d'aste afferma che la moneta venne scoperta prima dell’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909. L'attestato che rilasciano può, al massimo, servire a dimostrare che non ho responsabilità penale (gioverebbe per escludere la ricettazione o l'ncauto acquisto), ma la moneta si presumerebbe comunque di proprietà statale /quindi confiscabile), se applicassero sempre il principio di diritto enucleato delle decisioni citate.2 punti
-
Buonasera, già postata in passato, ma vista la rassegna specifica delle Piastre 56 , eccovi la mia, con doppio orecchio. Buona serata a tutti Silver2 punti
-
Ciao Alberto, il rovescio presenta un leone andante. La moneta richiamava le cinquine senatoriali romane che circolavano normalmente in Abruzzo, quale terra di confine tra due stati. Consigli per la lettura: https://www.academia.edu/34779004/Campagna_di_indagine_archeologica_anno_2016_ai_ruderi_della_chiesa_di_Sant_Egidio_a_Campo_Imperatore_L_Aquila_Notizie_preliminari_sui_reperti_numismatici_seconda_parte_By_Achille_Giuliani_e_Adolfo_Sissia https://www.academia.edu/32217621/La_cosiddetta_cinquina_emessa_dal_Senato_Romano_e_i_suoi_divisionali_In_Panorama_Numismatico_n_326_marzo_2017 https://www.academia.edu/49456578/Denari_e_quattrini_angioini_coniati_ufficialmente_nella_zecca_dellAquila_ad_imitazione_delle_serie_comunali_romane_4_2021_Copyright_dellAutore2 punti
-
L' 8 dicembre 1856, giorno dell'Immacolata Concezione, Ferdinando II assistette a Napoli alla Santa Messa con tutta la famiglia, gli alti funzionari governativi e moltissimi nobili del suo seguito. Dopo la celebrazione, il sovrano passò in rassegna a cavallo le truppe sul Campo di Marte. In quel momento, il soldato calabrese di idee mazziniane Agesilao Milano, che accusava Ferdinando II di essere un «tiranno da cui doveva liberarsi la nazione», si lanciò sul monarca e riuscì a ferirlo con un colpo di baionetta. Arrestato e condannato a morte, gli fu negata la grazia sovrana e il re rifiutò di ricevere personalmente il suo avvocato difensore. Milano fu impiccato in Piazza del Mercato il 13 dicembre dello stesso anno. (Fonte Wikipedia) Un saluto a tutti. Raffaele.2 punti
-
Salve a tutti. Prima di intervenire in questa spinosa questione, mi sono preso qualche giorno per poter eviscerare l’articolo di Paul N. Pearson et al., Authenticating coins of the ‘Roman emperor’ Sponsian, apparso in open edition su PLOS ONE il 23 novembre 2022. Come molti lettori avranno notato, la ricerca non è stata condotta da numismatici, se si esclude la partecipazione del dott. Jesper Ericsson, curatore del medagliere dell’Hunterian Museum di Glasgow, da cui provengono le monete oggetto di questo studio, ed in particolare il discusso esemplare a nome di Sponsiano, su cui il mio intervento si concentrerà in modo specifico. La metodologia e le analisi scientifiche che sono state messe in campo sono sicuramente da ammirare, ma probabilmente se la ricerca fosse stata condotta da un professionista della numismatica non ci sarebbe stato neanche bisogno di mettere in campo un simile quantitativo di analisi per arrivare a conclusioni ben diverse da quelle, ampiamente discutibili come dimostra la direzione che sta prendendo il dibattito in ambito scientifico e accademico, a cui sono approdati gli autori del suddetto articolo. Per loro stessa ammissione, infatti, molti dei risultati ottenuti mediante queste analisi scientifiche non sono sufficienti a stabilire appieno e in maniera incontrovertibile l’autenticità delle monete, e in particolare dello Sponsiano, e quindi l’esistenza stessa di questo misterioso personaggio, salvo poi asserire il contrario, a spada tratta, nelle conclusioni dello studio. Se sulle metodologie d’indagine poco o nulla va sottolineato, e credo che sia la parte più valida e meritevole di questa ricerca, il contesto in cui sono inserite le monete racconta tutta un’altra storia e i risultati a cui giungono gli studiosi sono altamente contestabili. Ma andiamo con ordine. La moneta di Sponsiano avrebbe fatto parte di un ripostiglio occultato in un momento storico imprecisato e venuto alla luce, in circostanze non meglio documentate, nel 1713 in Transilvania. L’unica menzione di questo ritrovamento si trova in una nota manoscritta di Carl Gustav Heraeus (1671-1725), Ispettore delle Medaglie di Vienna: egli era, in pratica, il curatore delle collezioni imperiali sotto i sovrani Giuseppe I (1705-1711) e Carlo VI (1711-1740). Il suo compito era piuttosto importante, in quanto doveva non solo conservare la più importante e prestigiosa collezione numismatica di tutto l’Impero austriaco, ma doveva anche gestirla ed ampliarla con nuove acquisizioni. Dopo il suo ritrovamento, le monete vennero disperse sul mercato antiquario ed è probabile che alcune furono acquistate per le collezioni imperiali da Heraeus stesso, visto che due esemplari di Sponsiano si trovano attualmente nel medagliere del Kunsthistorisches Museum di Vienna. All’acquisto partecipò anche il facoltoso alto ministro delle finanze Johann David von Palm (1657-1721). Anche la moneta a nome di Sponsiano, oggetto dello studio pubblicato su PLOS ONE, oggi all’Hunterian Museum di Glasgow, ha provenienza viennese, essendo essa stata comprata da William Hunter nel 1782 dalle raccolte dell’antiquario Joseph De France. Ho riassunto brevemente la vicenda della scoperta e dei diversi passaggi, così come si evince dalla ricostruzione dell’articolo, proprio perché essa non è casuale e ha un’importanza insospettabile per i nostri scopi, cioè dimostrare o meno l’autenticità delle monete di Sponsiano. Per questo, tenetela bene a mente, insieme con i nomi dei personaggi inizialmente coinvolti in tale vicenda. Di sicuro si conoscono più esemplari di Sponsiano: non è affatto vero, dunque, che esiste un solo esemplare (quello di Glasgow), così come caparbiamente sostenuto dall’utente Pxacaesar (alquanto favorevole ad accogliere positivamente le conclusioni dello studio di Pearson) nei suoi posts 22 e 24 e ciò si evince dalla semplice lettura dell’articolo inglese: di sicuro se ne conoscono ben 4 esemplari, ma da una ricerca più approfondita ce ne sarebbero addirittura 6 e ne vengono dati anche i relativi pesi: due sarebbero nel medagliere di Vienna (rispettivamente 9,38 g. e 10,07 g.); uno nella città austriaca di Herzogenburg (di 9,80 g.); poi c’è quello ormai famoso dell’Hunterian Museum (di 10,84 g.); un altro nel museo di Sibiu, in Romania, e probabilmente un ultimo a Parigi, la cui presenza, però, meriterebbe conferma. Di questi ultimi due esemplari non abbiamo dati certi riguardo il loro peso. Già qui sorge il primo problema per la teoria dell’autenticità: tutte le monete d’oro conosciute di Sponsiano hanno un peso di molto superiore rispetto a qualsiasi altro aureo o multiplo di aureo (binio) romano emesso nel corso del III sec. d.C. Di norma, gli aurei del tempo difficilmente superavano i 4,50 o i 5,00 g. e il binio di solito si attestava sui 5,80 g. circa, o poco più. Potrebbero essere dei medaglioni o dei multipli superiori al binio, ma i loro pesi, per di più così variabili e fluttuanti, impedirebbero loro un qualsiasi sensato inserimento all’interno del sistema monetario e ponderale romano in vigore all’epoca. Pearson e la sua equipe hanno ovviato al problema, nel loro scritto, dicendo che queste monete erano forse adoperate come una specie di lingotti aurei, ma qui sorge un altro interrogativo: noi conosciamo bene le sembianze di lingotti aurei romani (si veda, ad esempio, il caso del lingotto in fig. 1) e le monete di Sponsiano non hanno né forma, né marchi, né tipologie proprie dei lingotti o di altre barre metalliche romane, ma, al contrario (e questo è indiscutibile e chiaro a tutti gli osservatori delle foto dello Sponsiano di Glasgow), esse hanno tutte le caratteristiche di monete vere e proprie. Ma, stando al peso, difficilmente avrebbero potuto circolare. Fig. 1: Lingotto romano in oro conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna e proveniente dal ritrovamento di Czofalva (in Transilvania) del 1887 e risalente al 379 d.C. Monete, dunque, e non lingotti, che non avrebbero però potuto assolvere al loro compito per via dei pesi così anomali. Quindi, sarebbe strano anche chiamarle “monete” nel senso compiuto del termine, ma lo faremo ugualmente per comodità di comprensione. Altre anomalie, chiare dalle foto e notate da Pearson, sono la legenda del dritto che si trova solo sul lato destro del busto di Sponsiano e, caso ancora più strano, essa è declinata al genitivo. Si noti che nessuna moneta romana autentica di III sec. d.C. riporta una legenda con il nome imperiale declinato al genitivo. Inoltre, la tipologia di rovescio dello Sponsiano ricalca un altro rovescio, quello del denario repubblicano di Caio Minucio Augurino del 135 a.C. Per queste anomalie non è stata fornita alcuna spiegazione scientifica accettabile. Di sicuro, se pure le monete di Sponsiano fossero state delle produzioni barbariche, come pure è stato ipotizzato visto lo stile rozzo, bisogna riconoscerne i limiti: di solito, le imitazioni barbariche conservavano, chi più e chi meno, delle caratteristiche che ne consentivano la circolazione frammista ad esemplari autentici ed ufficiali: nel nostro caso, uno Sponsiano con simili caratteristiche ed anomalie tipologico-ponderali non avrebbe mai potuto essere immesso in circolazione, a maggior ragione se frammisto con aurei o multipli romani ufficiali. Il primo numismatico che ritenne false le monete di Sponsiano fu Henry Cohen (contro il cui giudizio pare che gli studiosi più moderni si siano particolarmente accaniti: anche noti accademici nostrani e professori universitari sembrano ormai snobbare le opere e i pareri del Cohen solo perché si tratta di un autore datato, imponendo addirittura di toglierlo dalle citazioni bibliografiche di recenti articoli numismatici: e parlo per diretta esperienza personale! Poi, a furia di snobbare gli studi di chi ci ha preceduto, incorriamo in situazioni di questo genere: Per una ipotesi di ATTRIBUZIONE della SERIE OVALE dell’aes grave - Monete Preromane - Lamoneta.it - Numismatica, monete, collezionismo, ma questa è un’altra storia). La tesi del Cohen fu poi ampiamente confermata dallo studio, citato anche dal RIC, di R. Münsterberg, del 1923, che riconobbe le monete di Sponsiano come prodotte per fusione. Tale giudizio è stato confermato dalle analisi scientifiche condotte dalla squadra di Pearson e pubblicate nel loro lavoro, ma qualsiasi numismatico sa benissimo che le monete romane di III sec. potevano essere prodotte solo per coniazione e non per fusione. Gli unici esemplari fusi all’epoca erano prodotti di falsari che miravano a riprodurre monete ufficiali realmente esistenti per poi mischiarle, in fase di circolazione, con le autentiche. Non avevano alcuna necessità o interesse, dunque, di creare monete false per fusione con un nome di un usurpatore sconosciuto come quello di Sponsiano, con tutte le anomalie finora accertate, sia ponderali che tipologiche (che ne inficiano la circolazione all’interno del sistema monetario romano, anche di provincia e oltre il limes), e che non poteva essere immesso in circolazione, né frammisto con altri esemplari ufficiali coevi. Davanti al metodo di produzione per fusione cade anche l’ipotesi dell’imitazione barbarica, in quanto anche le monete barbariche erano prodotte per coniazione e non per fusione: basti pensare, per rimanere in Dacia, alle imitazioni dei denari romani repubblicani fatte dalle tribù geto-daciche e ampiamente indagate dalla letteratura numismatica di settore. Ma c’è di più: anche la composizione e la purezza della lega dello Sponsiano di Glasgow risulta essere anomala e incompatibile con quelle di autentici aurei romani di III sec. con cui pure è stata comparata nello studio di Pearson (tabella in fig. 2). Fig. 2. L’elevato quantitativo di argento e rame rilevato nella lega stride parecchio se confrontati agli aurei di Gordiano III e di Filippo I che sono stati presi a paragone: per stessa ammissione degli autori dell’articolo, nonostante la crisi dell’oro monetato che coinvolse l’Impero Romano nel corso del III sec., i nominali aurei mantennero un livello di purezza molto alto, tanto da essere composti di oro quasi puro. E le analisi di Pearson e altri lo confermano. In più, anche se si tratti di un’imitazione barbarica o di un falso d’epoca, bisogna pensare che questi prodotti avevano lo scopo di circolare confondendosi con gli esemplari ufficiali ed autentici, quindi dovevano rispettarne alcune caratteristiche: tra queste anche la bontà del metallo, poiché, come viene detto anche nell’articolo di PLOS ONE, i mercanti del mondo antico erano in grado, con un semplice “scratch test”, di rilevare le impurità del metallo con sorprendente accuratezza. Motivo in più, se lo Sponsiano fosse davvero antico, di rispettare una lega ad alto contenuto d’oro quanto più vicino possibile agli esemplari ufficiali e originali, cosa che invece non è venuta fuori dall’analisi della composizione della lega dello Sponsiano di Glasgow. Pensiamo, inoltre, che i ducati d’oro austriaci dell’imperatore Carlo VI d’Asburgo, regnante all’epoca della scoperta del ripostiglio di Transilvania nel 1713, avevano una purezza di 986 millesimi circa… (e qui volontariamente mi taccio). Le tracce di terreno rinvenute sulla moneta di Sponsiano indicano solamente che il pezzo è stato interrato per diverso tempo, ma non sappiamo per quanto è stato tenuto sottoterra prima della sua esumazione: possono essere trascorsi secoli come pure anni, il che rende questo parametro del tutto inutile ai fini della ricerca per stabilire l’antichità e l’autenticità o meno della moneta. Come pure inutili e inconcludenti, per stessa ammissione di Pearson e della sua squadra, risultano essere le analisi condotte per rilevare l’usura superficiale della moneta: usura che è presente, ma che non può essere presa come sinonimo di antichità e autenticità, in quanto facilmente realizzabile dai falsari di XVIII e XIX secolo come dimostra il caso dei falsi di Wilhelm Becker. Gli autori, poi, entrano in contraddizione con loro stessi nelle conclusioni dell’articolo prendendo proprio questi due elementi a fondamento dell’autenticità dello Sponsiano: questo metodo di valutazione, purtroppo, non ha nulla di scientifico perché gli studiosi si contraddicono da soli nel giro di poche righe di testo. L’unica conclusione possibile, alla fine di tutta questa mia lunga disamina, è stata ben esposta in A. Bursche, Złote medaliony rzymskie w Barbaricum Symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku starożytności, Warsaw, Instytut Archeologii Uniwesytetu Warszawskiego, 1998. Egli, infatti, crede che le monete di Sponsiano siano dei falsi di inizio XVIII secolo, fatti probabilmente per ingannare una serie di sprovveduti ma facoltosi antiquari della Vienna del tempo. La moneta di un nuovo usurpatore romano, sconosciuto alla storia, avrebbe fatto gola a molti, tant’è che anche oggi, all’apparire della notizia che stiamo discutendo in questa discussione, c’è stato subito chi ha proposto di aggiornare la prosopografia degli imperatori romani, con i conseguenti risvolti collezionistici che ne derivano. Ma Pearson evidenzia che una simile truffa avrebbe richiesto un investimento iniziale molto costoso: egli, infatti, per confutare questa tesi, evidenzia come l’oro messo insieme per la fabbricazione di tutte le monete del ripostiglio di Transilvania del 1713 ammonti ad un valore di circa 20.000 dollari odierni. In più, gli stessi autori, sempre per confutare la stessa tesi, ribadiscono che nel Settecento non vi era un interesse antiquario così spiccato per la romanità del III sec. tale da giustificare una simile impresa fraudolenta. Ma entrambi i punti possono trovare una facile spiegazione: proprio perché non vi era tutto questo interesse negli ambienti colti per il III sec. vi era la necessità, per i falsari, al fine di stuzzicare l’attenzione, di creare monete che, invece di ricalcare tipi già noti ed esistenti, riportassero invece imperatori sconosciuti e tipi ibridi con incroci di conio che non si erano mai visti fino ad allora (elementi, entrambi, che ritroviamo in quasi tutte le sedicenti monete provenienti dal ripostiglio della Transilvania del 1713). Inoltre, la realizzazione di monete di stile “barbarico” e rozzo, il metodo della fusione, non richiedevano particolari abilità artistiche e capacità tecniche da parte dell’artigiano/falsario, rendendo molto più semplice il suo lavoro. Secondo punto, che giustifica l’investimento iniziale di 20.000 dollari in oro per realizzare i falsi: qui entrano in gioco i nomi coinvolti inizialmente, ve li ricordate? Avevo detto di tenerli bene a mente, perché sono proprio loro l’oggetto della truffa messa in atto. Le monete di Sponsiano, insieme alle altre, non erano destinate a comuni collezionisti o antiquari che navigavano in cattive acque, ma miravano a pesci molto più grossi, forse i più grossi di tutta la Vienna imperiale: il ministro delle finanze e le collezioni dello stesso imperatore d’Austria. Per fare ciò, dovevano creare qualcosa non solo di unico e di particolare, ma anche di prezioso e imponente, come sono appunto le monete di Sponsiano e le altre sue compagne. Pezzi che, per il loro prestigio, dovevano far gola allo stesso curatore delle collezioni imperiali, gente che poteva permettersi di sborsare ingenti quantitativi di denaro pur di accaparrarsi pezzi di un simile livello per innalzare il prestigio delle proprie raccolte. Il che giustificherebbe eccome un investimento iniziale così cospicuo, a fronte del guadagno che una simile truffa avrebbe potuto fruttare, vista l’ambizione di tutta questa macchinazione! E le analisi condotte da Pearson e altri rimanderebbero, come evidenziato finora, proprio in questa direzione: sarebbero una conferma della teoria della falsificazione settecentesca fraudolenta operata probabilmente da un solo artigiano viennese (stesso l’equipe di studiosi afferma nell’articolo che lo stile delle monete farebbe pensare ad un unico artigiano). A voi le conclusioni…2 punti
-
Se mi chiedono quale sia la cosa più strana che hai scoperto oggi è certamente la storia del passaporto di Ramses II: Nel corso del suo lungo regno, Ramses II, ha scritto la storia dell'antico Egitto, ma anche da morto continuò a stupire. Negli anni '70 prese l'aereo e volò a Parigi, con tanto di passaporto rilasciato per l'occasione. Ramses II viene spesso definito come uno dei più grandi faraoni dell’antico Egitto. Ha regnato per più di 60 anni ed ha contrassegnato un’epoca. I suoi successi non sono mai stati eguagliati da nessun altro faraone e, anche dopo la sua morte, Ramses II ha continuato ad essere considerato unico. Come molti altri faraoni del Nuovo Regno, Ramses II venne sepolto nella Valle dei Re, sulla riva occidentale del Nilo, di fronte all’antica città di Tebe. Inizialmente, il faraone venne sepolto nella tomba ora identificata come KV7. Tuttavia, qualche tempo dopo, per via delle continue profanazioni, il Sommo sacerdote di Amon decise di farla spostare e venne trasferita nel “nascondiglio” di Deir el-Bahari, dove rimase fino alla sua scoperta nel 1881. La mummia di Ramses II venne subito trasportata al Museo del Cairo, ma solo nel 1886 si ebbe la certezza che fosse effettivamente la mummia del grande faraone. Negli anni ’70 gli egittologi che lavoravano per il Museo del Cairo si accorsero che la mummia del faraone si stava deteriorando ad un ritmo allarmante e decisero di inviarla a Prigi, in Francia, perché potesse essere esaminata. Per la legge francese, ogni individuo che entra nel paese, che sia vivo o morto, deve possedere un documento di riconoscimento. Così, venne realizzato uno speciale passaporto per la mummia del grande faraone. (purtroppo questa foto è un fake ma sarebbe bello fosse vera) La mummia di Ramses II venne trasportata a Parigi con un aereo militare, dove venne accolta all’aeroporto con tutti gli onori di un Capo di Stato. Poi, venne portato al Musée de l’Homme, dove rimase per sette mesi sotto le cure di ben 110 esperti poiché scoprirono che il deterioramento era dovuto ad un fungo. Ebbero così l’opportunità di analizzare la mummia e vennero in evidenza nuovi dati su di essa. Il Re era alto 185 centimetri, aveva la pelle chiara e morì tra gli 85 e i 90 anni. Inoltre, poterono identificare alcune patologie da cui era affetto il faraone. L’uomo aveva gravi lesioni dentali, soffriva di una spondiloartrite anchilosante, una forma di artite molto dolorosa, oltre che di arteriosclerosi. https://mediterraneoantico.it/articoli/egitto-vicino-oriente/nome-ramesse-ii-segni-particolari-faraone-degitto/1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Grazie ma se guardate bene si vede anche la seconda a fianco.Non fatevi ingannare dal puntino.1 punto
-
1 punto
-
Vuol dire che si fa fatica a capire cosa vuol sapere; qualche parola in più non guasta. Se entra in un negozio di numismatica cosa fà, fa vedere una foto e continua a tenere la bocca chiusa o chiede qualcosa.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
@numa numaio sono convinto al 1000% che qualcosa in questa/e moneta/e non sia apposto (peso e fusione). Le immagini e la bilancia parlano da sole. Però l'aspetto stilistico è l'unico elemento che in questo caso di specie è neutro: non si può dire niente contro o a favore (in virtù della casistica troppo ampia e variopinta in possesso). Per gli scostamenti bisogna vedere tribù per tribù (o area per area). Di norma non ci sono grandi scostamenti (i popoli che avevano contatti diretti con i Romani cercavano di imitarne anche il peso), tuttavia ho visto anche monete sottopeso o troppo in carne. PS: comunque la si pensi, è bello vedere interesse.1 punto
-
Descrizione: Al dritto:PHILIPP.D.G.REX.ARA.VTRI, testa del Re con corona e volta a destra,dietro sigla GR, sotto al collo data e sigla:1575VP... Al rovescio:IN.HOC.SIGNO.VINCES✠, croce di Gerusalemme accantonata da crocette simili...1 punto
-
E un 3 cavalli coniato sotto Filippo II di Spagna per il regno di Napoli,e del tipo con data 1575 sotto al collo,con sigla GR del mastro di zecca Germano Ravaschieri dietro la testa del Re e la sigla VP del mastro di prova Vincenzo Porzio a destra della data sotto al collo... La moneta è catalogata al numero 160, pagina 145 del Magliocca, è considerata R3(rarissima)...1 punto
-
Stavo cercando anche io... qualcosa ho trovato:1 punto
-
Di recente ho acquistato il raro catalogo di vendita della collezione di Di Rauso Civitas neapolis, quella con la copertina rigida e con capitello. All'interno vi era un foglio volante con una nota che giustificava una seconda stampa del catalogo e un'errata corrige. Spero di fare cosa gratita nel pubblicarla.1 punto
-
Ciao Mauro, ti confermo che questo seriale rientra nelle 1000 lire carta ocra, come tutte le *A - Y ✌️1 punto
-
1 punto
-
Per essere precisi Un ascesso è una raccolta purulenta e può essere localizzata ovunque. Può essere esito anche di carie e lesioni dentali. Non capisco queste puntualizzazioni che non portano nulla di fondamentale alla discussione. peace and love1 punto
-
Un esempio a costo ridotto non lontanissimo dal valore dell'argento .925 contenuto: una conservazione modesta che non sottrae nulla al fascino della moneta, 28.28 grammi ed un diametro di 38.61 mm. Una mia corona UK1 punto
-
Bella moneta, non circolata ma con diversi segnetti da contatto Posto anche la mia, ex asta NAC 47 del 20081 punto
-
Mi aveva dato l'idea di una moneta buona ma molto circolata. In effetti sono stato eccessivamente precipitoso, vi sono dei segni di fusione molto evidenti, come le bollicine sotto la L del valore e nel campo del dritto. Mi scuso per aver dato un'indicazione errata. Chi vende questi falsi, che sono relativamente insidiosi per chi ha poca esperienza o per chi ha fretta (ho fatto l'identificazione rapidamente durante il check in aeroporto - cosa che non andrebbe fatta mai e poi mai!!), andrebbe evitato come la peste. Devi cercare di acquistare da alcuni venditori verso cui riporre assoluta fiducia.1 punto
-
La conoscevo questa storia, se così si può dire. In fondo Ramsess è stato uno dei capi di stato più potenti della sua epoca e riservargli degli onori non mi sembra così insensato o paradossale. Ad esempio grazie a lui (e alla controparte ittita) che nasce una vera diplomazia strutturata statale. Vari ascessi. Ma i denti sono stati trovati anche estremamente consumati in quanto, essendo vissuto per molti anni (anche per gli standard odierni) ha avuto modo di consumare più a lungo il pane egiziano che purtroppo contrneva delle tracce di polvere e sabbia.1 punto
-
è un pentanummo di antiochia, a occhio direi Giustino I, ma da confermare vedete in rosso la Epsilon rovesciata .. = 5 nummi in verde la parte diciamo edicola/struttura con colonne in giallo la Tyche di Antiochia saluti Alain1 punto
-
Ciao Se sono fdc,che motivo ci sta di pulirle? Saranno circolati.... Se parliamo di circolati per gli euro,un risciacquo anche sotto il rubinetto per pochissimo va pure bene,piú sapone neutro. Ovviamente massaggiando coi polpastrelli. Il termine rendere " belle brillanti" in numismatica equivale a bestemmiare😅,in quanto se rendessimo " blillante" una moneta,significherebbe che ci siamo "impegnati" a distruggerne la bellezza e la storia( parlando di patine). Quindi non rendere mai brillante nessuna moneta. Se anche dovesse trattarsi di un fdc che si è patinato un pò,lascialo stare,perchè gli euro "soffrono" molto la pulizia imprudente,anche e solo con le impronte digitali. Saluti Poi per caritá,i metodi di pulizia esistono,ma ponderati,fatti con coscienza ed esperienza e cambiano da monetazione a monetazione,sia per il metodo ,sia per la complessitá,che per la "forza di intervento".1 punto
-
Buonasera a tutti, oggi vi propongo un libro interessante sulla tematica della figura femminile nella cartamoneta, non è che se nè trovino molti: Autore: Natalia Aspesi e Maria Letizia Strocchi Titolo: "Valore donna: l'immagine femminile nella banconota", edizione 1991, pp. 112, formato 22 x 29. Copertina rigida di colore verde con titoli in bianco al piatto anteriore e sul dorso. Sovraccoperta illustrata. Prefazione di Nilde Jotti. Indice: L'opera si apprezza sia per l'ottima qualità della carta sia della stampa delle oltre 120 immagini che fanno apprezzare ed esaltare le classificazioni e le caratteristiche che le autrici hanno individuato ma facendole confluire in un denominatore comune: il valore della donna. Di seguito alcune immagini del libro: Nota storica: il primo foglio di carta stampato e convertibile in oro o argento, con la raffigurazione di una figura di donna risale al 1797, anno in cui la Banca d’Inghilterra ne emise una con la Britannia. Invece in Italia nel 1799 viene emessa la banconota da 100 lire delle Regie Finanze con due figure muliebri che riportano lo stemma dei Savoia in rilievo a secco, su una faccia una figura agreste con specchio e sull’altra la vittoria alata. Grazie a tutti, numys1 punto
-
Riprendo questa vecchia discussione per segnalare un ulteriore esemplare tratto dagli stessi conii che sarà a breve in asta. Bruttium, Kroton AR Stater. Circa 530-500 BC. Tripod, legs terminating in lion's paws, with ornaments on and serpents rising from the bowl; ϘPO to left, maeander pattern as exergual line / Incuse tripod, legs terminating in lion's paws, ornaments and serpents in relief; incuse maeander pattern below.; cf. Roma XVIII, 490 (same dies), Triton V, 1127 (same) and Triton II, 120 (same) for the only other three known examples. 8.45g, 29mm, 12h. Very Fine. Extremely Rare - the fourth known example. From a private European collection. Gli editori, sulla scia dei precedenti cataloghi di vendita, continuano a sottolineare che si tratta di un esemplare “Unpublished with maeander pattern in the major collections and reference works” e che questo è il quarto esemplare noto, nonostante la presenza di due pezzi rispettivamente nella collezione Fabricius (SNG 131) e a Winterthur (Bloesch 1987, I, 491), segnalati nel post precedente e la provenienza di due esemplari – pure sopra ricordati – da ben noti ripostigli dell’Italia meridionale (IGCH 1881, 1884, 1885) peraltro tutti editi integralmente e corredati da tavole illustrative. Si tratta certamente di una moneta con una peculiarità (esergo a meandro) che la rende rara, ma il computo degli esemplari noti è di nove e non quattro unità. 1. Reggio Calabria, MN 394, rip. S. Stefano di Rogliano 1910 (IGCH 1884), 16 (31.5 mm; 8,68 g) 2. Roma Num. 104, 2022, 37 (coll. privata europea: 8,45 g) 3. Reggio Calabria, MN 259, rip. Curinga 1916 (IGCH 1881), 127 (29.5 mm; 8,13 g) 4. Aarhus, SNG Fabricius 131 (29 mm; 7,60 g) 5. Reggio Calabria, MN 2235, rip. Strongoli 1955 (IGCH 1885), 10 (31 mm; 7,55 g) 6. Noble Num. 124, 2020, 2951 (coll. R. Tonner) ex CNG Triton V, 2002, 1127 (coll. N. Rudman: 7,42 g) 7. CNG Triton II, 1998, 120 (30 mm; 7,42 g) 8. Roma Num. XVIII, 2019, 490 (coll. privata europea “outside of Italy prior to Dec. 1992”: 28 mm; 7,32 g) 9. Winterthur 491 (= Naville XII, 1926, 561: 30.6 mm; 7,00 g)1 punto
-
A giudicare dalla forma delle torri, a me sembra sia capovolta solo quella in alto a sinistra. Occhio di falco! Complimenti1 punto
-
Ciao Skuby, Argomento “fumoso” e spinoso, che tuttavia è necessario chiarire come giustamente scrivi. Di seguito il link allo scritto di Head e le due pagine di quello del barone de Hirsch, entrambe pubblicate in Numismatic Chronicle del 1883: https://sas-space.sas.ac.uk/5925/2/T-23-6.pdf Devo ammettere che leggo troppe evidenze o certezze sull’iconografia e sulla provenienza per potere accogliere senza battere ciglio altre stranezze della vicenda. L’unica cosa certa è che dietro il tetradrammo di Aitna si celi un genio.. il resto andrebbe sondato a fondo, le “stranezze” giustificate.1 punto
-
Rimanendo sempre in Abruzzo, ho aggiunto in collezione questo quattrino di Giovanna II, Con rarità R2 dal catalogo Giuliani/Fabrizi, n. 126a. Presenta la legenda Regina Ivhanna al diritto, con il giglio nel II quarto della croce patente Saluti Eliodoro1 punto
-
Ma che fierezza ..... Splendida questa testa d'aquila. .1 punto
-
Apro questa nuova discussione con il collegamento ad una vecchia di una decina di anni fa, quando sul forum vi era ancora la voglia di discutere e di confrontarsi e di "parlare" di monete... In quel bel periodo postare una moneta non era solamente per metterla in "vetrina" o ostentare un nuovo acquisto, ma si ponevano interrogativi, si cercavano spunti, ci si confrontava cercando di trovare risposte o creare nuovi dubbi... Ora non facciamo i nostalgici, ma con la scusa di condividere il nuovo inserimento in collezione mi sembrava d'obbligo collegarmi con questa vecchia discussione, che ritengo interessante e degna di una rilettura. La moneta che voglio mostrare è come quella proposta allora dall'amico @andyscudo, una imitazione del quarto di savoia della zecca di Masserano. Ora col passare del tempo rimane poco da discutere, già condividevo le opinioni allora ed oggi le sposo completamente. Questa tipologia vuole imitare il quarto di Aosta di Emanuele Filiberto ed è attribuibile a Besso Ferrero Fieschi proprio per l'esatta lettura del diritto già data nella precedente discussione. Infatti al diritto in campo è chiara la scritta in gotico FER II ed in legenda MAR MESSERANI, traducibile in Ferrero secondo marchese di Messerano, quindi Besso, marchese dal 1547 al 1584, tutto il periodo di Emanuele Filiberto. Al rovescio la croce mauriziana col motto NON NOBIS DOMINE (non a noi Signore) Il mio esemplare, come spesso accade in queste monete "truffaldine", non è in perfetto stato, ma è identificabile e presenta ancora parecchie tracce dell'argentatura di cui era ricoperta.1 punto
-
E vediamole le due monete del 1790: Il Tarì con stemma del Conte Coppola e il nuovo con Corona d'alloro del Cavalier Planelli.1 punto
-
Buon giorno a tutti. Ho appena scoperto questa discussione e amerei avere i vostri pareri a proposito di questa parpagliola di Milano. Secondo voi, moneta autentica o falso d'epoca? Se autentica, quale Filippo? Metallo=Rame con resti d'argentatura. Dimensioni=mm.18. Peso=g.1,62. PS: l'avevo postata nella rubrica "identificazioni" .1 punto
-
Ok, mettici un italiano e c'è subito qualcuno che scopre che il nuovo direttore era il cugino della sorella della cognata di uno zio di tuo nonno. E parte il linciaggio mediatico. Una grande banca ha un direttore straniero, idem alcune aziende importanti. E la globalizzazione, gente !1 punto
-
Buon fine settimana a tutti, controllando nella galleria immagini del cell ho trovato queste vecchie foto di una rarissima 1856 mandatemi da un Amico che la aveva in Collezione. Ho deciso di condividerla in questa bella discussione di @Raff82 , spero vi faccia piacere. Errore in legenda di inversione di lettere: TVR anziché VTR Il Gigante (2018) al numero 87/b la riporta R3 Il Magliocca 566/a anche R3 Un caro saluto a tutti. Rocco681 punto
-
Sono andato a vedere le immagini sul catalogo de Lamoneta e tra i molti grossi di Ranieri Zeno sono del tipo Morosini le monete tipo 3, 6 e 7. Un'altra caratteristica di queste emissioni è il punto dopo VENETI che nelle sucessive scompare. Arka1 punto
-
Vi aggingo una curiosità sui grossi di quest'epoca. Se guardate attentamente il grosso di Marino Morosini noterete che i volti dei tre personaggi ivi rappresentati sono abbastanza grossi e piuttosto lunghi. Se guardate lo stesso particolare in quello di Pietro Gradenigo noterete una notevole differenza di stile. I volti si fanno più piccoli e più eleganti. Questa differenza di stile arrivò per la prima volta sotto il dogado di Ranieri Zeno, che, quindi, ha i grossi di entrambi i tipi. La riforma deve essere stata fatta nei primi anni del dogado, poichè i grossi con il viso lungo sono molto più rari. Arka1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?




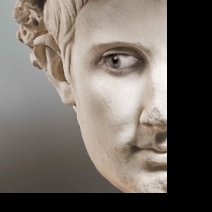
















.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)