Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 02/22/23 in tutte le aree
-
I legni di Ercolano: l'antichità ora ha un'aria di casa L’eruzione del Vesuvio carbonizzò senza bruciare arredi e oggetti: un patrimonio straordinario e unico, finalmente esposto al pubblico nella mostra "Materia" Un letto proveniente dalle domus di Ercolano, esposta nella mostra “Materia” - Luigi Spina I latini distinguevano tra legna da ardere e legna da costruzione: la prima è “lignum”, la seconda è “materia” (voce rimasta in spagnolo, madera, e portoghese, madeira). Il legno dunque non solo come materia prima ma la prima tra tutte le materie. E “Materia” si intitola la mostra che per la prima volta espone “il legno che non bruciò a Ercolano”. Fino al 31 dicembre nella Reggia di Portici, sede in età borbonica dell’Herculanense Museum, la raccolta dei primi scavi e germe del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sono infatti raccolti armadi, tripodi, sgabelli, letti, tavole, larari a forma di tempio, una culla, ritrovata con i resti del neonato. E poi lo scafo di una barca, un dritto di prora, un argano. Portamonete con serratura e il loro contenuto. Elementi decorativi in avorio e bronzo. E tavolette per la scrittura: il legno come supporto scrittorio è testimoniato a Ercolano da otto archivi privati di tavolette incerate trovati all’interno delle domus, che hanno conservato il contenuto graffito. Unicum tra gli unica, il soffitto del salone dei marmi della Casa del Rilievo di Telefo, ritrovato nel 2009. Divelto e rovesciato dallo spostamento d’aria, era finito sulla sabbia umida del litorale e quindi coperto dal fango poi solidificato: una particolare condizione che ha conservato il legno “vivo” e persino elementi della cromia. I cassettoni sono assemblati quasi esclusivamente a incastri a mortasa e tenone, senza uso di chiodi. Lo stato di conservazione di alcuni lacunari ne permette tutt’oggi smontaggio e rimontaggio. Una culla carbonizzata proveniente dalle domus di Ercolano, esposta nella mostra “Materia” - Luigi Spina Ercolano è di fatto l’unico sito che attesti con larghezza l’ebanisteria e la carpenteria dell’antichità romana. Oltre agli arredi mobili sono oltre trecento i legni architettonici rimasti in situ come travi, porte, tramezzi, balaustre, arredi di bottega. Nella sequenza di distruzioni e ricostruzioni che segna la storia delle civiltà, gli oggetti d’uso, anche quelli di pregio, e gli elementi costruttivi realizzati in una “materia” deperibile come il legno, sono sempre i primi ad andare perduti: bruciati, demoliti, consunti, gettati via. Paradossalmente è stata proprio la distruzione operata dalla celebre eruzione del Vesuvio del 79 d.C. ad averceli consegnati. A differenza di Pompei, devastata da una nube di ceneri e lapilli, la massa alta 20 metri di fango lavico ad altissima temperatura precipitata sulla città ha fatto sì che a causa dell’assenza di ossigeno il legno si sia carbonizzato e non combusto. Ma questi legni per diverse ragioni, principalmente conservative, sono sempre stati nei depositi. Solo un impegnativo e sperimentale progetto di restauro, tuttora in corso, coordinato da Elisabetta Canna e realizzato con la consulenza dell’Herculaneum Conservation Project, ha consentito di renderli in parte visibili. È una mostra che riporta il mondo antico alla nostra quotidianità. La persistenza, persino formale, degli arredi fa cadere la distanza di due millenni. È la forza di Ercolano e la mostra, attraverso l’allestimento, enfatizza la continuità dell’esperienza umana rispetto al dato scientifico, che pure può essere approfondito attraverso una app: «La mostra sui legni è stata un modo per avvicinare tempi lontanissimi – spiega Francesco Sirano, direttore del Parco archeologico di Ercolano e curatore della mostra – Mi sono rifiutato di scrivere “letto” vicino al letto, “culla” accanto alla culla. Abbiamo invece voluto accompagnare il percorso con citazioni di ogni tempo, non solo antiche. La statua, il mosaico, la pittura non sono la nostra esperienza quotidiana. Ma i mobili, quelli li abbiamo tutti. E sappiamo bene che un tavolo non è semplicemente un piano con quattro gambe, ma uno spazio di confronto e di condivisione della nostra vita». La mostra non è solo un modo nuovo di avvicinare l’archeologia ma ha una dimensione programmatica. Non a caso Stefania Siano, co-curatrice, la definisce «necessaria e improrogabile»: «L’eccezionalità di questo complesso di oggetti ha assunto un significato sempre più identitario per il sito». Se “ materia” contiene in sé “ mater”, questa mostra allora è la madre del futuro prossimo di Ercolano. https://www.avvenire.it/agora/pagine/i-legni-di-ercolano-mobili-carbonizzati-materia-mostra-alla-reggia-di-portici4 punti
-
Nella propria collezione - così come nei cataloghi d'asta - ognuno può metterla come gli pare. Ma dal punto di vista scientifico la risposta è una sola: l'autorità emittente è una cosa, il tipo un'altra. Le monete di consacrazione di Antonino Pio son state emesse sotto Marco Aurelio, quindi l'autorità emittente è Marco Aurelio, come infatti fa il RIC. Se no cosa facciamo, questa la inseriamo in collezione con i denari di Augusto?3 punti
-
Fonte: https://www.stilearte.it/acquedotto-romano-tempietto-e-altre-strutture-antiche-emergono-durante-gli-scavi-della-pedemontana-delle-marche/ Acquedotto romano, tempietto e strutture antiche emergono dagli scavi per la strada delle Marche “Uno degli scavi archeologici più estesi, nell’area che sarà percorsa dalla strada si trova in corrispondenza del nuovo svincolo di Matelica Ovest, e occupa un’area di circa 4,7 ettari. – scrive la Soprintendenza delle Marche – Nonostante il ridotto interro e l’intensa attività agricola protrattasi nel tempo con arature, filari di vigna e buche agricole (in verde nella planimetria allegata), lo scavo restituisce numerose testimonianze delle frequentazioni dell’area, che si estendono dalla preistoria all’età rinascimentale”. Sono stati infatti indagati nel corso delle diverse fasi di indagine: un’area di abitato con buche di palo e capanne databili all’eneolitico diverse capanne e resti di abitato databili tra l’VIII e il V sec. a.C. una necropoli con tombe a tumulo e fossato anulare riferibili al VI-V sec. a.C. una strada romana con orientamento E-W di cui sono state riconosciute diverse fasi a partire dall’età repubblicana e presumibilmente in uso almeno fino al tardo-impero una piccola struttura votiva di età repubblicana-augustea un impianto produttivo di età romana (I sec. a.C – III sec. d.C.) un acquedotto di età romana un acquedotto di età rinascimentale “All’età del rame può essere ricondotta, allo stato attuale delle indagini, solo una parte dell’abitato messo in luce testimoniato dalla presenza delle buche di alloggiamento dei pali attribuibili a una struttura a pianta rettangolare absidata. Tra i rinvenimenti più importanti un frammento di ceramica decorato a punti impressi, che trova confronti con il sito di Conelle di Arcevia e un punta di freccia in selce” scrive la Soprintendenza delle Marche. Qui si vedono benissimo le buche di palo se seguite il profilo si vede molto bene l'edificio absidato con una serie di buche centrali longitudinali “Dal periodo orientalizzante e arcaico e fino al V sec. a.C. le due aree vengono occupate da una serie di strutture abitative sparse, talvolta molto distanziate tra loro, che mostrano orientamenti e forme differenti: da quelle sub-rettangolari absidate a pianta molto allungata (lunghezza tra 19 e 33 m) a quelle di forma ovale e rettangolare più piccole. – prosegue la Soprintendenza – La copertura doveva essere straminea nelle strutture più antiche e di tegole in quelle più recenti. Frammenti di tegole associati a intonaco incannucciato e materiale ceramico sono stati rinvenuti, oltre che in alcune delle buche di palo, anche all’interno dei numerosi pozzetti e fosse legati alle attività domestiche e artigianali svolte negli spazi esterni in prossimità delle abitazioni”. Una necropoli, databile a partire dal VII-VI sec. a.C., era collocata a breve distanza dall’abitato. Sono stati individuati almeno 3 fossati anulari, su uno dei quali si imposta una struttura di V sec. a.C. “L’area, allo stato attuale delle ricerche, sembra essere stata frequentata pressoché ininterrottamente fino alla piena romanizzazione, quando venne realizzata una strada di ghiaia, pietre e calce che, con andamento E-W, metteva in comunicazione municipium di Matilica con il diverticolo della Via Flaminia che risaliva la Valle del Potenza verso il municipium di Nucera Camellaria. – prosegue la Soprintendenza marchigiana – La prima fase della strada, databile per ora genericamente all’età repubblicana, mostra vari rifacimenti non perfettamente sovrapposti tra loro, ma con spostamenti dell’asse anche di alcuni metri”. Al di sotto della strada sono emerse grandi fosse di cavatura nel limo argilloso che hanno restituito materiale ceramico in fase con l’abitato di V sec. a.C. L’attività di estrazione del limo argilloso è attestata anche in fase romana in un’ampia area in prossimità del margine stradale, dove è emersa una grande area di cava. Sul lato S della strada è stata messa in luce una piccola struttura votiva in muratura a pianta quadrangolare aperta sul lato est. “A testimonianza della defunzionalizzazione rituale avvenuta in antico, è emersa una lastra di rivestimento in terracotta decorata a rilievo con due palmette contrapposte e due spirali oblique su cui era collocata una moneta in bronzo inquadrabile cronologicamente all’ultimo quarto del I secolo a.C. – dicono gli archeologi della Soprintendenza – La lastra poggiava a sua volta su un livello di tegole in frammenti, accanto ai quali è stata rinvenuta una piccola testa in terracotta parzialmente cava sul lato posteriore. Nello strato sottostante dei piccoli chiodini/ribattini in ferro erano probabilmente riconducibili a un manufatto in materiale deperibile. Questo piccolo edificio di culto, dismesso in età augustea, insiste sugli stessi livelli su cui si imposta la strada di età repubblicana, rendendo plausibile una datazione alla stessa fase”. Sul lato N della strada si apriva, invece, un vasto edificio adibito ad attività produttive, conservato al livello delle fondazioni. L’indagine ha messo in luce i resti di una piccola vasca con pavimentazione a mattoncini e 2 fornaci, di cui si conserva solo la parte relativa alla camera di combustione e ai praefurnia. I materiali rinvenuti negli strati archeologici di riempimento e nei butti immediatamente al di fuori della struttura permettono di collocare la vita di questo impianto tra il I sec. a.C. e il III d.C. L’edificio era sorto al di sopra di una parte dell’insediamento preromano, come testimoniano le buche individuate al di sotto dei livelli romani. All’interno dell’Area A3 è stato rinvenuto un acquedotto romano, che riforniva il municipium di Matilica, realizzato in trincea aperta con spallette in opera cementizia foderata di mattoni e fondo in mattoni. La struttura risulta spoliata in molte sue parti e priva della copertura. All’estremità sud di scavo è stato portato in luce un tratto dell’acquedotto rinascimentale di approvvigionamento idrico della città di Matelica risalente agli inizi del 1600.3 punti
-
Sei un serio collezionista? Sicuro? Allora possiedi il requisito necessario per l'acquisto di questa banconota!2 punti
-
Salve a tutti. Dopo le interessanti discussioni su splendidi argenti apro una parentesi su un piccolo bronzo. Dovrebbe essere il primo tipo coniato a Thurium . al D/ Athena con elmo attico verso destra, al R/ toro andante verso sinistra, con testa abbassata; sopra ΘOYPIΩN; lettera A tra le zampe del toro; in esergo ? . Diametro 15,5 mm peso 2,83 gr . Classificato come HN Italy 1904, SNG Cop 1494, Attianese Calabria Greca 1250, BMC 124 (con toro verso destra), in nessuno dei tipi richiamati è riportata però la A sotto il toro. Acquistata una quindicina di anni fa da Lanz non ho trovato in aste seguenti, in cataloghi o in sillogi questa variante con lettera A sulla quale chiedo, come ormai è mia abitudine, lumi agli amici del forum che ringrazio anticipatamente. PS) le foto lasciano un po' a desiderare perchè ', oltre alle mie non grandi capacità, la patina nera, molto solida, è lucida e crea qualche difficoltà2 punti
-
Sembrerebbe un cavallo a nome di Carlo VIII, zecca L'Aquila. Cavallo (con croce mulinata) (lamoneta.it)2 punti
-
Ne possiedo una similare che mi è stata valutata una ventina di euro, però proviene da un rotolino intonso della zecca e non dalla circolazione.2 punti
-
Chiunque, anche tu. Basta che la giri dall'altra parte, dove c'è scritto petronius2 punti
-
.....e con varie angolazioni e "giochi di luce" ,visto che potrebbe esser anche "mascherata". Saluti2 punti
-
Ha il valore di un "buongiorno... grazie": irrisorio se provi a venderli, ma elevato per molte persone2 punti
-
2 punti
-
Vista l'ammucchiata di Rocco...La serie del 1804 con qualche doppione...2 punti
-
Ciao, è veramente molto leggera, quasi invisibile... anzi, è proprio invisibile! hai dimenticato ad allegare un'immagine.1 punto
-
Buonasera a tutti, tra le mie più belle. Una Tris di Argentini Borbonici Saluti Alberto1 punto
-
Nikita ma scherzi? Quella è una rarissima 5 euro stampata tutta al contrario! Infatti se leggi bene sono ORUE 5! 🙃 5000 euro di quelli standard le vale sicuramente1 punto
-
E' autentica se hai pagato circa 100mila euro per venirne in possesso, o se un tuo padre/zio/nonno ha sborsato un centinaio di milioni di lire per venirne in possesso, o se il tuo bisnonno era un generale di corpo d'armata o Ministro del Regno. In tutti gli altri casi è falsa.1 punto
-
ciao @nordcore Prendi quello che scrivo come un invito ad ulteriori approfondimenti. E' sempre difficile identificare queste monete soprattutto quando manca la parte di legenda che indica il granduca, comunque l'unica moneta dei medici con lo stemma a targa, simile alla tua, mi sembra essere la prova del doppio soldo di Ferdinando II riportata dal: Pucci III (prove e progetti), Mir 313, e Galeotti XXXV. Sarebbe in questo caso di grande rarità.. Di peso e diametro sei sicuro? Perché il peso di 1 grammo corrisponde alla crazia più che al quattrino, il diametro di 18 mm corrisponde al quattrino ma non agli esemplari citati dai riferimenti che ti ho indicato, in questo caso dovrebbe essere almeno 20 mm. Se fosse effettivamente una prova di moneta peso e diametro potrebbero comunque variare dai tipi consueti. Sentiamo anche @fofo se ha qualche idea Aggiungo la nota di Andrea Pucci Dimenticavo.. non pulirla per carità ! Un saluto1 punto
-
Io scelgo in base alla rappresentazione del rovescio! Mi piace il caduceo, le rappresentazioni di Ercole o alcuni rovesci che , per me, evocano qualcosa di particolare. Per gli acquisti ti consiglio o asta o rivenditori che trovi anche qui su questo forum! Puoi cercare nei loro siti e vedere se trovi qualcosa che suscita in te emozione o anche semplice interesse. oppure puoi scegliere in base alla qualità stilistica del dritto ( Gordiano non doveva essere proprio bello bello a vedere dal profilo)….. Diciamo che ognuno ha le sue preferenze e i suoi criteri, non ne esistono di oggettivi!1 punto
-
Ciao, sono anch'io abbastanza nuovo del forum quindi ti rispondo in base a tutte le discussioni che ho letto e alla poca esperienza fatta sulla mia pelle. Non saprei proprio dirti il tipo di moneta da cui iniziare. Puoi scegliere un ordine temporale o andare esclusivamente a guasto o scegliere un argomento. Per l'acquisto tendenzialmente se ti affidi a negozi di numismatica ti stai affidando a professionisti che ti danno garanzie di ciò che acquisti. Acquistando da case d'asta anche in questo caso hai garanzie in merito a ciò che compri ma leggevo che visionando centinaia di monete per ogni asta qualche errore ci potrebbe essere. Per il resto ad esempio i noti siti di acquisti online non ti danno garanzie di ciò che compri e bisogna valutare chi è il venditore guardando magari recensioni rispetto al suo profilo. Però diciamo che è la zona un po' più rischiosa. In questo forum c'è poi una sezione molto utile per chi come noi approccia alla numismatica in cui puoi ricevere pareri su monete postando foto e possibilmente dati dettagliati del peso e dimensioni. Ci sono persone che hanno visto fior fior di monete e falsi e quindi in caso di palese "tarocco" riescono a dartene indicazione. Inoltre se cerchi nelle discussioni ci sono parecchie indicazioni su particolari su cui soffermarsi per individuare un falso. Ma in assoluto credo che una perizia numismatica sia il metodo più certo. Buon divertimento1 punto
-
1 punto
-
Ah ecco, quindi gli appassionati di numismatica sono solo quelli che comprano per rivendere? Chi compra per passione o perché gli piace il semplice collezionismo non è da considerarsi un numismatico? Senza offesa, ma che stai a di'?1 punto
-
La sicurezza è un grosso problema. Spero che chi di dovere cominci a fare in modo che venga assicurata. Sarebbe più che ora. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
In effetti la doppia C potrebbe spiegarsi con lo scivolamento di conio e anche la mancanza della L e la V parziale. Ripeto mia opinione. Ecco come dovrebbe presentarsi la leggenda al diritto: Foto prese dal web Saluti Alberto1 punto
-
Magnifica. Si può dire che è tra le migliori esistenti? E questo è un salvadanaio rotto.1 punto
-
Ciao sembra più Cosimo iii che Ferdinando… prova a guardare qui. https://numismatica-italiana.lamoneta.it/riepilogo/SW-COS31 punto
-
1 punto
-
Ciao Rocco. Pietro mi ha detto che la moneta non è presente nel medagliere. Il fatto è strano poiché il re non solo ha sbagliato a trascrivere la legenda, ma anche il millesimo! Quindi, a quanto pare, Vittorio Emanuele non aveva in collezione nessuna piastra del 1802.1 punto
-
In questa conservazione non si può parlare di valore economico. Ma rimane la testimonianza di un travagliato periodo storico.1 punto
-
1 punto
-
Io le metto in base alla data di emissione della moneta quindi direi sotto Marco Aurelio1 punto
-
1 punto
-
Salve Sicuramente vale più di 20 centesimi quindi vale la pena in ogni caso tenerla da parte. Il valore è molto difficile da determinare perché dipende da quanto qualche collezionista di questi errori sarebbe disposto a spendere. Però sicuramente vale la pena conservarla.1 punto
-
1 punto
-
Buona serata, per esprimere un parere è necessario mettere un paio di foto, dritto e rovescio della moneta.1 punto
-
l'Italia a mio parere potrebbe; anzi dovrebbe coniare una serie di monete commemorative dedicate ai grandi uomini della Massoneria. Monete in Oro di Francesco D'Aquino, di Cavour come di Garibaldi e Bixio; Vittorio Emanuele II così come Ugo Foscolo ed Enrico Fermi. Tutte rigorosamente in Oro - solo , non argento od altro - in onore all'aulico messaggio massonico come allo spessore degli appartenenti, di nascita peninsulare, nel corso degli ultimi trecento anni1 punto
-
Ci provo anch'io, ma non sono al tuo livello!!! La mia è un'ammucchiata amatoriale...1 punto
-
Quel giorno ero contento di poter incontrare il "papà" di uno dei miei eroi della mia infanzia ed era stata organizzata una giornata celebrativa in tuo onore e per quello che sei stato capace di creare. Ma all'improvviso non potesti venire, poiché ti sei ritrovato ad affrontare una grande battaglia e che hai combattuto con lo stesso spirito che è presente nei racconti che ci hai lasciato... "Ci rivedremo in quel luogo dove le ruote del tempo si incrociano". Buon viaggio Maestro Matsumoto. Akira "Leiji" Matsumoto ( 25/01/1938 - 13/02/2023 )1 punto
-
Buondi', Sempre belle da vedere.....in ogni posizione le si metta.1 punto
-
Non so se questa sia la sede più opportuna, nè se sia stato già segnalato, ma Rai3 ha prodotto un meritorio Servizio sul medagliere del Museo di Siracusa. Interessanti le immagini anche se un po' semplificati i commenti. https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2023/02/mediterraneo-siracusa-museo-orsi-monetiere-61497138-2041-4f5c-8aa1-c49abbc9271e.html?nxtep1 punto
-
È risaputo: i gatti sono animali molto puliti e si dedicano spesso alla cura della loro igiene personale. e poi - naturalmente per il bene dei felini domestici che si ammutandano - si potrebbe aumentare il ritmo del ricambio degli indumenti intimi, ed il gioco è fatto!1 punto
-
Circa la bonifica degli acquitrini nel territorio di Selinos é interessante leggere il seguente scritto PDF del professore Simone Rambaldi del 2010: https://core.ac.uk/download/pdf/53279422.pdf L’autore rigetta fondamentalmente l’ipotesi del collegamento con le vicende di Empedocle nel quadro di una più ampia attribuzione ai culti delle specifiche divinità fluviali di una polis, per quanto concerne le raffigurazioni di Selinos ed Hypsas sulle emissioni della colonia fondata da Megara Iblea.1 punto
-
Non avevo notato il peso 3.54 (Gorny) vs. 3.60 (Lanz). Direi che da Lanz già il peso condannava la moneta: quando mai eccedente in una moneta d'oro? Per curiosità ho fatto un rapido sondaggio e di ducati con peso 3.60 g ne compaiono solo 9 nelle varie aste (al confronto con 400 del peso 3.54 g e 455 di 3.53 g), di cui uno è quello Lanz, uno è un Antonio Venier (dubbio, anche se non il tipo con nimbo interrotto) e gli altri 7 sono verosimili falsi o imitazioni levantine (probabilmente con titolo aureo ribassato). E' plausibile che il peso dell'esemplare Gorny sia stato adattato per non far porre troppi sospetti ...1 punto
-
1 punto
-
Ciao a tutti, riportata a casa dall'Inghilterra...era un peccato lasciarla là...finalmente farà compagnia al 60 grana, testa piccola, del 18.1 punto
-
Grazie @VALTERI per aver menzionato questa moneta, che offre alcuni spunti di riflessione. Si tratta infatti della moneta censita al n. 532 del famoso Randazzo hoard, ritrovato nel 1980 in Sicilia e ricostruito magistralmente dalla Arnold Biucchi. Questo esemplare era già stato già venduto in asta diverse volte dal 1981 (Bowers & Ruddy, Leu, Genevensis, Nomos). Dal punto di vista numismatico è un tetradramma interessante - artisticamente ad alcuni può non piacere - perché si tratta di una tipologia con il simbolo del “ketos” attribuita al post Demareteion, e quindi al periodo appena dopo la caduta dei Dinomenidi nel 466, quando a Siracusa si restaurava la democrazia. Coerentemente, è una delle ultime monete del ripostiglio, la cui chiusura è attribuita al 450 a. C., e l’elevata conservazione lo dimostra. Una riflessione a margine. Quanto sia opportuno per un collezionista EU (e italiano in particolare) acquistare una moneta ex ripostiglio del 1980 è un altro paio di maniche, e non escludo che questo aspetto possa aver contribuito alla disattenzione di Kuenker nel non rappresentare la prima provenienza della moneta…1 punto
-
Buongiorno. I cataloghi servono all'inizio per conoscere una monetazione e farsi un'idea molto indicativa di prezzi e rarità. Stop. Per tutto il resto serve frequentare i mercatini, i convegni, fare l'occhio sulle aggiudicazioni nelle Aste (oggi con internet anche senza essere in sala, possono essere scaricati i cataloghi e le aggiudicazioni). Il mio Gigante del 2013 credo rimarrà senza sostituti per molti anni ancora...1 punto
-
Cari amici la raccolta dei colli lunghi aumenta notevolmente di qualità con tre sontuosi inserimenti che sostituiscono altrettanti esemplari non malvagi ma certo non così, tutti provenienti dall’asta Nomisma 66. Questo presentato stasera è quello peggio conservato dei tre, seguiranno a breve gli altri due, superiori in quanto privi di quei piccoli graffietti presenti al R che si riscontrano su questo esemplare, periziato dalla casa d’aste qFDC, ma con rilievi davvero attraenti, anche al D. I fondi lucenti si accompagnano a una patina abbastanza leggera al R e quasi eterea, impalpabile al D. La differenza di valore in questi grandi moduli tra il FDC e il BB viaggia a livelli di venti, trenta, anche quaranta volte, a seconda del millesimo. Questo è comune, non così tanto reperibile in questa conservazione. Buona serata1 punto
-
è una moneta tra le più comuni vittima di una bolla speculativa, non escludo che molte siano coniazioni recenti. sarebbe interessante confrontare le varie tipologie di elefanti con quelli conosciuti nell'ottocento, certi sembrano autobotti dello spurgo!1 punto
-
Non riesco a classificare questa tessera mercantile cortesemente potreste aiutarmi? Grazie odjob1 punto
-
Sto controllando lo studio del Bovi "Osservazioni sui maestri di zecca di Filippo II a Napoli" (B.C.N.N. a.XXXIV, n°1, genn-giu 1949) e noto che ci sono sostanziali differenze con quanto, invece, asserito dal De Sopo: mentre quest'ultimo ci dice così: MAESTRI DI ZECCA Giovan Battista Ravaschieri - Sigla IBR 1548-1567 Germano Ravaschieri - Sigla G.R. 1567-1579 Giovanni Antonio Grimaldi 1579-1591 Marco Antonio De Leo - Sigla MAL 1591-1598 Giovanni Antonio Fasulo - Sigla IAF 1594-1598 il Bovi dà date e nomi diversi: Zecchieri durante il regno di Filippo II. Giovanni Battista Ravaschieri ultimo Maestro di Zecca di Carlo V e primo di Filippo II fino al 1564 Germano Ravaschieri 1564-1584 Giovanni del Castiglio reggente 1584-1591 M. Antonio De Leo (o Leto) 1591-1594 Giovanni Antonio Fasulo ultimo zecchiere di Filippo II dal 1594 e primo di Filippo III. E' pur vero che il De Leo comprò, per 6500 ducati, la carica di Maestro di Zecca quando, nel 1591, moriva Germano Ravaschieri, ma, secondo Bovi, ci sarebbe, tra i due, un intermezzo di reggenza di Giovanni del Castiglio (1584-1591): è solo un caso che le iniziali di Iohannes de Castillo (presumo di origine spagnola) siano CI?? Teniamo anche conto che (fonte de Sopo) il Giuno Maestro di prova sotto Filippo III aveva come segno la sola lettera G... D'altro canto, però, il Bovi stesso, in un suo successivo studio ("Le monete di M. A. Leto", B.C.N.N., a.XXXV, n°1, gen-dic 1951), citando spesso la sigla CI (senza, purtroppo, darne spiegazione...), ci dice che essa è presente anche sui tornesi degli anni 1594-5-6-7-8 assieme alla sigla IAF Allora mi chiedo: "Del Castiglio sì o Del Castiglio no?"... Cosa ne pensi?1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?










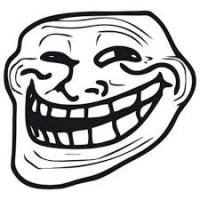

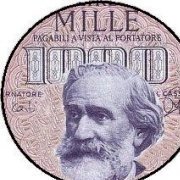


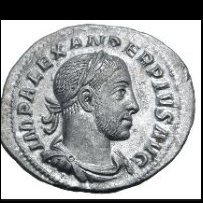



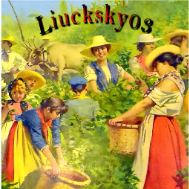
.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)
copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)




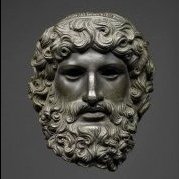
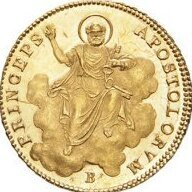



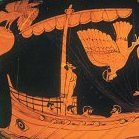



.thumb.jpg.49bf7893ab8deb0b9efbfc02c41b7421.jpg)