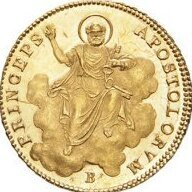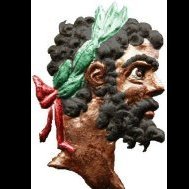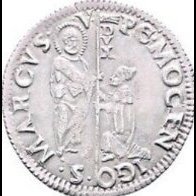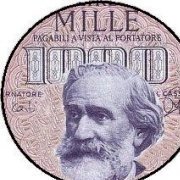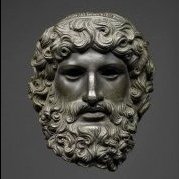Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 06/02/23 in tutte le aree
-
Ciao a tutti, oggi condivido con voi un mio denario di Plautilla: provenienza Numismatica Tintinna. Ex vecchia collezione Inglese. Descrizione del venditore. Impero Romano. Plautilla, moglie di Caracalla (deceduta nel 212 d.C.). Denario. D/ PLAVTILLAE AVGVSTAE. Busto drappeggiato a destra. R/ PROPAGO IMPERI. Caracalla e Plautilla, stanti uno di fronte all'altra, si stringono la mano. RIC 362. gr. 3.45 19.00mm. R. AG. SPL.7 punti
-
Auguro a tutti un buon 2 giugno (Festa della Repubblica....VENETA????😉) ed al tempo stesso vi presento l'ultimo arrivato (che bel modo di festeggiare). Si tratta di un soldino di Andrea Contarini inedito che permette a tutti di capire meglio il perchè di un particolare decreto. La moneta si presenta: Al D/ +ANDR'9TAR'DVX il Doge stante a sinistra con il vessillo, in campo a sinista iniziale del massaro che in questo caso è F (Filippo Barbarigo) Al R/ +.....IFER.VENE.... o VENE.... (per VEXILFER.VENETIA4 o VENECIA4)6 punti
-
4 punti
-
Ciao a tutti a grazie per i suggerimenti: in effetti nel 1914 la Germania ha invaso il Belgio, occupandone per alcuni anni la maggior parte del territorio, e se queste spille furono create per i soldati (tedeschi) allora è logico trovarle da quella parte del confine. Come dice sopra @wstefano avevo pensato anch'io alla "trench art" e nel documto linkato viene mostrata anche quest'immagine come " Jewelry Trench Art" e tra le croci c'è proprio una moneta belga. Devo dire che per me la vera "arte da tricea" monetale è più questa fatta con ciò che si aveva sotto mano e con strumenti più rudimentali. Nel mio (nostro) caso, direi che i dettagli sono troppo ben rifiniti - le montature delle pietre e la catenella, l'argentatura(!) - per non essere di produzione come minimo semi-professionale (senza poi chiedersi da dove avrebbero preso le gemme in trincea ) Anche grazie all'ultimo post di @numys si vede che tante sono davvero molto similli (ordine delle monete, gemme, chiusura dell'ago) azzarderei un'ipotesi dicendo che in un laboratorio venivano assemblate le spille che poi venivano donate ai militari che se le portavano a casa come trofeo della "campagna del Belgio". Se tutti siamo d'accordo, io chiuderei qui il caso! Grazie ancora a tutti. Servus Njk https://www.money.org/money-museum/virtual-exhibits/wwi/trench-art3 punti
-
Ciao, condivido il mio esemplare della stessa tipologia, ovviamente non paragonabile in generale alla tua moneta 🙂 ANTONIO3 punti
-
Con questo soldino (cosa unica) invece abbiamo il caso inverso. Per creare il soldino è stato usato il Rovescio di un tornesello: Si può notare come la legenda VENETIA4 sia ravvicinata e non distanziata come nei normali soldini di Andrea Contarini dando prova certa dell'utilizzo del Rovescio di un conio di tornesello per creare questo inedito soldino. In questo caso sono d'accordo con @Arka sulla casualità. In pratica rompendosi il conio di martello del soldino si è pensato bene di ricorrere in emergenza al conio del tornesello, cosa non plausibile come affermato da @417sonia vista la continuità dell'utilizzo sui torneselli della legenda S.MARCVS.VENETI.3 punti
-
Segnalo l'uscita del n. 395 di Panorama Numismatico. Questo è l'indice: Gianni Graziosi, Il mito dell’uomo selvatico – p. 3 Roberto Diegi, La monetazione di tipo greco in Sicilia, 8, Anche Messina coniò proprie monete – p. 9 Realino Santone, Monete aragonesi del Regno di Napoli, Legenda inedita su un cavallo aquilano – p. 12 Angelo Cutolo, Note sul 15 grana della Reale Repubblica Napoletana con la sigla GAC/S – p. 13 Riccardo Martina, Le medaglie in ghisa fuse a Follonica sotto il Granduca Leopoldo II di Lorena – p. 21 Giuseppe Carucci, Talleri commemorativi di Ludwig di Baviera, prima parte – p. 35 A cura della Redazione, Il valore di una moneta che non c’è – p. 45 Recensioni – p. 50 Notizie dal mondo numismatico – p. 51 Emissioni numismatiche – p. 61 Mostre e Convegni – p. 62 Aste in agenda – p. 632 punti
-
Cari forumisti condivido volentieri 🫢🤣 il lotto 249 dell’ultima asta Varesi 81, ultimo entrato in collezione. Tallero da 80 soldi del Leone di Carlo I Cybo Malaspina signore di Massa di Lunigiana (1623-1662), MIR 319, 39 mm, 25,62 grammi, in buon BB. Sapete quanto rifugga dalle modeste conservazioni, ma qui si tratta di una moneta di straordinaria rarità presa poco sopra ad una base letteralmente ridicola. In un piccolo studio di qualche anno fa apparso su Cronaca Numismatica (“I talleri del leone di Carlo I Cybo Malaspina”, In Cronaca Numismatica n. 216), sono illustrati in tutto sette esemplari di tallero del leone di Carlo I Cybo Malaspina per la zecca di Massa di Lunigiana. Di questi esemplari: sei sono del tipo con valore espresso in numeri romani ed uno, l’unico conosciuto, con valore espresso i numeri arabi. Questo esemplare esitato dal buon Alberto, che sono riuscito non so ancora come a prendere, presenta il valore in numeri arabi! 😳 L’ho raffrontato subito con l’esemplare apparso su Cronaca Numismatica ed è assolutamente diverso (quello è anche leggermente meglio conservato). Ne ho dedotto quindi che si tratti del secondo esemplare conosciuto col valore 80 anziché LXXX. Ho avuto l’occasione nei giorni scorsi di incontrare quasi casualmente un profondo conoscitore milanese della monetazione, tra le altre, anche di questa piccola zecca, che io definisco tra quelle da amatori e gliel’ho portata. Mi ha sgranato letteralmente gli occhi, chiedendomi dove diavolo l’avessi trovata…confermando le mie deduzioni, è proprio il secondo esemplare noto. A volte l’emozione di avere in raccolta un R5, assoluto, mancante anche nella Collezione Reale, supera quella di un bel FDC. E detto da me è tutto dire ✌️😁 Buona serata2 punti
-
Visto che le Sedi Vacanti piacciono, e che se ne parla frequentemente nel forum, voglio presentare una chicca per conservazione che si trova da ormai vari anni nella mia collezione: un testone S.V. 1691. In quella SV non fu coniata la piastra, ma in compenso ben 3 tipologie di testoni con la colomba in direzione destra (capo a sinistra), ascendente e discendente. L'esemplare qui presentato è del 1° tipo (MIR 2106/1) e proviene da asta Nomisma 2012 ed ex Collezione Dolivo, Munzen und Medaillen XXVII, 15-16 Novembre 1963, lotto 836 , FdC. Il Camerlengo era il Card. Paluzzi Altieri, il cui stemma è rappresentato al diritto; al rovescio armetta Corsini.2 punti
-
https://www.panorama-numismatico.com/il-5-centesimi-1913-senza-punto/ Segnalo l’articolo: Il 5 centesimi 1913 senza punto2 punti
-
Grazie a tutti per le risposte, scusate per le foto, ma è la prima volta che le carico, provo ad allegarvene di nuove. Ciao, si è una gran bella serie, purtroppo ho solo questo esemplare da 5 cent e uno da 2 cent del 1917.2 punti
-
Sicuramente visto l'importanza dell'errore, in quanto i soldini corrono a Venezia,nella terraferma e nelle colonie la cosa non è passata inosservata per arrivare anni dopo al decreto che istituiva il locum separatum. Ma la cosa intrigante è il massaro Filippo Barbarigo. Sappiamo della denuncia e dei vari provvedimenti emessi nei suoi confronti e tutto ciò porta a pensare che l'inizio dell'abisso da parte della zecca di Venezia sia iniziato in maniera cruciale con la sua supervisione che definere superficiale è poco. Ci troviamo di fronte ad un furbo ladro che per aggiustare i conti utilizzava soluzioni fantasiose? Bella domanda su cui indagare. Auguro buona lettura e buon 2 giugno2 punti
-
Ciao @motoreavapore, il 1799 è quello con i fantasmini delle lettere al rovescio ? Ti aiuteremo a trovare le varianti che ancora ti mancano 😊 Complimenti per la famigliola ! Se non ricordo male avevamo gli stessi conii per il 1799... Ecco il mio2 punti
-
Buona festa della Repubblica!! Comunque che bella discussione che ho avviato hahahah non mi aspettavo che la mia prima discussione avrebbe avuto tanto dibattito e quindi tanto successo (prima discussione ‘’impegnata’’ dato che le precedenti le feci che andavo ancora a scuola) . Vi ringrazio per i vostri preziosi commenti da cui traspare grandissima esperienza! Mi state insegnando moltissime cose.2 punti
-
2 punti
-
Sempre a proposito di "segni segreti" sulle monete borboniche... Allego la foto di un mio 10 Tornesi 1858 (D/ tutte le V sostituite da A) FERDINAND∀S / ∀TR - variante rara già catalogata.2 punti
-
Salve a tutti, dalla foto della 120 Grana 1835 (legenda separata al Dritto) con conservazione migliore, postata da @LOBU, si può affermare che la tua, @magicoin ha la stessa capigliatura sul ciuffo frontale. Non si avvertono debolezze di conio. Sembra proprio che quel ciuffetto sia stato disegnato in maniera diversa, seppur con minime differenze rispetto allo standard. Concordo con @LOBU sul fatto che non possa definirsi una "variante degna di nota", ma pur sempre una variante, visto che deriva da una scelta stilistica (poco percettibile) da parte dell'incisore che, stranamente però, mantiene tutto il resto della capigliatura nel disegno standard... misteri delle monete napoletane.2 punti
-
Aggiungo che con una rapida ricerca effettivamente ho trovato anch'io molto altre spille veramente molto simili con le stesse monete Questa sul noto sito addirittura pensavo fosse lei stessa e invece le date sono diverse! https://www.ebay.com/itm/184519484070 Comunque visti i molti esemplari che si trovano e che le date delle monete non superano mai il 1914 e la conservazione è sempre abbastanza incompatibile con una lunga circolazione effettivamente potrebbe trattarsi di oggetti prodotti negli anni della guerra con monete belghe magari un po' come ricordo/trofeo per soldati tedeschi che avevano combattuto in Belgio.2 punti
-
Buonasera, ciao @magicoin mi piace il fatto che tu sia costantemente impegnato nella ricerca di nuove varianti... continua così! Comunque, tempo fa salvai l'immagine di questa moneta per confrontarla con delle altre Piastre 1835 legenda interrotta, proprio perché mi incuriosì la forma della testa... Alla fine, l'effige di questa 1835 è risultata essere uno dei numerosi ritratti giovanili di Ferdinando II - in questo caso - con ciuffo, naso e punta del collo leggermente diversi dal tipo base - e seppur si tratti di un conio raro - a mio avviso resta una curiosità, perché non rappresenta qualcosa di così rilevante da poterlo definire una "variante degna di nota". Riguardo la fronte ed il ciuffo, potrebbe trattarsi di un conio sporco/otturato o più semplicemente, di una leggera debolezza di conio. A proposito di ciuffi sulla fronte, ricordo che in un'altra occasione ti allegai anche un'immagine con i diversi tipi di ciuffi (in avanti, all'insù, all'indietro e con ricciolo tondo). In altre discussioni invece, abbiamo anche trattato più nel dettaglio il tema delle diverse effigi sulle piastre con volto giovanile, soprattutto tra il 1833 ed il 1836, quando evidentemente, vi è stata una più che massiccia coniazione di Piastre e di conseguenza, vi fu un'elevata produzione artigianale dei conii. Allego una Piastra 1835 che presenta lo stesso identico conio della tua, ma in uno stato di conservazione leggermente più leggibile. Allego anche un'immagine GIF comparativa con un'altra 1835 del modello base. Spero di esserti stato utile, Lorenzo2 punti
-
Ecco altro esemplare di questa medaglia da poco entrato in collezione, ex Lotto 42 Asta 1213 Pandolfini 29/5/2023 così descritta in catalogo con relative foto: MARCANTONIO GIUSTINIAN (1684-1688) CVII DOGE. MEDAGLIA CELEBRATIVA CONIATA NELLA ZECCA DI NORIMBERGA NEL 1687 OPUS GEORG HAUTSCH Ar gr. 114,38 mm. 72x57 PARCERE SUBIECTIS ET DEBELLARE SUPERBOS SCIT NOBILIS IRA LEONIS Il Doge seduto in trono al centro della scena sotto un regale baldacchino è affiancato da tre consiglieri in atto di ricevere, inginocchiati in segno di resa, i fratelli Mustafà Pascià e Hassan Pascià R/ EX UTROQVE VICTOR Il Leone di San Marco vittorioso, rampante a s., con la d. brandisce una spada avvolta da ramo d’alloro e con la s. stringe un delfino, simbolo del dominio del mare. Al suolo freccia e arco spezzati. Nel taglio: SERENISSIMI LEONIS LATI SOLO SALOQUE TURCARUM VICTORIS TRIUMPHALE FLORILEGIUM 1687 Rif: Volt. 1054; Milford Heaven 88, Vannel Toderi 1990, 54. Rarissima. Eccezionale esemplare con patina di medagliere, SPL/FDC Very rare. Outstanding specimen with cabinet tone, EF/MS Questa bellissima raffigurazione costituisce una testimonianza della resa fratelli Pascià, Mustafà di Nauplia e Hassan “Bassallo di Morea”, che nel 1687 giunsero a Venezia a cospetto del Doge. Costoro, sconfitti pochi giorni prima da Francesco Morosini e terrorizzati dal castigo che sarebbe stato loro inflitto per avere perso la fortezza di Nauplia, preferirono ricevere la protezione del Doge Giustinian che, come testimonia la legenda della medaglia, li accolse con umanità.2 punti
-
ASTA 155 nr 1137. MAXIMIEN HERCULE (286-305), AV aureus, 293-294, Trèves. D/ MAXIMI-ANVS P AVG T. l. à d. R/ HERCVLI D-EBELLAT/ PT Hercule deb. à g., brandissant sa massue pour assommer l'hydre de Lerne enroulée autour de sa jambe. RIC 10; Calico, Aurei, 4659. 5,43 g. Extrêmement rare. Bel exemplaire avec haut relief. Da una rapida analisi del diritto e del rovescio della moneta direi che non si tratti del medesimo esemplare presentato recentemente in asta Roma Numismatics e di cui si è parlato qui:1 punto
-
Catturato il "mostro" del Po: le immagini del pesce gatto di quasi 3 metri (che poi è stato liberato) L'impresa di Alessandro Biancardi: "Ci ho lavorato 23 anni" Il "mostro" del Po è stato catturato. Un pesce gatto di quasi tre metri (285 centimetri per la precisione) finito all'amo di Alessandro Biancardi. Che, lo diciamo a scanso di equivoci, poi lo ha subito liberato. Catturato il "mostro" del Po: le immagini del pesce gatto di quasi 3 metri E' semplicemente incredibile e se non ci fossero le immagini, foto e video, si potrebbe pensare davvero a un fotomontaggio. Ma è tutto vero. Alessandro Biancardi ha beccato sul Po un vero e proprio "mostro": si tratta di un pesce gatto della lunghezza record di 285 centimetri. Quasi tre metri di pesce, una vera e propria rarità, che farebbe invidia a Jeremy Wade, il noto presentatore del programma di successo, River Monsters... La cattura risale a qualche giorno fa ha stracciato il record mondiale per 4 centimetri. Un risultato, spiega il diretto interessato, frutto di un lungo lavoro durato 23 anni. Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4 Non è la prima volta... L'Italia non è nuova a scoperte di questo tipo. Pensate che lungo il fiume Adda, in Lombardia, nel mese di luglio del 2021 alcuni pescatori si sono fotografati stesi insieme a un pesce siluro di più di due metri. Foto 1 di 2 Foto 2 di 2 https://newsprima.it/attualita/catturato-il-mostro-del-po-le-immagini-del-pesce-gatto-di-quasi-3-metri-che-poi-e-stato-liberato/#gallery-1-foto-21 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
https://www.academia.edu/44975910/The_Grosso_of_Enrico_Dandolo The_Grosso_of_Enrico_Dandolo.pdf1 punto
-
un'interessante osservazione del prof. A. Saccocci (a cui vanno i miei ringraziamenti): -”Sicuramente e da inserire anche Enrico Dandolo fra i dogi che hanno utilizzato i segni di zecca, come d'altra parte appare logico. In un articolo di Stahl (7), dove sono illustrati molti dei coni dei grossi di Enrico Dandolo, si puo vedere che l'eccezionale pallino nella veste del Redentore e in realta presente almeno in 3 coni diversi (n°12a, 12b, 19a) Poi appare chiara la presenza di un pallino al dritto, tra le lettere D ed V di DVX, dell'esemplare n. 1b. La presenza di segni segreti attorno alla legenda DVX del dritto appare confermata dalla foto tratta dalla rete, dove la presenza di un pallino a sx della D e indubitabile e forse anche a d. della V.”. (7) A. Stahal The grosso of Enrico Dandolo, in RBN 19991 punto
-
Ciao, io ho una macchinetta digitale scarsa che ha più di 10 anni. Imposto su macro e faccio le foto al sole tenendo le monete in mano, il risultato è tutto sommato accettabile 😉1 punto
-
It is difficult to determine whether the coin is worn or cast purely from the images. My feeling is that it is worn and corroded. It would be easier to determine in hand under magnification. It looks like there is a lot of "stuff" sticking to the surface. This could just be dirt but the way that the coin has been cleaned to highlight the details is quite distracting. I think it is a worn, legitimate coin. I am not sure whether this is ANT* (RIC 57b) or ANT. (RIC 59b) I have an example of RIC 59b to share for comparison. I bought this one not just because of the coin but ANACS name the wrong emperor. They claim Maximinus II but it is clearly Galerius.1 punto
-
Grazie @fabry61! Questa in effetti non e' una moneta tra le altre...credo molto plausibile quello che suggerisci rispetto ad un punto di costruzione del conio...io personalmente dubito sull'esistenza di segni segreti dei massari sui grossi di Enrico Dandolo...si notano invece delle variazioni stilistiche ben evidenziate da @ak72...c'e' ancora molto da studiare su questa moneta ricca di storia... Concordo...alla mezza e ai tre quarti...da questa foto con luce diversa si nota meglio...1 punto
-
1 punto
-
Capisco, tu neghi l'esistenza del 5 Centesimi 1913 "senza punto", allora condivido con te quella veramente rara:1 punto
-
1 punto
-
Njk, in effetti questi ed altri oggetti di “trench art” sembra venissero assemblati come passatempo durante le interminabili attese nelle trincee durante la prima guerra mondiale. Immagino che questi vengano da una delle tante trincee 🇩🇪🇧🇪 https://www.livetheworld.com/activities/belgium/bayernwald-german-trenches-croonaert-wood1 punto
-
probabilmente è stata conservata in un un'ambiente umido.. e questi sono i risultati.. non credo sia stata pulita in passato poiché non vedo la minima traccia di qualche segnetto di pulizia.. se è stata lavata, è stato fatto in modo professionale..1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Continuo con questa moneta da 3 rubli 2023 della Transnistria, dedicata ai Vigili del Fuoco locali al dritto: emblema dello Stato e autorità emittente: Banca della Repubblica Pridnestroviana al rovescio : tre vigili del fuoco in azione,sormontati dalla leggenda : prevenire, salvare, aiutare !1 punto
-
1 punto
-
Se fortuna travaglia un nobil cuor e' raro che non gli da favore1 punto
-
Buongiorno Cherki.Karroumi, senza dubbio, quando si vogliono avere informazioni su una moneta, sarebbe auspicabile non limitarsi a postare solo le foto ma, per prima cosa, è buona pratica salutare ... e poi dire anche cosa si vuol sapere (qui di indovini non credo ce ne siano). 😉 Gli utenti sono sempre disponibili a dare un supporto ma per farlo ci mettono impegno, tempo, competenza e tanta buona volontà ... quindi la cortesia e la riconoscenza nei loro confronti è doverosa. Inoltre, se vuoi che si possa dare un parere obiettivo dovresti postare le foto delle due facce e del bordo, in modo tale che l'immagine della moneta risulti dritta (magari un pochino più grandi ... ma sarebbe meglio anche molto più grandi), e poi indicare il diametro della moneta ed il suo peso (l'ideale sarebbe anche lo spessore). Oltre a questo mi permetto di invitarti a presentarti al resto degli utenti del forum https://www.lamoneta.it/forum/71-nuovi-arrivati-presentazioni/ e poi a leggere le Linee Guida del Regolamento: https://www.lamoneta.it/guidelines/ comunque ... benvenuto. 😉1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Non è il mio campo, ma io sapevo che tutta la monetazione a legenda "KAPU" retrograda fosse datata al 216-211 a.C. Ecco un esempio degli stateri "CAMPANON", presa da acsearc: NUMISMATICA ARS CLASSICA NAC AG, AUCTION 126, LOT 1 Ancient Greek Coins Campania, The Campani Didrachm circa 415-400, AR 7.65 g. Head of Athena r., wearing crested Athenian helmet decorated with olive wreath. Rev. KAMΠANON Man-headed bull walking l. Sambon 769 (this coin). Jameson 1854 (this coin). Rutter 9b (this coin). AMB 29 (this coin). Historia Numorum Italy 4781 punto
-
ben arrivato nella numismatica di una volta, quella che cercava la rarità più che il grado MS.1 punto
-
può essere invece interessante una valutazione congiunta con un fatto simile che accade altrove.... abbiamo OSTROGOTI - che coniano monete in bronzo "grandi", roba che non si vedeva da un secolo almeno con la fine degli AE2 - che non riportano l'autorità imperiale e quindi appaiono "municipali" in un senso allargato del termine - che riprendono rimandi alla romanità più antica e contemporaneamente VANDALI - che coniano monete in bronzo "grandi", - che non riportano l'autorità imperiale e quindi appaiono "municipali" in un senso allargato del termine - che riprendono rimandi alla storia di Cartagine antica, una su tutti la protome equina, ma ce ne sono altri Questo è certamente un punto di vista interessante, e che certamente non è farina del mio sacco essendo stato toccato da vari numismatici, ma che lascia ancora spazi non del tutto chiariti... in primis quel termine "municipale" che ho appena usato in modo non per forza tecnico1 punto
-
Ringrazio l'amico @Fondamentale per avermi aiutato con queste sovrapposizioni.1 punto
-
Non ho mai scritto su queste discussioni "veronafil" che puntualmente si riterano ad ogni fine manifestazione, però posso dire qualcosa anche se non sono citato tra gli operatori "persi". Non credo di sbagliare se dico che mio padre (o mio nonno addirittura) fossero presenti dalla prima edizione, la mia memoria arriva fino a un certo punto ma ricordo con certezza di essere stato dietro allo stand da bambino (e sono del 79), di sicuro dal 2002/2003 le ho fatte tutte io, fino a circa 5/6 anni fa quando ho deciso di smettere, dopo aver mandato una bella lettera al presidente della scaligera, una raccomandata con ricevuta di ritorno vecchia scuola, non una mail (se cerco in negozio forse la trovo ancora). Il succo della lettera in soldoni, perdonate la rudezza, era che non potevano continuare a "fare i belli con il fondoschiena degli altri" perchè un po' alla volta il giocattolo si sarebbe rotto e, purtroppo, avevo ragione. Forse non era uno dei migliori banchi il mio? non lo so e non sta a me dirlo, ma quanti eurini erano esposti sul mio banco lo so di sicuro, e il mio più quello degli altri "persi" citati sopra facevano di Veronafil un gran convegno. Rischiare in prima persona di farsi rapinare e di conseguenza rovinare la vita e vedere l'associazione locale organizzatrice comprarsi ogni anno un appartamento in centro non è stato più accettabile per me e non riesco proprio a capire come i miei colleghi possano continuare a fare la roulette russa 2 volte all'anno. Mi risposero comunque, non ricordo precisamente le parole, ma il contenuto era sull'indignato/catastrofista, prolisso, ma soprattutto privo di qualunque apertura/considerazione/rispetto per chi (noi operatori) hanno reso il loro Veronafil quello che è (era), e che non sarà mai più, e voglio sottolineare, giustamente. Ricordo nello stesso periodo anche il ben più noto e blasonato Bolaffi aveva mandato una lettera alla scaligera dai toni pesanti, e mi sembra che anche loro non siano più venuti alla manifestazione (pensiamo soprattutto al peso che ha nella filatelia Bolaffi...). Soluzioni? Non ne ho. Speranze? Si, forse i tempi sono maturi per organizzare 1 convegno serio all'anno fatto da noi operatori. Quando e se succederà spero che tutti i collezionisti e appassionati che lamentano puntualmente il decadimento di Veronafil, "battano un colpo". Andrea Paolucci - Padova1 punto
-
Buonasera, il lato posteriore sembra quasi liscio, il peso non lo so quantificare, ho fatto delle ricerche, da profano mi sembra etrusca, penso di portarla alla soprintendenza delle belle arti1 punto
-
In una precedente discussione abbiamo analizzato gli sconosciuti fanti ashigaru. Oggi invece approfondiremo, sempre in maniera semplice ma concreta, un'altra tipologia di guerrieri talmente temuti che costrinsero addirittura alcuni signori feudali a collaborare con loro! Stiamo parlando dei monaci sōhei. Rappresentazione di una battaglia tra samurai e monaci guerrieri L'origine dei monaci sōhei: I sōhei, letteralmente "monaco soldato", furono dei gruppi armati associati ai templi buddhisti durante il periodo medioevale giapponese. I sōhei avevano molte somiglianze con i vari ordini monastici europei medievali, ma a differenza di questi si consideravano appartenenti al medesimo ordine religioso anche tra nemici. Come nacquero questi nuclei di monaci armati? Verso la fine del periodo Nara (710 - 794) i contrasti fra la religione shintoista e quella buddhista restavano ancora attivi, e ad aggravare ancora di più la situazione fu la crisi politica nata a seguito di una riforma fiscale che scontentava tutti. Solo i monasteri si trovavano in una situazione differente, sopratutto perché i loro domini erano esenti dalle tasse. A causa di questo fatto i monasteri furono sovrappopolati sempre di più e l'imperatore Kammu, temendo del potere sempre più crescente dei monasteri, cercò di arginare il fenomeno. Nonostante tutti gli sforzi non vi riuscì poiché i buddhisti erano ormai molto influenti. Per questo motivo nel 794 la capitale venne spostata da Nara a Kyoto, una scelta strategica per far cercare di allontanare il potere imperiale dalle roccaforti del potere monastico tutte legate a Nara. Oltre allo sviluppo del buddhismo, i nobili imperiali dovevano fare i conti anche con gli aborigeni dell'arcipelago, gli emishi, che minacciavano continue sommosse. Inoltre, le rivolte dei clan, sempre più frequenti, e le scorribande di pirati e predoni aggravavano ancora di più la situazione. Lo Stato imperiale stava iniziando a vacillare. Le forze governative vennero indebolite dalle lunghe lotte con gli emishi, e altre insurrezioni vennero affrontate a fatica. Nel frattempo il potere dei monasteri cresceva sempre di più: molti esercitavano un'autorità alternativa al governo imperiale e il buddhismo acquistò un carattere sempre più violento e aggressivo. La lotta per il potere, le dispute con le altre religioni e la difesa dei monasteri contro i predoni costrinsero i monaci a prendere le armi. L'iniziativa partì da uno dei monasteri principali, lo Enryakuji, e da lì alimentò la nuova istituzione dei monaci guerrieri sōhei. I samurai vi si sarebbero scontrati in diverse occasioni, con esiti non sempre favorevoli. Quali furono le basi dottrinali che consentirono ai buddhisti di prendere le armi? Le basi vennero prese dal Mahāyāna Mahāparinirvāṇasūtra (in giapponese Dainehankyō), cioè il "Sutra mahayana del Grande passaggio al di là della sofferenza". Questo sutra nasce dopo la distruzione dei templi buddhisti nel IV - V secolo d.C da parte degli Unni bianchi, e invita laici e buddhisti a prendere le armi per difendere il Dharma buddhista dagli aggressori. Una parte del monastero Enryakuji Gli eventi successivi: Nel 981 iniziò il vero battesimo di fuoco dei monaci guerrieri: la battaglia coinvolse gli sōhei del monastero Enryakuji e quelli del monastero di Miidera. La causa dello scoppio di questi conflitti tra monasteri era normalmente la nomina di un "abate", che per il monastero rivale era considerato privo di qualità. Tali conflitti proseguirono nel corso dei secoli con brevi interruzioni e conseguenti violenze fino al 1121, quando gli scontri militari divennero intensi e sanguinosi. Durante la guerra Genpei (1180 - 1185) le faide tra i templi furono ingigantite da eventi più grandi. I clan Minamoto e Taira combatterono per ottenere il titolo di shogun e cercarono l'aiuto dei monaci guerrieri: Taira no Kiyomori si alleò con quelli di Enryakuji; i Minamoto con i monaci di Miidera. Nella battaglia di Uji (1180) i monaci di Miidera, insieme a un contingente di samurai del clan Minamoto, cercarono di difendere il ponte sul fiume Uji, e il tempio dietro di esso, dalle forze del clan Taira. I monaci combatterono con grande energia, ma alla fine vennero sconfitti. Dopo la vittoria, Taira no Kiyomori ordinò la distruzione del monastero di Miidera. Dopo la guerra Genpei, i monaci guerrieri rivoltarono la loro attenzione alla ricostruzione dei monasteri, e in seguito anche il riottenimento del potere politico. Durante le guerre del periodo di Nanboku-Cho (1336 – 1392) il monastero Enryakuji offrì protezione all'imperatore ribelle Go-Daigo, e con l'aiuto dei monaci guerrieri lanciò una breve ribellione contro lo shogunato Kamakura. Stampa che rappresenta la battaglia di Uji (1180) La fine dei monaci guerrieri: Durante la guerra Ōnin (1467 - 1477) nuovi gruppi di monaci guerrieri si stavano formando nelle campagne: gli Ikko-Ikki. Essenzialmente erano coalizioni composte da monaci religiosi fondamentalisti, agricoltori e famiglie nobili che erano disposti a combattere letteralmente per le loro convinzioni. Nel 1488 il loro capo, Rennyo, incitò una rivolta contro il dominio dei samurai e fissò la provincia di Kaga come territorio principale per l'Ikko-Ikki. Da lì si diffusero verso le altre province di Nagashima, Ishiyama Honganji e Mikawa. Il potere degli Ikko-Ikki crebbe talmente tanto da attirare l'attenzione dei signori della guerra come Oda Nobunaga e Tokugawa Ieyasu. Nel 1564 Tokugawa Ieyasu attaccò la setta nella battaglia di Azukizaka, ma non riuscì a sconfiggerli definitivamente. Nel 1560 il signore feudale Oda Nobunaga prese il potere, ma i monaci guerrieri dell'Enryakuji riacquistarono la loro forza militare. Le sette militari buddhiste intralciavano il suo piano di unificazione del Giappone e dovevano essere sistemate una volta per tutte. Così nel 1571 l'esercito di Nobunaga, forte di 30000 uomini, attaccò l'Enryakuji, sterminò i suoi monaci guerrieri e lo rase al suolo. Successivamente Nobunaga passò a combattere l'Ikko-Ikki: nel 1574 assediò la fortezza Ikko di Nagashima; nel 1576 quella di Ishiyama Honganji. Il movimento Ikko-Ikki si arrese definitivamente nel 1580. Tra il 1580 e il 1590 varie fazioni di monaci guerrieri si schierarono dalla parte di Tokugawa Ieyasu e da quella del rivale Toyotomi Hideyoshi. Con l'inizio dello shogunato Tokugawa, il tempo dei monaci guerrieri si concluse (1603). Mon (emblema) della setta Ikko-Ikki L'equipaggiamento: I monaci guerrieri avevano un equipaggiamento abbastanza vario. Normalmente portavano una serie di vestiti kimono uno sopra l'altro, di solito bianco sotto e tan (una gradazione chiara di marrone) o giallo zafferano sopra. La calzatura tradizionale consisteva in calzini (tabi) e zoccoli di legno (geta), o dei sandali di paglia (waraji). Spesso i monaci creavano una sorta di turbante per coprire la testa, o indossavano una tradizionale fascia giapponese (hachimaki). Infine, alcuni portavano le classiche armature samurai (yoroi) I sōhei impiegavano una vasta varietà di armi: la lunga tachi era probabilmente la spada più comune, ma l'arma più tradizionale e utilizzata dai monaci guerrieri era il naginata , un'arma simile ai falcioni europei. Molti erano abili anche nell'utilizzo dell'arco (daikyuu), del coltello (tantō), della spada corta (wakizashi) e di una mazza da guerra (kanabo). Inoltre, vari monaci combattevano anche a cavallo. I monaci della setta Ikko-Ikki avevano un equipaggiamento ancora più vario: indossavano le più tradizionali vesti da monaco e vari tipi di armature. Svariati monaci indossavano vari tipi di caschi da samurai, mentre molti altri optavano per il cappello di paglia e il mantello da contadino. Il naginata rimaneva l'arma comune più utilizzata, ma utilizzarono anche un numero limitato di archibugi. Infine, un elemento molto comune dei monaci guerrieri Ikko-Ikki era un'asta con in cima uno stendardo (sashimono) che portavano lungo la schiena. Sugli stendardi era riportato uno slogan buddhista. Rappresentazione di un monaco guerriero del monastero Enryakuji Spero che anche questa discussione sia stata di vostro gradimento! Naturalmente per qualsiasi dubbio o informazione scrivete pure. Alla prossima Xenon971 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?