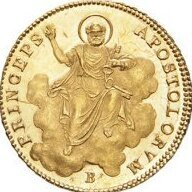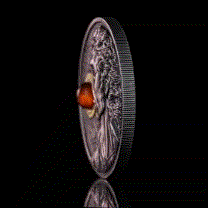Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 06/25/23 in tutte le aree
-
Buon pomeriggio a tutti. La parola GRATIA (per esteso) compare per la prima volta nel 1825 sulla monetazione di Francesco I e nello specifico, su tutte le monete d'oro e d'argento coniate a Napoli tra il 1825 ed il 1831. La parola GRATIA è stata quindi punzonata in modo corretto su svariate decine o forse, su alcune centinaia di conii preparati per la suddetta monetazione. A seguire, dal 1831 al 1859, Ferdinando II fece coniare oltre 180 monete (tra oro e argento) che riportano in legenda la parola GRATIA. La parola GRATIA, compare anche nella legenda delle 3 monete d'argento di Francesco II. In conclusione, possiamo constatare che la parola GRATIA è stata eseguita in modo corretto - per quarant'anni consecutivi - su migliaia di conii utilizzati per la produzione di circa 200 diverse monete della Zecca di Napoli. Solo ed esclusivamente su alcune Piastre da 120 Grana datate 1834, si possono riscontrare alcune anomalie riguardanti la parola GRATIA. Di queste anomalie fa parte la rarissima variante GRTIA: Fino ad oggi, questa variante sulle Piastre da 120 Grana è stata riscontrata solo ed esclusivamente su TRE diversi conii datati 1834. Si conoscono TRE diversi conii 1834 che presentano la variante GRTIA. Sono almeno TRE i conii delle Piastre da 120 Grana 1834 in cui si può leggere la scritta GRTIA anziché la parola GRATIA. La inscripción GRTIA se encuentra - exclusivamente - en 3 cuños distintos útiles únicamente para la acuñación de monedas de plata de valor nominal 120 Grana y únicamente en las fechadas 1834. The inscription GRTIA is found - exclusively - on 3 different dies useful only for minting silver coins with a nominal value of 120 Grana and only in those dated 1834. L’inscription GRTIA se trouve - exclusivement - sur 3 matrices différentes utiles uniquement pour frapper des pièces d’argent d’une valeur nominale de 120 Grana et seulement dans celles datées de 1834.4 punti
-
Ciao a Tutti, ecco la mia Cingranella 1838 di cui parlavo. Sembra mancante dei puntini eccetto che tra VTR e SIC. Buona Domenica.3 punti
-
Ciao @Litra68, Lotto 223 Nomisma Aste odierna (E-Live 3). Appena entrato in collezione (ne sono sicuro!). Così descritto in catalogo con foto: NAPOLI Filippo IV d'Asburgo (1621-1665) Grano - Magl. 59 CU (g 10,22) RRRR Grading/Stato: qBB3 punti
-
Il 5 Grana o Mezzo Carlino, detto “ Cingranella” nella locuzione popolare, come sapete è una moneta d'argento molto piccola ( diam. 16,5 mm Peso: 1,15 g. ) e per questo motivo, un vero piccolo capolavoro di arte incisoria. Coniata in poche date, 1836-38-44-45-46-47-49-51-53, è spesso poco considerata dai collezionisti di Monete Borboniche, forse perchè in collezione sparisce al confronto delle monete di grande modulo. Un piccolo tondello che però può dare delle soddisfazioni a livello di scoperte, come ribattiture della legenda e della data, mancanze, ed altre possibili variabili. Non ho trovato nel Forum una discussione “monografica” di questa tipologia ( mi scuso nel caso contrario ), pertanto il mio intendimento sarebbe la condivisione, con il vostro indispensabile aiuto, delle Cingranelle, al fine di riunire le nostre presenti in collezione. Tutte quante, normali, con errori e varianti. Inizierei con il primo millesimo: 1836 data molto comune, ma il criterio temporale non è assolutamente vincolante. Grazie a tutti e Saluti, Beppe Questa è quella della mia collezione2 punti
-
E’ online il numero 9 del Gazzettino di Quelli del Cordusio a disposizione di tutti sul nostro sito di academia.edu, buona lettura e buon anno ! https://independent.academia.edu/QuellidelcordusioGazzettini2 punti
-
A me ricorda, anche se risulta molto più "rozzo", alcune coniazioni bizantine (follis di Niceforo III) con il volto del Cristo. Andrea2 punti
-
Oggi è il Patrono di Firenze e per ricordarlo nelle Zecche Moderne metterò qualche rovescio dove vi è raffigurato nelle monete mie dei Medici un saluto dal Mediceo1 punto
-
Santo Patrono di Genova e Firenze, molto rappresentato nella monetazione di entrambe ma soprattutto di quest'ultima. Essendo a me caro per il nome che porto, vorrei ricordarlo invitando a postare qualche moneta che lo rappresenta. Nell'incertezza della scelta, mostro un mezzo giulio fiorentino relativo a Cosimo III, molto raro (R5) per la bassissima tiratura (qualche centinaio di pezzi), interessante per la rappresentazione di un S. Giovanni seduto e ancora giovinetto. D/ Stemma coronato R/ S. Giovanni seduto con lunga croce. CNI 98 MIR 339/2, Gal. XX, 3. Pucci, 8. CNI. 98. Ex asta Crono 7 (Crippa), ex asta Varesi 74.1 punto
-
https://books.google.it/books?id=HW4b2ZIC3xkC&pg=PA297&dq="ROMA+INTANGIBILE"&hl=it&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&ov2=1&sa=X&ved=2ahUKEwjAgo6And__AhXFPOwKHSBtCZgQ6AF6BAgFEAM#v=onepage&q="ROMA INTANGIBILE"&f=false1 punto
-
DE GREGE EPICURI Si legge al rovescio, attorno alla lira, ΑΠΟΛΛΟ -ΝΙΑΤΩΝ. Dovrebbe essere un bronzo di Apollonia Salbace, in Caria, 1° o 2° secolo a.C.1 punto
-
1 punto
-
Posso dire cosa non è. Né Ostrogoti Né Longobardi Né vandali ...io di altomedievali un po' ne ho viste... A me non dice nulla1 punto
-
Al rovescio ci vedo una figura seduta con caduceo in mano?! Al dritto forse Geta ma potrebbe anche essere una provinciale….. se non lo fosse si tratterebbe di un asse visto anche il peso1 punto
-
Bronzo del IV secolo della serie campgate , al dritto potrebbe essere Costantino, ma anche Crispo o altri del periodo non saprei. Per la zecca mi sembra di vedere 2 S in fila ma sono senza occhiali e potrebbe essere di tutto1 punto
-
Buonasera @oppiano e buona domenica, certo che ti dico la casa daste, e NBS AUCTIONS, SU BIDDR, saluti Enki,1 punto
-
La croce davanti al busto è un simbolo del coniatore. I simboli dei coniatori, come sappiamo, sono numerosi e alcune volte è capitato che lo stesso simbolo sia stato censito due volte con nomi diversi (rosetta e fiore potrebbe essere un esempio), poiché i censori che compilano i cataloghi usano vocaboli e interpretazioni diverse. D'altra parte, soprattutto per i nominali o le tipologie più rare, simboli che magari sono stati utilizzati decine di volte non sono mai stati riscontrati dai censori e quindi mancano nei cataloghi.1 punto
-
Il fatto è che l’ultima cifra non è ben chiara. Motivo per cui non l’hanno neanche riportata nella didascalia. Potrai, comunque, verificare bene quando ti arriverà la moneta. Ciao.1 punto
-
Complimenti @Rocco68 per le bellissime monete. Alcune considerazioni: per il millesimo 1836, come da te evidenziato, l'unica Variante censita è la mancanza dei segni di interpunzione e del puntino sotto il collo. Nessuna variante censita per il 1838 ( coniato in numerosi esemplari tanto da essere considerato il più comune della serie ). A questo proposito bisogna dire che si potrebbe discutere sulla mancanza completa o parziale dei segni di interpunzione presente in alcuni esemplari. Argomento non facile, considerando le dimensioni della moneta e le foto non sempre molto dettagliate. Potrebbe essere dovuto a "conio sporco". In collezione ho una 1838 che sembra priva parzialmente dei puntini nella legenda, ma mi riservo di rifotografarla in quanto le foto originali non sono molto dettagliate. Saluti a Tutti e condividete.1 punto
-
1 punto
-
Ti ringrazio per la gradita risposta. Infatti non mi compariva la tua risposta. Per quanto riguarda i denari anconetani, grazie al tuo chiarissimo lavoro, mi sono diventati immediatamente molto interessanti. Grazie ancora1 punto
-
La classificazione che hai fatto sulla base del mio studio è perfetta. Complimenti! Mi auguro che questo sia solo l'inizio di una collezione di denari anconetani che non finiscono mai di regalarci delle sorprese con nuove piccole varianti ed inediti. Ho riproposto il mio intervento, che non riesco a capire perché fosse rimasto bloccato.1 punto
-
Ad ogni buon conto, si tratta del Lotto n. 7 dell’asta NBS Auctions B.V. (Web Auction 18) tenutasi ieri, con prezzo di partenza pari a 1 euro e un risultato di 26 euro. L’asta ha proposto 12 esemplari similari, tutti aggiudicati. Tutti con partenza 1 euro. Massimo risultato: euro 55. https://www.biddr.com/auctions/nbsauctions/browse?a=3630&l=4205246 Domenico1 punto
-
No è stato un incontro diciamo di "paese" dove venivano illustrate le curiosità,ritrovamenti e conformità del territorio.1 punto
-
No. Che io sappia sono due mercati molto diversi e non complementari. Le gallerie che vendono opere d’arte si dedicano essenzialmente a opere di arte moderna e contemporanea - ed hanno poco o nulla a che fare con monete e medaglie. Quelle di arte antica - che comprendono gli antiquari possono avere maggiori chance di avere nei loro stock qualche medaglia, raramente vi ho visto qualche moneta che normalmente l’antiquario conosce poco, ha zero referenze cui rifarsi ( se non il classico amico ‘numismatico’) e per le quali non e’ raro chieda prezzi fuori mercato non essendo appunto la sua specializzazione. Sono comunque casi isolati , per il 90% si tratta di paccottiglia, maggior fortuna si ha con le medaglie ove il lato artistico - e non quello numismatico - e’ quello che fa premio1 punto
-
Dal 2014, quando una capsula della spezieria Al Cedro Imperiale è entrata nella mia collezione (post # 234), ho parlato in più occasioni della doppia insegna di forma ovale in cui compare questa farmacia accanto alla farmacia "All'Insegna della Vecchia", che si trova all’esterno, sulla colonna di destra dell’ingresso La fusione tra le due insegne in una sola farmacia per diritti di proprietà acquistati nel maggio del 1822 è certificata dai documenti. Una spiegazione meno burocratica e più ‘romantica’ dell’accaduto si trova nelle cronache del 10 gennaio 1755, la data del funerale della moglie del console di Gran Bretagna. La defunta era vestita d’un abito bianco di seta e teneva in mano un cedro come geroglifico dell’Eternità. In memoria di questa signora il farmacista dell’epoca, che secondo i pettegoli era legato da ‘affettuosa amicizia’ alla defunta, decise di modificare l’insegna ‘Alla Vecchia’ consegnandola ai posteri com’è oggi. apollonia1 punto
-
Bellissima moneta complimenti Aggiungo un mezzo giulio anche io, questa volta di Ferdinando I con un San Giovanni michelangiolesco saluti1 punto
-
Ma io non voglio che lo condivida nessuno, ho sottolineato che è un mio pensiero ! Io mi faccio delle domande e provo a darmi delle risposte, non me ne esco sempre con la solita solfa dell'errore, quando le monete ci dicono che gli errori, quelli veri, nelle legende sono stati corretti. Ok d'accordissimo con te, non abbiamo documenti si va per ipotesi e idee, io almeno ci provo ad andare oltre,vorrei però leggere anche altre ipotesi che vadano oltre "l'errore ". Se guardo le piastre dal 1831 fino al 1859 vedo solo 3 date con legende che storpiano il motto e sono :la GRTIA, la GRAITA la REGN per il 34,la REGN I cn la I in incuso nel 35 qui però si sono presi la briga di correggere direttamente sulla moneta, e la 56 TVR...perché solo in questi anni? Se in zecca operava gente che faceva errori non pensate che si sarebbero distribuiti anche in altre date? Ve lo siete mai chiesti? Oppure solo per il 34 e il 56 hanno lavorato operatori che non sapevano ne leggere e ne scrivere?1 punto
-
Non mi sembra la sezione giusta perchè non si tratta proprio di monete, euro o non euro, ma di gadjet somiglianti a una moneta.1 punto
-
@King JohnQuella che al Post 3 indichi come Costanzo II non è Costanzo, ma Costante (CONSTANS).1 punto
-
Buonasera a tutti. Mancava una Discussione specifica sulle Cingranelle, grazie @giuseppe ballauri . Come anticipato sopra, questo nominale non viene da tutti collezionato per via delle sue minuscole dimensioni, ma non sfigura certamente in bellezza . Partecipo con molto piacere con i miei due esemplari del millesimo 1836. Il primo lo acquistai nel lontano 2003 e riporta il numero cronologico 303 della mia Collezione, pesa grammi 1,15 . Questo conio del dritto non ha punteggiatura in legenda e non riporta nessun simbolo. Mancava nei testi per la mancanza di simbolo sotto il busto, infatti ne' il D'Incerti e né il Pagani lo conoscevano, e solamente il Magliocca nel 2018 lo cita al numero 656/a con rarità R21 punto
-
1 punto
-
Rientro ora dal Cerrofil. Location interessante e piacevole in mezzo al parco sotto agli alberi, con lo stand del cibo lì vicino. Buona la presenza di commercianti, direi in totale una ventina di banchi di monete, una metà di livello (professionisti come Felsinea, Valente, Anzilotti e altri) e una metà più amatoriali. Trovato pure qualche chicca interessante. Tornato come di consueto povero ma felice 😂1 punto
-
Non divaghiamo. Penso che @Pinoct61 sia soddisfatto dei riscontri ricevuti. Qualora volesse avere più informazioni, il Forum -come sempre- si rende disponibile. Grazie e buona giornata a tutti. Domenico1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
27 articoli, tante briciole, 180 pagine, una trentina di collaboratori in questo supernumero, è’ una grande soddisfazione rileggerlo man mano e vedere quanta varietà, quanti giovani autori e 3 ragazze che, magari sbaglierò forse è’ un record, tante passioni, tante competenze, tanti volersi mettere in gioco, in fondo tutto parti’ da qui, dal fare una numismatica di tanti per tanti…1 punto
-
Salve a tutti, in una vecchia scatola di famiglia ho ritrovato un vecchio gioco che mi ha riportato a quando ero un bambino! Domino filatelico, regalatomi da mio nonno, ovviamente abbonato di cronaca filatelica.. vi mando una foto, volevo condividere con voi! Ho anche trovato sul web un ritaglio delle regole1 punto
-
Buonasera, ritorno sull'argomento delle riforme monetarie siciliane del 1490 e 1513 e delle relazioni carlino/aquila/tarì. Leggendo un altro libro del Trasselli (Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V, vol. I, 1982) ho trovato alcune interessanti pagine sull'argomento che temo però facciano traballare quelle timide certezze che pensavo di aver raggiunto. A p.35 dice: "Fra le troppe componenti della fin de siècle [XV], non si dimentichi la riforma monetaria del 1490. In Sicilia circolavano ... monete d'argento napoletane di vecchio conio, gigliati e coronati; i gigliati avevano avuto corso al cambio di banco di un tarì ciascuno ed i coronati di un tari e 2 grani." Questo vuol dire che già prima del 1490 i carlini napoletani, che siano gigliati o coronati, comunque da 10 grani a Napoli, venivano cambiati con un tarì (da 20 grani) o più in Sicilia? E poi quella differenza del cambio tra gigliato (20 grani) e coronato (22 grani), che immagino dipenda dal rispettivo peso di 80 e 90 acini, è stranamente uguale al "cambio variabile" delle aquile coniate nel 1490 valutate appunto 1 tarì se cambiate in altro argento (es. mezzanini) e 1.2 tarì ovvero 22 grani se cambiate con piccioli. E' una coincidenza? Poi alle pp. 48-52 parla ampiamente della riforma del 1513 e della raggiunta parità tra carlino e tarì, che tra le altre cose favorisce il commercio tra Calabria e Messina, per il facile cambio tra le due monete. Ritorna anche sul cambio varibile dell'aquila del 1513, e cita la successiva riforma del 1531. Per chi fosse interessato: https://www.storiamediterranea.it/wp-content/uploads/2019/09/C.-Trasselli-Da-Ferdinando-il-Cattolico-a-Carlo-V-Volume-I.pdf1 punto
-
Può essere benissimo che io abbia invece interpretato malamente i desiderata del signore, chissà...1 punto
-
Sì. Prima della scienza moderna. Isaac Newton era un alchimista. L'alchimia era una disciplina, una scienza esoterica da cui discende parte della scienza moderna. Quindi, gli alchimisti, visti con gli occhi del passato e non con gli occhi moderni, possono essere considerati degli scienziati1 punto
-
Posso ritenermi fortunato... Rispetto ad altre FdC da rotolino che ho ricevuto, queste sono pressoché immacolate.. poi chissà, forse con un microscopio si trovano difetti 😜, ma vanno benissimo così! Potrei supporre che la commessa che ha maneggiato le monete, in quanto dipendente dell'ufficio filatelico numismatico, sapeva il fatto suo e soprattutto dei suoi abituali clienti... BRAVA COMMESSA! 🤩1 punto
-
Ritengo, mia personale opinione, che ad oggi la principale minaccia per la numismatica sia la moneta elettronica. Se soppianterà del tutto il contante, potrebbe essere che le generazioni che non avranno mai usato una moneta nella vita quotidiana non subiscano il fascino delle monete. Son d’accordo, anche io ho “sospeso” la numismatica dai 16 ai 35..1 punto
-
Comunque è contro chi fa queste porcherie che dovrebbe attivarsi la magistratura, invece di perdere tempo a mandare i carabinieri a buttar giù dal letto alle 6 di mattina il ragazzino che ha comprato un AE3 di Costanzo II su ebay... è questo il vero danneggiamento del patrimonio culturale.1 punto
-
Ciao, immagini troppo piccole e sfondo gigantesco, ma fortunatamente ritagliandole, ingrandendole e schiarendole non perdono molto e la data (riquadro bianco) è visibile. Nepal - 5 paisa del V.S 1986 (nostro 1929) molto comune. Altri caratteri numerici nepalesi corrispondenti:1 punto
-
Si certo, infatti i realizzi Nomos dell asta 26, sono proprio in questa direzione. 🙂1 punto
-
Alcuni articoli sono già arrivati per il 10 …altri arriveranno, non c’è fretta ma più voci ci saranno e meglio sarà, chi ha qualche idea lo aspettiamo volentieri !1 punto
-
assai interessante quanto noti Archestrato. In effetti riguardando il Calciati, per curiosità, e stimolato anche dalla richiesta di @Giov60, l'autore cosi si esprime: "l'emissione viene attribuita ad Exakestidas - sulla base di molti esemplari firmati... tuttavia vi sono molti esemplari che evidenziano tracce di firma non riconducibili ad Exakestidas". Inoltre aggiunge: "l'esame stilistico di molti esemplari rivela differenze cosi sostanziali che è certo l'intervento di altri incisori". Calciati illustra molti esemplari del tetras con pesi tutti attorno ai 2 gr., ma di stile molto piu' povero rispetto all'esemplare, straordinario, di Artemide. Inoltre, noto io, gli esemplari firmati citati nel Calciati riportano le iniziali EX oppure IM (incisore sconosciuto) ma sempre solo nel campo. Possiamo osservare che il valore del pezzo Artemide non risiede solo nella conservazione ma soprattutto anche nello stile, assai diverso dai pezzi illustrati nelle varie Sylloge citate e nel Calciati. Si pone quindi la questione se appartenga ad un'emissione particolare di questi tetras curata in modo differente rispetto agli altri conosciuti, e a questo punto occorrerebbe ipotizzare realizzata da chi e forse anche 'perché'/'per quale occasione' realizzarne una cosi fine. Infine, una domanda che mi sono subito posto: qual'è la provenienza del pezzo Artemide? A tale proposito ho fatto qualche indagine fra le collezioni di bronzi piu' selezionate passate e ho trovato che la Virzi aveva diversi esemplari di questi tetras, uno dei migliori è descritto come passato successivamente nella collezione di David freedman (Triton V) una delle piu' pregevoli raccolte se non la migliore per i bronzi greci dopo la Virzi'. Freedman aveva due esemplari del tetras, uno proveniente da una vendita Sternberg (XVI del 1985 - lot 74) di stile 'normale' e un'altra di stile piu' raffinato, simile a quella Artemide ma meno conservata (tale esemplare è citato come Virzi n. 1485 ma non corrisponde alle tavole fotografiche della collezione Virzi). Anche Laffaille, altra straordinaria collezione di bronzi greci aveva un esemplare del tetras, che descrive come dionkion, proveniente anch'esso dalla vendita Sternberg del 1985 (lotto 73), anch'esso di stile 'basso'. Infine nella vendita Virzi (Bank Leu n. 6 del 1973) al n. 215 compare un tetras con Aretusa in ottima conservazione ma non dello stile piu' raffinato (anche se comunque bellissimo anche questo). Ho riguardato anche le tavole fotografiche della collezione Tom Virzi (pubblicate privatamente) ove sono riportati ben 8 tetras con Aretusa frontale, ma nessuno (almeno a giudicare dalle foto che comunque appaiono molto nitide e ben fatte) dello stile dell'esemplare Artemide. Nella Sammlung Ludwig (coll. Athos Moretti) è riportato un esemplare, ex collezione Pozzi, del tetras del peso di gr. 2.37 (ingrandimento alla Tav. 38) di ottima conservazione ma di stile piu^severo rispetto all' esemplare Artemide. E' interessante pero' la nota dove il compilatore suggerisce che per questi bronzetti, assieme ad alcune rarissime litre, gli incisori si siano ispirati alla tetradracma dell'aretusa frontale di Cimone. Un altro esemplare ancora viene riportato nelle tavole del Cammarata alla Tav. II, 32 (pessime foto ma bellissime monete) , di nuovo un esemplare in alta conservazione ma, di nuovo, non del medesimo stile di quello Artemide. Il Rizzo (gigantesco Rizzo!) alla Tav. 48 illustra tre esemplari, di cui uno , la n. 24, sembra finalmente appartenere allo stile del tetras Artemide per la finezza del tratto. Rizzo, riferendosi a questi esemplari suggerisce la possibile attribuzione ai maestri firmanti menzionando Eukleidas e Kimon, anche se in realtà non sembra voler/poter approfondire troppo la questione, interessandosi maggiormente alla produzione argentea. § Ricapitolando, da un esame veloce (e quindi potenzialmente fallace e sicuramente parziale) dei tetras con Aretusa frontale citati nelle varie bibliografie e riportati nelle principali opere e cataloghi delle varie aste/collezioni, parrebbero tre gli esemplari che possono ascriversi a questo stile particolarmente fine (che potremmo definire 'sognante' del volto della ninfa) : Rizzo Tav. 48, 24; l'esemplare ex Freedman (Triton V, 235) ; e l'esemplare Artemide.1 punto
-
1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?





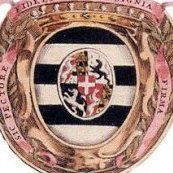



.thumb.jpg.0c713dd4d29897ec1aa5522233f464d8.jpg)