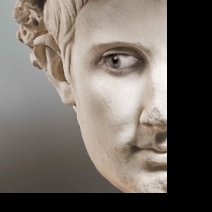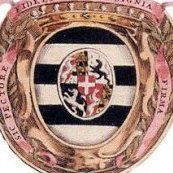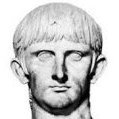Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 07/06/23 in tutte le aree
-
Buongiorno a tutti. Condivido ultimo acquisto, quarto di scudo vecchio 1733 Carlo Emanuele III con conio del dritto non censito.4 punti
-
potrebbe essere il seguito di un film coi vampiri, ma non lo è Ciao a tutti, ogni tanto vado a riprendere le banconote tedesche di un lotto che ho preso qualche tempo fa e me le riguardo, spulciandone poi una che magari solo ad una seconda occhiata può essere interessante (anche perchè non sono messe bene). Per esempio questa 20 marchi 1915 (anche se sono uscite dal '17 in poi) con tiratura di 77.528.000 esemplari, 140x90 mm siamo in piena guerra mondiale, ma niente cannoni: a sinistra e a destra ornamenti con sigillo della banca, al centro in alto due uomini con cornucopie (abbondanza aurea) e medaglione con aquila imperiale coronata col valore. Vabbè... giriamola che poi viene il bello! Sul rovescio rappresentazioni figurative in due campi ottagonali verticali, delimitati da leggere modanature riempite di linee verdoline. Gli stessi bordi dividono anche il resto dell'area stampata e racchiudono campi più scuri con linee bluastre tra loro. Due anelli nella linea centrale. Aha! a sinistra un uomo, sullo sfondo un albero e il sole come impersonificazione del lavoro (tiriamoci su le maniche!) e del giorno, a destra una donna dormiente, sullo sfondo luna e stelle come incarnazione del riposo e della notte se qualcuno adesso si chiede il perchè di questa rappresentazione, ebbene, rimarrà deluso nel non ricevere una risposta. Bisognerebbe fare una seduta spiritica e chiedere an un certo Arthur Kampf e Hans Meyer, che se ho capito bene hanno collaborato nella creazione della banconota. Una cosa che posso immaginare è che - essendo stata prevista nel 1915 - la banconota volesse richiamare più alla "deutsche Tugend" (Virtù tedesca: Wörk, Wörk!) che non ad una guerra che si espanderà solo dopo. Qui la filigrana: uhm... dove son finiti i buchi e le pieghe??? Non ci sono 😁: per pochi spiccioli ho preso un esemplare FDS (9,5/10) che però ha fatto una brutta fine: è finito a tempo indeterminato nel raccoglitore - mentre l'altro biglietto è ancora fuori ed ogni tanto va a giocare all'aria fresca insieme alle altre banconote! Alla prossima. Servus, Njk3 punti
-
Devo anche ringraziare, oltre agli autori dei 27 articoli, anche gli autori delle briciole firmate che sono poi degli articoli brevi, in particolare Stefano Antonietti, Realino Santone e @El Chupacabra. Le briciole in questo numero sono ben 11 e sono indubbiamente molto varie e con belle tematiche.3 punti
-
3 punti
-
La pubblicazione raccoglie le ricerche e gli studi di circa trenta anni sulla Parpagliola milanese della Provvidenza. Sono descritte dettagliatamente in singole schede le varianti capostipite divise per reggente, 65 pagine e nove tavole con 200 esemplari illustrati con fotografie di ottima qualità, tabelle riassuntive e delle rarità.2 punti
-
Hanno ritrovato il castello di Matilde di Canossa. Sul monte, sotto alberi e zolle, la struttura inizia a riemergere Poche ore di lavoro, all’inizio della campagna archeologica, sono bastate per iniziare a portare alla luce i resti di importanti edifici medievali. Ci siamo. Si cerca il castello perduto di Matilde di Canossa, tra gli alberi e sotto una spessa zolla di terreno. I primi ritrovamenti, in queste ore, all’inizio della campagna archeologica sul Monte Baranzone @ Archaeology Mountains Rivers “Nascosti nel bosco i resti del castello di Montebaranzone – affermano i responsabili di Archeo Metodologia Univr – Matilde di Canossa fece di Montebaranzone una delle sue residenze predilette, dove vi costruì uno dei fortilizi più importanti della collina tra il fiume Secchia e il torrente Fossa. Il toponimo sembra possa derivare dal pre-latino barranca cioè burrone, oppure da nomi propri liguri o longobardi quali Barancio o Barucio”. Le archeologhe del gruppo, impegnate in questi giorni nello scavo, posano in un’iconica foto in bianco e nero I primi ritrovamenti, in queste ore, all’inizio della campagna archeologica sul Monte Baranzone @ Archaeology Mountains Rivers · Le porzioni emergenti del fortilizio.@ Foto Archeo Metodologia Univr Montebaranzone è una frazione di Prignano sulla Secchia, un Comune di circa 3800 abitanti della provincia di Modena, il cui municipio sorge a un’altitudine di 557 metri sul livello del mare. Foto Archeo Metodologia Univr Montebaranzone nel 1197 sì assoggettò spontaneamente al comune di Modena anche se la fortezza fu rivendicata dal Salinguerra, erede di Matilde. Nel 1415 passò sotto il controllo diretto degli Estensi che ne diedero il governo nel 1432 a Jacopo Giglioli, già signore di Montegibbio. Due anni dopo, alla morte di questi, il duca Ercole I d’Este ne diede il feudo, unito con Sassuolo, ai Pio che lo tennero fino al 1599, quando morì assassinato Marco Pio, ultimo erede della famiglia. Successivamente, il duca Francesco I tolse Montebaranzone alla podesteria di Sassuolo, unendolo con Pescarola e Varana al marchesato di Montegibbio appartenente a Giacomo Boschetti. Morto Francesco, figlio di Giacomo, senza eredi, gli Estensi nominarono il Marchese Giovanni Galliani, signore di Montebaranzone e Varana, e il governo della sua famiglia, durò fino all’invasione dell’Italia da parte delle truppe napoleoniche nel 1796. Foto Archeo Metodologia Univr Nel punto più alto del paese sono visibili i resti dell’antica fortificazione. Nella parte del paese prossima all’antico castello si ammirano alcune case a schiera con portali trecenteschi a conci squadrati con rosa a quattro punte e una casa a torre (un edificio a pianta quadrata più robusta di una semplice torre segnaletica ma dotata di strette feritoie e di piccoli portali, in cui veniva abitato il piano intermedio dei tre che di solito costituivano questa tipologia edilizia). Scendendo da Montebaranzone verso il torrente fossa si incontra Volpogno, il quale conserva una casa a torre e alcuni edifici quattrocenteschi che si affacciano su un’aia comune. https://www.stilearte.it/hanno-ritrovato-il-castello-di-matilde-di-canossa-sul-monte-sotto-alberi-e-zolle-la-struttura-inizia-a-riemergere/2 punti
-
Buonasera a tutti, ringrazio @Releoper aver riproposto questa vecchia discussione, arricchendola con il suo esemplare. Ne approfitto per postare il mio secondo esemplare del tipo . Saluti Alberto2 punti
-
Scatenate l’inferno! Trovati resti della spaventosa battaglia tra le legioni romane. Armi, frecce, soldati decapitati Centinaia di armamenti, teste umane decapitate, punte di freccia e i detriti di uno scontro esplosivo. Gli archeologi francesi hanno fatto un’eccezionale scoperta, individuando il punto in cui fu combattuta l’ultima, disperata fase della battaglia di Lione, che contrappose le legioni dell’imperatore Settimio Severo e a quelle dell'”usurpatore” Clodio Albino il 19 febbraio 197 dC, alle porte della città. Battaglia persa da Clodio che significò l’abbandono della città alta di Lione per l’insediamento della popolazione vicino al letto della Saona. Resti della caserma romana, estremo punto di difesa e forse quartier generale di Clodio Albino © Muriel Chaulet, Ville de Lyon Decimo Clodio Ceionio Settimio Albino (Hadrumetum, Tunisia 145 circa – Saona, 19 febbraio 197) era stato proclamato imperatore dalle legioni della Britannia e della Spagna subito dopo la morte di Pertinace nel 193 (conosciuto anche come l'”anno dei cinque imperatori”), e si autoproclamò Augustus verso la fine del 195, poco prima della sconfitta finale degli inizi del 197, nel luogo ora sottoposto a scavi archeologici. Alcuni dei numerosissimi resti di armi trovati dagli archeologi francesi © Muriel Chaulet, Ville de Lyon Clodio Albino, per quanto fosse nato in Africa, apparteneva a una famiglia italica. La Historia Augusta narra che il nome Albino deriverebbe del fatto che, al momento della nascita, al contrario di tutti i bambini che hanno la pelle rossastra, Clodio era di carnagione bianchissima. Albus infatti significa bianco, ma anche, riferito agli uomini, pallido e smunto. Trascorse l’intera fanciullezza in Africa, ricevendo una sommaria istruzione in greco e latino. La sua indole fiera lo portò poi ad appassionarsi alla vita militare. Si arruolò, fece una rapida carriera combattendo in numerose regioni dell’impero. Divenne in seguito, prima console nel 187 e poi fu trasferito da Commodo in Gallia, probabilmente come governatore della Germania inferiore. Il cranio decapitato (il volto è rivolto verso il terreno). di uno degli uomini impegnati nella battaglia. Clodio Albino stesso subì la decapitazione, come i propri familiari e tanti uomini a lui vicini © Muriel Chaulet, Ville de Lyon La Historia Augusta riferisce che l’imperatore Commodo, colpito da come aveva condotto la guerra in Gallia e Germania, gli inviò una lettera in cui gli concedeva il diritto di assumere il titolo di Cesare. Di fatto, suo successore. Clodio proseguì la propria carriera governando la provincia di Britannia a partire dal 191. Frattanto Settimio Severo (comandante delle legioni danubiane della Pannonia superiore) acquisì un enorme potere. L’alleanza tra Settimio Severo e Clodio Albino ebbe breve durata. Con la fine del 195, Albino, una volta che Severo ebbe proclamato Cesare il proprio figlio Bassianus, il futuro imperatore Caracalla, si autoproclamò Augustus in aperto conflitto con Severo. Il 19 febbraio del 197 i due pretendenti alla porpora imperiale si scontrarono nella valle della Saône (battaglia di Lugdunum), non lontano dal punto scavato ora dagli archeologi. Secondo ciò che su può dedurre dalle fonti antiche sembra che sul campo fossero impegnati complessivamente 150.000 armati. L’esercito di Settimio Severo doveva essere numericamente prevalente perchè poteva disporre dell’intero esercito presente sul limes renano e danubiano composto da 200.000 armati. La battaglia fu spaventosa, per violenza, durò due giorni, durante i quali si ebbero numerosi rivolgimenti di fronte. Settimio Severo prevalse sul rivale, sebbene avesse subito uno scacco iniziale e avesse perduto il proprio cavallo. «Nel corso della battaglia decisiva – è scritto nella Historia Augusta – dopo che un gran numero dei suoi soldati erano stati uccisi, moltissimi messi in fuga e molti si erano arresi, Albino si diede alla fuga e, secondo alcuni, si uccise con le proprie mani; secondo altri, fu colpito dal suo servo e portato ancora in vita da Severo […]. Molti altri sostengono che ad ucciderlo furono i suoi soldati, che cercavano con la sua morte di ottenere il favore di Severo.» Severo gli fece tagliare la testa e la inviò su una picca a Roma, come monito a chi lo aveva sostenuto, tra cui molti senatori che l’avevano sostenuto. I suoi figli in un primo momento furono perdonati, ma poi anch’essi decapitati insieme alla loro madre e gettati nel fiume Rodano. Frattanto Lugdunum venne distrutta. I resti della battagli trovati ora in Francia sono emersi nei pressi di quella che doveva essere una caserma romana sull’attuale collina di Fourvière. E’ plausibile pensare che la caserma, in mano a Clodio, fosse diventato l’ultimo punto di resistenza per gli uomini di Clodio stesso. Le tracce di questo scontro finale sono chiaramente percepibili all’interno di questa caserma attraverso i 350 pezzi di armamenti e attrezzature militari che sono stati portati alla luce durante questi scavi. Tra questi ritrovamenti troviamo in particolare elementi di un elmo in bronzo, tacchi e punte di lancia, pilum, spada o anche due rampini da assedio. https://www.stilearte.it/scatenate-linferno-trovati-resti-della-spaventosa-battaglia-tra-le-legioni-romane-armi-frecce-soldati-decapitati/2 punti
-
Salve. Condivido il mio 2 grana 1810. La interpunzione è con le stellette. Il peso è di grammi 13,60. Saluto tutti.2 punti
-
054890 W19 FDC (stesso venditore che detiene la 054891 W19; alla faccia della rarità)2 punti
-
2 punti
-
Questa versione dello stemma Dandolo si blasona (---> si 😉 descrive in termini tecnici) troncato d'argento e d'azzurro, a sei gigli posti in fascia dell'uno nell'altro. Ossia: lo scudo è diviso orizzontalmente in due parti, sopra bianca e sotto blu, e in ogni parte ci sono tre gigli affiancati che hanno il colore dell'altra parte. Quindi, i segni orizzontali che vedi nella metà inferiore indicano l'azzurro tramite il cd. tratteggio araldico (convenzione grafica per indicare i colori negli stemmi acromi, tramite un sistema di segni). I segni verticali che li attraversano ai lati sono invece semplici ombreggiature, atte a dare tridimensionalità allo stemma.2 punti
-
Questa notizia effettivamente era già stata ampiamente discussa in altri post2 punti
-
esemplare Tari’ con provenienza da collezione privata. Peso 3,93 gr circa e diametro 25 mm Segnalo e posto l’articolo a firma della sig.ra Luisa Bovi Mastroianni, vedova del dott. Giuseppe Bovi: http://www.ilportaledelsud.org/bcnn1990_2.pdf Saluti, Domenico1 punto
-
Una testa romana emerge durante i lavori in piazza Augusto Imperatore Una testa romana emerge durante i lavori in piazza Augusto Imperatore Un volto di marmo è stato rinvenuto nel cantiere di piazza Augusto Imperatore. A dare la notizia il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La testa marmorea appena rinvenuta “Roma continua a restituire preziose testimonianze del suo passato: una splendida testa in marmo, integra, è stata appena ritrovata durante i lavori in corso a Piazza Augusto Imperatore curati dalla sovrintendenza capitolina ai beni culturali” ha annunciato il primo cittadino. Non è al momento possibile identificare chi, l’ignoto scultore, avesse rappresentato con il proprio scalpello. “Gli archeologi ed i restauratori – ha sottolineato Gualtieri – sono adesso impegnati nella pulitura e nello studio del reperto”. La sovrintendenza comunale, nel confermare che sono partiti i primi interventi di pulitura, ha aggiunto che la testa, di pregevole fattura, è stata scolpita “in marmo, probabilmente marmo pario”. Si tratta d'un tipo di pietra a grana fine, molto pregiata, solitamente estratta in Grecia. Con un marmo analogo è stata scolpita la Venere di Milo. La sovrintendenza Spiega il Sovrintendente Capitolino Claudio Parisi Presicce: Il reperto è stato rinvenuto nella fondazione di un muro tardoantico ma si conserva integro; riutilizzato come materiale da costruzione giaceva con il viso rivolto verso il basso, protetto da un banco d'argilla sul quale poggia la fondazione del muro. Il riuso di opere scultoree, anche di importante valore, era una pratica molto comune in epoca tardo medioevale, che ha consentito, come in questo caso, la fortunata preservazione di importanti opere d’arte". "La testa", continua Presicce, "è al momento affidata ai restauratori per la pulizia e agli archeologi per una corretta identificazione e una prima proposta di datazione, che appare ancorata all’epoca augustea". Una testa romana emerge durante i lavori in piazza Augusto Imperatore Una testa romana emerge durante i lavori in piazza Augusto Imperatore Una testa romana emerge durante i lavori in piazza Augusto Imperatore-3 La precedente scoperta in piazza Augusto Imperatore Non è il primo importante rinvenimento archeologico affiorato durante i lavori di sistemazione della piazza. Sempre a luglio, ma in quel caso del 2021, l’intervento di di messa in opera del sistema fognario aveva infatti portato alla luce un raro cippo pomeriale in travertino. L’eccezionalità di quella scoperta, come venne spiegato dalla soprintendente speciale Daniela Porro e da Claudio Parisi Presicce, direttore dei musei archeologici e storico artistici della Capitale, era data dall’esiguo numero di cippi finora trovati: dieci in tutto. Erano stati fatti sistemare dall’imperatore Claudio per delimitare il “pomerium” vale a dire il perimetro inviolabile dell’Urbe. Era stato trovato nella stessa posizione dove, nel 50 d.C., l’imperatore che era succeduto a Caligola. https://www.romatoday.it/attualita/una-testa-romana-emerge-durante-i-lavori-in-piazza-augusto-imperatore.html1 punto
-
Devo dire che sono davvero ammirato da questa tua collezione @ARES III e sono sempre contento quando mi arriva la mail che mi avvisa che ci sono nuovi post. Vuol dire che ci sono nuove monete1 punto
-
@Oppiano, condivido uno dei miei esemplari. Noterai che hanno in comune lo stesso conio del dritto ma diversi rovesci.1 punto
-
Mi hai letto nel pensiero. Avevo intenzione di fare notare la "lieve" differenza di stile tra le due teste e anche la sostanziale identità di capigliatura ma mi hai battuto sul tempo 😊1 punto
-
Questo, naturalmente Grande discussione, come sempre petronius1 punto
-
1 punto
-
Ciao @Fiore151, un rovescio originale per Claudio Gotico, e non è Saturno: https://ric.mom.fr/en/coin/699?tempRIC=&asmSelect0=&Reign=Claudius+II&asmSelect1=&asmSelect2=&asmSelect3=&asmSelect4=&asmSelect5=&asmSelect6=&asmSelect7=&Legend=AETERNITATI+AVG&asmSelect8=&asmSelect9=&asmSelect10=&asmSelect11=&BustDescription=&ReverseDescription=&Note=&Reference=&page=1&mod=result&from=advanced1 punto
-
Il KGB aveva (ha) la disinformacia, mentre la CIA la disinformation. Quindi gente che crea confusione e disinformazione c'è sempre stata ed è sempre stata utilizzata per fini geopolitici. @ART saprebbe raccontarlo meglio di me.1 punto
-
Ho seguito con attenzione questa discussione, cosa strana è che il caso ha voluto che acquistassi la prima moneta su Vcoins sul negozio di London Ancient Coins pochi giorni dopo questo post, ero titubante proprio a causa di quanto avevi scritto ma non ero riuscito a trovare altrove quello che cercavo (per informazione numismatica se interessa è un'asse di Nerone come Apollo Citaredo) con il budget che avevo e quindi ho deciso di rischiare comunque. Per quanto mi riguarda ho scelto la spedizione DHL World (la più cara ma la scelta è stata giusta alla fine), di solito con loro mi sono sempre trovato bene (conosco anche di persona il corriere di zona quindi mi chiama sempre in anticipo per sapere se sono a lavoro oppure a casa), la spedizione è stata ritirata in Inghilterra lunedì 3 luglio verso le ore 11.00, la sera mi è arrivata la richiesta di sdoganamento dal corriere, ho compilato il modulo, pagato online le tasse e mercoledì 5 luglio alle ore 13,00 mi è stata consegnata in ufficio. Ho pensato di condividere questa mia esperienza di acquisto estero, come hanno fatto altri sopra, soprattutto anche perchè interessa il medesimo negozio e magari può essere utile come confronto. Dimenticavo, ho effettuato il pagamento tramite il mio account paypal quindi in ogni caso avrei potuto recuperare se non tutta (generalmente le spese di spedizione se non erro non le rimborsano) almeno la maggior parte della cifra.1 punto
-
Vai vai e non lesinare...sii generoso tanto non costano (ancora) niente! PS: per gli amministratori , non fatevi venire idee strane per racimolare introiti, tassando le reazioni e le faccine! Che è un attimo trasformare il Forum in Parigi....1 punto
-
Ho conosciuto una persona che per soldi si fingeva anche stupido.... quindi se qualcuno si dà da fare talmente tanto, credo che qualche utilità dovrebbe avercela....1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Fantastico!!! 🤩 la ringrazio tanto per la risposta super esaustiva! È davvero bello poter apprendere queste informazioni per me che sono un neofita! Grazie mille!🙏1 punto
-
1 punto
-
Certo... La prima e della 32R e la seconda della GRTIA Sul rovescio della GRTIA ed in particolare sotto la E di ET c'è una correzione di conio che non sono riuscito a decifrare con certezza. Secondo voi cos'è?1 punto
-
Bronze Coin of Antiochus I Soter, Ecbàtana, 278 BC - 261 BC. 1944.100.73620 (Coll. ANS). Dritto: Diademed head of Antiochus I right Rovescio: BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY - Apollo seated left on omphalos, holding three arrows and resting left hand on grounded bow Descrizione fisica: Asse: 11. Dimensioni: Peso: 5.77. Diametro: 17. Canonical URI: http://numismatics.org/collection/1944.100.73620 apollonia1 punto
-
Buonasera Riccardo, non è una questione di fiducia, ma semplicemente che i tuoi argomenti sono stati più convincenti dei miei😅 E se il signor Vittorio ci vide un H, quasi certamente si trattava della versione piccola del Chimenti 25, da intendersi però secondo la tua ipotesi...1 punto
-
Ciao Releo, Il conio diverso (per me) inteso come diverso proprio nello standard ad esempio questo: Nota la line del collo, è diversa, l'effige è diversa quindi (per me) due conii diversi. Ora: Qualcuno mi potrà dire sono due conii diversi... Invece sono (per me) due conii uguali con due diverse varianti (o errori).1 punto
-
Correttamente la serie è la commemorativa Costantinopoli / Vittoria su prua (L'altra è Urbs roma / lupa che allatta) Confermo R corona Epsilon Datazione 330-331, 333-337 (ma dal peso e diametro calanti direi una datazione più bassa). Moneta abbastanza comune1 punto
-
Presso il museo Glauco Lombardi a Parma https://www.museoglaucolombardi.it/la-storia-in-miniatura/ Mostra a ingresso libero. Inaugurazione sabato 29 aprile 2023, ore 11.00 La nuova mostra del Museo Glauco Lombardi, realizzata in collaborazione con il Museo Medagliere dell’Europa Napoleonica di Arezzo, avvicinerà la storia di Napoleone Bonaparte attraverso un inaspettato strumento di narrazione, quello delle medaglie scatola, curiose sintesi illustrate in formato tascabile, che ebbero il loro momento di massima diffusione nel XIX secolo. Questi esemplari sono composti da una medaglia suddivisa in due parti, una che funge da coperchio, l’altra da contenitore (da cui il nome medaglie scatola) entro la quale xilografie o gouaches, affiancate da testi illustrativi, raffigurano le imprese belliche e gli episodi più salienti della vita di Napoleone. Le diverse produzioni (tedesca, francese inglese) mettono in evidenza la perizia tecnica dei disegnatori e degli incisori di ciascuna produzione, le caratteristiche distintive di ognuna e punti di vista a volte diametralmente opposti. Gli episodi narrati “in scatola” troveranno un parallelo in quarantotto incisioni facenti parte della raccolta Campagnes des français sous le Consulat et l’Empire e tratte dai dipinti originali di Carl Vernet, edite a Parigi nel 1820 dalla tipografia Firmin Didot, e saranno accompagnate da medaglie e altri oggetti di grande interesse già presenti nelle collezioni Lombardi, memorabilia che celebrano il matrimonio di Napoleone e di Maria Luigia d’Austria e la nascita del loro figlio, erede della dinastia napoleonica. La mostra sarà visitabile, sempre a ingresso libero, fino a domenica 3 settembre 2023; durante i mesi di apertura saranno organizzate periodiche visite guidate e una conferenza che permetterà di conoscere meglio la storia di queste affascinanti creazioni. Ci sono anche visite guidate: https://www.museoglaucolombardi.it/visite-guidate-alla-mostra-la-storia-in-miniatura-2/1 punto
-
Ciao @pedro_88 Un bel antoniniano con argentatura quasi integra. MIR 1222, seconda officina di Mediolanum. https://www.acsearch.info/search.html?id=78365381 punto
-
Grazie x la citazione @Raff82 non so se corrisponda a quelle descritte da @Releo ( complimenti per l'interessante discussione ). La posto anche se la conservazione è piuttosto bassa. Buona serata,1 punto
-
E non solo quella 😊 Anche la 1848 reimpressa appartenuta al Pin e riportata nel suo bel lavoro sulle Piastre di Ferdinando II.1 punto
-
Ti sconsiglio fortemente i fogli A4 trasparenti, la banconota si sposta in continuazione mentre sfogli l'album. Inoltre essendo troppo poco aderenti, sono i primi ad accogliere eventuali spore di muffa. Io utilizzo Leuchtturm, parere personale: non ho mai trovato fogli paragonabili in commercio. Buona raccolta!1 punto
-
Possiamo intanto dire che le consegne e le presentazioni da parte degli autori stessi del Gazzettino avverrà nell’ambito dell’evento di Milano Numusmatica, il 11 novembre 2023 all’Hotel De La Ville a Milano, di cui si parla anche nella sezione eventi.1 punto
-
Spettacolo ,niente mi fa sentire piu bene dei sesterzi nel vassoio1 punto
-
1 punto
-
Ommamma ho la pressione alta rischio l'infarto, devi mette il warning "attenzione roba forte", che spettacolo che sono, ritratti a parte il rovescio di entrambi è bellissimo. Ho riconosciuto Filippo I (comincio pian piano a riconoscerli 😁), ho un sesterzio suo anche io, il rovescio è molto consumato però lo adoro perchè è quello delle celebrazioni dei mille anni di Roma 🤩1 punto
-
Qualche settimana fa sono riuscito ad accaparrarmi questa moneta stranamente passata un po’ in sordina, per mia fortuna. Si tratta di Nerone (piccolo, appunto, ma pur sempre Nerone): Come detto, la moneta e’ piccola, complessa nel rovescio e non ben centrata; pertanto, mi ha richiesto una lunga ed attenta osservazione per poter cercare di interpretare tutti gli elementi (dalle effigi alle legende) necessari per arrivare ad una identificazione e quindi ad una classificazione le più corrette possibile (si spera), anche perché di questa monetina esistono diverse “varianti”. Ma, come spesso succede con la monetazione romana imperiale, la classificazione non e’ la cosa più importante. O almeno non lo e’ per me e non lo e’ in questo caso. Comunque, dovrebbe trattarsi di un semisse di Nerone in oricalco, il RIC I 233. Diametro massimo: 17,32 mm Peso: 2,82 g Ecco la descrizione (in corsivo) del RIC: NERO CAES AVG IMP: Nero, laur., r. CER QVINQ ROM CO: Table, seen from front and r., bearing urn on l. and wreath on r.; on the front panel, a bas-relief of two sphynxes (or two griphons) confronted; a round shield rests against table-leg. Value-mark S above table to l. S C ex. La moneta in mano e’ assai piacevole, con l’oricalco che occhieggia giallognolo dalle parti più in rilievo. Il ritratto di Nerone e davvero nitido ed espressivo, ben apprezzabile anche nei dettagli del viso (nonostante un piccolo eccesso di metallo adiacente al naso), soprattutto nonostante le dimensioni ridotte della moneta. Il rovescio e’ bellissimo nella sua complessità e i molti elementi rappresentati sono tutti apprezzabili. Che cosa rappresenta? La legenda e’ importante. Sciogliendola diventa: CERTAMEN QVINQVENNALE ROMAE CONSTITVTVM che si potrebbe tradurre come “giochi quinquennali istituiti a Roma”, intendendo quel ROMAE come genitivo locativo con valore di stato in luogo, vista la posizione nella frase. Questa e’ una mia ipotesi, ma il mio latino e’ scarso e vecchio. Magari qualcuno può contribuire con una traduzione più congrua della mia. Comunque, grammatica latina a parte, il senso dovrebbe essere chiaro. A cosa si riferisce, quindi, il rovescio? Nel 60 d.C. Nerone istituì a Roma (secondo il modello greco) il certamen quinquennale, un complesso di giochi (simili ai giochi pitici) cui diede il nome di Neronia. Esso comprendeva tre tipi di gare: ginniche (di atletica), equestri (corse di carri) e musicali (che includevano prove di canto e di recitazione in prosa ed in versi). Ecco cosa dice Svetonio a proposito dei Neronia (De vita Cesarum, Nero) : “Instituit et quinquennale certamen primus omnium Romae more Graeco triplex, musicum gymnicum equestre, quod appellauit Neronia”. “Fu il primo tra tutti ad istituire a Roma un concorso quinquennale secondo l’usanza greca articolato in tre sezioni, musica, esercizi ginnici, corse di cavalli che chiamò Neronia”. E Tacito, Annales, Liber XIV: “Nerone quartum Cornelio Cosso consulibus quinquennale ludicrum Romae institutum est ad morem Graeci certaminis, varia fama, ut cuncta ferme nova.” “Nell’anno del quarto consolato di Nerone e di Cornelio Cosso furono istituiti a Roma i giochi quinquennali sul modello di quelli greci, con reazioni molto diverse, come quasi sempre avviene con le novità.” Dei Neronia parla anche Cassio Dione nella sua Storia Romana (ho trovato la citazione, ma non il passo). Ma vediamo meglio il rovescio, davvero interessante. Forse, quella che si vede e’ una cosiddetta “mensa agonistica” sulla quale si esponevano i doni per i vincitori delle gare atletiche. Ci potrebbe stare visto ciò che si trova sopra, ovvero una corona d’alloro e un’urna che forse, ad onor del vero, sembra più una coppa, simile a quella che viene data oggi in premio ai vincitori delle competizioni. Inoltre, a terra potrebbe esserci uno scudo, ma secondo alcuni addirittura un disco che potrebbe richiamare le gare atletiche. Interessanti anche i grifoni (o sfingi?) affrontati del fondo che potrebbero essere un richiamo ad Apollo ed ai giochi pitici, più simili (rispetto a quelli olimpici) ai Neronia. Il termine quinquennale è stato molto discusso dagli storici anche sulla base delle fonti antiche (soprattutto Svetonio e Tacito). Probabilmente con esso, in realtà, si intendevano i giochi a cadenza “quinquennale”; ogni 4 anni, quindi, dal momento che in antichità nel conteggio venivano compresi il primo e l’ultimo anno dell’intervallo temporale. Ciò sarebbe in sintonia con il fatto che i giochi successivi al 60 si sarebbero dovuti tenere nel 64. E secondo Svetonio, in effetti, si tennero nel 64; invece, secondo Tacito, nel 65. Magari avevano ragione entrambi. Non è escluso che si siano svolti in due parti (nel 64 e nel 65) sia a causa di impegni imprevisti ed intercorrenti di Nerone (viaggio in Egitto e nelle province orientali, poi rimandato all’ultimo), sia soprattutto a causa dell’incendio di Roma. Circa invece l’edizione del 68 non sappiamo nulla. Probabilmente non si fece a causa delle ribellioni di Giulio Vindice, di Clodio Macer e della ascesa della figura di Galba che precedettero di poco la caduta di Nerone (e la sua morte) nella primavera proprio del 68. Nerone aveva forse altro a cui pensare… Dal punto di vista numismatico e’ una moneta che fa parte della III emissione di Roma del 64-65 d.C. caratterizzata dal fatto che, per la prima volta, tutta la serie bronzea (dai sesterzi ai quadranti) veniva coniata in oricalco. Probabilmente, si ipotizza, emessa proprio per la seconda edizione dei giochi. Si tratta di un effetto della riforma monetaria di Nerone (attuata tra il 63 d il 64 d.C.) che riguardò non solo la monetazione nobile di oro e argento, ma anche, per l’appunto, la monetazione enea. Con essa, tutta la monetazione bronzea fu coniata in oricalco e con una riduzione di peso di tutti i nominali. Le motivazioni della scelta di una emissione tutta in oricalco appaiono oscure e si possono solo fare delle ipotesi. L’oricalco, infatti, pur avendo in questo periodo subito una riduzione del tenore di zinco (componente fondamentale della lega) aveva un costo ben più elevato del rame. Quindi, pur se associato ad una riduzione del peso dei nominali, non si capisce bene che vantaggio economico ne avrebbe ricavato l’autorità emittente. Da come ho letto, forse vi era da parte di Nerone la volontà di armonizzare la moneta bronzea nonché il desiderio di migliorarne l’aspetto estetico (cosa cui, come sappiamo, Nerone prestava molta attenzione). Sta comunque di fatto che questa modifica ebbe vita breve. Alla fine, si tornò al sistema augusteo, ma con la testa radiata sui dupondi e con una riduzione della percentuale di zinco nel divisionali in oricalco. Certo che, quante cose ci sono dietro una piccola monetina! Un saluto a tutti da Stilicho1 punto
-
In questo caso, giuridicamente osservo che la questione è più controversa...questa moneta è stata oggetto, come molte altre, di un decreto di cessazione di corso legale...cioè...se dopo una tale data la portavate in banca non la cambiavano più e la riportavate a casa. Secondo il mio parere appare arduo oggi invocare di fronte ad un giudice la proprietà della moneta (Lo Stato Autorità Emittente), quando tempo prima lo stesso (Stato), si è rifiutato di accettarla al cambio. Sarebbe interessante vedere come si potrebbe sostenere in giudizio una tesi del genere.1 punto
-
Se l'acquirente è residente all'estero, ma si consegna il bene venduto in Italia, è necessario comunque chiedere il permesso di esportazione? In tal caso non è l'acquirente straniero a doverlo chiedere qualora porti il bene fuori dall'Italia?1 punto
-
Penso avrai risolto, cmq provo a darti il mio parere da inesperto. Per me la moneta è molto compromessa, specie sul rovescio, ma sul diritto qulcosa puoi recuperare. Io come trattamento acido per rimuovere ispessimenti di patine e cancri uso il cloruro ferrico oppure l edta, acido etilen diammonico tetracetico. Questo in base al tipo di ossidante, incrostazione, cancro che hanno colpito la moneta. Ovviamente dopo i bagni dovrai provvedere a rimuovere i residui acidi dalla moneta, per poi rimuovere le ossidazioni, cancri ecc con bisturi o altri strumenti meccanici e successivamente stabilizzare il tutto con benzotriazolo. La tua moneta al dritto la tratterei con il cloruro ferrico. La soluzione è quella utilizzata per i circuiti stampati. Il cloruro aggredisce la parte carcerosa, ma non la patina, meno che la moneta non resti immersa per ore. Il cloruro lo puoi usare per immersione, ma dovrai stare attento ai progressi di disgregazione degli ossdanti o cancri e appena vedi che si stanno sgregando devi togliere la moneta. La lavi h20 distillata fredda e poi la bolli in h20 distillata dentro un ciottolino di acciaio. In tale maniera asporti la parte polverulenta aggredita dall'acido e rimuovi l' acido rimasto. La raffreddi con h20 distillata, asciugandola a tampone. A questo puntopuoi iniziare il lavoro meccanico di rimozione. Il bisturi sempre perpendicolare, è importante per evitare graffi. Il cancro dovrà essere rimosso fino al metallo se necessario, quindi potrà rendersi necessario rimuovere la patina, anche se solitamente ciò non è necessario. Con questa procedura recuperi un alta % delle monete illeggibili, perchè sotto la coltre di cancro, almeno nel in un alta % delle monete, vi è la moneta vera e propria con tutti i dettagli annessi e connessi.finite leoperazioni di pulizia e recupero dovrai trattarla come descritto in questa discussione, quindi benzo e paraloid. La cera reinassance puoi usarla, ma a mio parere lucida troppo le patine. Per quanto riguarda le zone, ove la patina è stata asportata, potrai trattarla con fegato di zolfo,anche se la ripatinatura non è apprezzata con il fegato di zolfo riesci a ripristinare una patinatura quasi originale che non si nota ad occhio nudo, ma solo al microscopio o co lenti oltre i 6x. Ovviamente la patinatura richiede stabilizzazione e fissativo, quindi benzo e paraloid.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?