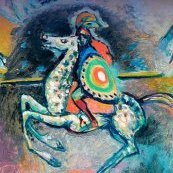Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 07/22/23 in tutte le aree
-
Quant' è bella la lettera R nelle reimpresse del 1832, piccola e ben fatta 😊5 punti
-
Buongiorno, vi presento la nuova opera sulla monetazione di Taranto, edita dalla Edizioni D’Andrea: The coins of Tarentum from 281 BC to 209 BC Il terzo dei quattro volumi dell'opera previsti che di fatto chiude l'intera produzione di Taranto. Il volume è in stampa e sarà disponibile tra la fine di Agosto e l'inizio di Settembre 2023. Il quarto libro dell'opera, compirà un’analisi delle coniazioni dal punto di vista tipologico, epigrafico e figurativo, con una proposta di tassonomia relativa all’evoluzione delle diverse forme dell’etnico. Il volume è stata scritto da Alberto D’Andrea, Marco Miglioli, Giuseppe Tafuri ed Enrico Vonghia.4 punti
-
Credo sia doveroso fare alcune precisazioni. La diatriba se scudo o ducato è stata oggetto di discussione anche in passato. E' noto che il ducato equivale a 100 grana e di conseguenza il mezzo ducato a 50 grana. I documenti di zecca riportano: "essendoci l'anni passati del 1617 e 1618 nella costruttione di monete di carlini quattro, sei e dodici il pezzo e delle grana quindece" (RASNa, Dip. della Somm., Zecca antica, Fascio 15°, Libro del Cred. Maggiore, p. 116). Questa semplice riga risolve l'arcano. Sono state battute monete da 120 grana (scudi), 60 grana (mezzi scudi) e 40 grana (terzi di scudi). Il Turbolo poi, parlando di questa specifica coniazione (ritenendo la moneta coniata scudo) fa riferimento al peso che deve essere proporzionale a quello del mezzo carlino che pesava 31 acini (1 acino corrisponde a 0.04455 grammi) quindi un carlino doveva pesare 0.04455*62= 2.7621 g. Da cui 12 carlini (lo scudo) dovrebbe avere un peso pari a 33.1452. un peso legale sicuramente più vicino allo scudo che non al ducato (10 carlini, quindi gr. 27.621).4 punti
-
Direttamente dalla battigia aggiungo l'ultimo acquisto. Tondello tra i più comuni e in conservazione non eccellente con un evidente difetto. Coronato con croce potenziata. Zecca: Napoli. Segno di zecchiere sotto croce: A Peso:3 punti
-
Magliocca 663 5 Grana 1851 , simbolo stella a 5 punte e taglio liscio. Con FERD ! Magliocca 663/a Simbolo punto, taglio liscio. Con HIER ..3 punti
-
Posto il mio esemplare, anch'esso di conio 2, in alta conservazione (FDC) e con fondi immacolati. I rilievi non sono così accentuati come nella moneta dell'asta Morton , ma appare ben coniato e permette, ad esempio, di vedere chiaramente la testina di leone in basso a sn nella legenda del diritto prima di SMV. Ho sempre trovato affascinante questa moneta ...2 punti
-
Siamo pronti a scendere nelle fogne per combatterli. Non ci arrenderemo. 🏴☠️ Arka Diligite iustitiam2 punti
-
Viene riportato e qui magari qualcuno mi corregga pure se dico inesattezze, che il personale di Zecca rimasto fedele a Ferdinando anche durante la Repubblica Napoletana, abbia addirittura conservato coni e materiali per essere pronti a coniare monete con l'effigie di Ferdinando per ristabilirne il potere anche visivamente su un qualcosa che passasse di mano in mano. Riporto alcune foto delle mie monete del periodo, monete che sono oggetto della discussione. Saluti Alberto2 punti
-
riprendo questa vecchia discussione perché proprio oggi ho segnalato, senza ovviamente inviare la foto che ho fatto, che mi sono imbattuto al castello sforzesco di Milano di un Follis da 40 nummi – Giustiniano – Cizico – KYZ – B – ANNO XII - MIB 120a1 con contromarca al dritto in campo a ore 10 solo per voi un piccolo assaggio2 punti
-
Materiale presente (scorie) sul conio di D/ al momento della battitura ..2 punti
-
Condivido volentieri l’esemplare Lotto 572 Asta E-Live 3 Nomisma Aste del 24/6/2023, così descritto (parzialmente esatto) in Catalogo e relative foto: ITALIA Medaglia 1986 Mussolini e l'Arcangelo San Michele Opus: Esseo AE (g 274 - 100,9 mm) Grading/Stato: SPL-FDC Dalle ricerche effettuate non si tratta del 1986. L’opus è la medaglista ungherese Elisabeth [Erzsébet] von Esseö, nata il 28/6/1883 a Jánosháza (Ungheria) e morta il 17/9/1954 a München (Germania). Una delle caratteristiche di questa medaglista è quello di lasciare il suo monogramma sulle medaglie: Ora, il mio problema è: a) capire l’anno sulla medaglia, che non può essere 1986 (presumo: 1916 = X romana 10): b) trovare qualche riferimento specifico alla medaglia; ho trovato vari esemplari, anche i musei, etc., ma non questa in particolare, anche a livello di aste passate, o altro. Forse non ho fatto un’approfondita ricerca. Saluti, Domenico1 punto
-
Buongiorno oggi, 19 luglio é l' 80° anniversario del primo bombaramento di Roma. Pochi minuti dopo le 11,00, in 6 ondate, 662 bombardieri protetti da 268 caccia attaccano Roma. L’aviazione italiana ha in tutto 38 caccia da opporgli. La contraerea può sparare fino a 3mila metri di altitudine, ma i bombardieri americani che volano a quota 6mila metri, non possono essere colpiti: solo qualche cannone tedesco, che ci è stato prestato, arriva a quella quota ed è in grado di forare la corazza dei bombardieri. Dopo le sei ondate, sarà abbattuto un solo bombardiere americano. Alle 11,40 la contraerea italiana esaurisce le munizioni in dotazione, fornite in quantità inferiore al previsto. La prima bomba da 500 chilogrammi viene sganciata da una fortezza volante americana, tocca terra alle 11.03 ed esplode all’interno dello scalo merci ferroviario di San Lorenzo. Gli aerei delle ondate successive alla prima non vedono più i binari ferroviari, perché le esplosioni hanno sollevato una grande nube di polvere che si è espansa mano mano che sale in quota, con il risultato che sganciano le bombe alla cieca, colpendo non più gli obiettivi strategici, ma per due ore bombardano i palazzi del quartiere di San Lorenzo, il Cimitero del Verano, i quartieri : Prenestino, Pigneto, Tiburtino, Esquilino e il Policlinico Umberto I. E' colpita anche la Basilica di San Lorenzo: la bomba che cade sulla Basilica provoca gravissimi danni e fa crollare il tetto. Ma subiscono danni anche gli edifici di Via Prenestina,Via Casilina, Via Appia, la zona di Santa Croce in Gerusalemme e il quartiere Italia, tra Piazza Bologna e Via Lorenzo il Magnifico. In Via dei Sabelli (vicino allo scalo ferroviario), da un orfanatrofio centrato in pieno dalle bombe, i Vigili del Fuoco riescono a estrarre sani e salvi centinaia di bambini sepolti vivi dalle macerie, anche se, purtroppo, per 78 di loro e per 6 suore non c’è più nulla da fare. Ma ci sono anche casi disperati, quando i Vigili del Fuoco sono costretti a coprire con la calce e il cemento una zona a Via dei Dalmati per i miasmi insopportabili che si respiravano, nonostante avessero estratto dalle macerie 34 cadaveri dopo sei giorni di lavoro. Dal 4 luglio, per sei volte, prima del 19 luglio, gli Alleati, non disturbati dalla nostra contraerea, lanciano da alcuni volantini di avvertimento sulla città, preannunciando il bombardamento da lì a poco. Ma nessuno ha creduto che facessero sul serio, pensando che la città del Papa non sarebbe mai stata colpita dalle bombe. Il resto lo fa la propaganda fascista sequestrando i volantini a terra e pretendendo la loro consegna da parte delle persone che li hanno raccolti. Ricordo famigliare: miei nonni paterni e materni, con mio padre ragazzo e mia mamma ancora bimba, abitavano entrambi al quartiere Pigneto, ma non si conoscevano allora nel '43; ebbero la casa bombardata, si salvarono tutti perché stavano fuori casa; ma dovettoro "sfollare" (come si diceva allora) in altre "sistemazioni". Nonni paterni e famiglia dentro una specie di grotta, nei sotterranei di un palazzo ancora intero; nonni materni si rifugiarono al paese di mia nonna : Sora, dove nel '44 passerà la linea Gustav (e lì un'altra storia...). Basilica di San Lorenzo distrutta Scalo merci ferroviario distrutto Cimitero del Verano devastato Quartiere San Lorenzo distrutto1 punto
-
Qui i vari "aggiornamenti": https://help-openai-com.translate.goog/en/articles/6825453-chatgpt-release-notes?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc&_x_tr_hist=true Qui le differenze tra la versione 4 e le precedenti: https://openai.com/gpt-4 Come puoi ben vedere, non fanno riferimento al fatto che all' A.I. ad esempio è stato inibito l'uso di link esterni.1 punto
-
1 punto
-
Posso aggiungere di avere visto anche esemplari napoletani tosati1 punto
-
Violenze inutili e gratuite sono state commesse, come in ogni guerra, da tutte le parti in conflitto, ricordarlo non significa certo essere revisionisti o, peggio, trasformarsi in "camicie nere", ma quello che non si dovrebbe mai dimenticare è che sono state le camicie nere, col consenso, ahimé, della maggioranza degli italiani, a cercare e volere questa guerra... si raccoglie quel che si è seminato petronius1 punto
-
Ciao quello che hai detto lo trovo interessante.. da approfondire... ciaooo1 punto
-
Ma anche (anzi, soprattutto ), in favore della sottoscrizione delle cartelle dei prestiti emessi per finanziare la guerra. Furono sei in tutto i prestiti nazionali lanciati per finanziare la prima guerra mondiale, quello indicato sulla cartolina dovrebbe essere il quarto, del 1917. petronius1 punto
-
Ci sono troppi biglietti da 1000 sulla piazza, decisamente troppi. In un mio catalogo del 1999 scritto a quattro mani da Bugani/Gavello, i biglietti da 1000 lire conosciuti sino all'ora erano 14. In poco più di vent'anni sono triplicati... Se poi guardiamo i numeri di serie e la progressività numerica possiamo arrivare a 300 unità.1 punto
-
ciao, una domanda, ma tu leggi quello che ti scriviamo? Ti abbiamo già detto che per ogni moneta devi aprire una discussione diversa, ma non sotto questo post che ormai tratta di troppi argomenti diversi, ogni moneta ha la sua sezione. Saluti :-)1 punto
-
In passato ne ho avuto diversi di questi "mezzi coronati" pagandoli però cifre forse più ragionevoli e prendendoli più per curiosità che per altro. Tra l'altro feci una statistica tempo fa e la maggior parte era della zecca dell'Aquila. Credo che anche questo postato sia aquilano (almeno mi pare di scorgere l'aquiletta sotto lo scudo). Una mia ipotesi era che coronati fortemente tosati, al punto di non essere più accettati nelle transazioni, venissero ulteriormente tosati per poi essere utilizzati come sottomultipli facilitando tra l'altro le piccole transazioni. Non ho mai approfondito l'argomento ma sono certo che ci deve essere una giustificazione per la presenza di questi coronati così fortemente tosati... e sul fatto che siano quasi tutti aquilani.1 punto
-
Roma Numismatics Ltd > E-Sale 110 Auction date: 3 August 2023 Lot number: 556 Price realized: This lot is for sale in an upcoming auction Lot description: Pisidia, Isinda Æ 20mm. 2nd-1st centuries BC. Dated year 4. Laureate head of Zeus to right, sceptre behind / Warrior on horse galloping to right, holding couched lance; below, coiled serpent to right and IΣIN, Δ (date) to left. Cf. RPC I 3512d; von Aulock, Pisidien 580-590; SNG BnF -. 7.21g, 20mm, 12h. Good Very Fine. Estimate: 50 GBP1 punto
-
1 punto
-
Va osservato che di questa osella 1759 sono riconoscibili 2 conii di diritto e rovescio, molto simili tra loro. Se chiamiamo 1° conio quello dei falsi, anche queste 2 oselle presentano la stessa impronta e, come opportunamente notato da @carvacco, le stesse debolezze e caratteristiche. Stante che non va bene condannare una moneta in fotografia, sarei quantomeno stupito se fossero periziate autentiche. Inoltre non se ne parla più (argomento sottaciuto) ma tra le oselle d'oro si trovano molti falsi (così come in genere tra i multipli in oro veneziani) di difficile riconoscimento. Questa osella mostrata da Fabrizio è invece stata prodotta con la seconda coppia di conii e sembrerebbe autentica. E' vero che i volti risultano meglio impressi, e questo è un criterio di qualità, tuttavia le coniazioni a martello portavano a risultati non sempre soddisfacenti. Potresti fornirmi gli estremi dell'asta (che numero? che lotto?)1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Cartolina satirica italiana del periodo bellico. La caricatura è sugli alleati africani e indiani del Regno Unito. Bel pezzo di storia.1 punto
-
tra M, AA menadi E scola TRAMA AMENA DI E. SCOLA Ciao. Stilicho1 punto
-
Un quarto di siliqua a nome di Giustiniano I è passata recentemente in asta Roma Numismatics. Dal diritto piuttosto non ben riuscito ma statisticamente abbastanza rara nel panorama della produzione del Sirmium Group (Alain nel catalogo del 2017 ne cita 10 esemplari in tutto che nel frattempo saranno cresciuti di numero). Riporta al diritto un busto imperiale con la legenda D N IINSTNNANVS V R (stando alla casa io leggo altro ma non conto) ed il retro anepigrafe con una versione semplificata del monogramma di Teodorico. La cosa interessante è che la casa d'aste abbia utilizzato per la catalogazione il lavoro di @Poemenius. A. Gennari, 'The "Sirmium group": about the so-called Gepids siliquae' (2017), Τype 8, p. 244, 169 (O98/R124 - stessa coppia di conii). Ex Bertolami Fine Arts - ACR Auctions, E-Auction 105, 21 October 2021, lot 2904.1 punto
-
Buongiorno, dalle foto, propenderei per un falso. Per averne certezza, come detto da altri, servirebbe sapere il peso esatto, il diametro, e se la moneta è in tutto, oppure in parte o per nulla magnetica.1 punto
-
a me l'appiccagnolo non dispiace, è coevo e testimonianza dei tempi. Meglio un appiccagnolo decente che appiccagnoli rimossi con risultati sconfortanti.1 punto
-
Ciao, torniamo sull'argomento 1000 lire turrita perché vorrei sottoporvi alcune immagini delle filigrane dei 4 tipi "turrita", da 50, 100, 500 e 1000 lire. Siccome la 1000 lire esiste anche nella varante sostitutiva, vi mostro entrambe, una N17 e una W19. La 500 lire ha la serie P37. Ho oscurato i numeri di serie perché le banconote non sono mie ma ho lasciato la serie nelle 500 e 1000 lire. A voi il giudizio... filigrane del 50 e 100 lire filigrana del 500 (numero di serie oscurato ma serie P37) filigrana del 1000 serie N17 1000 lire serie W19 a confronto... dettaglio Un po' mi spiace aver oscurato i numeri di serie perché sulle 500 e 1000 lire le cifre del numero seriale hanno un font diverso rispetto a quello della serie (P37/N17/W19)1 punto
-
Mi piace. Mi candido al titolo di Re del Pianeta Terra e Imperatore Supremo dell'Universo, questo universo finto che è frutto del gran gomblotto digitale. Visto che Napoleone e tutti gli altri non sono mai esistiti mi chiamerò ART I, nel senso che sarò il primo vero imperatore esistente.1 punto
-
1 punto
-
Accueil En périphérie du village de Lemud, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Metz, l’Inrap a exploré une portion de villa antique. Cette intervention a livré quelques résultats importants, concernant en particulier les modalités d’implantation de cet établissement rural, son évolution architecturale durant le Haut-Empire et les conditions de son abandon durant l’Antiquité tardive. Dans le cadre de l’extension d’une zone d’activité à Lemud (Moselle), l’Inrap a fouillé une portion de villa antique de mars à mai 2023. L’opération, portant sur une surface de 1500 m², a permis d’explorer une partie du bâtiment résidentiel et un grand grenier. Les recherches n’ont touché qu’une petite fraction de cet important domaine rural, dont l’emprise totale est estimée à un minimum de 1,5 ha mais ont livré des résultats intéressants. La découverte d’une importante occupation sous-jacente à la villa maçonnée permet en effet d’appréhender les modalités de création et d’évolution de cet établissement rural, qui remonte à l’époque romaine précoce (début du Ier siècle apr. J.-C.). Plusieurs états de construction maçonnés ont été observés, signalant des agrandissements de la partie résidentielle. Dans sa dernière phase, la demeure est notamment équipée d’une cave qui a piégé beaucoup de mobilier archéologique, dont des fragments de parois en terre crue décorées d’enduits peints. La partie supérieure du comblement de la cave a livré un petit dépôt d’une vingtaine de monnaies valentiniennes, ainsi qu’un lot d’outils en fer relevant du domaine de la construction. Ces deux ensembles métalliques sont manifestement liés à la récupération de matériaux architecturaux après l’abandon de la villa, à situer dans la seconde moitié du IVe siècle apr. J.-C. Cliché aérien de la fouille de Lemud réalisée à l’aide d’un drone. © T. Ernst, Inrap L’environnement naturel et anthropique du site La villa de Lemud se trouve à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Metz-Divodurum, le chef-lieu de la cité des Médiomatriques. Elle est directement reliée à cette capitale régionale par l’intermédiaire de la voie antique allant de Metz à Sarre-Union, qui passe à moins de 3 km au nord de la villa. Sur le plan de la géographie physique, le domaine de Lemud est installé sur une petite colline du plateau lorrain, couverte d’un épais placage de limons des plateaux et dominant le cours de la Nied, qui coule à moins de 500 m en contrebas. Ces conditions ont certainement présidé au choix d’implantation de cet établissement rural : une localisation dans l’orbite économique d’un chef-lieu, des terrains limoneux propices à l’agriculture, la proximité d’un réseau de communication fluvial et terrestre permettant de distribuer les productions du domaine. Aux origines de la villa : un important établissement rural d’époque romaine précoce La découverte de nombreuses structures excavées – fosses, fossés et trous de poteaux – antérieures à l’état maçonné renseigne sur l’origine et l’évolution architecturale de cet établissement rural. Les structures rattachables à cette première phase d’occupation permettent d’identifier au moins deux grands bâtiments construits en terre et en bois. Le premier se trouve sous le futur bâtiment résidentiel maçonné et forme un plan rectangulaire d’environ 7,5 m par 15 m, composé de douze poteaux monumentaux, dont les mieux conservés atteignent environ 1,5 mètres de hauteur, 50 cm de diamètre et sont plantés dans de grandes fosses de 1 m de large. Ils présentent également la particularité d’être légèrement inclinés dans le sens transversal de l’édifice ; une caractéristique typique de l’architecture de la fin de l’âge du Fer et du début de l’époque romaine. Le second bâtiment se distingue par une architecture mixte, comprenant une grande sablière basse relayée par des poteaux porteurs. Son plan exact n’est pas connu, car le grenier maçonné à piliers internes s’y superpose et a détruit une partie de ses vestiges. On peut néanmoins restituer un plan quadrangulaire d’au moins 13,5 m par 12,5 m. Ces deux grands bâtiments de terre et de bois semblent tous les deux remonter à l’époque romaine précoce, probablement au début du Ier siècle apr. J.-C. d’après les premières observations effectuées sur les céramiques associées. Ils signalent une continuité assez stricte avec l’état maçonné postérieur, puisque les bâtiments en pierre se superposent précisément aux bâtiments en bois, moyennant un léger décalage d’orientation. On voit ainsi que les tracés régulateurs qui présideront à l’organisation spatiale de la villa sont en place dès la création de l’établissement, au tout début de l’époque romaine. L’édifice à douze poteaux situé sous la résidence semble déjà avoir la fonction d’habitation, au vu de ses dimensions et de la puissance de ses fondations, qui indiquent une élévation importante. Il s’agirait donc d’une véritable proto-villa de terre et de bois, préfigurant assez précisément l’organisation spatiale et fonctionnelle du domaine du Haut-Empire. Une applique de harnais en forme de pelta découverte dans la cave. La pelta est à l’origine un bouclier, dont la forme de croissant échancré est reprise de façon récurrente dans les décors antiques en tant que symbole de la vertu guerrière. © S. Ritz, Inrap L’évolution architecturale du domaine au Haut-Empire La reconstruction en pierre du domaine intervient vraisemblablement à la fin du Ier siècle apr. J.-C. ou dans le courant du IIe siècle. Les principaux vestiges de cette période correspondent à un grand bâtiment résidentiel rectangulaire d’au moins 14 m par 25 m et à un grenier à six piliers internes de 14,7 par 13 m. Ce modèle de grenier, connu par ailleurs, semble être équipé d’un plancher surélevé sur une série de piliers afin d’assurer la conservation des grains en atmosphère aérée. Quant à la résidence, l’étude stratigraphique de ses vestiges permet de restituer son évolution architecturale : elle s’organise initialement autour d’un bâtiment rectangulaire, auquel s’ajoutent d’abord deux petites pièces carrées à l’ouest, puis une grande pièce rectangulaire au sud. Cet espace comprend notamment une cave, qui a piégé beaucoup de mobilier au moment de la destruction de la villa et de l’effondrement de ses élévations. Des fragments de parois en terre crue décorées d’enduits peints ont notamment été découverts au fond de la cave. Les premières observations montrent qu’il s’agit d’une maçonnerie en terre crue sans ossature en bois, c’est-à-dire d’un mur en adobes (briques de terre crue) ou en pisé (terre coffrée), et non en torchis sur un clayonnage de bois. Ces techniques architecturales restent assez exceptionnelles dans le nord de la Gaule, a fortiori en contexte rural. Ces fragments de parois appartiennent certainement à une ou plusieurs cloisons de refend venant compartimenter les espaces intérieurs de la villa, dans la mesure où leurs caractéristiques – des parois en terre crue d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur – excluent tout rôle structurel dans l’architecture de l’édifice. L’étude à venir des enduits peints apportera des précisions sur la nature des décors muraux mis en œuvre dans cette villa. L’abandon de la villa durant l’Antiquité tardive Le sommet du comblement de la cave est principalement composé de petits fragments de calcaire, qui correspondent à des déchets laissés sur place lors de la récupération des moellons du parement de la cave. La fouille de ces niveaux a livré, parmi d’autres éléments, un dépôt composé d’une vingtaine de monnaies valentiniennes, concentrées au même endroit et parfois collées ensemble par l’oxydation. Il s’agit probablement du contenu d’une bourse en matériau périssable. Le dépôt monétaire de l’Antiquité tardive lors de sa découverte dans la cave. © S. Ritz, Inrap À quelques centimètres de ce dépôt monétaire, un lot d’outils en fer liés au domaine de la construction (burin, ciseau, gouge…) a été découvert. Il formait également une concentration cohérente, qui laisse penser que ces outils étaient placés dans un contenant disparu, comme une trousse à outils en cuir ou en textile par exemple. Ces deux ensembles métalliques, monnaies et outillage, illustrent les travaux de récupération des matériaux architecturaux de la villa après son abandon, que l’on peut situer – grâce aux monnaies – dans la seconde moitié du IVe siècle apr. J.-C. Le lot d’outils en fer lors de sa découverte dans la cave. © S. Ritz, Inrap Aménagement : SEBL Grand Est Recherches archéologiques : Inrap Prescription et contrôle scientifique : Service régional de l’archéologie Drac Grand-Est Responsable de recherches archéologiques : Simon Ritz, Inrap https://www.inrap.fr/une-portion-de-villa-antique-lemud-moselle-173781 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Oddio, una a una meticolosamente ho dei dubbi, per una tiratura di migliaia di pezzi sarebbero belle ore di manodopera, credo che probabilmente raccolgano semplicemente le prime coniate dai conii nuovi, forse le prime 1000-5000(?) ad ogni cambio di conio.1 punto
-
1 punto
-
Eh, ma mica è sua... è in asta. Dovrebbe chiedere al venditore di farla periziare...1 punto
-
Il problema é: non piace la moneta in sé o non piacciono le foto? Certamente queste ultime farebbero diventare "falsa" qualsiasi moneta. Quanto all'usura, anche se è una moneta non nata per la circolazione, non scordiamoci che c'è stata una guerra mondiale tra la sua coniazione ed il nostro presente e che una moneta d'oro può aver fatto la differenza fra la vita e la morte di chiunque a quel tempo (mica sono state tutte sempre in un comodo nascondiglio)... Per dirimere la questione autentica/non autentica, comunque, lo si può fare solo con la moneta in mano.1 punto
-
Una cosa è certa,i libri di storia dicono ben poco di quello che dovremmo sapere. E nessuno è stato santo...e chiudo.1 punto
-
il titolo della discussione è buono anche per questa, mai vista una con G al posto di C1 punto
-
Ciao @Oppiano secondo me è un 3 venuto male, quindi 1936, nel 1916 non era il DUCE.1 punto
-
1 punto
-
Buonasera, non è una monetazione che seguo, ad ogni modo ritengo che qualsiasi modifica intenzionale di una moneta, se avvenuta in tempi non recenti, come l'applicazione di un appiccagnolo o la creazione di un foro per portarla al collo o altre manomissioni ancora le conferiscano un ulteriore interesse storico, se non altro per gli interrogativi e la curiosità che fanno nascere a proposito del motivo della modifica stessa. Luca.1 punto
-
Il simbolo definito come “cross torch” in realtà è una groma agrimensoria. Si tratta di uno strumento per tracciare allineamenti ortogonali. C’è un interessante articolo riportato in Academia.edu scitto da Campana e Miglioli su tale strumento riprodotto anche su alcuni bronzi di Herakleia e su alcuni stateri di Locri1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?



copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)



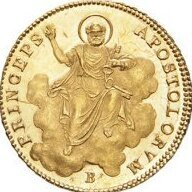









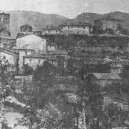
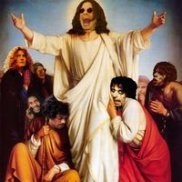




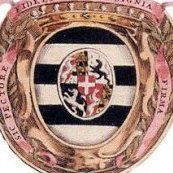

.thumb.jpg.ae694d43dad26808f483a70d749ce2f0.jpg)